Numero Completo 08


Editoriale
Prima di entrare nel dettaglio del numero, pare opportuno un sia pur rapido accenno a due questioni che appaiono particolarmente rilevanti, rispetto alle quali ci sentiamo di condividere con le nostre lettrici e i nostri lettori una posizione di redazione. Al momento in cui mandiamo in stampa la rivista, la tensione politica internazionale non accenna a decrescere e se apriamo i giornali o consultiamo le notizie sul web, non possiamo fare altro che essere presi dall’angoscia. Dilagano le notizie sui conflitti, ormai intrecciati in un sistema sempre più complesso di appoggi, alleanze e minacce. In questa difficile situazione, il nostro modesto apporto non può essere altro che un appello perché tutti gli scontri armati cessino al più presto.
La carenza e l’indebolimento di relazioni fondate strutturalmente sul mutuo appoggio, li vediamo e tocchiamo nel nostro mondo in vari ambiti, dal globale al locale.
Nell’ambito della politica interna, ad esempio, un tema che ci tocca sempre più da vicino è il graduale smantellamento della sanità pubblica, che sperimentiamo con sempre più lunghe liste di attese a causa della carenza di personale. I minimi investimenti nella sanità degli ultimi anni causa la fuga di moltissimi medici e infermieri al settore privato o all’estero, ma quello che più preoccupa è non vedere nessuna soluzione all’orizzonte.



Questo secondo spunto ci permette di iniziare la presentazione del numero dagli articoli dedicati al tema della medicina e della cura. In questo numero affrontiamo infatti il tema della medicina di genere e la sua recente inclusione nella medicina occidentale. Non si parla di medicina «delle donne», ma di un’apertura atta a valutare la cura dei disturbi secondo parametri più ampi, che tengano in conto che le differenze tra persone non sono solo biologiche ma anche ambientali, culturali, sociali, economiche. Il concetto della cura, ampliato al «prendersi cura di…» può essere centrale nella gestione politica delle relazioni e per modificare equilibri. La prospettiva individualista che è alla base del sistema capitalistico ha permeato la visione che abbiamo dell’altro e ci ha abituato alla delega della cura, considerando l’interdipendenza una questione di debolezza, associata all’ambito femminile (versus l’indipendenza e la forza, che identifica nell’immaginario tradizionale l’ambito maschile).
Per poter immaginare un mondo basato su diversi rapporti sentiamo la necessità di affrontare gli equilibri che si instaurano in famiglia, prima comunità nella quale impariamo a muoverci. A questo proposito, una citazione è per il film C’è ancora domani di Paola Cortellesi, che con linguaggio poetico ha portato nel mainstream una riflessione sul lungo processo (ancora in corso) di emancipazione delle donne nella società italiana, toccando temi fondamentali, come i modelli ereditati di relazione tra uomo e donna, ed esprimendo la necessità di istituire nuove relazioni famigliari basate sulla collaborazione e l’amore, invece che sulla sopraffazione. Il merito del film ci pare ovviamente non risieda nella questione del voto, quanto nel riconoscere che siamo ancora figli di quei modelli di relazione e che finché non riusciremo ad offrire nuovi modelli ai nostri figli e alle nostre figlie non possiamo sperare che scompaiano le disuguaglianze.




In questo numero affrontiamo sotto varie angolature la questione dell’essere membri di una comunità all’interno di comunità, dal micro al macro. La necessità di trasformarci in membri pienamente responsabili della nostra comunità è fondamentale per la salvaguardia della grande casa in cui viviamo, l’ambiente. Un approfondimento che definisce l’eco-anarchismo ci ricorda come le nostre intime famiglie primarie si inseriscano in comunità locali e che a loro volta si ineriscono in comunità regionali sia umane che più-che-umane (la Terra intera).
Sul rapporto con la natura e le piccole comunità, un altro film recente degno di nota è Un mondo a parte, di Antonio Albanese, che fa luce su due temi fondamentali: la sopravvivenza dei piccoli borghi periferici rispetto alle grandi città, e la scuola come cuore di una comunità. È proprio dalle piccole realtà che dobbiamo ripartire per poter aspirare a cambiare le cose. E a questo puntiamo con questa rivista, presentando, sostenendo e diffondendo esperienze che esistono nonostante tutto e dalle quali possiamo trarre spunto.
Sul ruolo che ciascuno di noi può avere nel cambiamento in senso libertario dei rapporti sociali, utili indicazioni vengono sia dall’articolo di Francesco Codello, che tratta il tema dell’anarchismo pragmatico o post-negativo, che da quello di Samuel Clarke, che descrive il funzionamento di una cittadina secondo principi libertari. Le conclusioni dell’articolo di Clarke, che apre questo numero, potrebbero essere utilizzate per un Manifesto della nostra rivista: «Se nel mondo ci sono pratiche anarchiche che esistono da più tempo del nostro inferno capitalistico, allora dobbiamo solo riaccendere quelle pratiche. Non dobbiamo necessariamente costruire una nuova utopia apparentemente aliena, dobbiamo solo incoraggiare i valori umani che precedono la nostra attuale distopia».




Il nostro immaginario è infatti così prigioniero di modelli e valori propri della società capitalista, che non riusciamo nemmeno a pensare che ci possano essere reali alternative. L’antropologia culturale, fortunatamente, ci ricorda come nella storia e nella geografia ci siano stati numerosissimi esempi di società organizzate in modi diversi e deve indurci a meditare sul fatto che quelli che molti sono portati a considerare dei dati naturali immodificabili, sono in realtà il riflesso di una visione culturale. E ci offre anche una speranza dimostrando che l’autorganizzazione che è scaturita storicamente in tante piccole comunità possa continuare ad essere la base delle interazioni umane.
Queste riflessioni ci portano al toccante resoconto che abbiamo ricevuto dalle carceri dell’Indonesia: il linguaggio fresco e sincero del compagno incarcerato ci permette di comprendere i diversi sensi che può avere la parola resistenza, e come in ogni situazione si possa cercare di cambiare le cose senza dare per scontato di doversi adeguare al sistema (e alla sua corruzione).
Il tema del mutuo appoggio costituisce il tratto distintivo di molti contributi. Per esempio, l’articolo di Alberto Franchini ci sembra importante perché ci ricorda che anche fare la spesa è un atto politico, mentre l’esperienza dei gruppi di mutuo aiuto, raccontata da Bruno Miorali, ci riporta all’importante ruolo di responsabilità di ognuno di noi all’interno di ogni piccola comunità.
In termini economici, aspetti centrali legati alla solidarietà o alla sua assenza sono trattati rispettivamente nella conversazione tra Piketty e David Graeber e nell’approfondimento dedicato alla dottrina «anarco-capitalista» che ha portato Milei al governo dell’Argentina.




Nella rubrica Radici presentiamo i profili di un grande classico dell’anarchismo, Errico Malatesta (1853-1932), e di una scrittrice libertaria scomparsa recentemente, Ursula K. Leguin (1929- 2018). Nella sezione musicale presentiamo infine un’intervista a Andrea Satta, dei Tête de Bois, che ripercorre la sua carriera come un viaggio nei paesaggi quotidiani e famigliari, senza dimenticare «l’amore e la rivolta».
Abbiamo bisogno, più che mai, di un anarchismo e di una visione libertaria che siano coscienti dei valori positivi e costruttivi che propongono. Per tale ragione, ci sforziamo di mostrare cosa ciascuno di noi può fare nel suo piccolo, vivendo coerentemente coi propri ideali e poi nelle relazioni con gli altri. La prima sfida è instaurare relazioni sane, permeate da pregiudizi o gerarchie. È riuscire ad applicare i principi di uguaglianza e solidarietà alla nostra vita quotidiana, nelle scelte di tutti i giorni.
Buona lettura! E continuate a sostenerci, come state facendo!




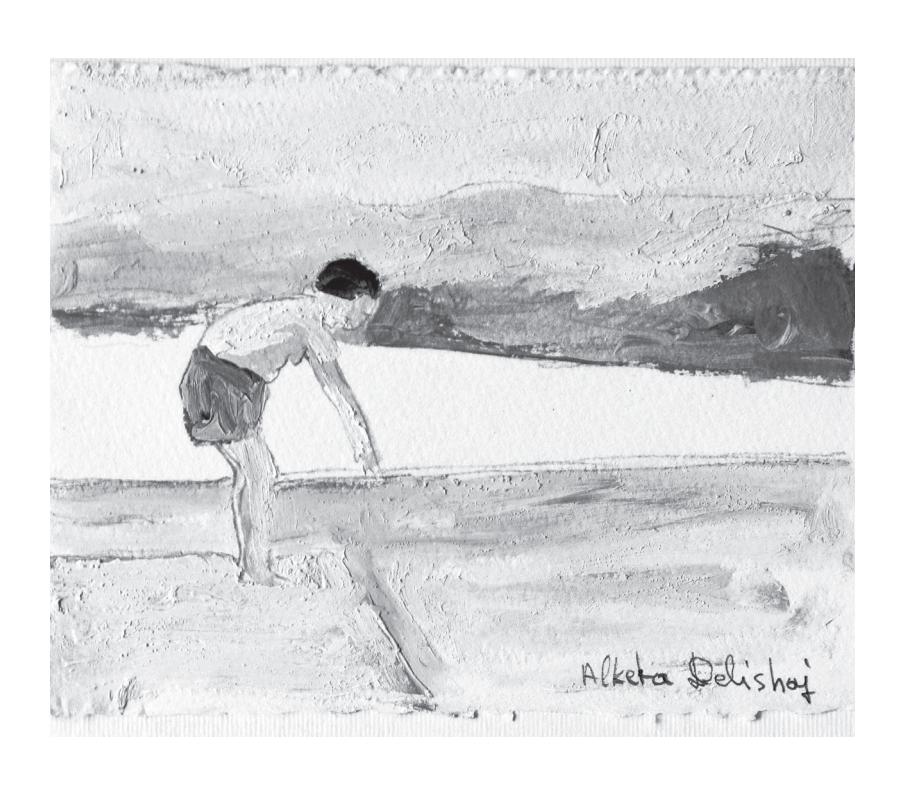




In una piccola città messicana, i residenti indigeni hanno creato una comunità nuova, democratica e in gran parte pacifica. La domanda è: cosa possiamo imparare dai loro risultati?
Murray Bookchin, nella sua opera fondamentale nel campo dell’ecologia sociale, L’ecologia della libertà, ha criticato la tendenza della storia a concentrarsi sulla «conquista del potere» e sugli imperi con i loro «templi, obitori e palazzi» – luoghi che «evocano la nostra radicata soggezione al potere». Le conseguenze di questo atteggiamento, per Bookchin, sono molto chiare:
Tragicamente, quest’ombra ha oscurato in gran parte la tecnica dei contadini e degli artigiani alla «base» della società: le loro reti diffuse di villaggi e piccole città, le loro fattorie e i loro orti domestici, le loro piccole imprese, i loro mercati organizzati intorno al baratto, i loro sistemi di lavoro altamente mutualistici, il loro acuto senso della socialità e i loro mestieri deliziosamente individuati, gli orti misti e le risorse locali che fornivano il vero sostentamento e le opere d’arte della gente comune.




Gli scritti dei normali libri di storia dipingono un quadro dell’umanità piuttosto desolante per un anarchico o un socialista libertario. Dai regni in competizione del periodo degli Stati Combattenti in Cina (475-221 a.C.), alla «corsa all’Africa» degli imperi coloniali (1881-1914 circa), gli annali dell’umanità sembrano inondati dall’adorazione o dalla sottomissione ai grandi
palazzi del potere. Ma è al di sotto di questi grandi palazzi che possiamo trovare la storia veramente anarchica che desideriamo, una storia di «convenzioni umane di base, solidarietà comunitaria e cura reciproca» che tende a scavalcare le varie differenze e ad agire a livello comunitario, nonostante i «vertici politici o quasi-politici» (Bookchin). In altre parole, a prescindere dalla persona che siede sul trono, ai suoi piedi c’è una rete di villaggi e cascine di tipo comunalistico e mutualistico. Questo non significa che tutte le società fossero centralizzate
o guidate da figure potenti. In effetti, se si guarda al di là dei libri di storia standard, si trova una vasta gamma di storia umana che è governata in modo comunalistico e molto democratico, sia nelle tribù confederate degli Irochesi, sia nei villaggi comuni di Sulawesi, in Indonesia. Nonostante ciò che molte storie occidentali vorrebbero farci credere, la democrazia non è un’invenzione degli antichi ateniesi, ma una tradizione globale che risale a centinaia, se non migliaia, di anni fa. La riluttanza a insegnare questo al pubblico occidentale è spiegata bene da David Graeber:
La vera ragione della riluttanza della maggior parte degli studiosi a considerare «democratico» un consiglio di villaggio di Sulawezi o di Tallensi – ebbene, a parte il semplice razzismo, è la riluttanza di ammettere che coloro che gli occidentali hanno massacrato con una tale relativa impunità fossero al livello di Pericle.



In definitiva la differenza tra la democrazia di queste tradizioni e quella della politica moderna è l’atto stesso del voto. Il consenso era il metodo democratico preferito da queste società e, come scrive Graeber, possiamo trovare «più e più volte» comunità egualitarie «in tutto il mondo, dall’Australia alla Siberia» che lo utilizzavano. Perché, si chiede, «in una comunità faccia a faccia è molto più facile trovare un accordo su ciò che la maggior parte dei membri della comunità vuole fare» e perché, come è tipico di queste società, «non ci sarebbe modo di costringere una minoranza a concordare con una decisione della maggioranza». La mancanza di una forza monopolistica significa che non c’è il potere di costringere le persone ad accettare le decisioni e quindi, naturalmente, si deve ricorrere a un metodo democratico che coinvolga tutti i membri della comunità. La mancanza di un sistema di voto simile a quello dei Greci o delle nostre società moderne può aver portato gli storici a ignorarla, ma state certi che la democrazia non è un’eccezione nella storia, bensì spesso (almeno a livello locale) la regola.
Queste tradizioni hanno influenzato anche il pensiero di due anarchici nigeriani, Sam Mbah e I.E Igariwey, che nella loro opera comune, African Anarchism: The History of a Movement, affermano che mentre l’anarchismo «come astrazione può essere remoto per gli africani», le pratiche anarchiche «non sono affatto sconosciute come stile di vita». La società africana era per lo più comunalista, perché «si creava una simbiosi tra gruppi che si guadagnavano da vivere in modi diversi». La loro organizzazione politica, basata su riunioni e incontri decentrati, non rifletteva in alcun modo i sistemi centralizzati sviluppatisi altrove nel mondo. Come scrivono:
Questi incontri e riunioni non erano guidati da leggi scritte, perché non ne esistevano. Si basavano invece su sistemi di credenze tradizionali, sul rispetto reciproco e sui principi indigeni di legge naturale e giustizia.




Sono queste tradizioni storiche che possono fungere da raggi di sole nelle nostre immagini altrimenti desolanti del futuro. Se nel mondo ci sono pratiche anarchiche che esistono da più tempo del nostro inferno capitalistico, allora dobbiamo solo riaccendere quelle pratiche. Non dobbiamo necessariamente costruire una nuova utopia apparentemente aliena, dobbiamo solo incoraggiare i valori umani che precedono la nostra attuale distopia. O, per dirla con le parole del filosofo taoista del III secolo Bao Jingyan, dobbiamo solo tornare indietro a un momento prima che i nostri cuori diventassero «ogni giorno più pieni di disegni malvagi».
Che ruolo ha Cherán in tutto questo?
San Francisco Cherán, nome completo, è una comunità indigena dello stato di Michoacán, in Messico. Tormentati dalle attività criminali, dal disboscamento illegale e dai «continui intrighi» dei partiti politici locali, gli stanchi abitanti di Cherán si sono riuniti il 15 aprile 2011 per prendere in mano la situazione. Hanno cacciato rapidamente i taglialegna illegali che stavano distruggendo le loro risorse naturali, ma quando hanno finito si sono rivolti contro le

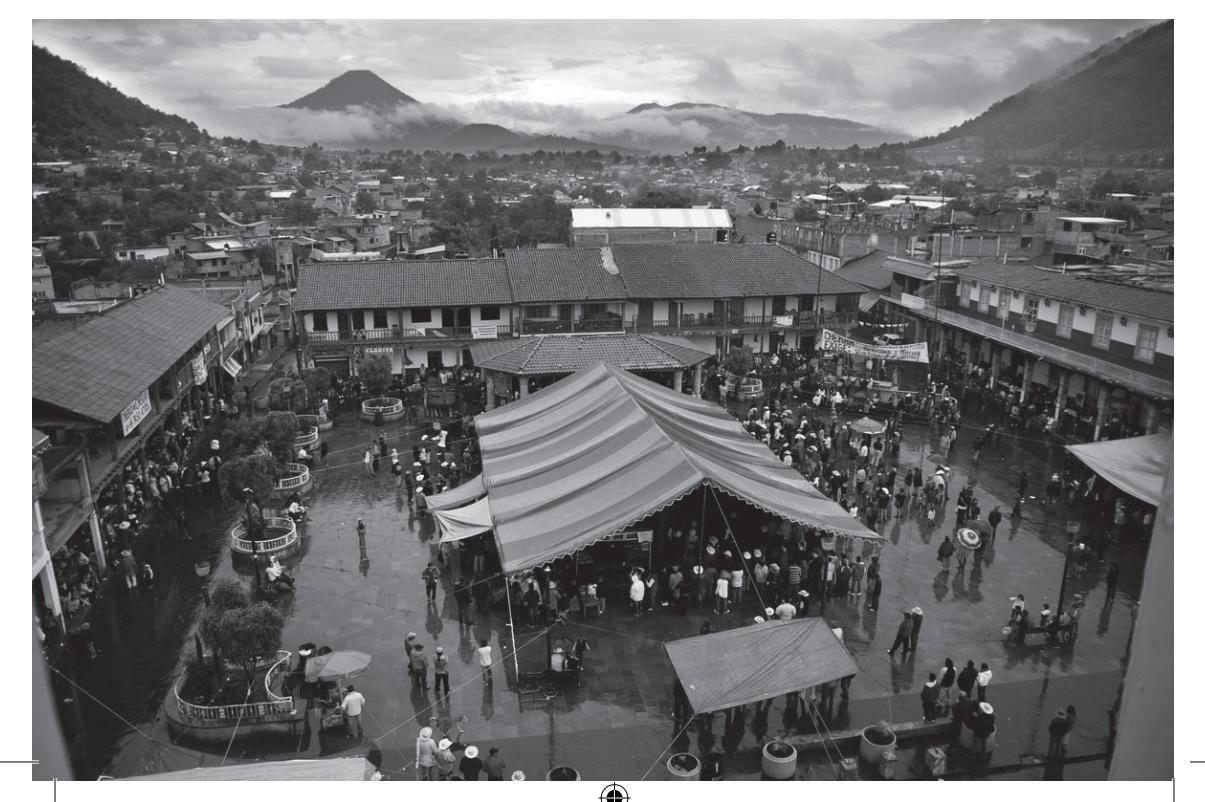

autorità municipali e alle forze dell’ordine che li stavano deludendo. Cacciando anche loro, la popolazione di Cherán è arrivata a istituire una «assemblea generale comunitaria», costruita dal basso da assemblee istituite nei quartieri locali. Le loro ragioni sono state spiegate bene da un abitante del luogo, Josefina Estrada, al «Los Angeles Times»:
«Non potevamo più fidarci delle autorità o della polizia, non sentivamo che ci proteggevano o ci aiutavano. Li vedevamo come complici dei criminali».
La pace e la sicurezza che ciò ha portato ai residenti di Cherán è incredibile.
Lo stato che li circonda aveva avuto in un anno 180 omicidi in un mese, mentre ora l’unico vero crimine della città sono le risse tra ubriachi o la guida in stato di ebbrezza. I trasgressori devono passare un po’ di tempo a smaltire la sbornia dietro le sbarre o a fare lavori socialmente utili, ma raramente la punizione va oltre. Anche il loro bilancio politico, rispetto a quello di gran parte del Messico, è molto ammirevole: i membri dei consigli sono pagati con stipendi modesti e sono chiamati a rispondere del loro operato da assemblee democratiche.
Inoltre negli anni precedenti alla rivolta, circa la metà dei 59.000 ettari di foresta di Cherán è stata abbattuta illegalmente, ma ora, con la scomparsa dei taglialegna e il regolare pattugliamento del territorio, sono ben difesi. Anche il significato di questo risultato è spiegato in un’intervista al «Los Angeles Times»:
«Queste foreste sono la nostra essenza, ci sono state lasciate dai nostri antenati per essere protette e nutrite», ha detto Francisco Huaroco, 41 anni, membro della pattuglia forestale, mentre con una squadra camminava accanto a ceppi che testimoniavano i precedenti saccheggi. «Senza questi boschi, la nostra comunità non è completa, non è se stessa».


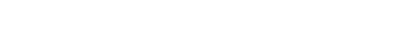

Questi meravigliosi sviluppi dovrebbero ispirare qualsiasi persona di sinistra e potrebbero portare alcuni a chiedersi: che tipo di influenza di sinistra si può trovare a Cherán? Questa è una domanda importante, ed è altrettanto importante, nel rispondere a questa domanda, sottolineare l’influenza della cultura indigena di Cherán nella creazione della nuova comunità. Come affermato in un articolo su « Open Democracy»:
La comunità di Cherán occupa questo territorio da prima del processo di colonizzazione. Ha conservato le proprie istituzioni per organizzarsi nella sfera politica, culturale, economica e sociale e questo ha avuto riflesso sulle sue dinamiche sociali. Gli abitanti della municipalità hanno combinato le proprie pratiche con la legge nazionale, in un regime di doppia legge.
Sebbene la città abbia certamente avuto influenze socialiste (come si può vedere nei murales del rivoluzionario messicano Emiliano Zapata), non sembrano esserci in vista alcuna insurrezione marxista, avanguardia comunista o agitatori anarchici. Non ci sono bandiere rosse o nere che sventolano in testa a questo movimento, ma solo volti di persone del posto che hanno pensato che «quando è troppo è troppo». E sebbene possano essere stati ispirati dalle rivoluzioni del mondo, passate e presenti, sono stati la loro cultura indigena, le loro tradizioni e il loro luogo di vita a dare corpo alla
ribellione e a gettare le basi per una nuova comunità. Cherán ha effettivamente ricevuto il sostegno della sinistra radicale di tutto il mondo, ma sono i gruppi locali come il Colectivo Emancipaciones, un gruppo per i diritti degli indigeni dell’America Latina, ad aver dato loro il sostegno più significativo.




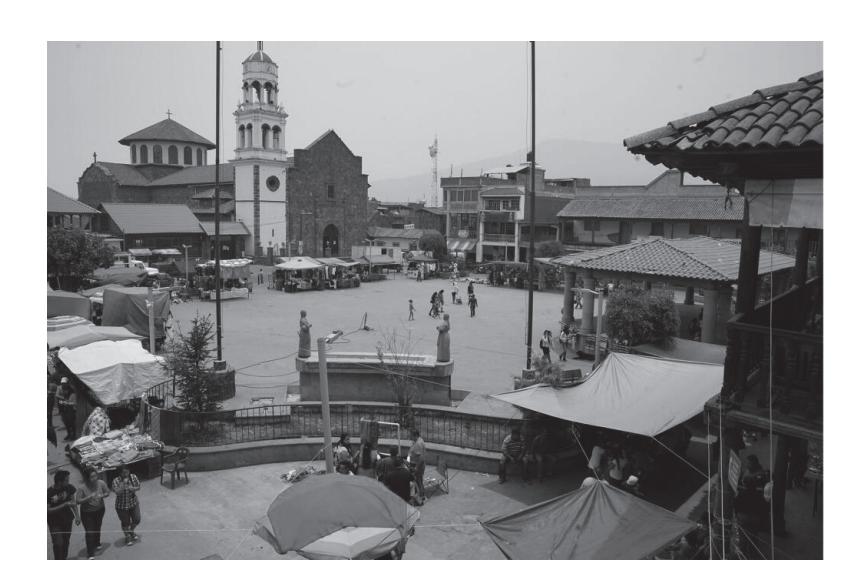
Ci sono due lezioni significative che potremmo imparare da comunità come Cherán:
-
- Che dobbiamo mantenere viva la speranza nel nostro mondo apparentemente triste e non rivoluzionario. Momenti come questi rafforzano la convinzione anarchica che gli esseri umani possono essere, alla radice, anarchici. Con questo intendo dire che gli esseri umani, in quanto persone locali, ispirate da tradizioni, comunità e culture locali, si sforzeranno di governare se stessi e, per estensione, di porre fine alle miserie dello Stato capitalista.
-
- Che un movimento non ha bisogno di sventolare una bandiera anarchica per realizzare ideali anarchici. Se crediamo veramente che l’umanità sia, alla radice, capace di raggiungere l’anarchia, allora non abbiamo bisogno di imporre o pretendere che i movimenti si conformino ai nostri standard. Se crediamo veramente che le società umane, se ne hanno l’opportunità, tenderanno a un modo di vivere comunitario, allora non c’è bisogno di stare in giro a imporre o a controllare l’azione rivoluzionaria, ma dobbiamo solo di cercare di ispirarla e sostenerla.




Pensando a Cherán, proporrei di essere il vero «radicale», come teorizzato da Paulo Freire in una prefazione alla sua opera La pedagogia degli oppressi:
Questa persona non si considera il padrone della storia o di tutti i popoli, né il liberatore degli oppressi; ma si impegna, all’interno della storia, a combattere al loro fianco.
L’incredibile lavoro di Freire è caratterizzato dall’idea che si debba sviluppare una «educazione al problema», che incentri il processo di apprendimento sulle condizioni materiali di chi apprende, o in altre parole, sul «qui e ora». Come scrive:
Il punto di partenza del movimento è l’uomo stesso. Ma poiché le persone non esistono al di fuori del mondo, al di fuori della realtà, il movimento deve partire dalla relazione uomo-mondo. Di conseguenza, il punto di partenza deve essere sempre l’uomo e la donna nel «qui e ora», che costituisce la situazione in cui sono immersi, da cui emergono e in cui intervengono.
La prima riga di questa citazione è significativa in questo caso, perché a Cherán è proprio vero che il movimento è partito dal popolo stesso. I legami sociali locali, il patrimonio e la comune umanità hanno fornito le basi per la loro nuova società. È stato quindi solo lo sviluppo di una comprensione dei mali del capitalismo e delle sue cause che ha portato a quel meraviglioso giorno del 15 aprile 2011. A noi radicali non resta che porre la domanda: «Perché le cose devono andare così?» e, se necessario, offrire gli strumenti per cambiarle. Ciò che è importante, tuttavia, è che abbiamo fiducia che il popolo organizzi e sviluppi da solo la propria liberazione. L’educazione è parte integrante, ma non è un’interferenza. Possiamo cercare di piantare un seme, ma non dobbiamo determinare come crescerà la pianta.



Se il tipo di tradizioni di cui hanno parlato Bookchin, Graeber, Mbah e Igariwey, combinate con l’influenza del pensiero e delle pratiche rivoluzionarie di altre parti del mondo, hanno portato alla ribellione di Cherán, allora possiamo aspettarci che molte ribellioni simili possano seguire. Il compito del radicale, quindi, non è quello di cercare di prendere il controllo di un movimento, né di «imporre la propria parola» su di esso (per usare la frase di Freire), ma di impegnarsi con le persone, ispirarle e lottare con loro, non per loro o al posto loro. Quello che possiamo chiamare o percepire come un movimento anarchico può non considerarsi necessariamente tale, ma questo non lo rende meno degno del nostro sostegno. Ciò che vediamo a Cherán è il popolo che prende in mano la propria liberazione, un atto che dovrebbe riempirci di speranza.
Traduzione di Marco Antonioli The Anarchist library, 21 giugno 2020


Un muro è solo un muro, può essere distrutto
Jungkir Maruta
Serikat Tahanan è un’associazione antiautoritaria di detenuti organizzata all’interno e all’esterno di undici carceri in Indonesia. Lavorano per raggiungere gli attivisti antiautoritari condannati e per difendere e informare il pubblico sulle condizioni di detenzione in Indonesia. «Organizzandoci in Serikat Tahanan, ci ricordiamo costantemente perché abbiamo iniziato la nostra lotta. Il nostro programma a lungo termine è l’abolizione della prigione». I compagni hanno deciso di raccogliere i loro scritti in una pubblicazione e hanno lanciato una campagna di finanziamento per coprire le spese. In segno di solidarietà e supporto, condividiamo un pezzo della prossima pubblicazione.
Fino a quando tutti saranno liberi.




Sappiamo che nel corso della storia, in diverse carceri del mondo, si sono verificate rivolte e sommosse. Ma sono stati eventi molto rari. I prigionieri dovevano vivere per anni nella stessa tetra stanza ed erano considerati soggetti passivi. Come possiamo definire una resistenza in cui possiamo contare quasi solo su noi stessi, in uno spazio praticamente isolato e pieno di pressioni, che non offre quasi nessuna possibilità di organizzarsi, come una prigione? I muri sono solo muri e gli esseri umani sono solo esseri umani. Anche le carceri e le loro guardie hanno dei punti deboli e i detenuti fanno del loro meglio per sfruttarli ogni volta che se ne presenta l’occasione. In Indonesia, il contrabbando e la corruzione dei guardiani sono fatti comuni. La presenza di oggetti proibiti nelle carceri indonesiane è stata ben documentata da molti mass media. Si va dalle droghe, ai telefoni cellulari, alle armi da taglio e persino alle armi da fuoco! Ho anche sentito parlare di detenuti che pagano per accogliere donne in prigione o fuori dal carcere per un po'.
Ma tutti gli esempi sopra citati costituiscono privilegi (di solito i prigionieri per corruzione sono politici e funzionari governativi) che la maggior parte degli altri detenuti non ha. Per superare le varie limitazioni e l’impotenza, spesso si verificano anche violazioni delle regole e sabotaggi. Non riuscendo a controllare la diffusione dei cellulari, sono stati installati dei disturbatori di segnale, che i prigionieri hanno continuato a distruggere di nascosto. Ciò include anche la distruzione di telecamere a circuito chiuso, il furto di utensili da cucina, di attrezzature da ufficio, il furto di cibo dalla cucina per poi rivenderlo e la manipolazione delle ispezioni giornaliere.
In questo caso vale il luogo comune che «le regole sono fatte solo per essere infrante». L’articolo 4 del Permenkumham (Ministero della Giustizia, N.d.T) 6/2013 prevede 22 divieti per ogni detenuto o internato. Fra questi ad esempio: avere rapporti finanziari con altri detenuti o con il personale di
I muri sono solo muri e gli esseri umani sono solo esseri umani
19




custodia; commettere atti immorali e omosessuali; tentare la fuga; detenere illegalmente denaro; dotare le stanze di apparecchiature elettroniche; installare impianti elettrici; avere mezzi di comunicazione; conservare armi e strumenti che possono provocare incendi; etc. In tutta la mia esperienza, tutti i 22 divieti (a eccezione della diffusione di insegnamenti eretici) sono stati violati. La sfida persiste e spesso i guardiani mantengono il compromesso in base ai propri interessi.
La resistenza si manifesta anche in forma non conflittuale o molto passiva. Ad esempio, fingendo di non sentire le chiamate o gli ordini, o fingendo di non vedere la presenza degli agenti. La vita in carcere è, a tratti, come un nascondino tra gatto e topo. Ci sono quelli che giocano d’azzardo, si tatuano, si drogano, usano il cellulare: tutti questi hanno bisogno di protezione, quindi ci sono sempre detenuti-spie pronti a dare l’allarme se una guardia si avvicina. Nella cella della polizia dove siamo stati rinchiusi molto tempo, abbiamo usato uno specchio per vedere attraverso le sbarre. Facevamo i turni per controllare con gli specchi e i prigionieri di turno li chiamavamo «spie».
Durante le ispezioni periodiche, abbiamo più volte intonato filastrocche (in Indonesia le chiamiamo pantun) come modo creativo e divertente per criticare, trasmettere aspirazioni e lamentele,





o semplicemente come dichiarazione di solidarietà tra detenuti. Una delle poesie che ho scritto criticava l’estorsione. Una volta, il cibo fornito da una famiglia non è stato consegnato al detenuto in questione. Il cibo (qualcosa di valore!) sarebbe stato consegnato solo se avesse pagato la polizia. Perciò, davanti a loro in assemblea, ho letto una breve filastrocca:
Tulang iga tulang rusuk / Kiriman kita dilarang masuk [Costine / Alla nostra spedizione è vietato l’ingresso].
Oppure, c’è stata anche una filastrocca per onorare gli assistenti dei prigionieri (definiti rincalzi):
Makan emping di empang / Tanpa tamping kami timpang [Mangiando in uno stagno / senza rincalzi saremmo zoppi].
A volte, la filastrocca che racconto viene dal profondo del cuore:
Batuk-batuk, makan gorengan / Aku berdoa untuk, dia yang kurindukan [Tossendo e mangiando cibo fritto / prego per chi mi manca].
I prigionieri (e i poliziotti) amano ascoltarmi. Spesso mi chiedono se ho preparato delle filastrocche. A volte la polizia risponde alle nostre filastrocche, non sono l’unico che compone versi. Dalla custodia della polizia sono stato trasferito in un centro di detenzione. Lì abbiamo dovuto trascorrere 12 giorni in quarantena in celle molto sporche, piene di rifiuti, con i bagni intasati, piene di vermi, millepiedi, scarafaggi e altri insetti, senza luce e acqua. Una notte è piovuto. Mi sono svegliato e mi sono reso conto che la nostra cella era diventata una piscina. Avevo il corpo immerso nell’acqua. Per poter passare a una cella più grande e più pulita, dobbiamo pagare circa 500mila Rupie indonesiane (circa 30 euro, N.d.T.). Se l’ultimo giorno non pagheremo, verremo trasferiti nella cella di isolamento, che serve come punizione. Questo è un ricatto!





Pertanto, ho invitato decine di detenuti di altre cinque celle di quarantena ad aderire allo sciopero dei pagamenti. Ho scritto una lettera da far leggere a un detenuto anziano. Diceva:
«Leggete questa lettera in ogni cella passatela fino alla cella di quarantena numero 6. Assicuratevi che tutti i detenuti conoscano il contenuto di questa lettera. Proponiamo di scioperare tutti e di non pagare la tassa di trasferimento. Non si tratta di un nostro obbligo, ma di tasse illegali richieste dai dipendenti. Ci è giunta notizia che il denaro per il trasferimento sarà di 500.000 Rupie. Se non paghiamo, saremo trasferiti nella cella di isolamento. C’è un amico vicino a noi, che da un mese è in isolamento perché non può permettersi di pagare le rette. Se scioperassimo tutti, i guardiani si confonderebbero, sia che venissimo cacciati immediatamente senza pagare, sia che venissimo spostati in una cella di isolamento. È possibile che saremo trattenuti tutti in celle di quarantena. Dobbiamo sopportare altri tre giorni qui, fino a quando non verranno trasferiti altri prigionieri. Il trasferimento di prigionieri avviene ogni due settimane. Questo renderà il direttore confuso nel decidere se metterci tutti in una cella comune o metterci insieme ai nuovi prigionieri. Se resteremo uniti verremo tutti espulsi senza dover pagare. Ricordate, le nostre famiglie fuori di qui stanno lavorando duramente per recuperare soldi. Poi, dovremo anche pagare un acconto, il capo della cella, per non parlare delle sue spese di vita. Se non dovessimo essere cacciati senza pagare, chiediamo almeno che la tassa di trasferimento venga ridotta. Ricordatevi, le formiche non mordono altre formiche. Le formiche mordono solo chiunque le calpesti. Le formiche mordono in maniera spensierata. Arrivati alla cella 6, per favore bruciate questa lettera. Fate in modo che nessun prigioniero venga accusato di essere un provocatore. Per coloro che sono d’accordo, ne discutiamo stasera».




Il detenuto più anziano era d’accordo, anche se diceva che avrebbe preferito stare qui piuttosto che essere trasferito nella cella più grande. Non so per quale motivo. Ma non ha letto la lettera e mi ha detto di tenerla. Però egli stesso incitava a gran voce i prigionieri delle altre celle a scioperare. Molti erano d’accordo, ma al dodicesimo giorno, siamo venuti a sapere che molti prigionieri avevano già pagato perché non riuscivano a sopportare la sofferenza di stare in quarantena. A mia insaputa, il mio avvocato aveva pagato i guardiani per farmi uscire dalla cella di quaran-
tena. Mi sono vergognato molto. Immaginate, ero il promotore dello sciopero e invece sono stato fatto uscire. È stato chiamato il mio nome e io ho solo potuto guardare mentre gli altri sfortunati prigionieri, compreso il detenuto più anziano che non poteva permettersi di pagare, dovevano rimanere in quella dannata cella ancora per un po’. Più tardi ho capito perché preferisse stare in quarantena: le celle residenziali non sono meno terribili e non c’è meno corruzione. Nonostante le celle di quarantena siano terribili, almeno lì non si deve pagare!

Quando sono stato trasferito di prigione, ho aperto una bancarella di cibo. Nella cella vendo caffè, sigarette, pane, noodles istantanei e molti altri prodotti di prima necessità. Un giorno, tutti i detenuti che vendevano furono portati dal direttore. Ha chiesto la chiusura di tutte le bancarelle, tranne per coloro che erano disposti a pagare un deposito di 5 milioni di Rupie (circa 300 €, N.d.T.) alla «cooperativa carceraria». Comunque ai detenuti viene chiesto di pagare una quota iniziale di ingresso di 500mila Rupie (circa 30 €, N.d.T.), e poi una quota mensile di 250mila Rupie (circa 15 €, N.d.T.).



In passato, prima che esistessero le cooperative, i detenuti potevano ricevere grandi quantità di beni di prima necessità (ad esempio noodle istantanei). Di conseguenza, si dice che la mia prigione fosse come un mercato in fermento, perché molti detenuti rivendevano i beni inviati dalla loro famiglia. Attualmente il numero di beni di famiglia è limitato, quindi il detenuto è costretto ad acquistare dalla cooperativa a un prezzo più alto. Un giorno le guardie hanno sorpreso un detenuto a vendere piatti riconfezionati inviati dalla famiglia. I guardiani sono anch’essi coinvolti nel business della vendita di cibo perché cercano di mantenere il monopolio della cooperativa.
Ho resistito a questa estorsione e ho continuato a vendere di nascosto. Ho camuffato la bancarella sparpagliando gli oggetti in diversi armadietti. Se durante una retata vengono trovati questi oggetti, i proprietari dell’armadietto devono semplicemente dichiarare che sono propri. Si tratta di una strategia di mercato nero per contrastare il monopolio delle cooperative e dei guardiani. Poche settimane dopo che siamo stati richiamati, i guardiani hanno diligentemente fatto una retata nelle celle e confiscato diversi articoli dei negozi, fra cui il pane. In quell’occasione giurai di fronte agli altri detenuti che avrei reagito se i beni del mio negozio fossero stati confiscati (per fortuna non è successo). Se questo vi sembra banale, devo ricordarvi che i noodles istantanei possono essere un bene di lusso in prigione. Soprattutto se ciò che riceviamo di solito è riso mezzo cotto, sabbioso e roccioso, pesce con una pungente puzza di marcio e verdure accompagnate da vermi. Fidatevi, ho mangiato tutto ciò in passato, non sto esagerando. C’è una lezione che ho imparato da quell’esperienza o, meglio, una riflessione sulle nostre condizioni odierne. Se i noodles istantanei commercializzati da un detenuto confiscati provocano indignazione, non riesco a immaginare cosa accadrebbe se diventassi un agricoltore e la mia terra venisse confiscata. In realtà questo è quello che succede oggi in tutti gli angoli dell’Indonesia. Sono stato in cella anche con un agricoltore che era stato arrestato in un conflitto contro una multinazionale delle




piantagioni. Si è commosso molto quando gli ho fatto leggere le memorie della prigione Nirbaya scritte dal giornalista indonesiano Mochtar Lubis, perché quando le ha lette, ha provato gli stessi sentimenti dell’autore che era stato imprigionato dal regime autoritario del Nuovo Ordine indonesiano.
La nostra immaginazione della resistenza porta invariabilmente a forme spettacolari e drammatiche di confronto popolare, spesso su scala massiccia, sia spontaneo che organizzato. Suggerisco di vedere anche la resistenza dal profondo del nostro essere. In un luogo in cui vengono imposti isolamento e restrizioni alle comunicazioni, rimanere in contatto con il mondo esterno è una lotta. Di fronte alle istituzioni della disciplina, dell’obbedien-
za creatrici di questi effetti deterrenti, il solo fatto di essere sè stessi è resistenza. In una situazione cupa che vi trascina nel baratro, mantenere la vitalità ed essere un esempio è resistenza. Alla fine, mi sono reso conto che se la prigione stava fondamentalmente cercando di negare la mia esistenza, anche affermare che io esistevo era semplice resistenza. Se tutto è proibito, allora tutto è resistenza.
So che quello che vi sto dicendo suona eroico. Di sicuro. Ma non mi interessa e non voglio farla sembrare più di quello che è. Voglio condividere la mia storia e spero che questo ispiri più persone a rendersi conto della propria capacità di resistenza nel contesto delle proprie lotte. Non scambiatemi per un ribelle fiero e orgoglioso. In effetti non sono coraggioso. Sarebbe più corretto definirmi sconsiderato. Sconsiderato significa sapere di essere debole, spaventato e perdente, ma decidere di continuare ad andare avanti. Ho trovato il coraggio con difficoltà. A parte ciò, tendo anche a essere introverso, calmo e limito le mie relazioni con gli altri detenuti. Il più delle volte sono stato obbediente e avevo un largo sorriso verso i guardiani. Non ho mai messo su una faccia di sfida.



Se mai dovrò agire, deve essere una situazione importante e urgente. Per qualcosa per cui vale la pena lottare, sono pronto a ribellarmi ai guardiani. Non preoccupatevi, ho messo dei limiti. Non andrò troppo in là prendendo rischi inutili. Ho già fatto ripetutamente errori madornali, quindi sto più attento. Tengo sempre a mente il messaggio di Alexander Brener:
«Prometto di essere sobrio e astuto, agile e pericoloso. Prometto di agire in modo tale che non possiate né annegarmi né circondarmi di silenzio. Prometto di combattervi con intelligenza e vigilanza, con attenzione e calma, in modo da colpirvi con delicatezza e forza, ovunque io possa, finché avrò abbastanza forza, anche se in tutto ciò non c’è futuro».
Scritto con tutto il mio cuore 1 agosto 2023
Jungkir Maruta è uno scrittore e ricercatore indipendente anarchico. Interessato agli studi di antropologia sulle società senza stato e alla storia del movimento anticolonialista indonesiano. Vuole ancora scrivere nonostante sia stato condannato a 15 anni di prigione per possesso di marijuana.
Traduzione di Marco Antonioli Estratto il 25-08-2023 da organisemagazine.org.uk/2023/08/25/ a-wall-is-just-a-wall-it-can-be-destroyed-international La Biblioteca Anarchica Jungkir Maruta theanarchistlibrary.org




Non mi ha mai entusiasmato molto fare la spesa al supermercato. Ambienti freddi, impersonali; luci al neon; atmosfera tesa; cibi impacchettati sotto molteplici strati di plastica (!); messaggi visivi invadenti che annunciano sconti e ribassi apparentemente imperdibili; musica dalla radio con i chiassosi successi del momento, interrotti da frequenti messaggi pubblicitari e da annunci sonori per il personale. Una giungla artificiale fatta di rumori, suoni, luci, materiali, colori che frastornano, talvolta irritano e ci allontanano da quello che dovrebbe essere lo scopo principale della nostra visita: una scelta consapevole del cibo del quale ci nutriamo.
La mia esperienza quotidiana di cosa sia fare la spesa è cambiata radicalmente da quando ho iniziato a frequentare il Food Hub a Monaco di Baviera, a poche centinaia di metri da dove vivo1 . Vi devo però avvertire: Food Hub non è un supermercato comune. Lo si capisce già dalle vetrofanie colorate che decorano le vetrine dell’ingresso, disegnate ad hoc dallo studio di grafica Waldmeister2 . All’interno sono del tutto assenti quei




chiassosi messaggi pubblicitari, sia sonori che visivi. L’arredamento è, infatti, parte integrante del corporate design, anche questo curato dai grafici.

Tutto è visivamente coordinato: dalle divise color sabbia di chi vi lavora, ai mobili bianchi e agli elementi di legno, fino alle multiformi lampade in vimini, appese al soffitto da colorati cavi tessili. La filosofia di Alexandra Dietl e Robert Scheurer, i grafici dietro al nome Waldmeister, si sposa alla perfezione con i valori di Food Hub, ovvero sostenibile, nel senso di biologico, ecologico, pulito, ma anche di longevo, durevole e consapevole.
L’ambiente è rilassato e le persone all’opera, spesso, sono occupate a parlare, tutto il contrario degli altri supermercati, dove le cassiere lavorano a ritmi forsennati senza mai alzare lo sguardo. Al Food Hub entri per comprare qualcosa e non esci senza aver scambiato una parola con qualcuno. Parole che possono sembrare talvolta banali o non necessarie ma che sono talvolta dei ponti per costruire relazioni più durature.
Questi sono i dettagli più evidenti di un nuovo modo di concepire un supermercato. Si tratta, infatti, di un supermercato




cooperativo e socialmente sostenibile, dove solo i soci possono fare la spesa. Essere socio al Food Hub non implica soltanto il pagamento di una quota (180 euro che vengono restituiti qualora si decidesse di lasciare la cooperativa), ma presuppone un contributo mensile di tre ore, nelle quali ci si impegna a lavorare manualmente nel
supermercato. Le mansioni di cui ci si deve occupare sono simili a quelle di un normale supermercato: la pulizia degli spazi, il lavoro come cassiere o cassiera, l’accettazione delle merci, il lavoro in magazzino, la distribuzione dei prodotti negli scaffali, affettare il formaggio, impacchettare le noci…
L’idea centrale è che il lavoro manuale consolida non solo la fiducia reciproca tra i soci, ma anche quella nel progetto, attraverso la cooperazione e il lavoro di squadra. Chiamarlo supermercato è in qualche modo riduttivo. Il potenziale sociale è alto e le attività che contribuiscono al rafforzamento di questa comunità sono molte e non prendono luogo solo all’interno del negozio ma anche in altri spazi della città. Ci sono ovviamente attività legate al cibo e alla cucina, assaggi di birre e vini, formaggio francese (uno dei cofondatori ha origini francesi), ma vengono fornite anche sessioni di caffè letterari, corsi di canto e ballo… In più vengono offerte giornate di «porte aperte», dove i nuovi interessati possono vedere il supermercato e parlare con i soci.
Questo progetto ha preso avvio nella Utopia Halle, il 16 gennaio 2021 e il suo primo negozio ha aperto i battenti nel quartiere di Giesing, il primo dicembre 2022. Oltre ai due concetti principali di cui vi ho già parlato, ovvero che il supermercato appartiene ai soci e che questi devono partecipare attivamente e manualmente al suo funzionamento, ce n’è un altro: la trasparenza dei prezzi.




Il Food Hub si rifornisce, per quanto possibile, direttamente dagli agricoltori locali, promuovendo quindi prodotti di stagione e a km zero. Quando questo non è possibile e dunque, per garantire un vasto assortimento di prodotti, Food Hub attinge a grossisti o produttori di cibi biologici. L’idea è di non costringere i soci a fare la spesa in altri negozi, ma, come un vero e proprio supermercato, di fornire un’ampia gamma di prodotti, dalla pasta ai prodotti per la pulizia.
Ciò che invece accomuna tutte le merci è la politica dei prezzi. Al costo del prodotto viene applicato di norma un 30% in più, con il quale coprire i costi del Food Hub, come ad esempio pagare i dipendenti. In questo modo prodotti di alta qualità vengono venduti ad un prezzo nettamente più basso rispetto alle normali catene di supermercati biologici.
L’assortimento dei prodotti è invece del tutto inedito, per lo meno per un supermercato. I soci possono suggerire l’acquisto di prodotti o un produttore scrivendo all’interno del «libro dei desideri» che si
trova all’ingresso del supermercato. I suggerimenti vengono poi esaminati e a ciascun suggerimento viene data risposta. Un sistema simile a quello in uso nelle biblioteche dove gli utenti possono suggerire l’acquisto di libri.
I criteri di selezione dei prodotti sono definiti nella «politica di acquisto» che comprende prodotti preferibilmente biologici, regionali, stagionali e di alta qualità, ma anche puliti, giusti e a buon prezzo. Anche la logistica gioca un ruolo determinante per la selezione. I prodotti, suggeriti e approvati, rimarranno negli scaffali fintantoché saranno richiesti dai clienti. I processi che regolano il Food Hub sono importanti per il funzionamento di questo supermercato come organismo sociale e avvengono con principi decisionali «dal basso».




Parlando di prodotti, dobbiamo ricordare che l’attenzione alla sostenibilità passa anche per l’offerta di una gamma di prodotti non impacchettati che possono essere comperati nella quantità desiderata, facendo ricorso ai propri vasi o contenitori che pertanto possono essere riutilizzati e non devono essere gettati via dopo un solo uso. Per ora i prodotti offerti in questa modalità sono la frutta, la verdura, ma anche alcuni prodotti secchi, come i cereali per la colazione. Anche in questo caso l’offerta viene articolata in base alla domanda, forse ancora troppo bassa per allargare la gamma di prodotti unverpackt.
I cofondatori di questa iniziativa, Quentin Orain, Kristin Mansmann e Karl Schweisfurth, si sono ispirati al Park Slope Food Coop di New York3 e al La Louve a Parigi4 . Il primo è stato fondato nel 1973 e conta oggi 17.000 soci, il secondo ha aperto le porte nel 2017 e ha raggiunto la cifra di 7.700 soci. Numerosi altri esempi basati su questi modelli si trovano in Francia e in Belgio. In Germania Food Hub è in collegamento con altri supermercati simili, come Supercoop a Berlino, Köllektiv a Colonia e Supercoop ad Amburgo.




All’apertura di Food Hub c’erano già 700 soci, oggi i soci sono più di 2000. Tra questi il 70% abita nell’arco di un chilometro dal negozio e comprende persone di due fasce d’età, tra i 30 e i 35 anni e tra i 60 e 65 anni.
Il finanziamento di questa iniziativa monacense si basa su tre pilastri. Il primo, di cui abbiamo già parlato, riguarda la quota associativa che può essere ridotta in caso di famiglie con un reddito basso. Il secondo riguarda dei prestiti volontari da
parte dei soci, che servono a Food Hub come garanzia per i prestiti da richiedere alle banche, nel caso di ampliamenti, arredamenti e quant’altro ecceda le normali spese per il funzionamento del supermercato. In questo caso ci sono due possibilità. La prima riguarda il prestito con buoni da 300 a 1500 euro, che vengono restituiti con gli interessi fino al 2% nell’arco di dieci anni, sottoforma di buoni per la spesa. La seconda opzione è quella dei prestiti subordinati a partire da 500 euro che vengono restituiti con interessi analoghi dopo otto anni. Il terzo pilastro riguarda GLS Bank, una banca etica, che ha con-
cesso un prestito iniziale di 500.000 euro da restituire entro otto anni con un interesse al 3%. Senza questo determinante e cospicuo aiuto finanziario e morale, questa iniziativa non si sarebbe potuta realizzare.
Innovazione e tradizione sono i concetti alla base di questo progetto dove attorno all’importanza del cibo si è costruito un network nazionale che raccoglie assieme diverse comunità locali. I soci di Food Hub, come quelli degli altri supermercati di cui ho accennato, condividono gli stessi principi.


La scelta del cibo e la nostra consapevolezza rispetto a quello di cui ci nutriamo non ha solo una connotazione salutista, attenta a calorie e carboidrati, ma è anche una scelta politica. Supermercati come questo selezionano accuratamente non solo i prodotti ma anche le aziende che li producono. Lavorano in simbiosi con il territorio nel quale si trovano. Accorciano dove possibile i percorsi delle merci.
Promuovere alcune iniziative piuttosto che altre sulla base del modo in cui esse sfruttano le risorse naturali e il nostro territorio è essenziale se vogliamo salvare il nostro pianeta. Food Hub contribuisce a questa causa. Fare la spesa è un atto politico. Cercare alternative alle grandi catene di supermercati è necessario oggi più che mai. Se non ci sono, auto-organizzatevi e fondatele!


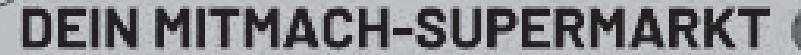



I gruppi di auto/ mutuo aiuto: relazione e comunità
Bruno Miorali
«Secondo la collaborazione reciproca (con un partner o con i gruppi di mutuo aiuto), siamo tutti a un tempo forti e deboli, capaci e incapaci, colti e ignoranti, curati e curatori, e perciò possiamo usare tutte le nostre energie positive per aiutarci reciprocamente».
JEROME LISS
L’uomo è un animale sociale: tra le sue caratteristiche precipue vi è quella di costruire molteplici relazioni sociali, a vari livelli. Questo articolo analizza un tipo speciale di interazione di gruppo, parzialmente diversa da quella che mettono in opera alcuni movimenti politici: non si occupa, infatti, dei gruppi di affinità a vocazione politica, ma di quelli di auto/mutuo aiuto. Obiettivo del seguente contributo è di sviscerare gli elementi di peculiarità di tali gruppi, mettendo in luce l’importante ruolo che anch’essi possono assumere nella costruzione di una comunità genuinamente libertaria. ESPERIENZE




Premessa
In genere, sono considerati gruppi primari quelli caratterizzati dal prevalere dell’interazione faccia a faccia, da un’intensa collaborazione e da un profondo senso di appartenenza. I gruppi di affinità ne possono essere considerati un sottotipo. Nel suo libro Dallo stato alla comunità, John Clark aggiorna la concezione dei gruppi di affinità, analizzando la forma che hanno assunto nei
movimenti alternativi degli ultimi decenni. Clark evidenzia gli elementi costitutivi di tali gruppi: l’attivismo basato sull’amicizia, la condivisione di valori, cause, obiettivi e tipo di azione (prevalentemente nonviolenta), la scelta di pratiche egualitarie, autonome e partecipative. In questo modo, il gruppo tende a oscillare tra una presenza temporanea legata al sostegno di una campagna promossa dai movimenti, al consolidamento di strutture che tendono a prefigurare «il mondo nuovo» a partire da «un sistema auto-organizzato per la costruzione di relazioni sociali alternative» (Dupuis-Déri in Clark 2023: 60).
Mentre i gruppi di affinità sviluppati nei movimenti alternativi rivolgono la loro azione verso la trasformazione radicale della società, cercando di operare in modo coerente con i propri fini, un altro tipo di gruppi di affinità, definiti di auto/
mutuo aiuto, partono dal sostegno reciproco tra pari per realizzare la trasformazione della persona, magari passando per «la costruzione di relazioni sociali alternative» e, a volte, arrivando a collegare il gruppo in un contesto di comunità in trasformazione; in ogni caso, il gruppo deve fare i conti con la sua dimensione



di microsocietà in evoluzione, non può operare come situazione laboratoriale avulsa dal contesto sociale.
I gruppi di auto/mutuo aiuto nascono, quasi un secolo fa, dalla convinzione che un gruppo di persone che condivide problemi o condizioni ha la capacità di sviluppare dinamiche di mutuo sostegno, finalizzate a fronteggiare problemi personali. Nel fare questo, il gruppo si trova ad affrontare dinamiche relazionali e valoriali che vanno oltre l’autorealizzazione individuale. Si può ipotizzare che siano questi aspetti che portano a intrecciare naturalmente la storia dei gruppi di affinità con quella dei gruppi di mutuo aiuto; la riflessione sulle pratiche di quest’ultimo ambito può aiutare la crescita dei primi.
La condivisione delle informazioni e delle esperienze, la libertà di espressione anche dei propri tabù personali, l’elaborazione partecipata di regole e processi organizzativi, il progredire del senso di interdipendenza dei partecipanti rispetto allo scopo scelto insieme, il sostegno emotivo reciproco che nasce a prescindere dalle diversità, l’attivazione dei processi di reciprocità in modo cooperativo, la creazione di un clima emotivo favorevole alla sperimentazione delle alternative di vita, l’energia potenziata dal sentire la forza e la solidarietà del gruppo, tutto ciò favorisce la formazione di nuovi modi di comunicare, interagire e guardare alla realtà sociale (Steinberg 2002: 37-52).





L’esperienza nel mondo della scuola
Fornito un quadro sommario delle relazioni tra gruppi primari, di affinità e di auto-aiuto, è ora di volgere l’attenzione verso alcuni casi studio di gruppi di mutuo aiuto, formatisi in ambito scolastico.
L’esperienza del gruppo di mutuo aiuto nella scuola di cui anzitutto intendo parlare nasce in un istituto superiore di Mantova circa venti anni fa. Con l’aiuto dei facilitatori dell’associazione per il benessere mentale Oltre la Siepe si decise di suddividere gli studenti in tre gruppi, per affrontare la difficile situazione di una classe multiproblematica. Due facilitatori dell’associazione introdussero le regole del mutuo aiuto negli incontri settimanali. L’elemento che smosse subito la situazione fu la condivisione delle informazioni sulle difficoltà presenti. L’attenzione dimostrata dai facilitatori contribuì poi a creare quel clima di fiducia necessario all’assunzione di responsabilità nella gestione dei problemi della classe.
Qualche mese dopo il progetto fu esteso ai genitori degli alunni certificati, che cominciarono a ritrovarsi periodicamente per condividere informazioni ed esperienze nell’affrontare i problemi comuni. Si creò subito un clima di fiducia che favoriva progressivamente la libertà di espressione su temi che fino a quel momento erano rimasti un tabù familiare.
All’inizio di ogni percorso si discutevano spazi, orari, regole e scopi degli incontri. A turno veniva scritto un diario libero, che andava a formare una storia di senso del gruppo. Un genitore espresse così il suo stato d’animo: «Noi genitori di figli con difficoltà siamo soli, il poter esprimere le proprie emozioni e le proprie paure a persone che sai che ti capiranno profondamente è già un sollievo». Un altro genitore sottolineò il legame solidale di interdipendenza con gli altri: «Abbiamo formato un gruppo di famiglie per passare momenti insieme e fare in modo che i nostri figli si trovino fuori dalla scuola per fare una vita sociale più aperta».




Qui va fatta una prima riflessione sulle iniziative promosse grazie al gruppo ma fuori dal gruppo. Non basta considerarle una ricaduta positiva: questi genitori che si organizzano per facilitare la gestione del tempo libero ai figli che si sono conosciuti in occasione degli eventi conviviali del gruppo dimostrano di aver colto il senso di tutte le attività proposte in un progetto che tende a favorire la formazione di un sistema sociale complesso autodeterminato.
Intanto a scuola riuscimmo, sia pure temporaneamente, a proiettare l’aspetto orizzontale del gruppo all’interno del progetto del doposcuola, dove gli alunni si organizzarono in piccoli gruppi per aiutarsi nello studio. Provvedemmo anche alla formazione di un gruppo misto (costituito da docenti empatici e studenti che avevano sperimentato i gruppi mutualisti in classe) di ascolto, che gestì uno sportello di incontro con gli studenti per un anno scolastico.
Dopo alcuni anni di sperimentazione, si sentì la necessità di costruire un percorso formativo a livello di gruppo classe a partire dal biennio, con la finalità di sviluppare quelle abilità sociali che sono utili nella gestione delle dinamiche relazionali che ogni gruppo primario si trova ad affrontare: la costruzione di identità plurali, la comunicazione empatica, la soluzione dei problemi, la gestione dei conflitti (anche con l’insegnante), ecc. Nel suo scritto Conflitti, riconoscimenti, mediazioni, Andrea Canevaro specificò:
«Gli elementi da cui può nascere l’auto-aiuto sono propri del gruppo o di singoli alunni che fanno parte del gruppo. L’insegnante, che del gruppo fa parte e nello stesso tempo è osservatore privilegiato, ha la possibilità di valorizzare e dare forza alla dinamica dell’auto-aiuto» (Canevaro 2007: 8).
Questo percorso venne prima proposto all’interno degli istituti superiori, poi, con qualche adattamento, anche nelle scuole medie.




Col tempo emersero tendenze che cambiarono radicalmente le dinamiche dei gruppi degli adulti. Nel gruppo dei genitori partecipavano anche insegnanti e ciò arricchiva gli incontri, perché consentiva di vedere i problemi sotto un duplice aspetto e promuoveva una nuova modalità di comunicazione tra scuola e famiglia, che andava oltre la discussione sull’andamento scolastico degli alunni. In pratica, arrivammo ad adottare la modalità proposta dal pedagogista Riziero Zucchi, quella del gruppo di narrazione composto da genitori e docenti. Durante questa lunga esperienza, abbiamo sperimentato anche la rotazione del ruolo del facilitatore
fra i partecipanti del gruppo. Un’altra riflessione riguarda proprio il rischio di identificarsi con il facilitatore «abilitato», creando una situazione di appartenenza precaria. In Germania, dove questi gruppi sono molto numerosi, il facilitatore segue il gruppo solo per alcuni mesi, poi questo si autogestisce. In Italia, fu la rivista «Animazione Sociale» ad affrontare per la prima volta questo problema, in un articolo scritto nel 2009 da Leopoldo Grosso. In un numero monografico, si parla esplicitamente di
«licenziamento del conduttore». Si tratta di un atto simbolico che caratterizza la fase «dell’appropriazione dell’identità di gruppo, con un crescente bisogno di autogestione globale», di una proiezione esterna che finisce talora col portare alla formazione di un’associazione capace di promuovere servizi ed attività per i propri associati (Grosso 2009: 117). Anche Dominique Steinberg afferma che «un gruppo maturo dovrebbe essere in grado di farsi carico in modo quasi autonomo della propria gestione, e quindi funzionare come sistema i gruppi di auto/mutuo aiuto» (Steinberg 2002: 86). In altre situazioni, si trova un equilibrio funzionale fra appartenenza all’associazione ombrello dei gruppi di mutuo aiuto e appartenenza all’associazione di settore del gruppo specifico.




Va infine aggiunta una variante che rappresenta un’evoluzione delle buone pratiche mutualiste, l’esperienza dei gruppi dialogici di origine finlandese. Tale esperienza ha coinvolto la psichiatria e la scuola e non nasce a caso. Anche nella recente storia italiana, noti psichiatri come Eugenio Borgna hanno rilevato che raggiungevano il massimo della loro efficacia quando si ponevano al livello del paziente: «Non c’è dialogo possibile
in psichiatria se non quando la relazione originariamente asimmetrica, fra chi cura e chi è curato a mano a mano si trasforma in relazione la più possibile simmetrica» (Borgna 2017: 54). Inoltre i finlandesi avevano da tempo studiato l’esperienza del pedagogista Carlo Perticari, riportata con le dovute osservazioni nel loro testo base, Metodi dialogici nel lavoro di rete.
Nonostante questi precedenti, in Italia è soprattutto nei servizi psichiatrici che si sperimenta e, talora, si porta a sistema lo strumento del gruppo dialogico. In breve, vi sono C.P.S. (Centri psico sociali), gruppi formati da utenti, familiari, volontari, operatori e dirigenti psichiatrici che si trovano periodicamente per progettare attività di riabilitazione e di emancipazione e dove tutti partecipano alla pari.
Ho avuto l’occasione di seguire un sottogruppo formato da giovani utenti che si sono organizzati in modo autonomo per promuovere iniziative di prevenzione del disagio psichico nella scuola, in concreto per aiutare i coetanei ad affrontare situazioni che loro avevano già vissuto. In questi ultimi anni, in cui nella scuola sono aumentati i casi di disagio psichico (disturbi alimentari, atti di autolesionismo, ecc.) anche a causa del lockdown introdotto nel periodo del covid, il mutualismo sembra assumere una dimensione resistenziale umanitaria tale da garantire la difesa del gruppo come la sua evoluzione comunitaria.




Empowerment e comunità
Per alcuni teorici, la gestione dei gruppi di mutuo aiuto non è che una competenza aggiuntiva degli operatori sociali. Questo atteggiamento riflette una cultura socio-sanitaria, che vede nel mutuo aiuto una tecnica complementare della cura e una funzione subalterna al sistema sanitario. Sempre Leopoldo Grosso ricorda che il gruppo di mutuo aiuto «è immerso nella comunità locale, ne diventa un punto rete, crea collegamenti, interazioni, coinvolgimenti» e fa parte di una possibilità di riappropriazione di «un ruolo che consiste nella capacità di ognuno di aiutare gli altri», «ruolo che è stato delegato, espropriato dallo stato di benessere» (Grosso 2009: 122).
Rispetto a questa visione, si configurano dinamiche alternative del mutuo aiuto a partire da quello dell’empowerment che oscilla dalla dimensione individuale, a quella gruppale e a quella comunitaria. Secondo la psicologa sociale Matrizia Montero, l’empowerment (fortalecimiento) è «un processo attraverso il quale individui, gruppi o comunità sviluppano capacità e risorse per controllare la propria situazione di vita […] per arrivare alla trasformazione del proprio contesto in base alle proprie necessità e aspirazioni, trasformando al contempo se stessi» (Converso, Hindrichs 2009: 91).
Questo approccio supera la visione subordinata e individualista di certi operatori del mutuo aiuto per sviluppare una prospettiva collettiva che collega l’emancipazione del gruppo a quella della comunità, affrontando la problematica del trasferimento dei valori e delle pratiche del mutuo aiuto a un livello sociale più ampio.
Concludendo, nei movimenti sociali si va configurando un nuovo paradigma, per il quale la caratteristica della dinamica orizzontale assume un valore fondante, non solo per un’organizzazione sociale, ma anche per l’ambito della cura, unitamente all’aiuto reciproco, alle pratiche cooperative, all’empowerment e all’empatia.



Stefano Mancuso è riuscito a dare una grande forza a questo messaggio libertario, che diventa visione e proposta di comunità (direbbe John Clark), quando scrive: «in questi modelli organizzativi diffusi, senza centro di comando, come nelle piante, i centri decisionali si diffondono e nascono spontaneamente a livello periferico, cioè lì dove devono essere per risolvere con esattezza i problemi» (Mancuso 2019: 69).



BIBLIOGRAFIA
- E. BORGNA, L’ascolto gentile, Einaudi, Torino, 2017.
- A. CANEVARO, Conflitti, riconoscimenti, mediazioni, in http://www. grusol.it/informazioni/22-08-07.pdf.
- J. CLARK, Dallo stato alla comunità. Il mondo di domani, elèuthera, Milano, 2023.
- D. CONVERSO, I. HINDRICHS, Il potere in gioco nell’empowerment. L’intreccio tra sfera individuale, sociale e politica, in AA.VV., I percorsi dell’auto-aiuto, «Quaderno di Animazione Sociale», Torino, 2009.
- L. GROSSO, Il tragitto sociale dei gruppi di auto-aiuto. Uno spazio per la costruzione di reti significative in AA.VV., I percorsi dell’auto aiuto, cit.
- J. LISS, Insieme per vincere l’infelicità, FrancoAngeli, Milano, 1996.
- S. MANCUSO, La nazione delle piante, GEDI, Roma, 2019.
- B. MIORALI (cur.), Per una civiltà dell’empatia nella scuola, Atti del Convegno, Università Verde Pietro Toesca, Mantova, 2017, pp. 5-20.
- A. MOLETTO, R. ZUCCHI, La metodologia pedagogica dei genitori, Maggioli, Rimini, 2013.
- J. SEIKKULA, T. E. ARNKIL, Metodi dialogici nel lavoro di rete, Erickson, Trento, 2013.
- D. STEINBERG, L’auto/mutuo aiuto, Erickson, Trento, 2002.



43


Medicina di genere: la medicina della differenza
Mariangela Mombelli
La concezione androcentrica della medicina tradizionale ha storicamente considerato la donna una variabile del genere maschile, un «piccolo uomo» da studiare nella sua specificità limitatamente all’apparato riproduttivo. Galeno, medico romano del II secolo d.C. riteneva che gli organi genitali femminili fossero una forma imperfetta, non sviluppata di quelli maschili: il corpo della donna era un corpo sbagliato, venuto male, non degno di studi particolari. Andrea Vesalio, fondatore dell’anatomia moderna, pur essendo tra i primi assertori del superamento dell’antica medicina galenica, continuava ad affermare che «l’organismo maschile e quello femminile non differiscono in alcuna maniera se non nell’apparato riproduttivo». Fino alla fine del 1600 non esisteva nemmeno un termine che definiva la vagina, considerata un «pene introflesso», secondo la descrizione che ne faceva Erofilo, medico del III secolo d.C.
Nella storia della medicina le donne sono sempre state assenti o, se presenti, relegate a ruoli marginali e non facilmente ricostruibili. Sono state mediche senza laurea, infermiere senza qualifiche, assistenti naturali e spontanee. Non avevano un ruolo ufficiale, né una formazione accreditata. È una questione di potere. L’esercizio della medicina infatti attribuisce al medico il potere di curare,




esercitato per il bene del malato. Lo dice bene Rodrigo De Castro, medico del diciassettesimo secolo, nel suo trattato Medicus politicus quando afferma che come il sovrano governa lo Stato e Dio governa il mondo, il medico governa il
corpo umano. Potere, governo e controllo biopolitico sono tre pilastri del patriarcato: non è difficile immaginare quindi perché la scienza medica sia stata un affare solo del genere maschile e abbia confinato le donne alle pratiche della cura, espressione di conoscenze tramandate che richiedevano un approccio empirico e non scientifico. Le donne presenti in campo medico andavano oscurate perché, occupando uno spazio professionale di potere che gli uomini avocavano a sé, erano scomode. Non dimentichiamo che molte delle streghe perseguitate in Europa a partire dal XV secolo erano levatrici, in linea con una lunga tradizione di pratica medica più empirica che teorica: la caccia alle streghe era quindi anche un tentativo del medico uomo di riappropriarsi del settore dell’ostetricia, spazio prettamente femminile.
L’applicazione della medicina di genere è recentissima. Nel 1991 la cardiologa americana Bernardine Healy, direttrice del National Institute of Health americano pubblicò sull’importante rivista scientifica «New England Journal of Medicine » un articolo in cui metteva in evidenza le differenze nella cura di uomini e donne con le stesse malattie cardiovascolari. L’errata convinzione che fossero patologie tipicamente maschili portava infatti a ritardi nelle diagnosi e nella cura delle donne, spesso sottoposte a terapie inappropriate. Da quel momento a livello mondiale è cominciato un graduale e lento riconoscimento del genere come uno dei determinanti di salute. In Italia l’approvazione della Legge 3 del 2018 ha definitivamente inserito il concetto di genere nel Servizio Sanitario Nazionale.
Sesso e genere non sono sinonimi. Con il termine sesso ci si riferisce alle caratteristiche fisiche e biologiche dell’individuo che includono le concentrazioni ormonali, gli apparati riproduttivi, le espressioni dei geni e i loro effetti e le diverse conformazio-




ni fisiche, ad esempio la più alta percentuale di grasso corporeo nelle donne. Il genere invece è associato al comportamento, allo stile di vita e all’esperienza. È un costrutto sociale, cioè qualcosa che è prodotto dalla società e non inerente al nostro corpo. La società è culturalmente fondata sul binarismo di genere, ovvero sulla rigida distinzione tra maschile e femminile, da cui vengono fatte derivare aspettative altrettanto rigide sui comportamenti, gli atteggiamenti, l’aspetto e i ruoli. Una persona che ha un’identità di genere in linea con il sesso biologico è definita cisgender. Transgender è invece chi presenta un’identità di genere diversa dal sesso biologico. Alcune persone transgender decidono di intervenire sulla loro incongruenza di genere, ovvero sul loro corpo, per renderlo più simile a come si sentono, attraverso trattamenti ormonali e/o chirurgici.
La medicina genere-specifica nasce dalla constatazione che le differenze tra uomini e donne in termini di salute sono legate non solo ai caratteri biologici e alla funzione riproduttiva, ma anche a fattori ambientali, sociali, culturali e relazionali. È una dimensione trasversale del sapere medico che adotta criteri di valutazione scientifica a partire dall’influenza del sesso e del genere sulla fisiopatologia umana e sulla sintomatologia clinica. Le malattie non si manifestano allo stesso modo nelle femmine e nei maschi. Torniamo alle patologie cardiovascolari che hanno fornito lo spunto per iniziare a parlare di medicina di genere. In Italia per le malattie del sistema cardiocircolatorio muoiono più le donne che gli uomini. Tranne nel periodo della vita in cui la donna è fertile, che vede gli uomini di pari età essere più colpiti, dopo la menopausa, al venir meno della protezione data dagli estrogeni, la frequenza di queste patologie nelle donne va progressivamente aumentando fino a superare l’uomo dopo i 75 anni. Allo stesso modo esistono malattie ritenute tipicamente femminili, come l’osteoporosi, che spesso negli uomini non sono considerate pur rappresentando anche per essi minacce alla salute soprattutto in età avanzata. Anche la depressione sembra essere meno frequente negli uomini rispetto alle donne. Ma i dati




non tengono conto del fatto che il maschio ricorre con più difficoltà all’assistenza sanitaria in questo settore e che l’accertamento della malattia psichiatrica negli uomini è più complessa perché realizzata su linee guida che si basano solo sui disturbi manifestati dal genere femminile. La recente pandemia da SARS-CoV-2 ci ha fornito elementi per comprendere quanto le differenze biologiche legate al sesso e quelle socio-culturali legate al genere abbiano ricadute sulla salute delle persone. L’infezione da Covid-19 ha infatti manifestato un’ampia suscettibilità alla dimensione del genere, che ha riguardato tra l’altro la prevalenza e la severità della malattia e la mortalità. I dati disaggregati per sesso di cui si dispone hanno indicato infatti che, rispetto agli uomini, le donne hanno presentato meno complicanze e mortalità. Ciò è dovuto al fatto che le cellule del sistema immunitario delle donne hanno la capacità, grazie agli estrogeni, di attivare risposte più pronte, efficaci e durature rispetto a quelle degli uomini, rendendole più resistenti alle infezioni. Il risvolto negativo è che questo le rende più suscettibili all’insorgenza di patologie mediate dal sistema immunitario, le cosiddette malattie autoimmuni. Ma le donne, anche se meno colpite in termini di morbilità, sono coloro che hanno subito maggiormente l’impatto sociale, economico e di violenza della pandemia con un rischio circa doppio di sviluppare o di aggravare sindromi patologiche a lungo termine. Anche la ricerca sui farmaci e sui dispositivi medici risente della concezione androcentrica della medicina. Questi ultimi ad esempio sono studiati prevalentemente sull’uomo: lo sono le mascherine che abbiamo portato durante la pandemia, che hanno un impatto maggiore sulla cute delle donne, e che sono state da loro indossate molto più che dagli uomini (pensiamo soltanto al personale impiegato nelle strutture sanitarie); lo erano i primi modelli di cuore artificiale usati per le persone in attesa di trapianto, troppo grandi per il torace della maggior parte delle donne; lo sono i pacemaker necessari per «sincronizzare» il cuore e risolvere lo scompenso cardiaco, più utilizzati negli uomini che nelle donne, pur traendone queste ultime maggior beneficio.




Ormoni e genetica giocano un ruolo importante anche nel meccanismo di azione dei medicinali. Solo dopo il 1993, su richiesta della Food and Drug Administration, gli studi clinici sui farmaci hanno cominciato a includere le donne. Il problema però non è solo quello di dare rappresentanza al genere femminile, ma di definire specifiche analisi di genere, gestendo separatamente i parametri di efficacia e sicurezza sui due sessi: quando si tratta di analizzare i dati il sesso viene spesso trascurato. Non serve mettere in commercio i farmaci con le confezioni rosa per le femmine e azzurre per i maschi se contengono lo stesso principio atti-
vo nelle medesime quantità: occorre definire dosaggi diversi per i due sessi in modo da garantirne la massima efficacia e la minor tossicità.
Sebbene sesso e genere siano due concetti diversi, sono molto legati tra di loro e spesso è difficile separarne l’interazione. In alcuni casi il sesso influenza la salute modificando il comportamento, che è più associato al genere. Questo accade, ad esempio, quando il testosterone influisce sulla probabilità di svilup
pare comportamenti «maschili» aggressivi portati alla prevaricazione e al dominio. Viceversa, comportamenti ripetuti, come cattive abitudini, scelte alimentari sbagliate, esposizione a stress o inquinamento possono portare a modificazioni epigenetiche, ovvero a quelle modificazioni ereditabili che portano a variazioni dell’espressione dei geni senza però alterare la sequenza del DNA. Sui comportamenti sappiamo che incidono pesantemente le diseguaglianze e gli stereotipi di genere su cui è normata la società: a livello globale sono le donne a essere maggiormente svantaggiate nell’accesso alle cure, a causa delle disuguaglianze di genere e delle discriminazioni sociali verso il genere femminile, con effetti pesanti sulla loro salute.





Non bisogna cadere nell’errore di considerare la medicina di genere come la medicina delle donne. Potremmo invece definirla come la medicina della differenza, un approccio diverso e innovativo alle disuguaglianze di salute, a partire dall’insorgenza e dall’evoluzione delle malattie, dovute all’appropriatezza della diagnosi e della cura, ma anche alle disuguaglianze sociali, culturali, etniche, psicologiche, economiche e politiche che determinano il vissuto delle persone.



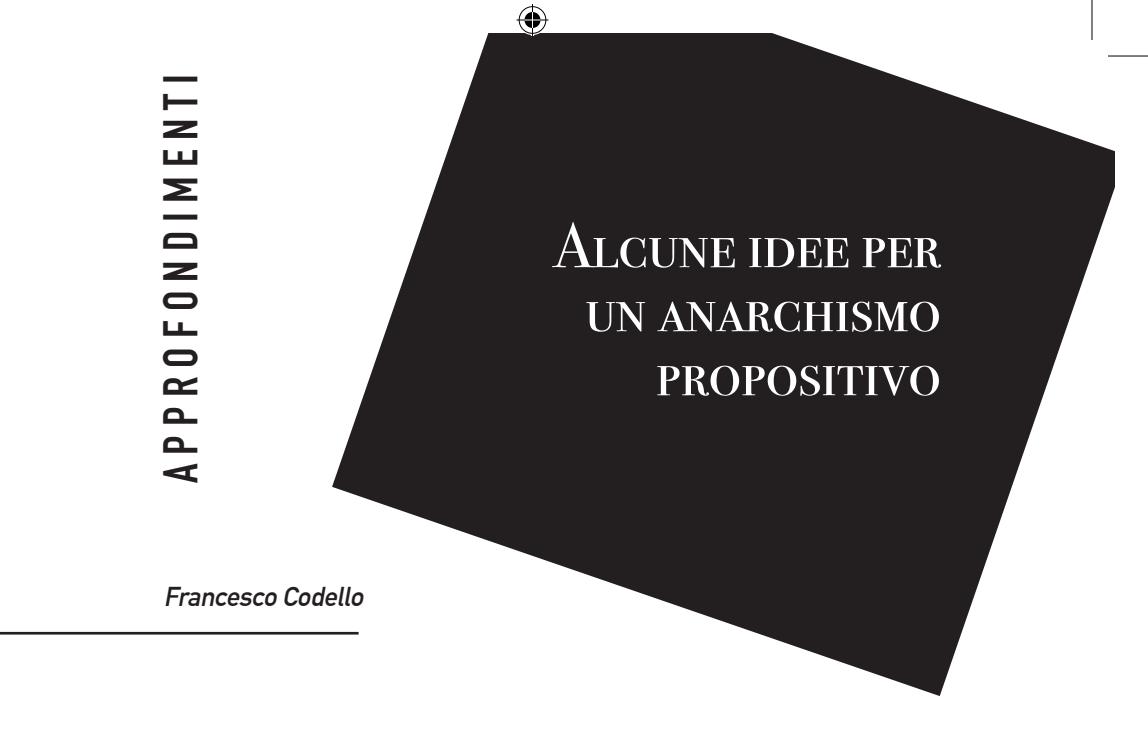
«L’anarchia non è cosa del futuro ma del presente; non è fatta di rivendicazioni ma di vita»
Gustav Landauer
Nelle rivista «Pagine Libertarie» (20 novembre 1922) Camillo Berneri scriveva:
«Noi siamo sprovvisti di coscienza politica nel senso che non abbiamo consapevolezza dei problemi attuali e continuiamo a diluire soluzioni acquisite dalla nostra letteratura di propaganda […] L’anarchismo deve conservare quel complesso di principi generici che costituiscono la base del suo pensiero e l’alimento passionale della sua azione, ma deve sapere affrontare il complicato meccanismo della società odierna senza occhiali dottrinari e senza eccessivi attaccamenti all’integrità della sua fede» (Berneri).
Questa riflessione di Berneri è stimolante e arricchente per chi desidera coniugare una visione con una serie di progetti. La visione è il sogno e la cornice di riferimento, i progetti sono le possibili soluzioni concrete e necessariamente sperimentali che




si possono proporre di fronte ai tanti problemi e alle tante criticità del vivere assieme. Pensiero e azione dunque intrinsecamente legati e reciprocamente confrontati. Partendo da questa premessa, appare sempre più evidente come l’anarchismo (o meglio gli anarchismi), storicamente determinatesi, debbano sistematicamente fare i conti con la loro capacità di essere da un lato dentro il corso della storia, seppure per contrastarne un processo di sviluppo del dominio, ma al contempo dall’altro non possono più permettersi, pena la loro insignificanza, di stare al di fuori della storia stessa.
Questa sfida appare sempre più centrale e necessariamente da cogliere, superando una pratica di lotte esclusivamente di resistenza e di denuncia delle varie forme che assume sistematicamente il dominio, per indirizzare la propria azione in lotte e sperimentazioni fatte di proposte concrete e di propositività.
Nel 1961 nelle pagine del settimanale anarchico inglese «Freedom» appare un articolo firmato da Colin Ward dal titolo: Anarchism and Respectability. Scrive Ward:
«Il tema che affronto in questo simposio è “siamo sufficientemente rispettabili?”. E con questa domanda non intendo interrogarmi sul nostro abbigliamento, sulla conformità della nostra vita privata agli standard statistici o sul modo in cui ci guadagniamo da vivere, ma sulla qualità delle nostre idee anarchiche, se esse siano meritevoli di rispetto».
Verificare questa rispettabilità significa chiedersi sistematicamente se le idee di questa grande utopia siano migliori e più utili a risolvere i problemi che uomini e donne si trovano ad affrontare quotidianamente. Se cioè l’anarchismo sia superiore ad altre ideologie autoritarie per determinare una società più libera, più giusta, più rispettosa, più solidale. Ma fin da subito, senza attendere che un’improbabile e comunque non sempre auspicabile rivoluzione possa portarci in un mondo migliore di quello che abbiamo. Conservando uno spirito rivoluzionario possiamo intraprendere qui e ora quel mutamento individuale e sociale in senso libertario a cui tendiamo idealmente.




In altre parole, la domanda qui posta può essere tradotta e sviluppata se c’è la convinzione che, al posto di un anarchismo «apocalittico» mirato al «tutto o niente», abbia ragione di essere un anarchismo pragmatico, teso a dar vita a comunità nuove, qui e ora, utilizzando il pur difficile e contraddittorio materiale presente nella nostra vita quotidiana. Il pensiero anarchico e l’anarchismo come movimento (gli anarchismi) si sono caratterizzati in quanto hanno assunto come fondativa la dimensione della negazione. La loro forza rivoluzionaria si è espressa storica-
mente, nel pensiero dei classici, soprattutto nella dimensione del rifiuto (di ogni forma di dominio). Ma la parte destruens dell’idea anarchica non è, a mio modo di vedere, più in grado (da sola) di cogliere le grandi opportunità e le sfide che la contemporaneità pone alle ideologie otto-novecentesche. Inoltre, è limitativo, e talvolta persino strumentale, risolvere l’originalità e la potenza dell’anarchismo dentro questa dimensione di negazione.
La negazione di ogni forma di dominio resta un tratto essenziale nella definizione dell’idea anarchica, ma vorrei darla come acquisita e consolidata e, soprattutto, sottolinearne la sua attualità in quanto si converte in visione positiva e prefigurativa di una società diversa. Insomma ribadire che oggi, più che mai, c’è l’urgenza di pensare a un anarchismo post-negativo e impiegare tutte le nostre risorse per sviluppare alcune linee risolutive libertarie che invertano la tendenza intrinsecamente autoritaria presente nella società e, allo stesso tempo, evitino le costruzioni ideologiche e astratte di un «totalmente altro». Nell’immediato dopoguerra Herbert Read e Alex Confort, Geoffrey Ostergaard, George Molnar, Paul Goodman, Martin Buber, George Woodcock, Murray Bookchin, Colin Ward, Gaston Leval e le riviste «Politics» di Dwight Macdonald, «Anarchy» di Ward, «Volontà» di Giovanna Berneri e Cesare Zaccaria, assieme ad altri contri-



buti, hanno cercato di indicare una via diversa rispetto a quella più tradizionale, con lo scopo di aggiornare non solo il pensiero ma, soprattutto, l’azione degli anarchici e delle anarchiche. Potremmo riassumere nel modo seguente le caratteristiche fondamentali di questo percorso libertario di questi anni:
- Scetticismo nei confronti della concezione insurrezionalista: critica alla sua realizzabilità e convinzione che un cambiamento genuino e profondo deve scaturire da un cambiamento della personalità individuale e delle relazioni sociali; a)
- «La libertà deve essere conquistata un centimetro alla volta ed è necessario rimuovere le catene che ci siamo auto-imposti prima che si possa agire come esseri umani responsabili» (Ostergaard); b)
- «Lo Stato non è qualcosa che può essere distrutto da una rivoluzione, è una condizione, una relazione tra gli esseri umani, un modo del comportamento umano; lo distruggiamo contraendo nuove relazioni, comportandoci in modo diverso» (Landauer); c)
- «Una società libera non può essere realizzata sostituendo un ordine nuovo a quello vecchio, ma piuttosto con l’ampliamento delle sfere di azione libere, fino a che esse vengano a costituire il fondamento dell’intera vita sociale» (Goodman); d)
- «Mentre il gradualismo marxista e socialista cerca di operare attraverso lo Stato estendendo le attività statali fino a che lo Stato inghiotte l’intera vita sociale, per il gradualismo libertario si tratta, qui e ora, di contrarre relazioni diverse da quelle statali, relazioni basate sul self-help cooperativo e sul mutuo appoggio» (Ostergaard); e)
- Differenza fondamentale tra pubblico e statale e privato; f)
- Ciò che dovrebbe preoccupare e impegnare gli anarchici sono i «cambiamenti sociali attraverso cui le persone possono allargare la propria autonomia e ridurre la soggezione all’autorità esterna» (Ward); g)




- Agire con spirito rivoluzionario in una situazione data (Read); h)
- Scetticismo per l’idea stessa di società anarchica. Molnar la chiama «teorema dell’impossibilità». Non è verosimile (o poco) che l’anarchia possa ottenere il consenso universale a meno che non venga usata la forza per imporla. Ma, Malatesta dixit, l’anarchia non si fa per forza. Ward scrive: «Ogni società umana, a eccezione delle utopie o anti-utopie più totalitarie, è una società pluralistica con vaste aree che non si conformano ai valori ufficialmente imposti o dichiarati»; i)
- Non basta neanche la risposta esclusivamente individuale e di protesta permanente, bisogna cambiare le strutture sociali e le relazioni comunitarie. Infatti, scrive Ward: «se l’idea di una società libera può essere un’astrazione, quella di una società più libera non lo è». L’idea di una società anarchica non va intesa tanto «come scopo da realizzare ma come scala graduata, unità di misura, mezzo attraverso cui valutare la realtà». L’anarchia viene in questo modo vista come un criterio normativo; cioè il criterio etico chiave per giudicare i meriti delle varie società sta nella misura in cui sono anarchiche; j)
- Distinzione tra principio sociale e principio politico: Martin Buber scrive: «Il governo tende ad appropriarsi di più potere di quanto sia necessario in una data situazione […] La misura di questo eccesso rappresenta l’esatta differenza tra amministrazione e governo […] Surplus politico […] il principio politico è sempre più forte rispetto al principio sociale richiesto da una certa situazione. Il risultato è una continua diminuzione della spontaneità sociale»; k)
- L’anarchia intesa come forma di rapporti sociali è già presente nella società: «l’anarchia lungi dall’essere la rappresentazione teorica di una società futura è la descrizione di un modo di organizzazione umana, radicato nell’esperienza della vita quotidiana, che opera a fianco delle tendenze aul)



toritarie dominanti, e a dispetto di esse le alternative anarchiche sono già presenti negli interstizi della struttura del potere dominante. Se vogliamo costruire una società libera, parti di essa sono già disponibili». Le caratteristiche fondamentali comuni a molte esperienze concrete che vanno in questa direzione sono: un forte riferimento all’azione diretta individuale (agenti e non consumatori di un bene prodotto per loro), riferimento significativo a relazioni mutualistiche e di mutuo appoggio: l’anarchia così intesa è una sorta di «auto-determinazione sociale» che può trovarsi spesso in contrasto sia con la burocrazia dello Stato che con le ingiustizie del liberismo economico.
- L’anarchia serve a risolvere problemi: cercare soluzioni anarchiche invece che indugiare sulla retorica della rivoluzione; m)
- Il fallimento degli anarchici, secondo Woodcock, è dovuto «alla scarsa propensione a fare proposte specifiche che possano condurre alla loro vaga e fumosa visione di una società idilliaca», le masse hanno preferito seguire chi poteva offrire soluzioni concrete a problemi concreti; n)
- Gaston Leval critica l’idea che l’anarchismo debba essere definito unicamente per ciò cui si oppone: «un movimento sociale non può vivere sulla negazione». L’anarchismo deve offrire un programma costruttivo e a tal fine «dobbiamo acquisire capacità e background per convincere coloro che intendiamo influenzare che hanno a che fare con uomini capaci, seri e responsabili, non semplici agitatori o dilettanti della rivoluzione»; o)
- L’anarchia è un tipo di rapporti sociali caratterizzati dall’azione cooperativa egualitaria di individui che si auto-definiscono come tali. Se la sfera della mutualità autogestita si espande ricoprendo l’intera vita sociale, allora senza dubbio avremmo una società senza Stato. Ma anche se non viviamo in una società senza Stato, possiamo avere a disposizione una quantità maggiore o minore di mutualità, e quindi di anarchia. p)




Penso che dovremmo portare l’anarchia nel tempo presente invece che rimandarla completamente a una futura ipotetica società senza Stato. I movimenti internazionali di contestazione di questi ultimi vent’anni, il contributo di pensatori come David Graeber, James Scott, John Clark, Amedeo Bertolo, Nico Berti, Eduardo Colombo, Matthew Wilson,
Tomàs Ibañez, pur nelle loro differenze di sensibilità e di approccio, e altri assieme a loro, ci stimolano a indagare ulteriormente questa prospettiva innovativa, mettendo in risalto anche le contraddizioni e le difficoltà che un’idea libertaria aperta inevitabilmente deve affrontare.
Il ruolo concreto dell’anarchico, secondo questa concezione, non è la realizzazione di questo sogno irraggiungibile, ma spingere la disordinata complessità della società in una direzione più anarchica. Il modo migliore per promuovere questa causa è verificare in concreto come l’anarchia, intesa come mutualità autogestita, possa contribuire a risolvere specifiche esigenze sociali. Accrescere cioè il più possibile il tasso di anarchismo nel mondo in cui viviamo.
«Il compito dell’anarchico, tuttavia, non è quello di sognare la società futura, ma piuttosto quello di agire nel modo più anarchico possibile all’interno della società attuale, di evitare per quanto possibile le situazioni in cui è comandato o è costretto a comandare e di sforzarsi di promuovere relazioni di cooperazione reciproca e volontaria tra i suoi simili. Nel mondo moderno, lo Stato è la manifestazione più importante del principio di coercizione. Per raggiungere l’anarchia, quindi, si deve rinunciare allo Stato; e lo si farà nella misura in cui gli uomini diventeranno capaci di vivere senza di esso» (Ostergaard).




Infine vorrei sottolineare un altro passaggio per me indispensabile che va affrontato in un’ottica di prospettiva propositiva. Mi riferisco alle caratteristiche che definiscono una società ideale secondo una visione libertaria. Troppo spesso anche gli anarchismi hanno immaginato un modello di società alternativa delineandone delle peculiarità mono qualificate sia in ambito economico, che sociale, che politico. In questo caso le idee anarchiche si sono allineate a una tradizione utopica e uniformate, dal punto di vista strutturale, a quelle di altre ideologie alternative a quella liberale. Appare invece urgente liberare anche il nostro immaginario da una concezione così rigida e chiusa di un mondo «altro» a favore di una visione plurale e diversificata, sperimentale e aperta anche nel nostro modo di pensare i contorni di un possibile mondo diverso. Per dirla ancora con Colin Ward:
«L’alternativa anarchica è quella che propone la frammentazione e la scissione al posto della fusione, la diversità al posto dell’unità, propone insomma una massa di società e non una società di massa».
Queste sono solo alcune considerazioni, espresse schematicamente, che speriamo possano stimolare una riflessione e, soprattutto, un’azione più idonea alle sfide del XXI secolo e non hanno niente di irreversibile e di dogmatico.




Per un iniziale approfondimento
C. BERNERI, Anarchia e società aperta, a cura di P. Adamo, M&B Publishing, Milano, 2001.
M. BUBER, Sentieri in utopia, Marietti, Genova-Milano, 2009.
M. BUBER, Communauté, Éditions de l’éclat, Paris, 2018.
J.P. CLARK, Dallo Stato alla comunità. Il mondo di domani, elèuthera, Milano, 2023.
F. CODELLO, Gli anarchismi, La Baronata, Lugano, 2009.
F. CODELLO, La condizione umana nel pensiero libertario, elèuthera, Milano, 2017.
P. GOODMAN, Individuo e comunità, a cura di P. Adamo, elèuthera, Milano, 2014.
G. LANDAUER, La comunità anarchica, a cura di G. Ragona, elèuthera, Milano, 2023.
C. WARD, Anarchia come organizzazione, elèuthera, Milano, varie edizioni.
C. WARD, L’anarchia, elèuthera, Milano, varie edizioni.
M. WILSON, Discorso sull’autogoverno, elèuthera, Milano, 2022.
I contributi di George Molnar, Geoffrey Ostergaard, Herbert Read, Alex Confort, George Woodcook, Gaston Leval sono reperibili nelle riviste «Politics», «Anarchy», «Volontà», online in The Anarchist Library. Gli altri testi degli autori citati sono facilmente individuabili nel catalogo delle edizioni elèuthera. Alcuni articoli di Colin Ward sono contenuti nel dossier di «A Rivista anarchica» (Estate 2020, n. 445) da me curato.




L’ennesimo esperimento del «laboratorio Argentina»: l’anarco-capitalismo di Javier Milei
Dal 10 dicembre scorso la Repubblica Argentina ha un nuovo Presidente. Si tratta di Javier Milei, che prima di diventare Deputato del Congresso nel 2021, era noto al pubblico argentino come polemista televisivo e radiofonico su temi di politica ed economia. Tanto sui media quanto nella sua recente carriera politica, Milei ha sempre ostentato la predilezione per teorie libertarie estreme, così da essere avvicinato da più di un osservatore alla dottrina anarco-capitalista.
In questo contributo sono definiti il quadro di riferimento ideologico e i principali elementi di questa filosofia politica (Sezione 1), invero poco nota, ed è proposta un’interpretazione dei motivi di instabilità economica dell’Argentina che hanno portato l’elettorato a optare per la proposta di Milei (Sezione 2); infine, sono analizzati gli elementi di continuità e di rottura, soprattutto quelli più vicini alla dottrina anarco-capitalistica, riscontrabili nel discorso politico del neo-Presidente (Sezione 3).




1. La teoria anarco-capitalista
Quando all’inizio degli scorsi anni ‘70 il modello del costituzionalismo post-bellico e la sua raffigurazione data dal welfare state entrano in crisi, gli spazi della teoria economica e della dottrina della scienza politica si evolvono alla ricerca di nuovi paradigmi. Se in ambito economico la critica neoclassica di ispirazione liberale si appunta principalmente sulle teorie keynesiane, responsabili di distorcere l’efficienza del mercato e di immolare la razionalità al servizio di obiettivi di redistribuzione non sostenibili nel lungo periodo, la condanna della scienza politica si appunta sulla riproposta dello Stato-Leviatano, il quale reagisce agli ormai diffusi e conclamati esempi di fallimento del governo1 alterando le regole stesse che dovrebbe tutelare, confiscando arbitrariamente i diritti individuali ed esasperando il ricorso all’intervento autoritario, come reso evidente dalla proliferazione diffusa di decreti e dispositivi tesi a rafforzare gli esecutivi (Gozzi 1980).
La letteratura sulle scelte pubbliche si concentra su due categorie di risposta al problema del nuovo Leviatano, entrambe rivolte all’alleggerimento del ruolo dello Stato. La prima soluzione si fonda su un’azione collettiva di negoziazione di un nuovo contratto sociale incentrato sul riconoscimento di valori e diritti comuni. Questo contratto sociale è l’unico bene pubblico necessario al funzionamento della società così rifondata e la sua difesa – che può implicare anche il monopolio della funzione coercitiva – è l’unico ruolo designato per l’apparato governativo (Anderson e Hill 1979). Si tratta di una concezione ben rappresentata dall’impianto teorico dello Stato minimo di Nozick (1973) e dal neo-contrattualismo di Buchanan (1975) e Tullock (1972), ma compatibile anche con interpretazioni à la Rawls


1 In contrapposizione al concetto di «fallimento del mercato», quelle di «fallimento del governo» sono le situazioni in cui le scelte collettive non attuano programmi basati sulle richieste dei cittadini, bensì su interessi corporativi (Buchanan 1975).

(1972) di miglioramento delle condizioni del più svantaggiato. La seconda soluzione invoca, nella sua forma più estrema, l’eliminazione di qualunque azione collettiva, sostituita dallo scambio di diritti privati sul mercato dei servizi, ivi compresi quelli di giustizia e protezione (Anderson e Hill 1979). Nella sua forma sublimata, questa visione è compatibile con l’annullamento dell’azione statale: la produzione di beni pubblici è privatizzata, la fornitura dei servizi essenziali scollegata dal suo finanziamento attraverso la fiscalità e l’impianto legislativo sostituito dalla definizione di una serie di contratti di carattere privatistico. Al contrario del neo-contrattualismo questa dottrina non propone un nuovo modello valoriale, ma si limita alla adozione di una tecnica sociale, ovvero l’economia di mercato, per consentire a ciascun individuo di ottenere i servizi richiesti in un contesto di massima concorrenza, razionalizzando ex-post la scelta soggettiva propria di un libero sinallagma (Gozzi 1980).
I fautori di questa filosofia si definiscono «anarco-capitalisti», a rimarcare i due fuochi della loro ideologia: l’anarchia, intesa come superamento di qualunque forma di Stato, resa effettiva solo dall’affidamento al mercato dei servizi necessari al pieno godimento dei diritti individuali (Holcombe 2005) e il capitalismo, nella interpretazione à la Rand (1989) di «sistema in cui gli uomini possono rapportarsi non come vittime o carnefici, non come padroni o schiavi, ma come liberi protagonisti di scambi volontari per il reciproco beneficio».
Il paradigma anarco-capitalista vede tra i suoi teorici principali: Rothbard (1973), che auspica una società formata non da cittadini guidati dal principio di sovranità popolare, bensì da clienti in rapporto contrattuale di mercato con una serie di fornitori di servizi diversi; Friedman (1973), che rifiuta l’ipotesi di una società esposta al caos, poiché tutti i servizi di sicurezza e l’esercizio della giustizia sarebbero affidati ad agenzie private incaricate di fornire il servizio sì in concorrenza reciproca, ma con modalità di risoluzione non violenta delle dispute; Hoppe (2001), che – recuperando Rothbard – teorizza la liceità di esclusione o di




sospensione dei diritti civili e umani quando in conflitto con il diritto di proprietà, a essi superiore. Block (1976), che sottomette il principio di inalienabilità della persona a quello di efficienza del mercato, tollerando di conseguenza schiavitù contrattuale, tratta degli esseri umani e libero commercio degli organi.
Al di là della letteratura scientifica, è interessante notare come l’anarco-capitalismo sia citato anche in un romanzo di fantascienza, che immagina l’adozione negli Stati Uniti di un sistema ispirato ai suoi principi in reazione all’ennesimo episodio iperinflazionistico2 . Quello che secondo alcuni potrebbe essere il futuro dell’Argentina con Javier Milei.
2. L’eterno groundhog day dell’economia argentina
Alla conclusione del secondo conflitto mondiale, l’Argentina può vantare una delle situazioni economiche più floride al mondo: risparmiata completamente dalle distruzioni belliche, la fornitura di prodotti alimentari ai Paesi belligeranti le ha consentito di accumulare ingenti riserve in moneta estera e oro, un attivo destinato a crescere con l’espansione del commercio internazionale, e una posizione creditoria netta nei confronti di molti Stati, tra i quali la Gran Bretagna.
A partire da questo momento, tuttavia, il Paese rioplatense precipiterà progressivamente in uno stato di disordine caratterizzato dal punto di vista economico dal susseguirsi di episodi di ripudio del debito e di in


2 Si fa riferimento qui a Snow Crash, romanzo del 1992 scritto da Neal Stephenson.

flazione a due quando non a tre zeri e, dal punto di vista politico, dal continuo ritorno del peronismo in alternanza – almeno fino all’inizio degli anni ‘80 – alla presa di potere dei militari.
La figura chiave del dopoguerra è quella di Juan Domingo Perón, che – dismessa l’uniforme di colonnello dell’esercito nel 1945 – fonda un movimento politico a ideologia corporativista ed è eletto Presidente. Perón inaugura una nuova stagione di nazionalismo economico incentrata su espansione dei comparti industriali leggeri e creazione dell’industria di Stato, scelta che risponde all’obiettivo di favorire i ceti lavoratori urbani, solida base del suo potere. Puntando infatti sulla produzione di beni per il mercato interno, Perón tutela i consumi a scapito delle esigenze dell’industrializzazione pesante e utilizza il settore industriale come strumento di assorbimento della disoccupazione e di redistribuzione del reddito dalle classi agrarie esportatrici a quelle operaie urbane. Quello industriale argentino è soprattutto un settore dispensatore di occupazione assistita da parte dello Stato, così inefficiente da dovere la propria sussistenza esclusivamente alla protezione tramite tariffe e sussidi (Gerchunhoff 1989).
Se i risultati di breve periodo di questa politica sono confortanti, con aumento del reddito reale e rapida espansione dei consumi interni, il mancato investimento nella competitività delle produzioni nazionali lascia presto il passo a effetti negativi che si calcificano nell’apparato economico nazionale: inflazione congenita, conseguenza sia delle politiche salariali espansive che del contenimento dei tassi d’interesse, estensione del deficit di bilancio, peggioramento del saldo commerciale con l’estero. Soprattutto, il modello economico di Perón sconta il peccato originale di impoverire la fonte stessa dello sviluppo, vale a dire il settore agricolo esportatore. La politica di calmieramento dei prezzi alimentari e il drenaggio dei capitali dagli esportatori di carne e cereali ai comparti industriali leggeri sacrificano le possibilità di ammodernamento e crescita dell’unico settore competitivo sui mercati internazionali, quello agricolo, per sostenere i salari di settori incapaci di reggere qualunque forma di concorrenza




estera. Dopo appena tre anni, il presunto miracolo economico argentino lascia il campo a una crisi di difficile gestione, combattuta dallo stesso Governo peronista e, dopo il golpe del 1955, dal governo militare con il rilancio del settore agricolo, che però genera improvvisa carenza dei generi alimentari destinati al mercato interno e conseguente aumento indiscriminato dei prezzi al consumo.
Da questo momento, la necessità di reperire risorse da trasferire ai settori industriali, forieri di occupazione e consenso politico, è affrontata di volta in volta con la cessione a privati, spesso compagnie straniere, del patrimonio di Stato, con l’indebitamento sui mercati dei capitali e, quando l’avvenuta dismissione di tutti gli asset appetibili o l’ennesimo default sul debito rendono queste soluzioni impraticabili, con emissione di moneta da parte di una Banca Centrale ancora sotto il controllo governativo.
Ma la più ingombrante eredità lasciata da Perón, con cui dovranno fare i conti i partiti e i governi eletti negli anni successivi, sarà a ben vedere lo stesso peronismo: la proscrizione come partito del primo movimento di massa del Paese, decisa all’indomani del golpe e mantenuta di fatto per quasi trent’anni, avrà infatti la duplice conseguenza di non permettere il consolidamento di un sistema politico pienamente democratico e di introdurre la psicosi della presa di potere peronista per via indiretta o violenta, un timore a cui si risponderà con colpi di mano periodici da parte dell’esercito.




Il ritorno della piena democrazia elettiva all’indomani della psicotica dittatura del Proceso de Reorganización Nacional e della fallimentare avventura militare nelle Falkland, lascia dapprima il Presidente radicale Alfonsín e poi il peronista (di destra) Menem a misurarsi con gravi episodi iperinflazionistici. L’ultimo di questi spinge Menem, eletto con un programma tipicamente peronista di sostegno ai redditi e spesa pubblica, a introdurre una politica economica di rigida osservanza monetarista, affidata al nuovo ministro dell’economia Domingo Cavallo. Questi introduce per legge un cambio fisso Peso-Dollaro 1:1 che impedisce di fatto alla Banca Centrale interventi di politica monetaria, avvia un’ulteriore tornata di grandi privatizzazioni (finalizzata non solo ad alleggerire la spesa pubblica, ma anche e soprattutto a reperire i dollari necessari a difendere il nuovo tasso di cambio) e limita le libertà sindacali.
Inizialmente Menem riesce a interrompere il circolo vizioso spesa pubblica-inflazione e a riconquistare la fiducia degli investitori stranieri, con il susseguirsi di stagioni in cui il Prodotto Interno Lordo cresce stabilmente a tassi annui attorno all'8%, ma nemmeno in questo caso l’andamento si consolida. A partire dal 1995, infatti, riemerge, seppure per canali diversi, il problema strutturale dell’economia argentina post-bellica, ovvero la distorsione delle politiche pubbliche in favore dei settori non esportatori. La liberalizzazione del mercato interno alle merci di importazione e la fissazione di un tasso di cambio che sopravvaluta fortemente la moneta nazionale sottopongono a pressione insostenibile il sistema industriale interno, con incremento esponenziale dei fallimenti di imprese, taglio dell’occupazione pubblica, forte contrazione dell’impiego e, in ultima istanza, dei consumi (Nochteff 1996). A inizio millennio diviene evidente che la difesa del tasso di cambio brucia le riserve della Banca Centrale a un ritmo tale che solo i prestiti da parte del Fondo Monetario Internazionale possono permettere. Ma a fine 2001 il FMI rifiuta l’ennesimo appoggio e l’intero impianto politico ed economico nazionale tracolla.




Dopo un periodo di transizione in cui si susseguono nel giro di due settimane tre Presidenti ad interim, il secondo dei quali dichiara il default unilaterale su un debito di circa 170 miliardi di dollari, la situazione si stabilizza grazie all’ascesa all’interno del partito peronista di una nuova corrente di sinistra, guidata da due politici della provincia meridionale di Santa Cruz. Si tratta dei coniugi Kirchner, Nestor e Cristina Fernández de Kirchner, che monopolizzeranno di fatto i vent’anni successivi della politica nazionale.
La lunga stagione kirchnerista alla guida del Paese, con Nestor Presidente nel 2003 e Cristina a succedergli con due mandati dal 2007 al 2015, per poi tornare con la Presidenza di Alberto Fernández nel 2019, ripercorre l’andamento tipico dell’economia argentina: un primo periodo di forte crescita, sospinta da politiche di ispirazione keynesiana e impulso alle esportazioni (Pozzi e Nigra, 2015), seguita dalla crisi. Quando dopo il 2008 i prezzi internazionali delle derrate agricole calano, la spesa pubblica si sostituisce agli avanzi di bilancia dei pagamenti nel finanziare i consumi interni, riaccendendo inflazione e indebitamento. Indebolito anche da accuse di corruzione e in rotta con gli altri poteri dello Stato, in particolare con la magistratura, il potere peronista lascia il passo all’esperimento liberale di Mauricio Macri, imprenditore con un passato di sostenitore di Menem ed ora alla guida di un nuovo movimento di dichiarata ispirazione di centrodestra dal nome evocativo di Cambiamo (Hernandez 2019; Niedzioiecki e Pribble 2017).
Macri inaugura una serie di politiche di rottura con i predecessori, improntate ai capisaldi delle teorie liberiste: drastica riduzione dei sussidi statali alle famiglie, eliminazione progressiva dei controlli su tassi di cambio e prezzi dei beni alimentari, delle quote a import ed export, liberalizzazione del prezzo dei servizi pubblici, accompagnati dall’impegno a non aumentare l’imposizione fiscale e dalla negoziazione con il FMI internazionale nel 2018 di un nuovo prestito di 57 miliardi di dollari, il più elevato nella storia dell’istituzione. Se la capacità di ral-




lentare l’inflazione e di ridurre il debito pubblico è raggiunta, le misure di austerità imposte si fanno sentire, cosicché alle nuove elezioni presidenziali del 2019 l’elettorato torna a premiare l’opzione peronista.
Il nuovo inquilino della Casa Rosada è Alberto Fernández, ma la figura di spicco del governo è ancora Cristina Kirchner, questa volta nel ruolo di vice-presidente (ABAL MEDINA 2020). Dal punto di vista economico, il nuovo quadriennio peronista vede pochi sussulti e ancora meno successi, con un altro episodio di ristrutturazione del debito nel 2020. Dal punto di vista politico, l’ennesimo ritorno del peronismo e, soprattutto, di una discussa Kirchner, favorisce anche in Argentina il sempre più marcato distacco della società civile e un crescente apprezzamento per il semplicismo populista. In questo clima di profonda avversione per la classe politica e con una crisi economica sempre più grave, emerge da assoluto outsider Javier Milei.
3. Ideologia e prassi di Javier Milei
Assistito da una formazione economica che lo ha portato ai vertici di istituzioni finanziarie e gruppi bancari, oltre che a insegnare in alcuni atenei nazionali, Javier Gerardo Milei conosce nuova fama a partire dal 2015, quando irrompe nel mondo dei media e della carta stampata curando rubriche di economia e critica politica.
La vena polemica e l’avvicinamento – invero piuttosto tardivo – alla scuola austriaca dell’economia lo portano a sviluppare un vero e proprio astio nei confronti della classe politica argentina, astio che sfocia nella fascinazione per le teorie «libertariane ». Il suo esordio politico è in occasione delle consultazioni per il rinnovamento della Camera dei deputati del 2021, quando fonda un nuovo soggetto politico (La Libertad Avanza, LLA) di ispirazione liberal-conservatrice a sostegno della sua elezione alla circoscrizione della Capitale. Nemmeno due anni dopo si presenta come candidato al primo turno delle Presidenziali, im-



bracciando una motosega e promettendo, al grido di «trema la casta», tagli drastici al bilancio dello Stato e ai costi della politica. Primo per preferenze con il 30% dei voti, si conferma al ballottaggio di tre mesi dopo con 10 punti percentuali di vantaggio sul candidato peronista Alberto Massa.
Il Milei Presidente eredita una situazione di grande difficoltà: i dati ufficiali registrano il 40% della popolazione al di sotto della soglia di povertà, l’esistenza di un cambio parallelo Peso-Dollaro pari a 2,75 volte quello ufficiale (giunto nel frattempo a 365 pesos per dollaro), un debito pubblico pari al 90% del PIL e in crescita continua, e un tasso di inflazione presuntiva al 200% che Milei, forte della mancata misurazione ufficiale imposta da alcuni anni dal governo kirchnerista, sostiene essere «proiettata verso il 15.000%».
Un simile scenario macroeconomico si presta all’applicazione di politiche ortodosse, come avvenuto in passato con l’accoppiata Menem-Cavallo e – più di recente – con Macri, divenuto dopo il primo turno alleato parlamentare di Milei3 : taglio della spesa pubblica per ridurre il peso del debito, politiche monetarie restrittive in chiave anti-inflazionistica, liberalizzazione dei mercati in modo da favorire l’eliminazione delle imprese più inefficienti e tutelate dal sostegno pubblico. Milei ha ricevuto una investitura popolare diretta e indiscutibile per agire in questo senso, anche se – complici la sfasatura tra elezioni presidenziali e parlamentari prevista dal sistema argentino, il suo carisma personale e la recentissima vita del suo partito – alla maggioranza dei voti elettorali non corrisponde una maggioranza politica all’interno del Congresso.



3 Dal ritorno della democrazia nel 1983, le politiche economiche di ispirazione liberista sono state fondamentalmente due, attuate dal Governo Menem e dal Governo Macri. È interessante notare che entrambi i personaggi sono in qualche modo rappresentati nella maggioranza di governo: detto dell’appoggio di Macri e della sua coalizione (Juntos por el Cambio, JxC), che esprime quattro ministri all’interno dell’esecutivo, va rimarcata infatti la figura di Martín Alexis Menem, nipote dell’ex-Presidente e figlio del di lui fratello Eduardo, ai tempi senatore di maggioranza, compagno di partito di Milei e Presidente della Camera dei Deputati.

I primi 90 giorni della Presidenza Milei hanno visto il Governo oscillare tra misure volte a blindarne l’azione, segnali di coerenza rispetto alle promesse elettorali, ad esempio il taglio nel numero dei dicasteri e l’eliminazione dei controlli sui prezzi, e politiche in netto contrasto con il messaggio originale, quali l’aumento delle prestazioni sociali, con raddoppio dell’assegno famigliare per figlio e incremento del 50% del contributo statale per l’acquisto di beni alimentari degli indigenti. Nel frattempo, è scattato il primo sciopero popolare contro le misure previste dalla «Legge omnibus» (Megadecreto de Necesidad y Urgencia), destinata a introdurre tagli alla spesa pubblica, privatizzazioni e riduzione del sostegno a costi dei trasporti e alle bollette energetiche delle famiglie, poi ritirato dalla stessa compagine di Governo per evitare il rischio della débâcle parlamentare.
Come rimarca Pablo Gerchunoff, eminente storico dell’economia argentino: «La società è molto volubile(…) fa presto a rivoltarsi: ‘Questo non è quello che mi avevi detto. Mi hai parlato di colpire la casta, di colpire lo Stato e invece colpisci me’. Il cambiamento non è senza costo». Per poi concludere: «D’altro canto, a tutti i Presidenti è stato concesso tempo e questo deve valere anche per Milei»4 .
Se è ancora troppo presto per capire quale sarà la prassi politica effettiva di Milei, è innegabile che il suo discorso politico sia intriso di molti principi propri dell’anarco-capitalismo. Quest’ultimo è senza dubbio alla base dell’enfasi sulla riduzione delle prerogative dello Stato – con taglio dei ministeri e proposta di forte riduzione del personale pubblico – e sull’abbattimento dell’imposizione fiscale. Risponde inoltre a una visione anarco-capitalista l’idea di rinunciare al Ministero per l’Istruzione e affidare la copertura dei costi scolastici a voucher da impiegare in scuole scelte individualmente dalle famiglie, sebbene la logica anarco-capitalista pura esigerebbe la scomparsa del finanziamento pubblico ai voucher stessi.



4 Pablo Gerchunoff, Intervista di Sofía Diamante, «La Nación», 20/12/2023 [Nostra traduzione]

Anche la proposta di dollarizzazione completa dell’economia è un concetto che ben si sposa con la dottrina anarco-capitalista, non tanto per il corollario della eliminazione delle prerogative della Banca Centrale nazionale, ma soprattutto perché risolverebbe la contraddizione – spesso presente nell’opera dei principali teorici anarco-capitalisti – di anelare a un sistema interamente fondato sul mercato, senza tuttavia chiarire a quale agenzia sarebbe affidato il compito di fornire gli strumenti di pagamento necessari alle transazioni. Con il ricorso a una moneta estera, si raggiunge l’obiettivo di terzietà del fornitore rendendo inoltre praticabile l’opportunità, tipicamente anarco-capitalista, di scegliere liberamente tale fornitore sul mercato internazionale delle valute.
Infine, è del tutto in linea con i concetti blockiani e rothbardiani quella che al momento è forse la presa di posizione più «contundente» di Milei, così sopra le righe da fare sospettare che si tratti di una boutade propagandistica: l’idea di avviare in Argentina un mercato legale di organi umani. Segnalata da Milei nel 2022, come opportunità per chiunque non abbia altro da offrire al mercato, la questione è stata ripresa di recente – invero con contorni piuttosto nebulosi – dalla neoministra agli Esteri Diana Mondino. Del tutto in contraddizione con questi principi, invece, il ricorso a un decreto di necessità e urgenza per rafforzare l’azione di governo, espediente segnalato spesso come manifestazione plastica dello Stato-Leviatano, peraltro utilizzato a piene mani da un criticatissimo Menem nel corso della sua Presidenza.
Ciò che resta della cosmogonia di Milei pare fondato sui concetti basilari dell’ultra-destra: la dura presa di posizione verso l’aborto, un anticomunismo di concezione anacronistica, che lo ha portato a inquadrare tra i principali nemici della nazione nientemeno che Jorge Bergoglio, un forte sospetto nei confronti dell’internazionalismo, come dimostrato dall’incipiente opposizione nei confronti del Mercosur e degli altri accordi regionali che vedono coinvolta l’Argentina.



In conclusione, viene da chiedersi se con Milei siamo di fronte a una versione rioplatense di quella tendenza che vede emergere leader populisti in tutto il mondo o se non stiamo invece osservando una proposta del tutto originale. A prescindere dalla capacità di superare i problemi che affliggono qualunque governo di minoranza, al di là della asprezza lessicale e del semplicismo istituzionale del suo discorso politico, elementi che lo avvicinano alla figura classica del leader demagogo, in Milei l’elettorato ha probabilmente riconosciuto qualcosa di marcatamente argentino: la figura guida, il condottiero che comprende in modo intuitivo la situazione e decide con rapidità per il bene della nazione, sfidando gli innumerevoli nemici interni ed esterni. Con Milei siamo di fronte all’ennesimo ritorno del leader che dialoga direttamente con le masse, ma con la novità che, per la prima volta, tale leader non è peronista. In questo senso, risulta illuminante un altro passaggio della già citata intervista a Gechunoff: «In tutti i piani di stabilizzazione, chi patisce di più è la classe media. Questo è più facile da mettere in pratica per un governo peronista, perché la sua base elettorale è popolare. Nel caso di Milei è interessante, perché il suo consenso è trasversale»5 . Resta quindi da capire a chi l’anarco-capitalista Milei, se e quando riuscirà a superare l’opposizione parlamentare, presenterà il conto delle riforme.
Bibliografia
J. M. ABAL MEDINA, Peronism Back in Power in Argentina: Economic Crisis and Political Stability, «Latin American Policy», 11/1 (2020).
T. L. ANDERSON, P. J. HILL, An American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West, «Journal of Libertarian Studies», 3/1 (1979).
W. BLOCK, Defending the Undefendable, Fleet Press, New York, 1976.
J. M. BUCHANAN, The limits of Liberty: between Anarchy and Leviathan, Liberty Fund, 1975.



5 Pablo Gerchunoff, ibidem [Nostra traduzione].

P. GERCHUNOFF, Peronist Economic Policies, 1946-55, in G. DI TELLA,
sm, Open Court, La Salle, 1973.
- R. DORNBUSCH (ed.), The Political Economy of Argentina, 1946-‘83, Palgrave Macmillan, London, 1989.
- G. GOZZI, Verso lo stato-sistema. Tra anarchia e Leviatano, in G. GOZZI (a cura di), Le trasformazioni dello Stato: tendenze del dibattito in Germania e in USA, La Nuova Italia, Firenze, 1980.
- C. HERNANDEZ, IMF flexibility or neoliberal adaptation: A discursive content analysis of Article IV policy biases in Argentina, «Governance» (2019), DOI: 10.1111/gove.12407.
- R. G. HOLCOMBE, Common Property in Anarcho-capitalism, «Journal of Libertarian Studies», 19/2 (2005).
- H. H. HOPPE, Democracy The God That Failed: The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order, Transaction Publishers, New Brunswick, 2001.
- S. NIEDZWIECKI, J. PRIBBLE, Social Policies and Center-Right Governments in Argentina and Chile, «Latin American Politics and Society», 59/3 (2017).
- H. NOCHTEFF, The Argentine Experience: Development or a Succession of Bubbles?, «Cepal», 59 (1996).
- R. NOZICK, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, New York, 1974.
- P. POZZI, F. NIGRA, Argentina a Decade after the Collapse The Causes of the Crisis and Structural Changes, «Latin American perspectives», 42/1 (2015), DOI: 10.1177/0094582X145572472015,
- A. RAND, Introducing Objectivism, in A. RAND, The Voice of Reason: Essays in Objectivist Thought, Penguin, Ontario, 1989.
- J. RAWLS, A Theory of Justice, Harvard University Press, Harvard, 1971.
- M. N. ROTHBARD, For a New Liberty, Macmillan, New York, 1973.
- M. N. ROTHBARD, The Ethics of Liberty, Humanities Press, Atlantic Highlands 1982.
- F. SILVESTRI, L’Argentina da Perón a Cavallo Storia economica dell’Argentina dal 1945 a oggi, CLUEB, Bologna 2005,
- G. TULLOCK (ed.), Explorations in the Theory of Anarchy, Center for the Study of Public Choice, Blacksburg, 1972.




Cronologia minima dal 1945 a oggi
1946 Juan Domingo Perón è eletto Presidente della nazione. Nel corso del secondo mandato presidenziale, Perón dichiara il default sul debito pubblico
1955 Un golpe guidato dal Generale Eduardo Lonardi destituisce Perón, lo esilia e dichiara fuori legge il Partito peronista. Nel 1956 il governo militare dichiara l’impossibilità di pagare il debito in scadenza e il conseguente default
1958 Con l’appoggio esterno di Perón, Arturo Frondizi (UCR) è eletto Presidente. Sarà deposto da un nuovo golpe militare nel 1962
1963 Arturo Illia (UCR) è eletto Presidente, ma un nuovo golpe lo destituisce nel 1966; al suo posto il generale Onganía, che proclama la istituzione della Revolución Argentina
1971 Un avvicendamento interno all’istituzione militare porta alla Presidenza il generale Alejandro Lanusse, che dichiara decaduto il veto al Partito peronista e indice nuove elezioni per marzo 1973
1973 Perón torna in patria e vince le elezioni presidenziali in ticket con sua moglie Isabel, che nel 1974 diviene Presidente a seguito della morte del marito
1976 Dopo due anni in cui l’economia è andata progressivamente peggiorando e la violenza terroristica si è diffusa nel Paese, le forze armate depongono il governo; nuovo Presidente è il Generale Jorge Rafael Videla. Ha inizio il Processo di Riorganizzazione Nazionale, responsabile della sparizione e della soppressione di almeno 30.000 cittadini.
1982 L’Argentina invade le Isole Falkland, nell’Atlantico meridionale; la Gran Bretagna invia una task force e recupera il controllo delle isole in meno di tre mesi. A seguito della sconfitta, la giunta militare avvia una rapida transizione verso un nuovo governo civile liberamente eletto. Le alte spese militari e l’isolamento internazionale spingono il Paese a un nuovo default
1985 A fronte della grave crisi economica il neo-Presidente Raúl Alfonsín (UCR) vara il Plan Austral, con sostituzione della moneta, gravata da forte inflazione e sfiducia
1989 Il candidato peronista Carlos Saúl Menem è eletto Presidente; la crisi economica sempre più drammatica (inflazione al 5.000% e nuovo default) spinge Alfonsín a passare le consegne in anticipo
1990 Nuovo episodio iper-inflazionistico (1.343%), Menem accelera le riforme economiche e chiama al Ministero dell’Economia Domingo Cavallo



1991 Cavallo idea il Piano di Convertibilità, che introduce il cambio fisso 1:1 tra moneta argentina e US$. Altre misure economiche in chiave liberista (privatizzazioni, limitazione delle prerogative sindacali)
1999 Fernando de la Rúa, precedente sindaco di Buenos Aires, vince le elezioni presidenziali a capo di una coalizione di centro-sinistra (UCR e FREPASO)
2001 In una situazione di ristagno economico, Cavallo è richiamato con estesi poteri a capo del Ministero dell’Economia. Il FMI nega nuovi prestiti all’Argentina; per evitare la fuga di capitali, si impongono severi controlli sui prelievi dei depositi (corralito bancario), che scatenano rivolte di piazza; prima Cavallo e poi l’intero governo si dimettono. Il Presidente de la Rúa fugge dalla Casa Rosada in elicottero
2002 In pieno marasma economico e istituzionale, è nominato Presidente dal Parlamento il peronista Adolfo Rodríguez Saá, che dichiara il default unilaterale del debito contratto nei confronti degli investitori privati esteri. Dopo poche settimane, Rodríguez Saá rinuncia, sostituito dal peronista Eduardo Duhalde. La Convertibilità è abbandonata, il nuovo cambio Peso-Dollaro è 4:1
2003 In un primo turno in cui si presentano 17 ticket presidenziali, accedono al ballottaggio Carlos Menem con il 24% dei voti e Néstor Kirchner, appoggiato da Duhalde, con il 22%. Menem – deluso dall’esito del primo turno e dato per sicuro sconfitto dagli ultimi sondaggi – rinuncia. Kirchner è eletto Presidente
2007 Cristina Fernández de Kirchner è eletta 51° Presidente della Repubblica Argentina; il suo mandato è rinnovato nel 2011. Dopo anni di intensa crescita economica, il «nuovo miracolo argentino» si blocca e i conti si deteriorano, fino a un nuovo default «tecnico». L’istituto nazionale di statistica rifiuta, su indicazione della Presidenza, di comunicare alle organizzazioni internazionali i dati ufficiali sullo stato dei conti e degli indicatori macroeconomici, tra cui l’inflazione
2015 Il liberale Mauricio Macri, ex sindaco di Buenos Aires, è eletto Presidente. Riesce a negoziare un prestito di 57 miliardi di dollari dal FMI per evitare il default, ma non a rilanciare l’economia
2019 Il peronista Alberto Fernandez è eletto Presidente in ticket con Cristina Fernández de Kirchner. Nel 2020 torna a dichiarare il default sul debito
2023 Javier Milei vince il ballottaggio contro il candidato Alber-




Tassare i ricchi Uno scambio su capitale, debito e futuro
con David Graeber e Thomas Piketty
Moderatori:
Entrambi sembrate pensare che il sistema economico e finanziario prevalente abbia fatto il suo corso e non possa durare ancora a lungo nella sua forma attuale. Vi chiedo di spiegare perché.
Thomas Piketty: Non sono sicuro che siamo alla vigilia di un collasso del sistema, almeno non da un punto di vista puramente economico. Molto dipende dalle reazioni politiche e dalla capacità delle élite di convincere il resto della popolazione che la situazione attuale è accettabile. Se esiste un efficace apparato di persuasione, non c’è alcun motivo per cui il sistema non debba continuare a esistere così com’è. Non credo che fattori strettamente economici possano precipitare la sua caduta.
Karl Marx pensava che il calo del tasso di profitto avrebbe inevitabilmente portato alla caduta del sistema capitalistico. In un certo senso, sono più pessimista di Marx, perché anche in presenza di un tasso di rendimento del capitale stabile, diciamo intorno al 5% in media, e di una crescita costante, la ricchezza continuerebbe a concentrarsi e il tasso di accumulazione della ricchezza ereditata continuerebbe ad aumentare.


Ma, di per sé, questo non significa che si verificherà un crollo economico. La mia tesi è quindi diversa da quella di Marx e anche da quella di David Graeber. L’esplosione del debito, in particolare di quello americano, è certamente in atto, come abbiamo osservato tutti, ma allo stesso tempo c’è un grande aumento di capitale, un aumento di gran lunga superiore a quello del debito totale. La creazione di ricchezza netta è quindi positiva, perché la crescita del capitale supera anche l’aumento del debito. Non dico che ciò sia necessariamente una buona cosa. Sto dicendo che non esiste una giustificazione puramente economica per sostenere che questo fenomeno comporti il collasso del sistema.
Moderatori:
Comunque continui a dire che il livello di disuguaglianza è diventato intollerabile?
Piketty: Sì. Ma anche in questo caso, l’apparato di persuasione – o di repressione, o una combinazione dei due, a seconda del Paese considerato – può consentire la persistenza della situazione attuale. Un secolo fa, nonostante il suffragio universale, le élite dei Paesi industrializzati riuscirono a impedire qualsiasi imposta progressiva. C’è voluta la Prima Guerra Mondiale per introdurre un’imposta progressiva sul reddito.
David Graeber: Ma l’indebitamento di una persona implica necessariamente l’arricchimento di un’altra, non credi?
Piketty: Questa è una domanda interessante. A proposito, il tuo libro mi è piaciuto molto. L’unica critica che vorrei muovere è che il capitale non può essere ridotto al debito. È vero che un maggiore indebitamento per alcuni, pubblico o privato, è destinato ad aumentare le risorse di altri. Ma non affronti direttamente le possibili differenze tra debito e capitale. Argomenti come se la storia del capitale fosse indistinguibile da quella del debito. Credo che tu abbia ragione nel dire che il debito ha un ruolo storico molto più significativo di quanto si sia ipotizzato, soprattutto se si escludono le favole degli economisti sull’accumulazione del capitale, sul baratto, sull’invenzione del denaro o




sullo scambio monetario. È ammirevole il modo in cui reindirizzi la nostra attenzione sottolineando le relazioni di potere e di dominio che sono alla base delle relazioni di indebitamento. Resta il fatto che il capitale è utile di per sé. Le disuguaglianze a esso associate sono problematiche, ma non il capitale in sé. E oggi c’è molto più capitale che in passato.
Graeber: Non intendo dire che il capitale sia riducibile al debito. Ma l’assoluto contrario è ciò che viene detto a tutti. È nostro compito riempire gli spazi vuoti lasciati da questo resoconto per quanto riguarda la storia del lavoro salariato, del capitalismo industriale e delle prime forme di capitale. Perché dici che le risorse aumentano anche quando aumenta il debito?
Piketty: La ricchezza netta è aumentata, intendendo per «ricchezza» le risorse nella misura in cui possiamo calcolarle. E questo è vero anche quando si tiene conto del debito.
Graeber: Intendi dire che oggi c’è più ricchezza pro capite che in passato?
Piketty: Chiaramente, sì. Prendi in considerazione la casa. Non solo ci sono più abitazioni oggi rispetto a cinquanta o cento anni fa, ma, per anno di produzione, le abitazioni, al netto del debito, sono in aumento. Sulla base del PIL annuale, se si calcola il capitale nazionale (definito come l’insieme delle entrate generate dall’attività economica) e poi l’indebitamento totale di tutti gli attori pubblici e privati del Paese, si vedrà che il primo è aumentato rispetto al secondo in tutti i Paesi ricchi. Questo aumento è un po’ meno spettacolare negli Stati Uniti rispetto all’Europa e al Giappone, ma esiste comunque. Le risorse aumentano molto più velocemente del debito.
Graeber: Tornando alla domanda iniziale, il possibile collasso del sistema, credo che previsioni storiche di questo tipo siano una trappola. Certo è che tutti i sistemi devono finire, ma è molto difficile prevedere quando potrebbe arrivare la fine. I segni di un rallentamento del sistema capitalistico sono visibili. Per quanto riguarda la tecnologia, non abbiamo più la sensazione,




come negli anni ‘60 e ‘70, che stiamo per assistere a grandi innovazioni. In termini di visioni politiche, sembriamo molto lontani dai grandi progetti del dopoguerra, come le Nazioni Unite o l’avvio di un programma spaziale. Le élite statunitensi non riescono ad agire sul cambiamento climatico, anche se questo mette a rischio il nostro ecosistema e la stessa vita umana. Il nostro senso di impotenza deriva dal fatto che per trent’anni gli strumenti di persuasione e coercizione sono stati mobilitati per condurre una guerra ideologica a favore del capitalismo, piuttosto che per creare le condizioni affinché il capitalismo rimanesse vitale. Il neoliberismo pone le considerazioni politiche e ideologiche al di sopra di quelle economiche. Il risultato è stato una campagna di manipolazione delle fantasie, così efficace da far credere a chi ha un lavoro senza prospettive che non ci siano alternative.
È evidente che questa egemonia ideologica ha raggiunto il suo limite. Ciò significa che il sistema è sul punto di collassare? Difficile a dirsi. Ma il capitalismo non è vecchio. Non esiste da sempre. Sembra altrettanto ragionevole immaginare che possa trasformarsi in qualcosa di completamente diverso o immaginare che continuerà necessariamente a esistere fino a quando il sole non esploderà o fino a quando non ci annienterà attraverso una qualche catastrofe ecologica.
Moderatori:
È il capitalismo stesso la causa del problema o può essere riformato?
Piketty: Uno dei punti che più apprezzo del libro di David Graeber è il legame che mostra tra schiavitù e debito pubblico. La forma più estrema di debito – dice – è la schiavitù: gli schiavi appartengono per sempre a qualcun altro e, potenzialmente allo stesso modo, anche i loro bambini. In linea di principio, uno dei grandi progressi della civiltà è stata l’abolizione della schiavitù. Come spiega Graeber, la trasmissione intergenerazionale del debito che la schiavitù incarnava ha trovato una forma moderna nel crescente debito pubblico, che consente di trasferire l’indebitamento di una generazione a quella successiva. È possibile




immaginare un caso estremo di questo tipo, con una quantità infinita di debito pubblico pari non solo a uno, ma a dieci o venti anni di PIL, creando così di fatto quella che è, a tutti gli effetti, una società di schiavi, in cui tutta la produzione e la creazione di ricchezza sono dedicate a ripagare il debito. In questo modo, la grande maggioranza sarebbe schiava di una minoranza, il che implica un ritorno agli inizi della nostra storia.
Attualmente non siamo ancora a questo punto. C’è ancora molto capitale per contrastare il debito. Ma questo modo di vedere le cose ci aiuta a capire la nostra strana situazione, in cui i debitori sono ritenuti colpevoli e siamo continuamente assaliti dall’affermazione che ognuno di noi «possiede» tra i trenta e i quarantamila euro del debito pubblico nazionale.
Ciò in particolare è folle perché – come ho detto – le nostre risorse superano il nostro debito. Gran parte della popolazione possiede individualmente pochissimo capitale, poiché il capitale è altamente concentrato. Fino al diciannovesimo secolo il 90% del capitale accumulato apparteneva al 10% della popolazione. Oggi le cose sono un pochino diverse. Negli Stati Uniti il 73% del capitale appartiene al 10% più ricco della popolazione. Questo grado di concentrazione significa ancora che metà della popolazione non possiede altro che debito. Per questa metà, il debito pubblico pro capite eccede ciò che possiedono. Ma l’altra metà della popolazione possiede più capitale che debito, quindi è un’assurdità scaricare la colpa sulle popolazioni per giustificare le misure di austerità.
Ma per tutto ciò, come scrive Graeber, l’abolizione del debito è la soluzione? Non ho nulla in contrario, ma sono più favorevole a una tassazione progressiva sulla ricchezza ereditata insieme ad aliquote fiscali elevate per le fasce più alte. Perché? La domanda è: cosa succederà in futuro? Cosa facciamo una volta che il debito verrà eliminato? Qual è il piano? L’eliminazione del debito implica il trattamento dell’ultimo creditore, il detentore finale del debito, come parte responsabile. Ma per come funziona in realtà il sistema delle transazioni finanziarie consente agli attori




più importanti di disporre di lettere di credito ben prima che il debito venga condonato. L’ultimo creditore, grazie al sistema di intermediari, potrebbe non essere particolarmente ricco. Quindi cancellare il debito non significa necessariamente che i ricchi perderanno soldi nel processo.
Graeber: Nessuno dice che l’abolizione del debito sia l’unica soluzione. A mio parere, è semplicemente una componente essenziale di un insieme di soluzioni. Non credo che eliminare il debito possa risolvere tutti i nostri problemi. Penso piuttosto a una rottura concettuale. In tutta onestà, credo che l’abolizione massiccia del debito avverrà a prescindere da tutto. Per me il problema principale è come ciò avverrà: apertamente, in virtù di una decisione top-down disegnata per proteggere gli interessi delle istituzioni esistenti, o sotto la pressione di movimenti sociali. La maggior parte dei leader politici ed economici con cui ho parlato riconosce che è necessaria una sorta di abolizione del debito.
Piketty: Questo è precisamente il mio problema: i banchieri concordano con te!
Graeber: Una volta ammesso che la cancellazione del debito avrà luogo, la questione diventa come controllare questo processo e garantire che il suo esito sia come lo desideriamo. La storia offre molti esempi di eliminazione del debito che sono serviti solo a preservare strutture sociali inique.
Ma a volte l’abolizione del debito ha prodotto cambiamenti sociali positivi. Prendi le costituzioni ateniese e romana. All’origine di ognuna di esse c’è stata una crisi del debito risolta in modo tale da portare a una riforma politica strutturale. La repubblica romana e la democrazia ateniese sono nate da una crisi del debito. In effetti, tutti i grandi momenti di trasformazione politica sono stati precipitati da tali crisi. Durante la Rivoluzione americana, l’annullamento del debito da parte della Gran Bretagna era una delle richieste dei rivoluzionari. Ritengo che oggi ci troviamo di fronte a una situazione simile, che richiede inventiva politica.




La cancellazione non è di per sé una soluzione, perché la storia ne registra tanti casi irrimediabilmente regressivi. I ricercatori del «Boston Consulting Group» hanno scritto un paper intitolato Back to Mesopotamia? su questo tema. Essi sviluppano vari modelli per vedere cosa potrebbe accadere in caso di cancellazione massiccia del debito. La loro conclusione è che ne deriverebbero grandi turbolenze economiche, ma che se non si intraprendesse questa strada si creerebbero problemi ancora più gravi. In altre parole, la protezione delle strutture economiche prevalenti richiede la cancellazione del debito. Questo è un tipico caso di richieste reazionarie di annullamento del debito.
Per quanto riguarda il capitalismo, ho difficoltà a immaginare che possa durare più di altri cinquant’anni, soprattutto in considerazione della questione ecologica. Quando al movimento Occupy Wall Street è stato rimproverato di non aver formulato richieste concrete (anche se lo ha fatto), ho suggerito – in modo un po’ provocatorio – che i debiti dovrebbero essere condonati e la giornata lavorativa ridotta a quattro ore. Ciò sarebbe vantaggioso dal punto di vista ecologico e allo stesso tempo risponderebbe ai nostri tempi di lavoro ipertrofici (questo significa che facciamo molti lavori il cui unico scopo è quello di tenere occupate le persone). L’attuale modo di produzione si basa più su principi morali che economici. L’espansione dell’indebitamento, dell’orario di lavoro e della disciplina del lavoro: tutto ciò sembra andare di pari passo. Se il denaro è effettivamente una relazione sociale, fondata sul presupposto che tutti assegnano lo stesso valore alla banconota in loro possesso, non dovremmo pensare a che tipo di presupposti vogliamo abbracciare riguardo alla produttività futura e all’impegno nel lavoro?
Per questo dico che l’abolizione del debito implica una rottura concettuale. Il mio approccio vuole aiutarci a immaginare altre forme di contratto sociale che dovrebbero essere negoziate democraticamente.


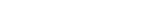

Moderatori:
Leggendo il tuo lavoro, Thomas Piketty, si ha l’impressione che per te l’eliminazione del debito non sia una soluzione «civile». Cosa intendi con ciò?
Piketty: Il fatto è – come ho detto – che gli ultimi creditori non sono necessariamente quelli che dovrebbero pagare. Cosa ne pensi, David, della proposta di imporre una tassa progressiva sulla ricchezza, che mi sembra un modo più civile per arrivare allo stesso risultato? Devo ribadire la mia perplessità sul fatto che i più entusiasti sostenitori dell’abolizione del debito, oltre a te, siano i partigiani degli haircuts, per usare un’espressione gradita al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e alla Bundesbank. Questa proposta si riduce all’idea che i detentori del debito pubblico hanno assunto dei rischi e ora devono pagare. Quindi è sufficiente ridurre il debito greco del 50% o quello cipriota del 60%: non è certo una misura progressista!
Perdonami, ma sono molto sorpreso che tu attribuisca così poca importanza alla questione di quali strumenti dovremmo impiegare, quali istituzioni collettive dovremmo creare, per meglio colpire coloro che vogliamo colpire. Parte del nostro ruolo di intellettuali consiste nel dire quali istituzioni collettive vogliamo costruire. La tassazione fa parte di questo.
Graeber: La tassazione progressiva mi sembra l’epitome dell’era keynesiana e dei meccanismi redistributivi basati su aspettative di crescita che non sembrano più valide. Questo tipo di meccanismo redistributivo si basa sulle proiezioni dell’aumento della produttività, legato all’aumento dei salari, che storicamente ha accompagnato l’applicazione di politiche fiscali redistributive. Ma tali politiche sono attuabili in un contesto di crescita debole? E con quale impatto sociale?
Piketty: Beh, la crescita debole rende questi strumenti fiscali ancora più desiderabili. Non penso solo alle tradizionali imposte sul reddito, ma anche a un’imposta progressiva sulla ricchezza e sul capitale. Le persone possiedono una certa quantità di capitale, al netto dei debiti. Se si impone un’aliquota fiscale pro-



gressiva, per coloro che possiedono molto poco l’aliquota può essere negativa, il che equivale a condonare parte dei loro debiti. Si tratta quindi di una politica ben lontana da quella keynesiana di tassazione del reddito.
Inoltre, un tasso di crescita debole rende ancora più desiderabili sia le imposte sul reddito che quelle sul patrimonio, perché aumenta il divario tra il tasso di rendimento del capitale e il tasso di crescita. Per la maggior parte della storia, il tasso di crescita è stato quasi nullo, mentre il rendimento del capitale si aggirava intorno al 5%. Quindi, quando il tasso di crescita è intorno al 5%, come in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, il divario tra i due tassi è minimo. Ma quando il tasso di crescita è dell'1%, o addirittura negativo, come accade oggi in alcuni Paesi europei, il divario è enorme. Questo non è un problema da un punto di vista meramente economico, ma lo è certamente a livello sociale, perché porta a una grande concentrazione della ricchezza. In risposta a ciò, le imposte progressive sul patrimonio e sulle successioni sono di grande utilità.
Graeber: Ma un’imposta progressiva sul capitale non dovrebbe essere di portata internazionale?
Piketty: Sì, certo. Sono un internazionalista come te. Su questo punto non abbiamo divergenze.
Graeber: Si tratta comunque di una domanda interessante, perché storicamente, ogni volta che inizia un’epoca di credito oneroso, si trova in genere una sorta di strumento generale per proteggere i debitori e dare ai creditori libertà di azione, arrivando persino a favorire attivamente i debitori. Tali meccanismi per limitare il potere dei creditori sui debitori hanno assunto molte forme, tra cui la monarchia basata sul diritto divino in Mesopotamia, la legge biblica del giubileo, il diritto canonico medievale, il buddismo, il confucianesimo e così via. In breve, le società che adottavano tali principi avevano strutture istituzionali o morali progettate per mantenere una qualche forma di controllo sulle pratiche di prestito.




Oggi siamo in un periodo in cui il prestito è decisivo, ma facciamo le cose al contrario. Abbiamo già le istituzioni generali che hanno un carattere quasi religioso, in quanto il neoliberismo può essere visto come una sorta di fede. Ma invece di proteggere i debitori dai creditori, queste istituzioni fanno esattamente il contrario.
Per trent’anni, la combinazione di FMI, Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), istituzioni finanziarie nate a Bretton Woods, banche d’investimento, multinazionali e ONG internazionali ha costituito una burocrazia internazionale di portata globale. E a differenza delle Nazioni Unite, questa burocrazia ha i mezzi per far rispettare le sue decisioni. Dal momento che l’intera struttura è stata esplicitamente creata per difendere gli interessi dei finanzieri e dei creditori, come potrebbe essere politicamente possibile trasformarla in modo tale da farle fare l’esatto contrario di ciò per cui è stata progettata?
Piketty: Posso solo dire che bisognerebbe convincere molte persone! Ma è importante sapere esattamente dove vogliamo andare. Ciò che mi preoccupa qui è il fatto che per le grandi istituzioni di cui parli è molto più naturale di quanto si pensi condonare i debiti. Perché pensi che a loro piaccia così tanto la parola haircuts? La tua prescrizione è intrappolata nell’universo morale del mercato. Il colpevole è la parte che detiene il debito. Il pericolo che vedo è che le istituzioni finanziarie si muovano esattamente nella direzione da te descritta.
Ad esempio, nel caso della crisi cipriota, dopo aver preso in considerazione l’idea di un’imposta (leggermente) progressiva sui beni capitali, il FMI e la Banca Centrale Europea hanno infine optato per gli haircuts, insieme a una flat tax.
Nella Francia del 1945-46, il debito pubblico era enorme. Sono stati usati due strumenti per risolvere il problema. La prima è stata l’alta inflazione, che è il modo principale, storicamente, di liberarsi del debito. Ma questo ha ridotto il valore di chi aveva poco: i poveri anziani, ad esempio, che hanno perso tutto. Di conseguenza, nel 1956, un consenso nazionale ha sostenuto l’introduzione di una pensione di vecchiaia, una forma di reddito minimo garantito per i pensionati così colpiti.




I ricchi, nel frattempo, non sono stati toccati dall’inflazione. L’inflazione non ha ridotto la loro ricchezza perché i loro investimenti erano in capitale reale, che li metteva al riparo. A far perdere loro denaro fu la seconda misura, adottata nel 1945: un’insolita imposta progressiva sulla ricchezza e sul capitale. Oggi, settant’anni dopo, il FMI vorrebbe farci credere che è tecnicamente impossibile stabilire un’imposta graduale sul capitale. Temo davvero che le istituzioni da te citate abbiano potenti ragioni ideologiche per favorire gli «haircuts».
Moderatori:
Che dire del rischio di evasione fiscale? Non è forse più facile per i proprietari di capitale evitare le tasse che evitare l’impatto della cancellazione del debito?
Piketty: No, è molto facile evitare gli effetti della remissione del debito, così come è facile proteggersi dall’inflazione. I grandi portafogli non contengono lettere di credito: sono composti da capitale reale. È possibile combattere l’evasione fiscale? Sì, se c’è la volontà, si può fare. Quando i governi moderni vogliono davvero che le loro decisioni siano rispettate, riescono a farle rispettare.
Quando i governi occidentali vogliono inviare un milione di soldati in Kuwait per impedire che il petrolio kuwaitiano venga sequestrato dall’Iraq, lo fanno. Siamo seri: se non hanno paura di un Iraq, non hanno motivo di temere le Bahamas o il New Jersey. L’imposizione di tasse progressive sulla ricchezza e sul capitale
non pone problemi tecnici. È una questione di volontà politica. Questo scambio è tratto da una conversazione tenutasi a Parigi tra David Graeber e Thomas Piketty, che discutono della pessima situazione in cui ci troviamo e di cosa potremmo fare per uscirne. Si è tenuto presso l’École Normale Supérieure; moderato da Joseph Confavreux e Jade Lindgaard; editato da Edwy Plenel; pubblicato la prima volta sulla rivista francese Mediapart nell’ottobre 2013 e tradotto dal francese da Donald Nicholson-Smith per The Baffler.
Tradotto da Marco Antonioli da «The Anarchist Library», luglio 2014





«L’Umanità è la Natura che prende coscienza di se stessa». Élisée Reclus (Clark and Martin 2013)
L’eco-anarchismo è la forma di ecologia politica che colloca il politico più profondamente nella storia e nella crisi della Terra. Ritiene che il nostro futuro e quello del pianeta dipendano dalla capacità di compiere il nostro destino come mezzo attraverso cui la Terra pensa e agisce per il bene comune di tutti gli esseri. Questa è la visione sviluppata dal geografo e filosofo francese del XIX secolo Jacques Élisée Reclus (1830-1905), il fondatore del moderno pensiero eco-anarchico (Clark e Martin, 2013). È stato il primo pensatore a concepire in modo dettagliato la storia della Terra come lotta per la libera fioritura dell’umanità e della natura e contro le forze di dominio che limitano tale fioritura. Questa è la visione che viene portata avanti oggi dalla tradizione eco-anarchica.
Il significato centrale dell’eco-anarchismo è evidente dall’etimologia del termine. Deriva dal greco antico oikos, che significa «famiglia» o «casa», e anarche, da ana-, che significa «senza», e arche, che significa vagamente «regola», «principio» o più precisamente «dominio». Inoltre, è una forma abbrevia-



ta di «anarchismo ecologico» e quindi presuppone un terzo termine, logos. Il logos di qualsiasi essere è la via e la verità di quell’essere, il suo modo di raggiungere il bene. L’eco-anarchismo rispetta quindi profondamente il logos dell’oikos, il suo ordine immanente e il suo autosviluppo, e cerca di difenderlo da ogni arche o forma di dominio.
Ma cos’è il nostro oikos? L’oikos è un tipo di comunità, in particolare quella che identifichiamo come la nostra casa. L’eco-anarchismo è quindi una forma di comunitarismo nel senso più forte del termine. Riconosce che siamo membri di comunità all’interno di comunità. I nostri oikoi comprendono la comunità intima primaria della famiglia e la piccola cerchia di amici stretti. Includono anche le nostre comunità locali e regionali, sia umane che più-che-umane. E comprendono, infine e soprattutto, l’oikos di tutti gli oikoi, la nostra casa globale, il nostro pianeta-casa, la Terra. L’eco-anarchismo sostiene che dobbiamo iniziare con la massima urgenza a trasformarci in membri pienamente responsabili della Casa Terra. Tale vocazione è «eco-anarchismo» in quanto esprime un impegno ecologico primario a promuovere la fioritura della comunità terrestre e un impegno anarchico primario a difendere tale fioritura da tutte le forze distruttive che vorrebbero schiacciarla ed estinguerla.




Entrare nel Necrocene
Qualsiasi movimento politico che si fondi su un livello minimo di sanità mentale deve concentrarsi con determinazione sul fatto che ci troviamo in un periodo di estrema crisi nella storia della Terra. Lo Stockholm Resilience Centre ha sviluppato in modo molto utile il concetto di «confini planetari», oltre i quali c’è un’alta probabilità di disastro ecologico (Rockström et Al. 2009). I ricercatori hanno identificato tali confini nelle aree del cambiamento climatico, dell’acidificazione degli oceani, dell’esaurimento dell’ozono stratosferico, dei cicli biogeochimici dell’azoto e del fosforo, dell’uso globale dell’acqua dolce, del tasso di perdita della biodiversità, del cambiamento del sistema terra, dell’inquinamento chimico e del carico di aerosol atmosferico. Hanno concluso che la violazione di un solo confine planetario potrebbe essere catastrofica, ma che tre confini sono già stati superati e la maggior parte degli altri si sta avvicinando rapidamente. Appaiono notizie quotidiane di un’accelerazione delle tendenze alla crisi globale in molte di queste aree.
È stato ampiamente suggerito che la gravità della crisi ecologica globale dovrebbe essere espressa dall’idea che siamo entrati in una nuova era geologica chiamata «Antropocene», in cui gli esseri umani sono identificati come la causa della crisi. Un approccio eco-anarchico rifiuta questa strategia, poiché descrivere la causa come un generico Anthropos o umanità omogenea è una distorsione ideologica delle specifiche realtà globali. Riconoscendo questa distorsione, altri hanno suggerito di chiamare la nostra epoca «Capitalocene», per identificare la vera causa di fondo nel capitalismo. Si tratta di un netto passo avanti verso una comprensione più profonda e concreta. Tuttavia, se adottiamo questo approccio di «causa reale» e seguiamo un’analisi eco-anarchica, avremo bisogno di almeno tre termini per specificare la natura della causalità. Per specificare le principali determinanti della crisi avremo bisogno di «Capitalocene» per identificare il Capitale, «Tech-




nocene» per identificare la Megamacchina tecnologica (compresa la Megamacchina primordiale, lo Stato) e, non ultimo, «Androcene» per identificare il Patriarcato (Il termine «megamacchina» è, ovviamente, mutuato dalla discussione seminale di Mumford 1967; 1970).
Tuttavia, nessuno di questi termini descrive con precisione la natura della transizione dall’era geologica precedente, il «Cenozoico». Cenozoico significa «nuova era della vita» e descrive ciò che è avvenuto nella biosfera ed è stato registrato direttamente nei reperti fossili. Il suo successore deve quindi concentrarsi non su ciò che stiamo facendo noi o le nostre istituzioni, ma su ciò che la Terra stessa sta subendo. Pertanto, il termine più accurato, incentrato sulla Terra, è «Necrocene», la «nuova era della morte». La nostra è l’epoca della morte, dell’estinzione di massa della vita sulla Terra e questo è ciò che verrà registrato dai reperti fossili.
Un sinonimo di Necrocene può essere «Thanatocene». Questo termine suggerisce che la storia della Terra è stata una lotta tra le forze della vita, della rigenerazione e della creazione, o Eros, e quelle della morte, della degenerazione e del dominio, o Thanatos. L’evoluzione della ricchezza e della diversità della vita sulla Terra ha espresso l’opera creativa e liberatoria di Eros. La scomparsa di specie, popolazioni, ecosistemi, culture e comunità sotto il regno sterminatore dell’Impero manifesta l’opera distruttiva e dominante di Thanatos. In un mondo in cui tutte le ideologie politiche dominanti costituiscono il Partito di Thanatos, l’eco-anarchismo è il Partito di Eros.




Comprendere cause e condizioni
Essere eco-anarchici significa riconoscere l’urgente necessità, nel Necrocene, di trasformare tutte le principali sfere di determinazione sociale. Significa rendersi conto che, a questo punto della storia della Terra, è troppo tardi per accontentarsi delle «ambizioni», dimostratesi inefficaci, dei Vertici sul clima e di simili esercizi di politica del gesto. Significa riconoscere che il sistema di dominio regnante è incapace di governare e autocorreggersi in modo efficace. Non è in grado di prevenire i crolli, perché opera secondo regole strutturali che sono esse stesse alla radice del problema. Ne consegue che dobbiamo prendere coscienza di come operano le principali sfere di determinazione sociale, lavorare diligentemente per sviluppare la nostra immaginazione e il nostro coraggio morale e trovare come cambiare il modo in cui operano queste sfere.
Sebbene i processi di determinazione sociale siano inseparabili e reciprocamente determinanti, possiamo dividerli, ai fini analitici, in quattro sfere. La «sfera istituzionale sociale» che consiste nelle strutture materiali e organizzative della determinazione sociale. «L’ethos sociale» che indica la costellazione di pratiche sociali, sentimenti e sensibilità che costituiscono un modo di vivere. «L’immaginario sociale» che si riferisce alla sfera della «fantasia fondamentale» della società, espressa dalle immagini di sé prevalenti e dalle narrazioni dominanti. E «l’ideologia sociale» che denota sistemi di idee che pretendono di essere rappresentazioni oggettive della realtà, ma in realtà la distorcono sistematicamente in nome di interessi particolaristici. Nell’ambito della civiltà, tutte queste sfere di determinazione sono modellate in modi che sostengono sistemi di potere gerarchici e dualistici – il che significa, oggi, il capitalismo globale, il sistema degli Stati nazionali, il patriarcato e la megamacchina tecnologica.
Se l’attuale sistema di determinazione sociale continua, siamo condannati a vivere sotto il giogo della dominazione sociale per un breve periodo nella storia della Terra, dopodiché il sistema




collasserà, insieme alla biosfera. La soluzione a questo problema è ovvia. Dobbiamo agire per rimpiazzare l’ordine ecocida con uno che affermi la centralità della Terra e che comprenda istituzioni sociali ecologiche, un’ideologia sociale ecologica (o anti-ideologia), un immaginario sociale ecologico e un ethos sociale ecologico.
Una politica di azione diretta
La politica eco-anarchica ha due aspetti principali. Il primo consiste nell’azione diretta per prevenire la catastrofe sociale ed ecologica che si sta sviluppando. La seconda comprende un programma completo per il cambiamento sistemico e la creazione di una società ecologica libera – una politica di trasformazione sociale.
L’approccio eco-anarchico dell’azione diretta è esemplificato dal lavoro del movimento ecologico radicale Earth First!. È incarnato dallo slogan del gruppo: «Nessun compromesso in difesa della Madre Terra». L’auto-descrizione del movimento inizia con la preoccupazione per l’estinzione di massa e la devastazione della Terra e dei modi di vita basati sulla Terra (earthfirstjournal. org). Riconosce che l’ordine dominante non ha fatto nulla per invertire il corso ecocida della storia e che è necessaria un’azione diretta militante, che comprenda la disobbedienza civile e l’ecotaggio. Inoltre, dobbiamo partecipare attivamente ai processi di rigenerazione della Terra attraverso il restauro ecologico.
Molti altri movimenti di eco-difesa sono stati fortemente influenzati dall’eco-anarchismo, soprattutto quelli che riguardano la protezione dell’acqua, della terra e delle comunità umane ed ecologiche locali. Un esempio eclatante è il lungo movimento di resistenza contro la costruzione dell’aeroporto di Notre-Dame-des-Landes, vicino a Nantes, in Francia. Il movimento è recentemente uscito vittorioso dopo quarant’anni di azione diretta che ha incluso l’occupazione permanente dell’area contestata da parte di una vasta comunità di resistenti. Da questo e altri sforzi





è nato il concetto di ZAD, o zone à défendre (zone da difendere). Dopo l’annullamento della costruzione nel gennaio 2018, gli Zadisti hanno scelto di lottare contro lo sfratto e di rimanere sul terreno come esempio di eco-comunità autonoma post-capitalista (zad.nadir.org).
Una politica di trasformazione sociale
Nella nostra epoca di crisi ecologica globale, la resistenza all’ordine ecocida dominante è essenziale. Tuttavia, la crisi non può essere superata solo con la resistenza. Sarà necessario un vasto movimento sociale che offra non solo una critica devastante del sistema ecocida dominante, ma anche una visione completa e convincente di una società ecologica libera, che affronti tutti gli ambiti importanti, compresi quello etico e spirituale, quello politico ed econo-
mico, quello pratico e personale. Sulla base di questa visione, bisogna iniziare in modo molto potente e tangibile a «costruire il nuovo mondo nel guscio del vecchio».
Forse l’esempio più sviluppato nella storia recente di ciò che potrebbe significare è il Movimento Sarvodaya, o «Welfare per tutti», in India, noto anche come «Movimento gandhiano» (Vettickal 2002; Clark 2013). Il Sarvodaya, i cui membri sono stati definiti «anarchici gentili» (Ostergaard e Currell 1971), è noto per aver condotto la lotta di liberazione dell’India dall’Impero britannico attraverso il satyagraha, o azione diretta nonviolenta. Tuttavia, fin dall’inizio si è trattato di un movimento di rivoluzione sociale ed ecologica di ampia portata. Il suo programma mirava a un ideale che Gandhi stesso descrisse come «un’anarchia ordinata» (Gandhi 1940: 262).



I principi morali e spirituali che guidano il Sarvodaya sono incentrati sul perseguimento del bene comune e sull’eliminazione del dominio. La parola sanscrita sarvodaya può essere tradotta con «realizzazione per tutti». Il principio etico chiave del movimento, l’ahimsa, significa «non nuocere» (più precisamente, non dominare) e, detto in termini positivi,
implica agire con un profondo rispetto per la sacralità e il bene intrinseco in tutti gli esseri viventi. Il Sarvodaya condivide quindi l’ideale eco-anarchico di una società basata sul non-dominio e sull’autorealizzazione universale.
La politica e l’economia sarvodayana mirano a un sistema di swaraj o autogoverno democratico, incentrato sul livello della comunità locale autonoma. In questo sistema, il chaupal, lo spazio comune tradizionale al centro del villaggio, diventa il punto focale per le istituzioni di una vigorosa democrazia locale. Un esempio è il panchayat, o consiglio di villaggio composto da cinque persone, elemento tradizionale della governance locale. Un altro è il gram sabha, o assemblea del villaggio, che deve diventare il depositario ultimo del potere in un sistema sviluppato di democrazia comunale.
Lo swaraj richiede anche un sistema economico democratico e controllato dalla comunità, con una produzione per i bisogni reali. Questo sistema cooperativo praticherà lo swadeshi, la produzione bioregionale radicata nella terra. Tale economia di sussistenza o di sostentamento porrà fine allo sfruttamento dei lavoratori e della terra, impedendo la devastazione ecologica che deriva dalla produzione per la massimizzazione del profitto. Per creare un sistema di questo tipo, il Sarvodaya istituì una campagna per il bhoodan («dono della terra»), in cui la terra veniva donata e messa in comune per progetti di agricoltura cooperativa nei villaggi. Grazie a questo sforzo, 5 milioni di acri di terreno




sono stati inseriti in progetti di cooperazione. L’obiettivo finale era il gramdan, o «dono del villaggio», in cui tutte le località sarebbero state trasformate in eco-comunità autogestite e ampiamente autosufficienti.
Un altro obiettivo era quello di formare un corpo di gram sevaks, organizzatori a tempo pieno della comunità Sarvodaya. Dovevano andare in ogni comunità per educarla e assisterla nell’auto-organizzazione secondo la visione sarvodayana. Il movimento avrebbe anche formato uno shanti sena, cioè un «esercito di pace», o un corpo di mediatori. Per porre fine a tutte le forme di violenza sistemica e per promuovere la cooperazione pacifica, il potere della polizia statale dovrebbe essere progressivamente sostituito da una forza nonviolenta.
Una delle idee pratiche più brillanti del movimento fu la creazione di un ashram in ogni villaggio e quartiere. Nel senso sarvodayano del termine, si tratta di una comunità di base politica e spirituale in cui i membri vivono in comune e diffondono gli insegnamenti sarvodayani attraverso l’educazione e, soprattutto, la forza dell’esempio ispiratore. Come luogo per le tecnologie appropriate e la produzione locale, l’ashram potrebbe essere definito un modello di ecovillaggio. La speranza era che ogni villaggio e quartiere contenesse un esempio funzionante del tipo di comunità cooperativa, attenta alla vita che potesse diventare l’intera società.
Una società ecologica emergente
Il Sarvodaya è un esempio inestimabile di un vasto movimento sociale con dimensioni sia anarchiche che ecologiche che ha intrapreso una trasformazione istituzionale, immaginaria, ideologica ed etica in una società di centinaia di milioni di persone. Il punto non è replicarlo, ma guardare sia ai suoi grandi successi che ai suoi significativi fallimenti per trarne insegnamenti che possano essere utilizzati nella creazione di un movimento utile per la trasformazione socio-ecologica. Così, l’eco-femmi-




nista Vandana Shiva e i suoi colleghi della Navdanya Biodiversity Farm and Seed Bank di Dehradun, in India, portano avanti consapevolmente molti aspetti della tradizione gandhiana, ecologizzandoli radicalmente attraverso un’enfasi più esplicita sulla centralità della Terra e del territorio. Inoltre, sottolineano molto di più l’importanza di superare le forze distruttive del dominio patriarcale e di liberare l’energia femminile Shakti della nascita, della vita e della crescita.
Oggi ci sono movimenti significativi che vanno ancora di più nella direzione di creare il tipo di società ecologica post-statalista, post-capitalista e post-patriarcale immaginata dall’ecoanarchismo. Si tratta in parte di un recupero e di una ridistribuzione di ciò che è andato perduto dalle precedenti società pre-statali, pre-capitaliste, pre-patriarcali, basate sulla Terra. Le istituzioni comunitarie, partecipative, radicalmente democratiche e basate sul consenso erano comuni in queste società. Per questo motivo, l’eco-anarchismo riconosce ai movimenti indigeni un’importanza molto maggiore di quanto non indichino i loro semplici numeri. Portano nel mondo un’antica storia vivente di democrazia comunitaria e di decisioni consensuali, il riconoscimento del mondo naturale come nostro mondo, un profondo senso di parentela con tutti gli altri esseri viventi, parti dell’economia del dono e un chiaro riconoscimento dell’importanza dei valori femminili e non possessivi come centrali per la cultura e la comunità. Troviamo queste tradizioni oggi, ad esempio, nel movimento zapatista, che ha creato municipi liberati in Chiapas, Messico, che hanno trasformato la vita di diverse centinaia di migliaia di persone (Fitzwater 2019). Il movimento si basa in gran parte su una visione del mondo indigena, comunitaria, egualitaria e di affermazione della natura, che si esprime in istituzioni come assemblee locali, consigli e cooperative, in cui il potere è situato alla base. Per fare un altro esempio, nel Rojava (Kurdistan occidentale), il Movimento per l’autonomia democratica ha ispirato una trasformazione sociale radicale per diversi milioni di persone (Knapp et Al. 2016; Clark 2019). Le dimensioni anarchi-




che del movimento si manifestano in istituzioni di democrazia diretta decentrata come assemblee locali, consigli e comitati di cittadini, in un’organizzazione confederale non statalista e in un significativo movimento ecologico. Inoltre, la rivoluzione del Rojava va oltre la maggior parte dei movimenti anarchici nel suo impegno per una radicale trasformazione sociale femminista e per la distruzione del dominio patriarcale.
In breve, la visione eco-anarchica trova alcune potenti espressioni nel mondo contemporaneo che possono offrire ispirazione a coloro che sperano di vedere questa visione sfidare l’ordine ecocida dominante.
Una comunità terrestre risvegliata
L’eco-anarchismo vede l’obiettivo della libertà sia per l’umanità che per la natura oltre-che-umana come sinonimo di realizzazione del bene comune. Ciò significa la massima fioritura delle eco-comunità locali e globali e l’eliminazione di tutte le forme di dominio che limitano tale fioritura. Il motto del progetto con cui lavoro, La Terre Institute for Community and Ecology, è appamāda, un antico termine pali conosciuto come «l’ultima parola del Buddha». Ha molte traduzioni in inglese, ma la migliore potrebbe essere «cura consapevole». Esprime l’idea che se vogliamo salvarci e, soprattutto, salvare il mondo dalla devastazione, dobbiamo permettere a noi stessi, come persone e comunità, di risvegliarci alla natura di tutti i fenomeni e, soprattutto in questo momento, alla natura della sofferenza che la Terra sta vivendo. Dobbiamo essere ben consapevoli che questa consapevolezza è autentica solo se si esprime in azioni appropriate. Questo significa, soprattutto, prendersi cura in modo consapevole e impegnato del bene di tutti gli esseri della biosfera e del bene di tutti i beni terrestri, quindi del bene della Terra. L’appamāda potrebbe quindi essere considerata un sinonimo di pratica dell’eco-anarchismo.




Bibliografia
- J. CLARK, The common good: Sarvodaya and the Gandhian legacy, in J. CLARK, The Impossible Community: Realizing communitarian anarchism, Bloomsbury, New York, pp. 217-45.
- J. CLARK, Lessons of the Rojavan revolution, in J. CLARK (ed.), Between Earth and Empire: From the Necrocene to the beloved community, PM Press, Oakland, 2019, pp. 126-39.
- D. FITZWATER, Autonomy is in Our Hearts: Zapatista autonomous government through the lens of the Tsotsil language, PM Press, Oakland, 2019.
- M. GANDHI, An interesting discourse. Harijan, 25 August, 1940, disponibile in is.gd (accesso ottobre 2019); e anche in M. GANDHI, The Collected Works of Mahatma Gandhi, Government of India Press, New Delhi, vol. 79, 1999.
- M. KNAPP, A. FLACH, E. AYBOGA, Revolution in Rojava: Democratic autonomy and women’s liberation in Syrian Kurdistan, Pluto Books, London, 2016.
- L. MUMFORD, The Myth of the Machine, Harcourt Brace Jovanovich, New York, 2 voll., 1967, 1970.
- G. OSTERGAARD, M. CURRELL, Gentle Anarchists: A study of the leaders of the Sarvodaya movement for non-violent revolution in India, Clarendon Press, Oxford, 1971.
- E. RECLUS, Anarchy, Geography, Modernity: Selected writings of Elisée Reclus, ed. J. Clark and C. Martin, PM Press, Oakland, 2013.
- J. ROCKSTRÖM, W. STEFFEN, K. NOONE ET AL., A safe operating space for humanity, «Nature», 461 (2009), pp. 472-75.
- T. VETTICKAL, Gandhian Sarvodaya: Realizing a realistic utopia. Gyan Publishing House, NewDelhi, 2002.
Tratto da:
John Clark, What is eco-anarchism?, 2020. The Anarchist Library Traduzione di Marco Antonioli



100


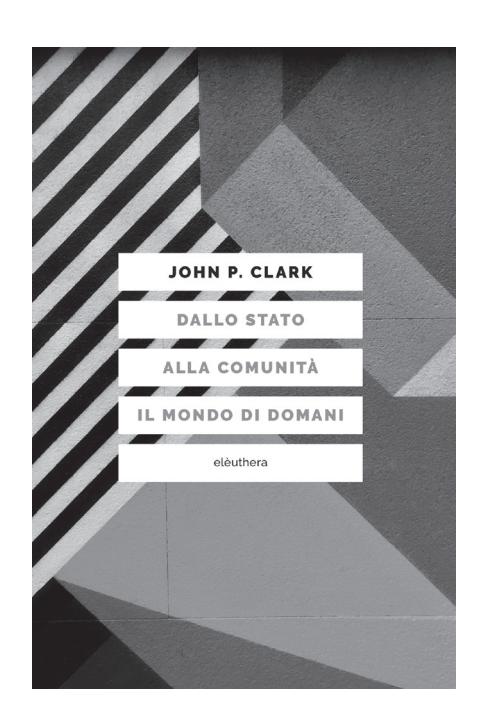
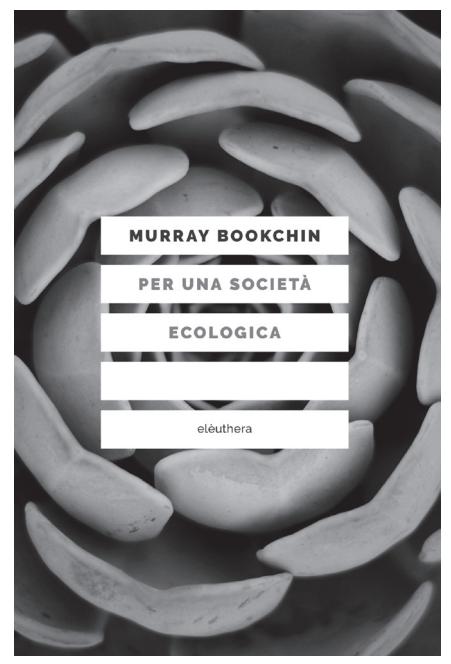



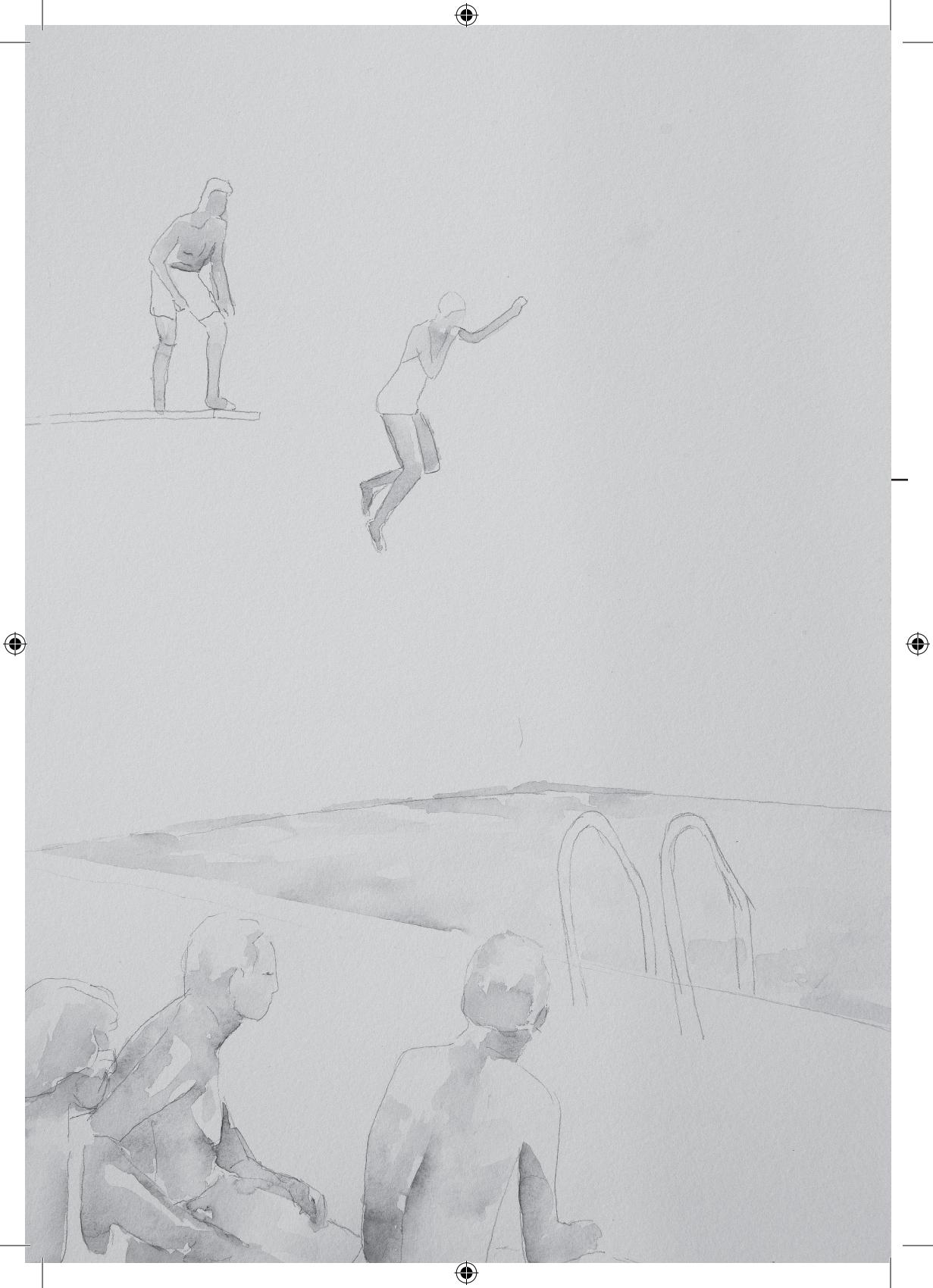
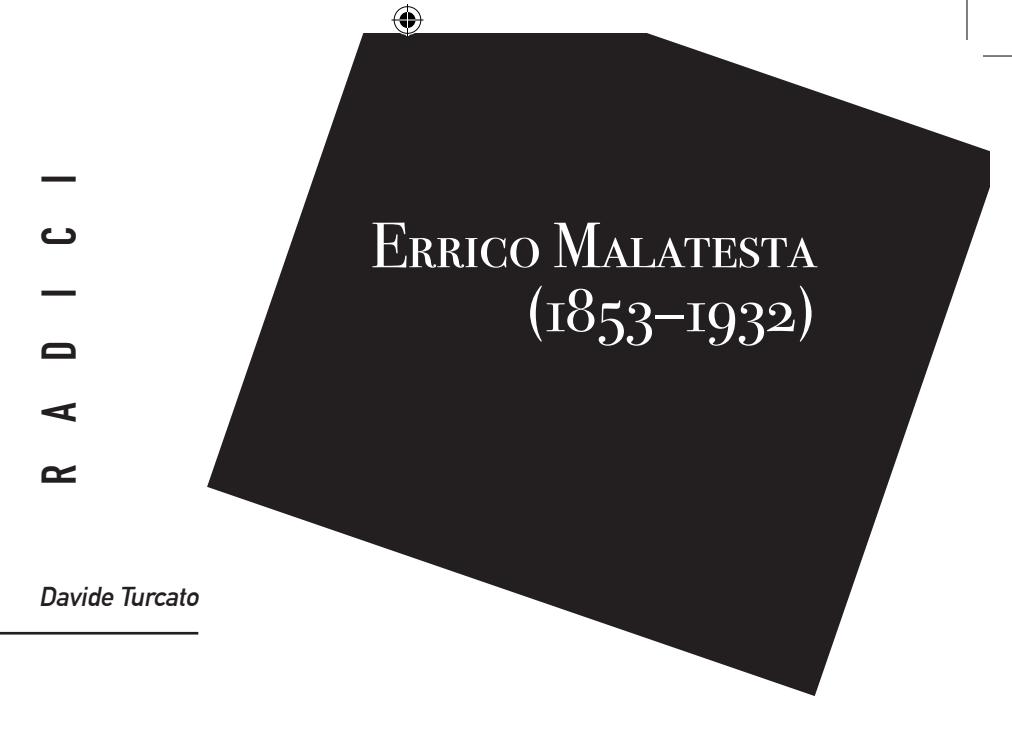
Parlare di Malatesta oggi suscita in alcuni persino irritazione. Perché parlare sempre dei «leader» e non dello stuolo di anonimi compagni? Perché, nell’era dei droni e dell’intelligenza artificiale, leggere ancora gli scritti di un autore nato nel regno borbonico? Non è ora di andare oltre Malatesta e svecchiare finalmente l’anarchismo? Un ovvio motivo per parlare di lui è che i più giovani possono non conoscerlo. A loro beneficio diciamo che la militanza di Malatesta ha abbracciato i primi sessant’anni di vita del movimento anarchico, dal congresso di St-Imier del 1872 ai prodromi della rivoluzione spagnola. Pur avendo vissuto la maggior parte della vita adulta all’estero, soprattutto a Londra, è stato protagonista dei momenti di più intenso scontro sociale in Italia, dai moti del pane del 1898 alla «settimana rossa» del 1914, al «biennio rosso» del 1919-20. È autore di alcuni dei più grandi «best-seller» della letteratura anarchica mondiale (Fra contadini, L’anarchia, Al caffè) e ha diretto alcuni fra i più importanti periodici anarchici in lingua italiana («L’Agitazione», «Volontà», «Umanità Nova», «Pensiero e Volontà»). Detto, questo, veniamo alle possibili lamentele di cui sopra. Ebbene, governo e proprietà privata dei mezzi di produzione – le massime incarnazioni dei due modi in cui si possono opprimere gli uomini, la forza brutale e il controllo dei mezzi di


sussistenza – sono altrettanto vive nell’era dei droni quanto lo erano in quella dei Borboni. Da questo punto di vista, ahimè, non c’è niente di nuovo sotto il sole. E l’aspirazione ad andare oltre Malatesta è lodevole, come lo è quella ad andare oltre Darwin in biologia o Copernico in astronomia, ma bisogna essere in grado di farlo, altrimenti si rischia solo di scoprire l’acqua calda o, peggio, di uscire dal solco dell’anarchismo.
A mio avviso, parte della grandezza e dell’immutata rilevanza di Malatesta consiste proprio nell’aver tracciato quel solco, cioè nell’aver chiarito meglio di chiunque altro i tratti essenziali, cioè necessari e sufficienti, che definiscono l’anarchismo (al singolare). Nell’opuscolo L’anarchia Malatesta fornisce una definizione che è tanto concisa e apparentemente ovvia quanto è profonda:
«L’anarchia, al pari del socialismo, ha per base, per punto di partenza, per ambiente necessario l’eguaglianza di condizioni; ha per faro la solidarietà; e per metodo la libertà.»
L’eguaglianza è un punto di partenza, una pre-condizione. Poiché il monopolio dei mezzi di produzione è una forma di oppressione («chi è povero è schiavo»), eguaglianza di condizioni significa proprietà comune dei mezzi di produzione, cioè socialismo. La libertà, poi, è un metodo. Questo è probabilmente il concetto più fecondo di Malatesta:
«Un programma che tocca le basi della costituzione sociale non può far altro che indicare un metodo. Ed è il metodo quello che soprattutto differenzia i partiti e determina la loro importanza nella storia. A parte il metodo, tutti dicono di volere il bene degli uomini… Bisogna dunque soprattutto considerare l’anarchia come un metodo.»
Il metodo anarchico è il metodo della libertà: libera iniziativa di tutti e libero patto. Infine la solidarietà è un faro, è il valore che guida gli anarchici nella loro azione. L’anarchia che Malatesta descrive qui non è un modello statico di società, ma un processo sperimentalista e pluralista dall’esito aperto. Pluralismo significa che ogni individuo o gruppo ha diritto a concepire, propugnare e



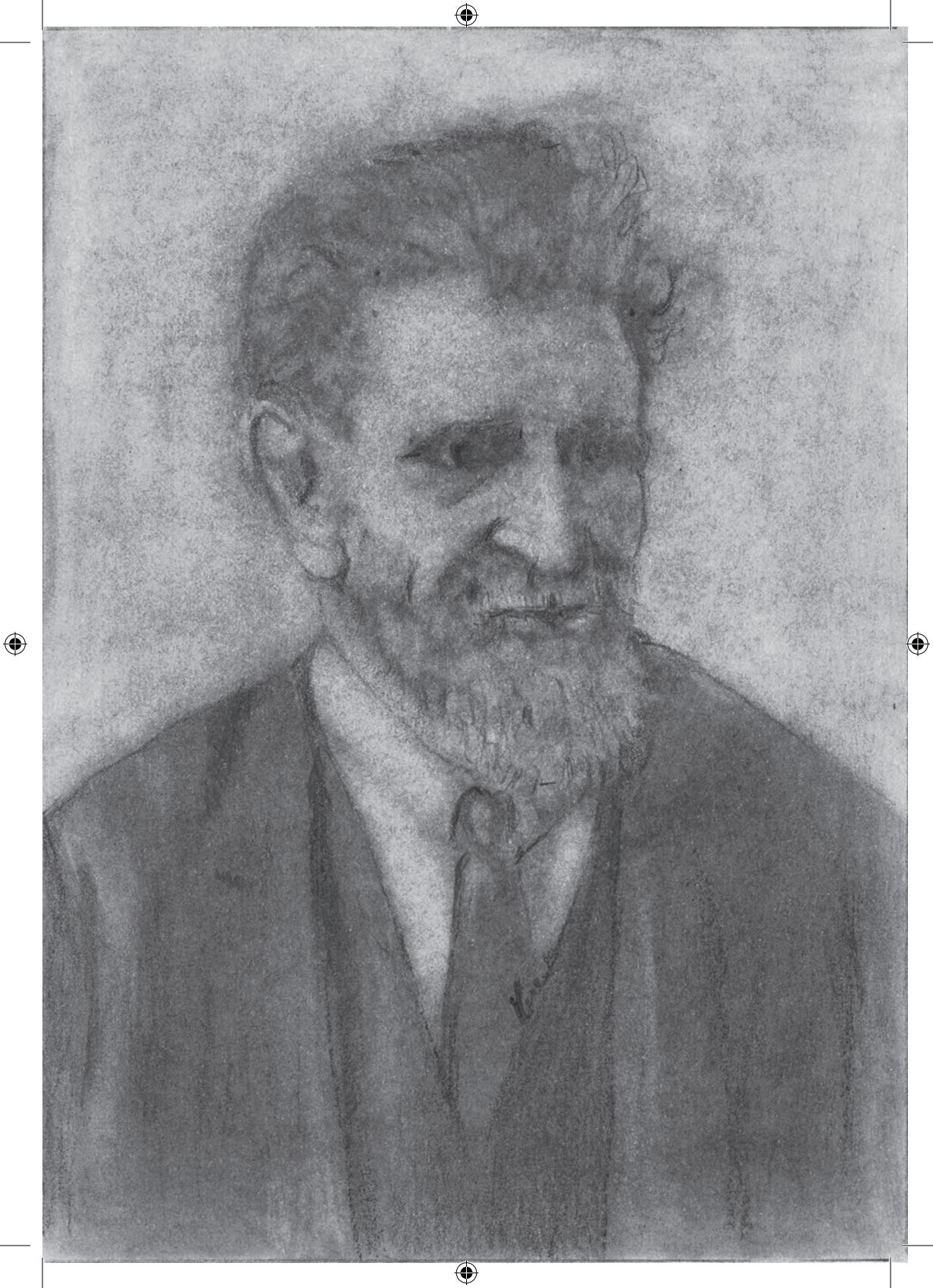

sperimentare un proprio modello di società che non contraddica i presupposti del processo stesso. Può e deve esservi quindi una pluralità di modelli, ma non si tratta di una pluralità di «anarchismi», come oggi è in voga affermare. Ciascuno di questi modelli ha diritto di cittadinanza nell’anarchismo ma nessuno di essi può essere inscritto nel programma anarchico, nella definizione di anarchismo. Ciò che caratterizza l’anarchismo è il metodo e soltanto il metodo, e in questo senso può esservi un solo anarchismo. Il semplice e fecondo presupposto metodologico che informa tutte le idee di Malatesta è il rifiuto di pensare le entità collettive – nazione, società, popolo, comunità – come totalità indivise. Le collettività sono aggregati di individui, e come tali la direzione che esse prendono è la risultante delle iniziative di tutti gli individui che le compongono. Questo presupposto metodologico, assieme al concetto dell’anarchismo come metodo, costituisce il fondamento teorico del gradualismo anarchico di Malatesta. La pratica del metodo della libertà è l’essenza tanto dell’azione anarchica nel presente quanto della società anarchica. La società anarchica non è altro che una società di anarchici, cioè di individui che praticano il metodo della libertà. Inoltre, l’idea che la società è la risultante delle iniziative dei suoi componenti implica che la società sia tanto più anarchica quanti più anarchici operano in essa. In ultima analisi, la distanza tra la società presente e l’«utopia» anarchica si dissolve nella graduale diffusione delle pratiche anarchiche. L’anarchia diventa una questione di grado di anarchismo dei membri della società.
Tuttavia, per quanto «interstiziali» e «rizomatiche» possano essere quelle pratiche nel presente, non si può pensare che l’anarchismo possa diffondersi «di soppiatto», quasi senza dare nell’occhio e senza incorrere nella reazione delle classi dominanti – legale o all’occorrenza extra-legale. A questa questione si possono dare risposte diverse, ma una risposta chiara va data. Una risposta nobilissima e chiarissima è quella tolstoiana della non-violenza. Un’altra è quella di Malatesta, che riteneva invece che alla violenza governativa si dovesse rispondere con




la forza e che la rivolta sociale, intensificandosi, sarebbe sempre giunta inevitabilmente al bivio fra capitolazione e insurrezione. Chi trova sgradevole la prospettiva insurrezionale la bolla come «apocalittica», «catartica», «palingenetica», rispolverando così il vieto armamentario dell’interpretazione millenaristica dell’anarchismo, che da alcuni anni gli storici più avveduti stanno cercando di mettere in soffitta. In realtà, la concezione malatestiana dell’insurrezione era l’esatto contrario e nasceva proprio dalla consapevolezza che essa non avrebbe potuto essere un evento apocalittico. L’idea squisitamente malatestiana che il prossimo passo verso l’anarchia sarà una rivoluzione non anarchica è il nucleo del suo gradualismo anarchico e fu non solo enunciata fin dal 1899 ma messa in pratica nella «settimana rossa» del 1914, ben prima che l’etichetta del «gradualismo» fosse coniata. Come gli scritti Contro la monarchia e Verso l’anarchia apparvero contemporaneamente, così per Malatesta gradualismo e insurrezione sono due facce della stessa medaglia.
Bibliografia essenziale
Scritti di Errico Malatesta
Fra contadini, La Fiaccola, Ragusa, 1972.
L’anarchia, La Fiaccola, Ragusa, 1973.
Al caffè, Centro Documentazione Anarchica, Torino, 1978.
Buon senso e utopia, elèuthera, Milano 2018.
Opere complete, a cura di D. Turcato, 10 volumi, Zero in Condotta, Milano e La Fiaccola, Ragusa, 2011 – in corso di pubblicazione.
Scritti su Errico Malatesta
G. BERTI, Errico Malatesta e il movimento anarchico italiano e internazionale, 1872–1932, Franco Angeli, Milano, 2003.
A. BORGHI, Errico Malatesta, Edizioni Anarchismo, Catania, 1978.
L. FABBRI, Malatesta: L’uomo e il pensiero, Edizioni Anarchismo, Catania, 1979. M. NETTLAU, Malatesta, Samizdat, Pescara, 1998.
D. TURCATO, Il metodo anarchico: Gli esperimenti di Errico Malatesta con la rivoluzione, 1889–1900, Odradek, Roma, 2023.




Ursula Le Guin nacque il 21 ottobre 1929 a Berkley, in California, da Alfred L. Kroeber, noto antropologo, e Theodora Kroeber, autrice del bestseller Ishi in Two Worlds: A Biography of The Last Wild Indian in North America (1961). La vivacità intellettuale del suo contesto di crescita, punto d’incontro e di dialogo di scienziati, scrittori e nativi della California, alimentò significativamente il suo interesse verso le alterità culturali. In effetti, dopo gli studi in letteratura rinascimentale francese e italiana presso il Radcliffe College e l’ottenimento di un «Master of Arts» nella medesima disciplina presso la Columbia University (1952), la scrittrice diede vita a una produzione letteraria caratterizzata da una notevole versatilità, dove la spinta alla scoperta delle culture aliene e delle differenti società potrebbe essere individuata come il fil rouge complessivo.
In particolare, se la parte più ampia del corpus letterario dell’autrice, a partire dal suo stesso racconto d’esordio April in Paris in «Fantastic Science Fiction» (1962), è ascrivibile al genere fantascientifico, è altresì vero che Le Guin scrisse anche un centinaio di storie brevi, oltre che dodici volumi di poesia e cinque traduzioni, tra cui Tao Te Cjing: A Book about the Way and the Power of the Way di Lao Tzu (1997); anche i lavori di traduzione



sembrano incarnare, in questo senso, il tentativo di gettare ponti, attraverso la parola scritta, tra lingue e culture differenti.
La precisa volontà di Le Guin di costruire un’eclettica identità di scrittrice, esulando da rigide etichette definitorie, sembra inoltre trovare una certa corrispondenza nello sviluppo libero e arborescente della sua stessa visione politica, che non appare in definitiva in alcun modo asservita a una specifica connotazione ideologica, ma risulta anzi profondamente originale, arricchita da fonti eterogenee.
In questo senso è interessante come, prescindendo dal radicato ateismo che caratterizzò il suo contesto famigliare, Le Guin fondò la propria scrittura sui pilastri taoisti dell’equilibrio e dell’armonia universale. La filosofia taoista, intrecciandosi allo spirito marcatamente anarchico e libertario dell’autrice, la portò a esprimere nelle sue opere una visione antropologica appassionatamente contraria a ogni forma di potere: nel suo pensiero, l’essere umano non poteva più assurgere al ruolo di conquistatore, ma si inseriva armonicamente nell’equilibrio universale, tentando forme di contatto con le culture a lui aliene. Seguendo l’interpretazione in chiave libertaria della filosofia del Tao, i contorni di questa prospettiva anarchica sarebbero, in questo senso, del tutto coerenti rispetto ai princìpi della pratica taoista, secondo la quale ogni tipo di legge repressiva si configura come una minaccia all’ordine e all’armonia naturale. Di qui la necessità di una vigilanza continua per impedire a uomini astuti di approfittare del sistema di governo per instaurare il proprio dominio. Inoltre, sulla base della credenza taoista per la quale gli esseri umani sono appunto naturalmente chiamati a vivere tra loro in equilibrio e armonia, Le Guin si fece promotrice di una visione antropologica dalla connotazione spiccatamente anti-gerarchica, per la quale gli individui sono (o dovrebbero essere) tra loro eguali, liberi e dotati di pari potere.
Già nei suoi primi romanzi, come Rocannon’s World e Planet of Exile (1966) – pubblicati negli anni appena successivi al matrimonio con lo storico Charles Le Guin, con il quale si trasferì a




Portland ed ebbe tre figli – emerge la capacità di Le Guin di contaminare il genere fantascientifico, in quel momento da lei ritenuto ancora imperniato sulla «tradizione dell’uomo bianco che conquista l’universo», di temi rispondenti alla sua sensibilità: il «viaggio archetipico» di un protagonista che ricerca la propria identità attraverso un duplice viaggio (interiore ed esteriore), il pacifismo, la connessione identitaria con l’ambiente naturale, la riconciliazione degli opposti in un quadro di equilibrio universale.
La visione leguiniana si rese inoltre permeabile rispetto alla stagione politica delle rivendicazioni rivoluzionarie sessantottine, specialmente in relazione al tema delle disuguaglianze di genere: uno dei suoi più celebri romanzi, The Left Hand of Darkness (1969), si propose in particolare, ritraendo una società fatta di androgini, e dunque scevra delle tradizionali distinzioni sessuali, di effettuare un esperimento immaginativo volto a esplorare la dimensione dei ruoli di genere senza irrigidirsi nella visione radicalmente dualistica perpetuata dai canoni occidentali. Dirette conseguenze politiche di questa immaginaria «reiscrizione della natura» erano l’assenza di potere costituito, delle guerre, dello sfruttamento naturale e della concezione della sessualità come fattore sociale permanente.
La riflessione libertaria di Le Guin culminò infine ritraendo, con The Dispossessed (1974), il popolo anarchico di Anarres, che spingeva l’esigenza di difesa della libertà individuale fino allo sradicamento di ogni potere gerarchico, compresa la religione organizzata e la proprietà privata: gli si contrapponeva il popolo di Urras, improntato ai principi del capitalismo e dell’individualismo. La visione antidogmatica di Le Guin la spinse tuttavia a consegnare, con questo romanzo, un’utopia «ambigua» che, lungi dall’incarnare il tradizionale schema di incorruttibile equilibrio e armonia, mostrava punti di debolezza: i due paradigmi politici estremi di Anarres e Urras, dietro la maschera delle opposte ideologie, manifestavano infatti una medesima difficoltà a gestire il concetto di libertà, configurandosi, in ultima analisi, come riflessi delle reciproche incongruenze.




In The Dispossessed Le Guin sembra consegnare ai lettori un monito rispetto alle conseguenze che derivano dal chiudersi all’interno di paradigmi definitori e limitanti, dall’irrigidirsi in definizioni spinte fino all’estremo: pur nutrendo, anzi, un’evidente fascinazione e interesse nei confronti dell’anarchismo, dipinse Anarres come una società che radicalizza la propria adesione a questo pensiero politico fino a cristallizzarlo in una gabbia ideologica, dando vita a un clima oppressivo che soffoca, come anche avviene a Urras, la possibilità di sviluppare la lucidità e l’imparzialità necessarie per giudicare le proprie mancanze. Entrambi i pianeti, di conseguenza, non possono che da ultimo mancare la sfida di riconciliazione degli opposti che l’autrice, in accordo con la pratica taoista, individua come obiettivo cruciale del percorso evolutivo tanto dell’anima umana, quanto dell’ordine universale del cosmo nel suo complesso.
L’enfasi posta dall’autrice nell’evidenziare le fragilità dimostrate da entrambi i pianeti nel loro sforzo di dare costruzione al sogno sociale sul quale pure innestano le loro basi, potrebbe rendere forse opportuno non considerare The Dispossessed un’utopia o una distopia – la stessa Le Guin, non a caso, definì quest’opera come «un’utopia ambigua» –, ma come un esempio delle nuove forme di discorso utopistico emerse negli anni ‘70 del XX secolo con il nome di critical utopias: disegni utopistici non esenti da incongruenze e problemi, talvolta anche non risolvibili, che per loro stessa irrisolutezza permettono al lettore di sviluppare riflessioni critiche.
In effetti, con la descrizione di Anarres, Le Guin ha evitato di proporre ai lettori la soluzione di un mondo anarchico perfettamente compiuto, incontestabile e privo di lacune, che chiuda le porte all’immaginazione di alternative possibili. Al contrario, ha fatto propria una visione profondamente «aperta», per sua struttura rivedibile e correggibile, dunque intrinsecamente libertaria e non dogmatica, quasi a voler consegnare un «messaggio in bottiglia» per le generazioni future.



Nell’ideare un mondo anarchico dalle incongruenze così chiaramente evidenti, l’autrice sembra anzi abbracciare il problema critico della revisione dell’anarchismo posto per la prima volta da Camillo Berneri, che senza indugio negò che la società anarchica potesse essere «la società dell’armonia assoluta», e optò piuttosto per una «società della tolleranza».
La spinta libertaria e antidogmatica ha costituito la linfa inesauribile della produzione letteraria di Le Guin, che morì nel 2018 a Portland.
BIBLIOGRAFIA
Scritti di U.K. Le Guin
I reietti dell’altro pianeta, Mondadori, Milano, 2021.
I sogni si spiegano da soli: immaginazione, utopia, femminismo, a cura di Veronica Raimo, Sur, Roma, 2022.
Il linguaggio della notte: saggi di fantasy e fantascienza, introduzioni e cura di Susan Wood, Editori Riuniti, Roma, 1986.
Il mondo di Rocannon, Casa Editrice Nord, Germignaga, 2006.
Il pianeta dell’esilio, Mondadori, Milano, 2016.
L’occhio dell’airone, elèuthera, Milano, 1987.
La mano sinistra delle tenebre, Mondadori, Milano, 2021.
Scritti su U.K. Le Guin
S. M. BERNARDO, G.J. MURPHY, Ursula K. Le Guin: a critical companion, Greenwood Pub Group, Londra, 2006.
H. BLOOM, Ursula Le Guin, ed. and with an introduction by Harold Bloom, Chelsea House, New York, 1986.



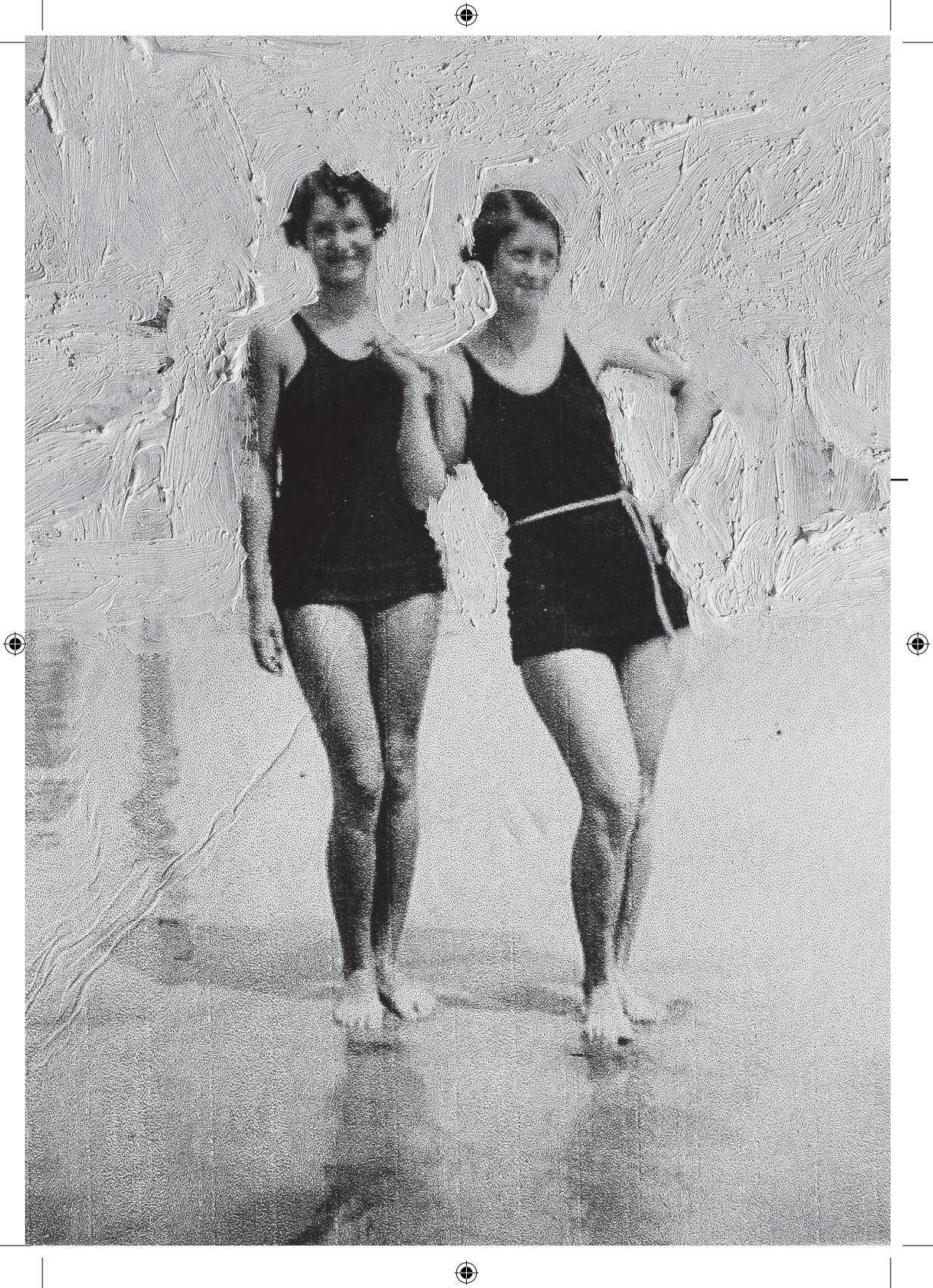

La cura come principio organizzatore della società: una lettura del Manifesto della cura di The Care Veronica Pacini Collective
Di critiche al neoliberismo se ne sono prodotte tante, tantissime negli ultimi decenni, in alcuni casi accompagnate da proposte alternative che vanno dal timido riformismo alla rivoluzione radicale. Il Manifesto della cura è una di queste. La sua particolarità sta nel fatto di utilizzare come centro della riflessione critica e della proposta concreta il concetto di cura. Autore del Manifesto è il gruppo The Care Collective, un collettivo inglese composto da persone del mondo accademico e dell’attivismo sociale. Fin dalla sua nascita, anno 2017, il gruppo di studio si è occupato della «crisi della cura» e con la pandemia, durante la quale le questioni legate alla cura sono diventate centrali, ha condensato le sue riflessioni nel Manifesto.
1. Critica al neoliberismo
Il neoliberismo è un sistema economico che si fonda sull’estensione delle pratiche che portano a estrazione del profitto e che contemporaneamente minaccia o elimina quelle che non lo permettono. È quindi un sistema che si fonda sull’incuria (carelessness) e che fagocita nei suoi processi tutte le azioni di cura che possono essere tradotte in scambio economico e ostacola o rende invisibili


le altre. Con la sua capacità di assorbimento è riuscito a creare un cortocircuito per il quale sono ammesse e incoraggiate le pratiche di cura individuale (selfacare) legate ai concetti passpartout di resilienza, crescita personale e benessere (wellness), spingendo contemporaneamente i governi a demolire l’idea di benessere comunitario e sociale e le relative strutture (welfare). Sostituire all’incuria la cura come principio organizzatore delle pratiche sociali è, secondo il collettivo di autori e autrici, la chiave per poter uscire finalmente da un sistema che sembra inscalfibile per la sua capacità di assorbire tutto, anche le forze contrarie.
2. Come fare? Partire dall’individuo e dalla famiglia: cura universale e cura promiscua
La proposta si articola in vari livelli. Il primo livello di trasformazione parte dall’antropologia dell’individuo: ogni essere umano è per sua natura «dotato di valore intrinseco ed è dipendente dagli altri. Nella cultura neoliberista la dipendenza dalla cura è stata patologizzata anziché essere riconosciuta come parte integrante della condizione umana» (p. 37), e questo perché riconosce come maschili, e quindi migliori, l’autonomia e l’indipendenza, e come femminili, e quindi peggiori, l’interdipendenza reciproca in quanto espressione di fragilità e debolezza (oltre al fatto che prestare cura è da sempre considerato un lavoro da donne e quindi di serie b). Accettare che ogni individuo è contemporaneamente bisognoso di cura e degno di ricevere cura vuol dire riconoscere come diritto e dovere di ciascuno la cura universale e quindi l’ideale di una società in cui la cura sia al centro di ogni aspetto della vita e dove tutti siamo responsabili in maniera collettiva del lavoro di cura, sia a livello quotidiano sia nella sua accezione di sostegno necessario per la tutela della comunità e del mondo intero. Questo non vuol dire che «tutti devono fare tutto», ma che dobbiamo organizzare la nostra realtà dal micro (l’individuo), al macro (lo Stato) in modo che tutti possano dare e ricevere cura, essere umani, animali e ambiente. Il secondo livello è sostituire la cura familiare con la «cura




promiscua», cioè con un’etica che gli autori e le autrici riprendono dalle comunità afroamericane deprivate dei giusti mezzi di sussistenza dal razzismo e dai movimenti LGBTQ+ e delle persone malate di AIDS degli anni ‘80-‘90, in cui, per garantirsi quel sostegno negato dallo Stato, si creavano «famiglie per scelta», famiglie in cui i legami di sangue non erano necessari per garantirsi reciproca cura. «Cura promiscua non significa relazioni effimere tra estranei. Significa invece riconoscere che la cura può mettere in relazione persone non necessariamente vicine» (p. 53).
3. Coltivare comunità di cura
Il terzo livello sono le «comunità di cura» ovvero quegli spazi in cui è possibile agire la cura promiscua e universale, che vanno costruiti e ampliati continuamente nei contesti reali in cui viviamo: biblioteche, scuole, comunità di quartiere, gruppi e reti sociali… Esse si basano sul mutuo soccorso, si sviluppano dentro lo spazio pubblico, danno priorità alla condivisione delle risorse, e sono democratiche. In questi spazi si esercita una democrazia reale, e l’invito è quello di portare questo spirito all’interno di ogni tipo di gruppo sociale a cui apparteniamo nelle nostre realtà e di spingere i nostri governi a garantire infrastrutture e risorse, contrapponendo al «capitalismo compassionevole e alle temporanee soluzioni di cura una cura municipale», offrendo cioè alla comunità mezzi per potersi auto-organizzare e praticare la cura in forme democratiche.
4. Stato di cura ed economia della cura
Come abbiamo visto il collettivo individua, in ultima istanza, lo Stato come fornitore delle infrastrutture, degli spazi e dei mezzi necessari all’autorganizzazione delle piccole comunità democratiche e anche come garante del riconoscimento della reciproca interdipendenza e quindi della cura come principio organizzatore della società. In quest’ottica ogni Stato dovrebbe partire dal




riconoscimento delle atrocità compiute nel passato e dalla riparazione materiale delle comunità colpite, dalla decolonizzazione e dal riconoscimento dell’imperialismo come origine delle disuguaglianze: solo allora, sostiene il gruppo di autori e autrici, saremo in grado di coltivare nuove modalità radicali di stare in relazione con gli altri e il mondo intero. Dovere degli Stati è allora lo smantellamento dello stato sociale keynesiano e la costruzione di uno stato di cura che metta al centro i «soggetti storicamente marginalizzati e riconosca a ogni abitante dello stato il diritto di dare e ricevere cura in tutte le sue accezioni». Questo nuovo stato non deve essere succube delle politiche economiche ma fautore di un’economia in cui «i mercati e i mezzi di produzione e consumo siano collettivizzati, socializzati e democratizzati, e quindi invertire il processo che ha sostituito le relazioni sociali con le relazioni tra merci e il valore della cura con il valore di scambio» (p. 88). Centrali sono le politiche economiche basate sui beni comuni e sul controllo democratico dei mercati, le cooperative, il riumanizzare il commercio rigenerando le economie locali.
5. L’ottica globale
L’idea del manifesto è fare una proposta che valichi i confini nazionali perché sia garantita la cura di tutti gli esseri umani e del pianeta intero, quindi anche animali e ambiente. Le proposte sono: lanciare un Green New Deal che permetta di affrontare la questione climatica e che prevede la creazione di «lavori green», l’espansione delle energie rinnovabili, la protezione dell’ambiente, la riforestazione, la riduzione della settimana lavorativa per diminuire le emissioni e aumentare il tempo di vita e i mezzi che abbiamo per prenderci cura di noi. Inoltre, secondo la proposta del collettivo, è necessaria la cancellazione del debito, l’interazione con l’economia femminista e le teorie ecologiste della decrescita, aumentare la porosità dei confini nazionali, agire sulle condizioni di povertà endemica di tante zone del mondo.



118


6. Conclusioni
Il manifesto della cura risulta essere un testo molto stimolante e attivante, soprattutto nella parte di critica al neoliberismo e nei primi tre livelli della rivoluzione antropologica che propone:
-
- il riconoscimento dell’interdipendenza reciproca;
-
- la necessità di interiorizzare i concetti di cura promiscua e universale;
-
- l’ampliamento delle comunità di cura autorganizzate, mutualistiche e democratiche.
In realtà non sono concetti completamente nuovi, in essi risuonano il «generate parentele, non bambini» di Donna Haraway, le teorie sui Beni Comuni, le T.A.Z. di Hakim Bey (seppure queste siano pensate in opposizione alle istituzioni, e non garantite dalle istituzioni) e altre teorie nate in ambiente anarchico e non.
Le proposte di politica internazionale appaiono però generiche, e rischiosamente generico e insidioso il ruolo attribuito allo Stato: può veramente lo Stato farsi garante della cura come principio organizzatore della società? Ci pare una posizione alquanto ingenua. D’altra parte aumentare i livelli di democraticità dentro di noi e nelle nostre comunità (questioni che, come detto, risuonano con molte pratiche dell’anarchismo) può portare a riflessioni interessanti a livello macro. Se il punto di arrivo è meno descrivibile, il punto di partenza del collettivo che firma il Manifesto è chiarissimo: partire da una prospettiva femminista, queer, antirazzista ed eco-socialista. Ognuno di noi avrà considerazioni più o meno critiche rispetto all’eco-socialismo, ma sono convinta che anche all’interno del mondo anarchico sia necessario contaminarsi con le lotte femministe, queer, antirazziste, decoloniali e ambientaliste, perché tutte sono interessate allo smantellamento di agglomerati di potere che impediscono a soggetti specifici umani e non umani l’autodeterminazione e, spesso, la vita. Il Manifesto della cura, in questo senso, è una lettura molto stimolante e con cui si può entrare in dialogo.
The Care Collective, Manifesto della cura. Per una politica dell’interdipendenza, Edizioni Alegre, Roma, 2021.



MUSICA
Andrea Satta Niente di nuovo tranne te dopo l’amore e la rivolta
Felice Liperi
Pediatra in bici della periferia romana, narratore del pensiero e della parola, Andrea Satta ha da poco pubblicato Niente di nuovo tranne te, il suo esordio discografico da solista dopo una carriera di oltre 30 anni con i Têtes de bois*.* Solitaria formazione dedicata alla canzone francese in Italia grazie a un rapporto molto stretto con Leo Ferrè soprattutto dopo il trasferimento del grande cantautore in Toscana. Uomo dalle mille iniziative, con questo nuovo album si lancia in un lungo viaggio nella memoria di famiglia dove riappaiono una fisarmonica verde e biciclette che diventano macchine d’energia. Così emerge un tessuto musicale fatto di salite e discese emotive, come metafora di vita e di pedali.
Niente di nuovo tranne te è una raccolta di canzoni che parla di persone comuni alle prese con problemi quotidiani, influenzata dagli amori per gli chansonnier francesi e i grandi autori italiani, però forse diversi da quelli frequentati con i Têtes de bois. Lucio Battisti, ad esempio, spesso, anche nel brano d’apertura Coupon che Satta presenta «come una dedica che ognuno può fare a sé stesso o alla persona a cui si è più legati». Ma tutto l’album è molto attento alle parole, come in Bellissima dove il cantautore


spiega come i suoi viaggi possano essere importanti per capire che il mondo offre punti di vista diversi, anche personali, con passioni sovrapposte costruite nel proprio vissuto.
Le tue canzoni sembrano l’approdo di un evento personale, come ad esempio in Amore al centro commerciale dove proponi un testo che ricorda molto lo stile di Piero Ciampi.
Assolutamente, in questo caso è stato ispirato da una storia vera, anche se trasfigurata. Mi trovavo in bicicletta a un centro commerciale di Roma Est con un pratone dietro al quale c’erano mucche al pascolo quasi coperte da un cartellone immobiliare che pubblicizzava la vendita di case con panorama agreste. È passato del tempo e sono tornato in quel luogo, il cartellone era arretrato perché nel frattempo le costruzioni avevano riempito gli spazi però l’annuncio era lo stesso: case bellissime con splendidi panorami. In definitiva si vendeva un’illusione e un imbroglio. Quanto a Ciampi sono onorato di averlo evocato perché mi piaceva il suo modo diretto di raccontare la realtà e i sentimenti anche più sofferti.
Hobo Sapiens sembra avere un testo in bilico fra Vasco Rossi e Pasquale Panella?
Questa canzone intreccia due storie, quella di mio figlio Lao, che vive a Terni con la madre e dopo un passaggio a Roma mi ha chiesto di accompagnarlo al treno perché voleva stare con i suoi amici. L’altra propone un incontro con un clochard sul marciapiede della stazione, si chiama Mohamed Keita, ed è la prima volta che Lao vede un clochard. Lo avvicino per capire qual è la sua storia e se posso fotografarlo poi gli propongo di avvicinarsi lui alla fotografia per mettere a profitto la sua fantasia, si scopre così che ha un talento da fotografo: un hobo sapiens, appunto.
Abbi pazienza ricorda una classica riflessione sulle nostre nevrosi, un po’ alla Gaber.




L’idea mi è stata suggerita dal fatto che proviamo a stare attenti ma siamo sempre distratti da tutto e sembra che sappiamo già tutto, o magari lo crediamo solo, o forse è una semplice metafora dello Smart Phone e del fatto che siamo sempre pronti a scusarci dall’estrema distrazione che ci pervade.
Cosa ti ricordi di tuo padre apre un capitolo personale fondamentale per la tua vita.
Un confronto con la realtà che non potevo escludere dal mio primo disco perché credo che mio padre sia stato un eroe normale lanciando il segnale che dobbiamo essere pronti a reagire. Poi questo brano apre un capitolo centrale della mia vita dove è fondamentale l’idea che l’amore non finisce mai. Come quando mio padre ha ripreso in mano la fisarmonica e gli sembrava qualcosa di vivo.
Ma quella fisarmonica ha un significato molto più profondo.
Richiamava il lungo viaggio in una meta lontana, in Germania, quasi al confine con la Polonia: un campo di concentramento nazista, in cui fu rinchiuso mio nonno Gavino. In questo viaggio nella memoria si è sciolta la matassa dei ricordi che legano nonno, padre e figlio e sullo sfondo si sovrappongono i ricordi della Sardegna degli anni Trenta, storie d’amore e di vendetta, poi della Roma del dopoguerra, in cui la vita può rifiorire.
Protagonisti di questa storia siete tu, tuo padre e tuo nonno?
Nonno Gavino, mio nonno, era un soldato italiano considerato traditore dopo l'8 settembre, per questo venne costretto a salire su un treno e fu deportato a Lengenfeld. Qui conobbe fame, fatica e umiliazione. Di ritorno dal lager, portò con sé una fisarmonica verde e un segreto racchiuso nella sua anima ferita, quella di un uomo normale che non voleva perdere di vista la memoria.




Ecco perché la fisarmonica diventa un oggetto simbolico di una esperienza drammatica e di una rinascita.
Poi però questo viaggio l’hai fatto con tuo figlio Lao?
Un viaggio e un racconto a partire da oggetti ritrovati – un cappotto rosso, un documento che denuncia una strage e una fisarmonica verde – durante il percorso in bicicletta con Lao in cui abbiamo ripercorso le tappe del lungo ritorno a casa del nonno Gavino.
Una peculiarità della tua esperienza artistica mi sembra quella che tu riesca a viverla in modo totalizzante con la vita e le esperienze che fai, per esempio il tuo lavoro di pediatra che sembra molto legato a quello del cantautore.
C’è una magia nella nascita dei bambini che sta nella loro trasformazione, prima appena nati sono scuri, se non paonazzi, poi diventano chiari, vivi. È qualcosa di inspiegabile come il modo casuale con cui si è salvato mio nonno.
Come ho detto nel tuo album si sente l’influenza di Ciampi, Battisti, Panella, in alcuni testi Capossela, meno dei francesi, com’è cambiato il rapporto con quei cantautori che hanno ispirato i Têtes de bois?
Probabilmente per una ragione linguistica dato che la lingua francese è stata lentamente sostituita dall’inglese e per questo la conoscenza della canzone francese è stata più complicata anche perché i suoi testi sono fondamentali e questo naturalmente l’ha penalizzata. Ciò non toglie che per me, per noi Têtes de bois, il rapporto in particolare con Leo Ferré rimane molto profondo anche perché siamo di casa a Castellina in Chianti, il luogo dove si è trasferito in età matura.
C’è qualcosa di pacificante nelle tue nuove canzoni.




Forse perché Niente di nuovo tranne te raccoglie tutta la mia vita in canzoni, nel mio sguardo tra periferia e provincia. Nessuna situazione estrema, apparentemente, solo una quotidianità sfibrante che inesorabilmente travolge, in cui nascono e finiscono amori e ipotesi di domani. Storie vere, vissute, intercettate da un balcone o alla fermata di un bus o forse nel mio ambulatorio.
O forse perché sei stato spesso coinvolto in performance stupefacenti?
In effetti nella mia vita ho avuto la possibilità di fare molte cose bizzarre e appassionanti, ho suonato nella vasca delle otarie allo zoo, per anni su un vecchio camioncino-palco, ho ideato il Palco a Pedali, ho fatto l’inviato al Tour de France e al Giro d’Italia e tanti concerti nelle stazioni abbandonate, nelle gallerie, sulle scale mobili, al centro di rotonde stradali, nelle fabbriche che sputavano amianto. Ora, i Têtes per i nostri 30 anni mi hanno concesso una licenza-premio, ho preso la mia carta d’imbarco e scelto un altro suono, per navigare nel mare che ho in testa. Ho scritto le mie canzoni però non dimentico «l’amore e la rivolta».
Con i Têtes de bois Andrea Satta ha vinto tre Targhe Tenco Interpreti, pubblicato nove album, compiuto migliaia di performance nei festival di strada e sul palco di Sanremo con Paolo Rossi. Ha scritto I riciclisti, Ci sarà una volta, Officina Millegiri, Mamma quante storie! libro ispirato alla Giornata delle Favole, che organizza da anni nel suo ambulatorio, Pise e Pata - dialoghi tra bambini sulle cose del mondo, e La fisarmonica verde.






