Uno sguardo non indifferente
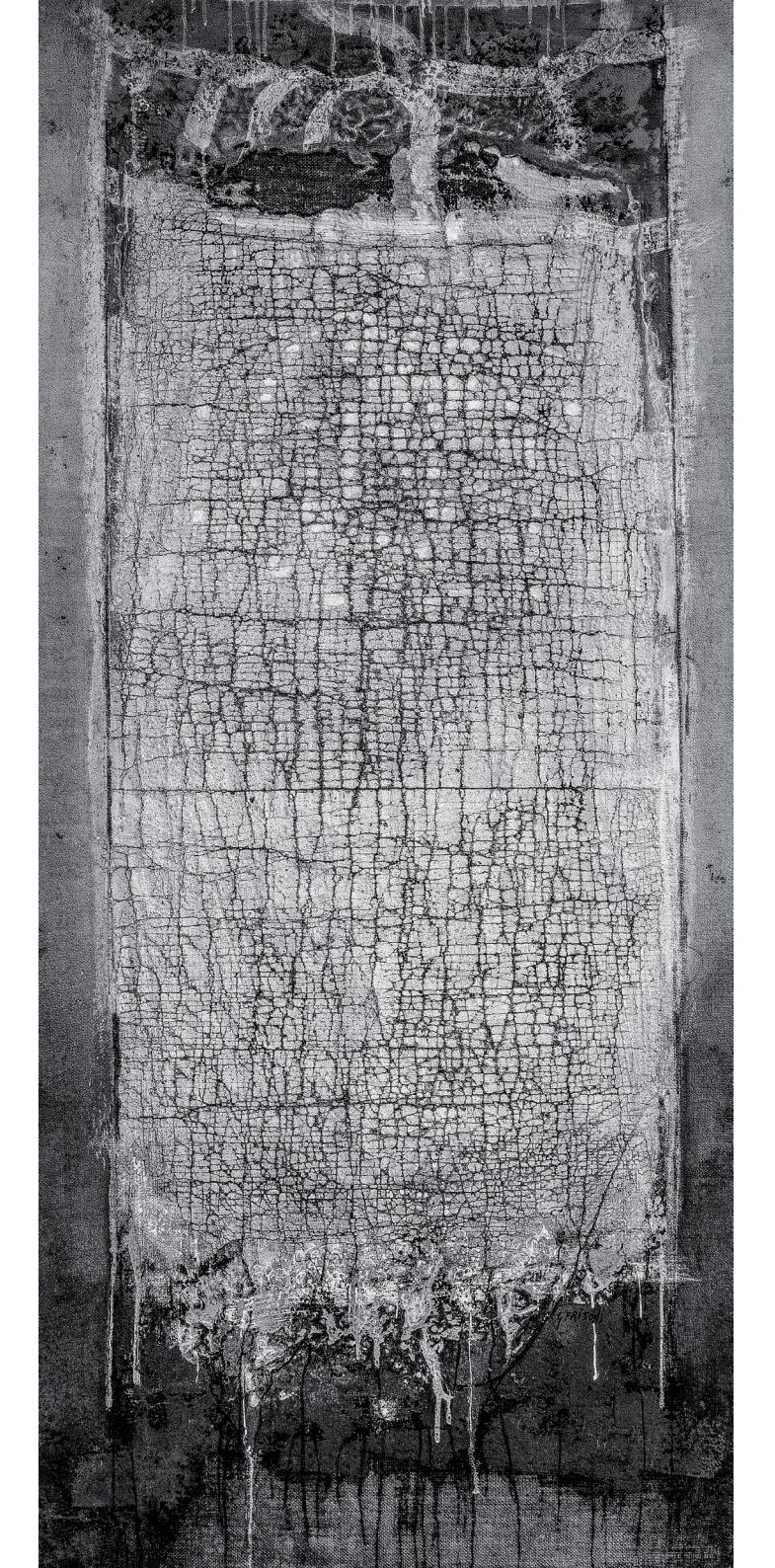
P E R C O R S I DI VISIONE Uno sguardo non indifferente Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri
Sono molte le atrocità nel mondo e moltissimi i pericoli. Ma di una cosa sono certo: il male peggiore è l’indifferenza. Elie Wiesel
Le parole di Elie Wiesel, sopravvissuto all’Olocausto e Premio Nobel per la pace, assumono un significato ancora più profondo in questi tempi complessi. L’indifferenza è quel distacco emotivo che, di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze altrui, ci consente di voltare lo sguardo da un’altra parte, rivelandosi così una delle minacce più sottili alla nostra umanità. Paradossalmente, sono proprio la sovraesposizione mediatica e il consumo superficiale delle immagini, tipici del nostro tempo, a produrre un effetto anestetizzante sulle coscienze, rendendo abituale l’orrore. In questa cornice, il cinema, grazie allo «sguardo non indifferente» di alcuni registi e registe, ci costringe a guardare ciò che preferiremmo ignorare e a provare ciò che spesso scegliamo di non provare. L’indifferenza ha un raggio d’azione vastissimo e, spesso senza che ne siamo pienamente consapevoli, tocca gli aspetti più profondi del nostro vivere. Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto e complesso, quello che vogliamo proporre è un percorso di visioni per esplorare come il cinema, può essere uno spazio di consapevolezza e responsabilità capace di porre domande scomode e sollecitare a un confronto autentico con le conseguenze dell’indifferenza, sia individuale che collettiva.
Poche pellicole incarnano il concetto di «sguardo non indifferente» con la forza di No Other Land. Vincitore dell’Orso d’Argento alla Berlinale e dell’Oscar come Miglior Documentario nel 2025 – eppure introvabile negli Stati Uniti, dove nessun distributore l’ha comprato – il film rappresenta in maniera esemplare il potere dell’immagine come strumento di testimonianza e resistenza. È stato realizzato da un collettivo di registi israelo-palestinesi uniti in un progetto comune, due dei quali – Basel Adra, attivista palestinese e Yuval Abraham, giornalista israeliano – sono anche protagonisti, voce narrante, sguardo e coscienza. Siamo a Masafer Yatta, una regione semi-desertica nel sud della Cisgiordania occupata, sottoposta al pieno controllo militare israeliano. L’area è stata dichiarata «zona di tiro», destinata all’uso militare, e come tale da svuotare dei suoi abitanti attraverso saccheggi, demolizioni e la privazione dei mezzi di sussistenza. Il film mostra gli aspetti più brutali del colonialismo israeliano in Cisgiordania, non si concentra sul dinamismo del conflitto, ma sulla sua reiterazione: documenta lo schema degli sgomberi e la sistematicità della distruzione che si ripete nel tempo, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Lontano da ogni spettacolarizzazione, lo sguardo della macchina da presa, mostrando la metodicità della violenza, spinge a riflettere sul tempo immobile e ciclico che definisce la tragedia quotidiana della Palestina. Durante le riprese Basel e Yuval riflettono sulla necessità stessa di filmare: a cosa serve «mostrare», si domanda Basel, se il cinema non riesce a scalfire l’indifferenza, ma si limita a suscitare un’emozione passeggera, uno sdegno che non diventa azione né consapevolezza? In questo senso, No Other Land non è un film che documenta l’ottimismo o la speranza, ma esplora il potere della testimonianza attiva come strumento di trasformazione, anche in un contesto in cui il cambiamento appare quasi impossibile.
Uno sguardo non indifferente è quello della regista macedone Teona Strugar Mitevska, la cui filmografia si distingue per un impegno politico lucido e una costante interrogazione delle strutture di potere. In Dio è donna e si chiama Petrunya (2019), ambientato nella Macedonia contemporanea, la regista racconta la storia di una giovane donna, laureata in storia ma senza impiego, che casualmente infrange un rituale religioso – il tuffo nelle acque gelide di uomini a torso nudo per recuperare un crocifisso di legno lanciato da un sacerdote – riservato agli uomini, facendo così esplodere le tensioni latenti tra religione, Stato e patriarcato. La protagonista, accusata di nulla se non di essere fuori posto in quanto donna, diventa simbolo di una ribellione silenziosa ma radicale contro l’ordine sociale. Quasi divertita da tutto ciò che le succede attorno, Petrunya prende coscienza di non aver bisogno della «croce»: può lasciarla nelle mani della Chiesa, dello Stato, della polizia, di qualunque struttura e tradizione patriarcale che necessita invece di un pretesto per affermarsi. Lei è libera e, come tale, si aggira stringendo tra le braccia il busto di un manichino: quello di una donna che non esiste se non nell’immaginario di chi vuole controllarla.
In L’Appuntamento (2022), Teona Strugar Mitevska cambia registro ma non intensità. Ispirato a una storia realmente accaduta alla sceneggiatrice bosniaca Elma Tataragic, il film si svolge in una Sarajevo post-conflitto, dove una donna si ritrova faccia a faccia con l’uomo che le ha sparato durante l’assedio. Lo spazio chiuso dell’incontro è denso di silenzi e sguardi trattenuti: non c’è vendetta né redenzione, solo la convivenza forzata tra vittima e carnefice, emblema di una pace apparente che non risolve ma rimuove. L’Appuntamento è un’indagine introspettiva profonda sui traumi della guerra che permangono anche dopo le armi con tutti gli interrogativi su colpa e perdono, sulle tensioni tra memoria e oblio, tra giustizia negata e bisogno di andare avanti.
In entrambi i casi, per la regista macedone il cinema è un atto politico: non tanto perché denuncia apertamente, ma perché scava sotto la superficie del reale, espone ciò che viene rimosso e restituisce complessità a ciò che la società tende a semplificare. Il suo sguardo non indifferente insiste sul dettaglio, sul corpo, sul gesto come forme di resistenza a ogni narrazione dominante. Alcuni film riescono a raccontare le realtà sociali di un Paese con maggior efficacia rispetto a tanti servizi giornalistici: è il caso del cinema iraniano che, nonostante la censura e la repressione, continua a denunciare la vita sociale e politica del paese attraverso un linguaggio cinematografico ricco di simboli, metafore e allusioni che veicola messaggi di resistenza. È un cinema che rischia, resiste e testimonia: nonostante la censura, gli arresti e le condanne, registi e registe non smettono di raccontare con le immagini ciò che il regime vuole oscurare. Il male non esiste (2023) di Mohammad Rasoulof pone al centro il tema della pena di morte, che in Iran non colpisce soltanto chi si è macchiato di reati gravi ma anche i dissidenti, oltre a essere prevista anche in caso di blasfemia, possesso di droga, adulterio o contrabbando di opere d’arte. Stando ai dati di Amnesty International, nel 2024 in Iran si è registrata una media di un’esecuzione capitale al giorno, barbara prassi ancora condivisa da troppi Paesi, tra cui Cina, Giappone e Stati Uniti. Il regista, autore di numerose opere precedentemente censurate, è stato condannato a dieci anni di prigione e costretto, nel 2017, a lasciare l’Iran. Il film è composto da quattro episodi, ciascuno caratterizzato da una propria struttura narrativa – dal dramma familiare all’azione, dal sentimentale al thriller – che ruotano intorno a quattro personaggi le cui storie, seppur diverse, si intrecciano attorno al tema della pena di morte. Ciascuno dei quattro protagonisti dovrà misurarsi con una scelta destinata a cambiare la propria esistenza: accettare o rifiutare il ruolo di boia nelle esecuzioni per impiccagione, nella consapevolezza che, punendo i colpevoli e accompagnandoli alla morte, finirà per condannare anche la propria coscienza. In quanto esseri umani, siamo chiamati a confrontarci con le implicazioni etiche delle nostre azioni, anche quando queste rientrano in un quadro normativo che impone ordini da eseguire. L’adesione a regole ingiuste o a comandi imposti dall’alto non può automaticamente assolvere chi li mette in pratica: il fatto di agire «per dovere» o «per legge» non elimina la dimensione personale delle scelte. La storia, non solo quella recente, è piena di esempi in cui l’obbedienza cieca ha portato a violazioni gravi della dignità umana. In questo senso, ogni atto compiuto, anche nel rispetto di un ordine superiore, resta inscritto nella sfera della responsabilità soggettiva e chiama ciascuno a una presa di posizione consapevole.
Un altro sguardo scoraggiante sulla società iraniana è offerto da Il mio giardino persiano (2024), di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, registi a cui il regime ha sequestrato il passaporto e impedito di accompagnare il film alla Berlinale. Si tratta di una commedia amara e malinconica, punteggiata da una sottile ironia, che racconta la vicenda di Mahin, un’anziana vedova dall’indole indipendente, cresciuta nell’Iran pre-rivoluzionario e forse per questo incline a sfidare le regole della Repubblica Islamica. Quando una giovane finisce nel mirino della polizia morale, Mahin sceglie di esporsi per difenderla, animata da un profondo senso di giustizia e da un desiderio di affetto che la società le nega. Nel corso di una serata, all’interno del rifugio domestico, si crea un inatteso legame con Faramarz, un tassista solitario, che apre uno spiraglio di umanità e tenerezza in un mondo oppressivo. Ma anche i momenti di dolcezza si rivelano fragili, destinati a infrangersi contro una realtà politica che vieta alle donne non solo la libertà pubblica, ma persino la possibilità di vivere l’intimità senza colpa. Il film si chiude con una scena dal forte valore simbolico, che trasforma il gesto privato in un atto di resistenza, restituendo voce e dignità a chi non ha il diritto di scegliere.
Ci spostiamo in Romania per parlare di Animali Selvatici (2022) di Cristian Mungiu, autore capace di raccontare la contemporaneità rumena con uno sguardo sulla società come elemento umano collettivo. Basato su un fatto di cronaca realmente accaduto nella regione della Transilvania – dove coabitano da sempre rumeni, ungheresi e tedeschi – il film racconta la sollevazione indignata e impaurita degli abitanti di una piccola comunità all’arrivo di tre operai provenienti dallo Sri Lanka, regolarmente assunti in un grande panificio solo per raggiungere il numero minimo di dipendenti necessario a ottenere i finanziamenti dell’Unione Europea. Questo luogo marginale e periferico si trasforma nel palcoscenico delle contraddizioni della globalizzazione: un villaggio ormai spopolato, dove, da un lato, nessuno è disposto ad accettare il salario minimo offerto dalle aziende, e, dall’altro, vengono rifiutati proprio quei lavoratori extraeuropei che, soli, accetterebbero quelle condizioni. Il film affonda la lama nei mali che attanagliano la società europea: razzismo e rifiuto del diverso, populismo e crisi della democrazia, impoverimento e crescita delle disuguaglianze. La forza della pellicola sta nella sua capacità di non esprimere giudizi morali, mostrando invece come le contraddizioni del sistema economico globale creino tensioni apparentemente insanabili tra le comunità locali e i flussi migratori. Quando la comunità si sente minacciata dall’arrivo degli «estranei», la razionalità cede il passo alla paura dell’altro: gli Animali Selvatici sono gli stessi abitanti del villaggio che, spinti dalla paura e dall’insicurezza, regrediscono a comportamenti primordiali, trasformandosi in un branco che agisce secondo logiche territoriali e di sopravvivenza.
Andiamo in Africa. Mentre l’attenzione mediatica globale si concentra su altri scenari di crisi, il Sudan resta una delle guerre più dimenticate del nostro tempo, un conflitto che si consuma nell’indifferenza generale nonostante la sua devastante portata umanitaria. A ricordarci questa realtà rimossa interviene la regista franco-tunisina Hind Meddeb, autrice di numerosi lavori in zone dimenticate tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Con il documentario Sudan, Remember Us (2024), presentato alle Giornate degli Autori all’interno della Mostra del Cinema di Venezia, Meddeb ci porta in un Sudan immediatamente successivo alla destituzione, tramite un colpo di stato, del dittatore Omar al-Bashir, portandoci dentro lo scenario di una guerra civile che continua ancora oggi a lacerare il paese.
La regista racconta i sogni dei giovani e delle giovani attivisti e attiviste sudanesi che, con parole, poesie e canti, lottavano per la libertà, sfidando il potere e la repressione. Senza il sogno che animava le loro azioni, la potenza dell’immaginazione e la forza delle loro espressioni artistiche non sarebbero stati e state in grado di rovesciare il regime precedente. Il loro sogno era un’esistenza basata sull’autosufficienza, la giustizia, la libertà e la dignità, un sogno che svanì quando, dopo cinquantasette giorni di sit-in rivoluzionario a Khartoum, l’esercito irruppe, massacrando centinaia di persone e distruggendo ogni speranza di un nuovo Sudan.
I film citati, nella loro diversità stilistica e tematica, non offrono facili consolazioni, ma invitano a una riflessione profonda sui meccanismi di potere, sulle ingiustizie sociali e sulle responsabilità individuali. Quando l’autorità – sia essa religiosa, statale o economica – impone narrazioni univoche che escludono o emarginano, il danno non riguarda solo chi subisce direttamente la discriminazione, ma corrode il tessuto stesso della società. Adottare uno sguardo non indifferente, come quello scelto da registi e registe che spesso operano in condizioni difficili e pericolose, significa allora riconoscere e denunciare le connessioni tra ideologie conservatrici e interessi economici, tra retorica nazionalista e disuguaglianze sociali. Ma significa anche, per noi spettatori e spettatrici, assumerci la responsabilità del nostro sguardo, che non dovrebbe mai essere neutrale: solo lasciandoci coinvolgere, rinunciando alla distanza protettiva di cui godiamo e accettando il rischio di lasciarci trasformare dalla visione di questi film, possiamo far nascere una consapevolezza capace non solo di resistere, ma anche di agire per produrre un cambiamento.