Numero Completo 12
INDICE
| ESPERIENZE | Editoriale | 3 |
|---|---|---|
| - Demetra Forno di Paese - Autocostruzione a Monaco - Sempre più in alto |
Sabrina Bianchi Alberto Franchini Alberto (abo) Di Monte |
9 15 31 |
| APPROFONDIMENTI | ||
| - Smascherando il mansplaining - La legge sulla sicurezza n. 80/2025: condizionamenti alle pratiche libertarie e alle lotte anarchiche - Il pianeta si è accorto degli smartphone - Pedagogia hacker, o dell’autogestione |
Mariangela Mombelli Marco Ferrero Micorriza Carlo Milani |
45 51 60 71 |
| CONVERSAZIONE | ||
| - con Pietro Babina | a cura della Redazione |
81 |
| INTERNAZIONALE - Colin Ward: un’ambigua eredità |
Matthew Wilson |
97 |
| RADICI | ||
| - Itō Noe - Paul Goodman |
Francisco Soriano Pietro Adamo |
109 115 |
| MUSICA | ||
| - Sperimentare musica fra antagonismo e anarchia | Felice Liperi |
123 |
| PERCORSI DI VISIONE | ||
| - Uno sguardo non indifferente | M Mombelli e E Ruggeri |
133 |
| VOCABOLARIO POLITICO | ||
| - Anarchismo e democrazia | Francesco Berti |
141 |

Editoriale
Ottant’anni fa il mondo tragicamente conosceva gli esiti reali della bomba atomica. Quello che apparve da subito come il male assoluto dell’impiego dell’energia atomica in ambito militare sconvolse il mondo intero e ancora oggi rappresenta un monito non cancellabile per ogni coscienza libera e civile.
Ma in questo mondo così veloce, che cancella il passato e non immagina il futuro, che vive solo in un presente immediato, rapido, consumistico in ogni aspetto della vita quotidiana, sembra proprio che la storia non sia proprio magistra vitae. Si stima infatti che nel 2025 siano attivi ben 56 conflitti armati che coinvolgono 92 paesi del mondo. Gli orrori e le tragedie che producono le guerre continuano ad alimentare il nostro presente continuo. Quando Kurt Vonnegut diceva che «gli esseri umani sono scimpanzé che quando si ubriacano di potere perdono il controllo» affermava una verità inconfutabile. Come non comprendere lo scoramento, il pessimismo, la disperazione perfino, che trova sempre più diffusione tra noi abitanti di questo mondo così minaccioso? Gaza, Uganda, Sudan, Ucraina, Siria, Trump e Putin, il governo Netanyahu e Hamas, e l’elenco può continuare, sconvolgono giustamente le nostre vite, ci sbattono in faccia ogni giorno l’orrore in modi diversi ma uguali negli esiti tragici. Abbiamo davanti agli occhi le immagini terrificanti di ciò che è accaduto e sta accadendo, del dolore, della morte, della distruzione. Niente e nessuno è risparmiato da queste sconvolgenti tragedie. Soprattutto vittime innocenti, donne e bambini, che pagano con la morte le follie della violenza, delle guerre, della barbarie causate dalla bramosia di potere e dalla ferocia del dominio.
Eppure proprio perché riteniamo valido il monito di Lev Tolstoj: «Fai quel che devi, accada quel che può!» noi continuiamo a fare la nostra piccola parte, resistiamo e portiamo la nostra goccia d’acqua per spegnere l’incendio. Non solo quindi insistiamo in questa strada, impervia e tortuosa, ma siamo convinti che proprio in questa situazione, che appare realisticamente quasi irrisolvibile, occorra osare e andare oltre ogni paralizzante pessimismo. Lo spirito di questa rivista, il suo dna, è un approccio propositivo e positivo, a dispetto e in alternativa alla infinita ed estrema negatività. Impresa difficile, forse impossibile, ma senza alternative a nostro modo di vedere. Ne siamo consci e informati. Proprio in virtù di ciò, di questa consapevole scommessa, pensiamo che l’unica via possibile di uscita dall’incubo della disperazione sia l’utopia. In un mondo distopico come quello che ci appare solo l’utopia può aiutarci a resistere e a uscire dal tunnel. Non è una fuga dalla responsabilità, anzi è proprio il contrario quello che proponiamo. La domanda che continuamente ci poniamo è rivolta a capire e a indagare quanto questi sentimenti di disperazione possano alimentare altre negatività, fino a condurci alla completa paralisi e quindi alla sconfitta di ogni speranza e di ogni alternativa. Avere una visione ampia, plurale, aperta, di un futuro diverso (si badi bene non perfetto) è indispensabile e necessario. Senza una visione, senza quella che i cosiddetti realisti considerano l’impossibile, siamo destinati a soccombere. Solo questi sentimenti utopistici possono scrollarci di dosso l’impotenza e impedirci di aderire al partito della servitù volontaria. Stimolare un altro immaginario, l’idea della pluralità e della varietà dei mondi possibili, aiuta sicuramente a rompere le catene di una realtà considerata dai più come inevitabile e insuperabile. Un nuovo immaginario, che si costruisce giorno per giorno, nelle pratiche di vita reale diversa, rappresenta, a nostro parere, una possibile strada da intraprendere assieme, per aumentare, come diceva il nostro Colin Ward, il tasso di anarchismo in questo mondo. Non esiste un totalmente altro, esiste ed è perseguibile il parzialmente altro, pezzo dopo pezzo, di una società diversa, che cambia e si modifica cammin facendo con lo sguardo alto e di grande respiro che solo una visione può dare. In fin dei conti utopia è qualsiasi progresso sociale prima che si realizzi. Questa utopia è rappresentata dalle tante persone che in ogni angolo del pianeta non hanno rinunciato a lottare, a sperare, a sognare e a desiderare, con tutta la loro forza e la loro tenacia, che un mondo diverso non solo è possibile ma è urgente e necessario e fin da subito e concretamente lo sperimentano. Noi vogliamo sentirci parte di questa umanità.
In questo numero della rivista vi presentiamo come sempre alcune «esperienze» concrete che possono essere stimolanti per ciascuno di noi per farci riflettere su tante possibilità di sperimentazione e di prefigurazione sociale in senso antiautoritario. Ecco così il racconto di Sabrina Bianchi e del forno di paese «Demetra» a Longiano, in Romagna, spazio di produzione e distribuzione di pane ma anche luogo di incontro e di scambio, di condivisione e di riflessione a tutto campo. Poi la descrizione di un altro esempio di autocostruzione a Monaco di Baviera, fatta in maniera anche tecnica dal nostro collaboratore Alberto Franchini. Infine una riflessione quanto mai attuale di Alberto (Abo) di Monte sulla montagna e sulla storia e il senso ancora oggi importante di un’associazione di escursionisti ed esploratori di vette e boschi montani.
Nella sezione «approfondimenti» Mariangela Mombelli fa il punto sulla situazione e sulle riflessioni necessarie in merito al tema del femminismo contemporaneo. Marco Ferrero, avvocato, commenta e sviluppa importanti concetti giuridici che hanno una immediata concretizzazione in norme e in leggi che utilizzano il tema della migrazione come laboratorio di pratiche autoritarie e discriminatorie. Infine due interessanti contributi che hanno come connessione tra loro un medesimo argomento di fondo: l’uso e l’abuso del digitale. Il primo, di Micorriza, ci fa riflettere sull’uso dello smartphone e sulle conseguenze che questa tecnologia implementa nelle abitudini quotidiane e nella cultura di massa oggi presente. L’altro di Carlo Milani (membro di CIRCE, Centro Internazionale di ricerca per la convivialità elettrica) sulla pedagogia hacker. Nel denunciare i risvolti autoritari e condizionanti di queste tecnologie ambedue gli autori ci stimolano a definire e praticare relazioni appropriate col digitale per abituarci a decolonizzare le nostre menti e le nostre pratiche e ad abitare la tecnologia con un’attitudine conviviale.
La «conversazione» di questo numero della rivista è con Pietro Babina, registra, scenografo, autore, interprete, che ci presenta la sua visione dell’anarchia come antidoto al dominio e tensione all’utopia, tema che cerca di affrontare con le sue opere.
Nella sezione «internazionale» potrete trovare un articolo scritto da Matthew Wilson nel quale presenta con chiarezza ed efficacia il suo riconoscimento intellettuale nei confronti di Colin Ward, autore che i nostri lettori conoscono e che rappresenta un punto di riferimento decisivo nella linea editoriale della nostra rivista.
Le consuete due «radici» questa volta sono dedicate a Paul Goodman (Pietro Adamo) e alla giapponese Noe Itō (Francisco Soriano). Continuano come sempre le nostre due rubriche dedicate alla musica (Felice Liperi) e al cinema (Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri).
Completa questo numero un saggio di Francesco Berti sul rapporto tra democrazia e anarchia nella sezione «Dizionario politico». Dopo la disamina dei concetti di violenza e non violenza (apparsi nel numero 7, febbraio 2024 della rivista) questo secondo contributo di Berti si concentra appunto sul rapporto che intercorre tra la democrazia e l’anarchia mettendone in evidenza relazioni e contraddizioni.
Vi proponiamo quindi un numero ricco e vario e vi invitiamo, come sempre, a scriverci e darci il vostro parere, a proporre temi, argomenti, a sottolineare aspetti e limiti della nostra rivista che pur avendo una sua precisa linea politica ed editoriale, è aperta al confronto e al dialogo in termini propositivi e positivi. Ricordiamo come sempre, ma dobbiamo farlo, che l’unico modo per sostenere i nostri sforzi è abbonarsi e presentarla in ambiti e situazioni diverse.
Chiudiamo questo editoriale ricordando la prima edizione della BOAB – Bologna Anarchist Bookfair (boab.zone) dove eravamo presenti nella collettanea delle riviste e nello stand di elèuthera. In due giorni circa 1.000 persone, oltre 30 banchetti di case editrici, riviste e archivi e 4 tavoli di discussione e confronto molto partecipati. Tutto ciò dimostra la grande ricchezza di idee e varietà di contenuti dell’attuale pubblicistica anarchica e libertaria di cui con la nostra rivista siamo pienamente parte.
Buona lettura.

ESPERIENZE Sabrina Bianchi Demetra Forno di Paese
Demetra è un forno molto piccolo. Si trova nel centro di Longiano, un paesino sulle colline romagnole. Ha aperto le porte nel 2020, nei duri giorni del Covid. Oggi, dopo quasi cinque anni, tira un sospiro di sollievo per esserci ancora, nonostante i primi mesi difficili e l’ubicazione all’interno di un contesto piccolo e spesso diffidente. Tutto è cominciato in modo molto semplice: una persona a fare pane e dolci in laboratorio, e un’altra al banco di vendita. Eppure, fare il pane per venderlo agli altri non era il solo intento di Demetra. Il progetto è stato immaginato e pensato per diversi anni. Se l’obiettivo del primo periodo era quello di sopravvivere, per assolvere la necessità primaria del forno – ovvero autosostenersi e dare da vivere a chi ci lavorava – l’immagine successiva era quella di un luogo in cui, attraverso il pane, le persone si sarebbero potute incontrare e avrebbero avuto la possibilità di condividere interessi, scoprire nicchie e realtà esistenti sulle colline di Romagna.
Facciamo un passo indietro: perché Demetra?
Nel mito orfico, Demetra è colei che insegna agli esseri umani a coltivare la terra e a trasformarne i frutti. Durante la ricerca della figlia Persefone – rapita da Ade, divinità infera – viene accolta da una famiglia povera ma generosa. In cambio dell’aiuto ricevuto, Demetra dona loro il sapere agricolo e i riti legati al grano. È in quel momento che l’umanità, fino ad allora legata alla sola sopravvivenza, entra in una nuova fase della sua esistenza. Secondo lo studioso Károly Kerényi, uno tra i più illustri interpreti del pensiero mitologico e filosofico antico, Demetra rappresenta il passaggio fondamentale dall’esistenza istintiva alla consapevolezza culturale. Kerényi scrive che, per i Greci, «l’uomo ha due nascite». La prima è legata all’animalità, alla sopravvivenza. La seconda avviene quando l’uomo entra in contatto con l’agricoltura e i suoi misteri. Questa rinascita coincide con l’apprendimento del pane e dei riti a esso connessi.
Il significato del nome Demetra nasce proprio da qui: il pane non è solo un alimento che nutre il corpo, ma anche un’occasione per agire nella realtà. Ogni volta che lo prepariamo e lo condividiamo, riportiamo al centro un’idea di umanità che ci ricorda che il fare ha un significato che va oltre la funzione. È un gesto quotidiano, ma può diventare anche un atto di emancipazione. Tutti i giorni entriamo in laboratorio e, tutti i giorni, ripetiamo azioni con costanza. Tuttavia, non si tratta di gesti alienanti. Al contrario, sono coinvolgenti e capaci di offrire una dimensione organica e trasformativa, per noi in quanto esseri umani e in quanto donne. Il pane è un elemento che fa parte dell’uomo. Ognuno lega a esso un ricordo, un ritorno, una memoria più o meno consapevole. Farlo ogni giorno aiuta a comprendere quanto ciascuno di noi sia il costrutto di ciò che è stato, con un margine di trasformazione che ci rende unici.
Una preparazione semplice: acqua, farina, lievito madre, sale e pazienza. Tante ore di lievitazione e poi in forno. Le pezzature sono grandi, almeno da un chilo, per fare in modo che si mantenga più a lungo, evitando così di doverlo acquistare ogni giorno. Ogni pagnotta viene formata a mano, messa nel proprio cestino e lasciata a lievitare. Il momento della formatura è quello in cui si capisce se l’impasto ha avuto tutto ciò di cui aveva bisogno per una buona lievitazione. È anche un bel momento di confronto e di silenzio, per noi che lavoriamo insieme dalla mattina molto presto fino al primo pomeriggio.
Fare il pane è ogni giorno uguale, ma ogni giorno diverso, la dimensione umana è fondamentale. Al momento, il laboratorio è costituito da tre ragazze: Sara, Barbara e me. Della vendita si occupa un’altra ragazza, Stephanie. Infine, Cristina si occupa delle pulizie alla chiusura del turno. La giornata lavorativa comincia alle cinque del mattino e termina attorno alle due del pomeriggio. Il ritmo del forno è quello delle persone che sì, ci lavorano, ma senza tirare il fiato. Le ore passate insieme sono momenti di confronto, non solo su ciò che facciamo nel lavoro, ma anche sulle nostre vite, sui bei momenti e sulle difficoltà, sui pensieri discordanti o affini. Insomma, il lavoro si inserisce nella vita, non la interrompe per poi concedere una ripresa alla fine della giornata.
L’esclusività della presenza femminile non è stata cercata, è capitata nel tempo. Le dimensioni dell’aiuto e del sostegno sono molto presenti. Non ci troviamo mai di fronte a episodi di pre-
varicazione o competizione. Il dialogo caratterizza il nostro modo di partecipare a un obiettivo comune, che è quello di guadagnarsi da vivere, ma anche quello di far vivere il forno come luogo di incontro e condivisione. Qui il pane non è solo merce di scambio. Lo mettiamo al centro e cerchiamo di richiamare chi, come noi, sente il bisogno


di agire. Proponiamo azioni da cui qualcosa possa iniziare, con il proposito di alimentare, in modo orizzontale, un pensiero e una prassi creativa che incidano sul sentire comune. A tal proposito, è presente un piccolo gruppo – di cui anch’io faccio parte – che si occupa di ciò che il pane non è: Federica, Giorgia e Matteo. Ogni mese realizziamo una pagina di informazione chiamata Semenza: un tentativo di condividere, con chi
ha ancora voglia di leggere, questioni che ci interrogano e che ci spingono ad aprire un dialogo. È un testo breve, leggibile nel tempo di un caffè, l’alternativa allo schermo del telefono. È come un fischio che cerca attenzione, e siamo felici di poter dire che in molti lo sentono.
Inoltre, circa un anno fa è nato il progetto di Selva, spazio pensante. All’ingresso del forno c’è una libreria in cui si può trovare una selezione di libri e riviste da sfogliare: questo è Selva. Abbiamo scelto questo nome perché rappresenta un grande spazio sul quale crescono, e resistono, tanti e diversi tipi di alberi spontanei. Nella selva piante diverse fra loro coesistono e affrontano condizioni climatiche più o meno impervie. È un terreno su cui differenti specie trovano un equilibrio, con forza si ritagliano un habitat, con tenacia stanno al mondo e lo rendono migliore. Proprio come le idee che accompagnano ogni singolo seme all’interno della libreria. Abbiamo realizzato questo spazio perché pensiamo sia importante cercare di difendere e far conoscere materiali editoriali proposti da persone che cercano di contrastare un’omologazione che toglie il movimento naturale che caratterizza gli esseri umani. Questo è un modo per stare vicino a chi si mette in prima linea per difendere quanto di più caro dovremmo avere: la libertà di pensiero e di espressione, e il diritto al dissenso.
Demetra è un forno ma avrebbe voluto
essere una piazza È giusto che un forno ospiti intenzioni di questo genere? È giusto che artigiani e agricoltori sollevino questioni che
esulano dal lavoro manuale? Penso che ognuno di noi sia ciò che fa. E penso che nessuno possa permettersi di vivere del proprio lavoro estraendosi dal contesto. Fare il pane non significa solo mescolare ingredienti e pensare a come rivenderli, significa entrare in un processo storico che ha attraversato epoche di fame, sofferenza e conflitti. Mettere le mani nella farina e nell’acqua implica una presa di responsabilità nei confronti del proprio agire come essere sociale. Implica una presa di posizione rispetto a chi partecipa alla filiera del pane. Quando si parla di filiera si astrae, si dimentica che la filiera non è un elenco di materie prime corredato di provenienza. La filiera è fatta di vite spese in piccoli contesti resistenti, in cui si cercano – fra piccoli produttori e trasformatori – relazioni che consentano il sostegno reciproco, lo scambio umano, l’aiuto lavorativo e, soprattutto, l’indipendenza. Indipendenza da una grande produzione che propone un’abbondanza fondata sullo spreco e sulla demolizione dei contesti aggregativi.
Demetra è un forno ma avrebbe voluto essere una piazza.
Vogliamo incontrare e parlare con le persone del paese e con chi viene da fuori, e cerchiamo di preparare giornate che ci consentano di farlo. Circa un anno fa è nata la Libera Infornata, una giornata in cui il forno è aperto a chi lavora i propri impasti a casa e poi viene a cuocerli qui. In questa occasione impastiamo a mano dal mattino, insieme a chi ha piacere di farlo, un

grande pane che poi condivideremo nel pomeriggio. Invitiamo persone che sentiamo affini a parlare di ciò che fanno e dei loro progetti. C’è sempre qualcuno che suona, e alla fine, attorno al pane e alla sua cottura, nasce una festa.
Per il futuro abbiamo un sacco di progetti e proviamo quotidianamente ad allargare il significato del pane. Cerchiamo di usare i linguaggi e le azioni a nostra disposizione per intessere legami che portino le persone a pensare insieme, guardandosi negli occhi e toccandosi. Perché il pane racchiude tutto questo: materia, sguardo, odore, movimento, respiro e terra.
Mi sembra appropriato riportare una citazione di Calvino:
Dal momento in cui un oggetto compare in una narrazione, si carica d’una forza speciale, diventa come il polo d’un campo magnetico, un nodo d’una rete di rapporti invisibili. Il simbolismo d’un oggetto può essere più o meno esplicito, ma esiste sempre. Potremmo dire che in una narrazione un oggetto è sempre un oggetto magico.
(Italo Calvino, Lezioni americane, p. 37)
Questo è il pane per Demetra: catalizzatore di significati, storie e vite spese, unite da una trama invisibile che appare sotto forma di pagnotta.

ESPERIENZE Alberto Franchini Autocostruzione a Monaco
Introduzione
La giornalista di Nature, Katharine Sanderson, ha scritto che l’ambiente costruito offre un’enorme opportunità per passare a un’economia circolare, poiché «gli edifici e l’industria delle costruzioni sono i maggiori consumatori di materie prime al mondo e contribuiscono al 25-40% delle emissioni globali di anidride carbonica» (Sanderson 2022). Con economia circolare si intende un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e dei prodotti esistenti il più a lungo possibile.
Sebbene centri il cuore della questione, Sanderson si limita a discutere di soluzioni high-tech ed evita di parlare di soluzioni low-tech. Queste ultime hanno il vantaggio di essere disponibili senza dover ricorrere a nuovi prodotti dalla tecnologia sofisticata che necessitano di una grossa concentrazione di capitali e di una complessa logistica che contribuisce anch’essa alle emissioni di CO2. Nel suo articolo e in molti altri dedicati a come costruire in modo più sostenibile non si parla nemmeno di quelle esperienze auto-organizzate che nel corso del Novecento hanno messo in pratica i principi dell’economia circolare (e del mutuo appoggio), prima che il concetto ricevesse un’attenzione da parte di importanti istituzioni, come ad esempio la Commissione europea.
Da alcuni anni sto studiando esperienze di autocostruzione auto organizzate nella ex-Repubblica Federale Tedesca, in cui famiglie in cerca di casa e architetti, spesso all’inizio della loro carriera, lavorano insieme per costruire utilizzando in modo più razionale le risorse. Questa ricerca corre in parallelo con la mia attività didattica e il coinvolgimento degli studenti della TU di Monaco (Technische Universität München) con i quali abbiamo riportato alla luce molte esperienze analoghe in altri paesi europei (Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito e Scandinavia) che hanno un notevole interesse per aiutarci ad affrontare le sfide del presente. Gli esempi riscoperti utilizzano approcci creativi basati sulle comunità locali, per affrontare le sfide ecologiche e sociali poste dalla crescita globale. La maggior parte di queste esperienze si distribuiscono tra gli anni Settanta e Ottanta, in contesti sociali con relativo benessere economico, capacità organizzative, fiducia reciproca e una consapevolezza riguardante la questione ambientale.
Residenza Collettiva a Monaco di Baviera
Mi concentrerò qui sull’analisi di un caso studio particolarmente significativo per mostrare questo approccio e le conseguenze sugli abitanti: l’edificio per sei famiglie nella Neubibergerstraße n. 28- 30 (1975-1978) a Monaco di Baviera, progettato da Doris (nome da nubile, Gröschel) e Ralph Thut. L’intero processo sarà analizzato in base alle diverse fasi del progetto, quali: l’acquisto del terreno; la fase di pianificazione; la valutazione delle esigenze espresse dai residenti; la bozza del progetto; la fase di costruzione; la fase di occupazione; la manutenzione e le modifiche. L’occupazione e le modifiche sono particolarmente importanti perché rivelano come il concetto di vita comunitaria si evolve e si modifica nel corso del tempo e come funzionano le strutture di autogoverno.
Intorno al 1968
Nel 1968 Doris e Ralph Thut incontrarono tre studenti di ingegneria, Lorenz Brandl, Peter Mülbauer e Sigfried Lederer, dell’Università Tecnica di Monaco. Ignari del loro futuro comune, si riunivano a leggere e discutere Il Capitale di Karl Marx con il vago obiettivo di scrivere un libro, che alla fine non si concretizzò, ma divenne per i Thut una pietra miliare per lo sviluppo di un loro pensiero teorico e pratico. Anche se vicini alla rivolta studentesca, i Thut, essendo stranieri (lei viennese e lui grigionese), preferirono rimanere distanti dalle proteste perché temevano l’espulsione dalla Germania. Tuttavia, portarono alcune delle idee del ‘68 nella professione, come il fai da te, l’auto-organizzazione, il mutuo soccorso, l’edilizia circolare e l’utilizzo dell’energia solare. La crisi climatica ebbe grande eco in quella che è stata definita New Left – il vasto movimento politico emerso dalla controcultura degli anni Sessanta e proseguito per tutti gli anni Settanta (Thompson 1997) – soprattutto dopo la pubblicazione di successo del primo incontro del Club di Roma, dal titolo: The Limits of Growth (Meadows et al. 1972 – trad it: I limiti dello sviluppo).
Baugruppe
Per dare una spinta alla loro carriera che stentava a partire, nel 1974, i Thut decisero di costruire e progettare un edificio di abitazione collettiva, come processo di autorealizzazione. Cercarono persone che si unissero a loro ma non fu facile. Alcuni studenti della Hochschule für Fernsehen und Film (Università della Televisione e del Cinema), che inizialmente si erano uniti al gruppo, se ne andarono dopo un po’ perché non volevano vivere fuori città, dove era più probabile trovare un lotto di terreno a un prezzo accessibile. Per questo motivo, ripresero i contatti con gli amici conosciuti nel circolo di lettura marxista. Il gruppo di costruzione (Baugruppe) era ora formato dai Thut, Lorenz Brandl e Ulrike Krakau, Christa e Siegfried Lederer, Rocque e Dorothea Lobo e Peter Mühlbauer. Al termine della fase di progettazione, il gruppo si rese conto che la costruzione di un’ulteriore unità abitativa avrebbe abbassato il costo di costruzione. Venne quindi aggiunta al progetto una sesta casa, venduta a Ursula e Jürgen Renner, i quali non parteciparono alla fase di progettazione. Uno dei motivi per cui il gruppo funzionò bene riguarda il fatto che appartenevano allo stesso gruppo sociale. Erano persone giovani, in prevalenza laureate, tra i quali tre ingegneri, un medico e un’insegnante.

Il gruppo di abitanti al lavoro. Archivio Thut.
Christopher Alexander
Nella primavera del 1975, i Thut si recarono in California per incontrare alcuni amici e cercare ispirazione. Durante questo viaggio, entrarono in contatto con alcune comunità hippie, visitarono alcuni villaggi nativi americani Hopi e il cottage di Etna Street, progettato e costruito a Berkeley da Christopher Alexander. Alexander era un architetto specializzato in un tipo di progettazione incentrata sull’essere umano; il suo libro A Pattern Language ebbe una grande influenza in diversi campi e in particolare nell’informatica (Alexander et al. 1977). Con il cottage, costruito nel 1973, Alexander tentò per la prima volta di sviluppare un sistema costruttivo organico e non convenzionale, che permettesse agli utenti di progettare i propri edifici e, in seguito, di ampliarli, modificarli e ripararli. Mentre il cottage di Alexander in Etna Street e i successivi esperimenti miravano a sviluppare «un processo di produzione in loco», i Thut all’epoca erano interessati a un sistema costruttivo che sfruttasse i materiali facilmente reperibili sul mercato e li utilizzasse «così come sono stati fabbricati», senza ulteriori lavorazioni, per ridurne i costi. Nonostante queste differenze, Alexander e i Thut erano interessati a responsabilizzare gli utenti nel processo di progettazione.
Walter Segal
Per trovare un precedente più preciso, dobbiamo considerare il metodo di Walter Segal, come menzionato in seguito da Jon Broome e Brian Richardson, collaboratori di Segal (Broome e Richardson 1991). Il metodo Segal non era un vero e proprio sistema costruttivo, ma suggeriva «come costruire» con materiali disponibili sul mercato, utilizzati nelle loro dimensioni originali, senza tagliarli. Si tratta quindi di un metodo che permette di utilizzare le risorse già disponibili in un modo efficiente, riducendo gli sprechi. Nella sua versione più comune, questo metodo si basava su semplici pannelli e pali in legno. Si trattava di una

rigorosa semplificazione dell’intero processo costruttivo, inclusa la progettazione, la documentazione e le procedure in cantiere. Walter Segal, architetto britannico nato a Berlino, dimostrò per la prima volta il valore di questo approccio nel 1962, con la casetta costruita nel suo giardino come edificio temporaneo destinato a ospitare la sua famiglia durante la ristrutturazione di una casa in mattoni a Highgate, Londra (Grahame e Mckean 2021). Con questo metodo, persone senza esperienza potevano costruire la propria casa da sole, fatta eccezione per il sollevamento della struttura portante.
Standard Buch
Per progettare senza aver ancora trovato un lotto e coinvolgendo i futuri abitanti, i Thut svilupparono due strumenti di progettazione specifici: lo Standard Buch e il Regie Buch.
I Thuts iniziarono a sviluppare lo Standard Buch nel 1975. Questo «libro» era concepito come una raccolta di disegni che rappresentavano il sistema costruttivo e i materiali da costruzione (legno, cartongesso, lana minerale, onduline…), insieme ai relativi costi. In questo modo, la costruzione poteva iniziare senza aver già definito nel dettaglio le singole case a schiera.
Questo «libro» conteneva sezioni semplificate, principalmente verticali o orizzontali, rappresentate su singoli fogli, pensate per spiegare ai futuri abitanti (non addetti ai lavori) come costruire. Si trattava di una sorta di manuale di istruzioni, simile a quello che riceviamo per costruire un mobile Ikea.
Regie Büch
Mentre il gruppo non era ancora definito del tutto e il lotto non era ancora stato trovato, la coppia di architetti chiese a ciascun futuro abitante, ignaro della tecnica costruttiva scelta, di compilare un Regie Buch per esprimere i propri bisogni, idee e desideri riguardo alla loro abitazione e alla loro idea di convivenza con i vicini. Era importante indicare chiaramente quanto o quanto poco ciascuno desiderasse confrontarsi con l’altro, che fosse in cucina o semplicemente in cantina, e quali abitudini desiderasse mantenere. I quaderni conservati nell’archivio dei Thut sono pieni di annotazioni manoscritte, ritagli di giornali e riviste, schizzi e scarabocchi. Non importava se alcune delle idee fossero irrealizzabili, lo scopo del Regie Buch era quello di creare le condizioni per una intensa comunicazione. Si tratta di una parte fondamentale del processo di progettazione, perché registrano il contributo degli abitanti all’intero progetto, ma devono essere visti anche come strumenti di sollecitazione per favorire un contributo proficuo alla discussione.
Ricerca del lotto
Trovare un lotto non era facile e il budget era molto limitato. Dopo un lungo periodo, Ralph Thut incontrò un agente immobiliare che desiderava realizzare un progetto su un lotto di 3000 metri quadrati. Questo terreno però era regolamentato dalla Staffelbauordnung, codice edilizio che limitava la costruzione di un solo piano terra e di un primo piano. Questo rendeva poco attraente qualsiasi progetto speculativo, ma era ottimale per il gruppo guidato dai Thut. Essi affittarono il terreno con un contratto di locazione dal proprietario, che viveva nelle vicinanze. Il contratto di locazione rappresentò una grande opportunità per il gruppo, poiché non dovette spendere soldi per acquistare la proprietà. Nel 1979, dopo la morte del proprietario, il lotto fu acquistato a un prezzo equo, grazie alla mediazione del signor Brandl. Dopo la costruzione e l’occupazione, il gruppo edilizio si è costituito in un’associazione di proprietari di case ai sensi della legge tedesca sui condomini (Wohnungseigentümergesetz) e il lotto è diventato una proprietà condivisa, insieme alla veranda, alla terrazza in legno e agli spazi al piano interrato: una sala comune, i locali tecnici e la falegnameria, già operativi durante la costruzione.
Terza fase di progettazione
Dopo la stesura dello Standard Buch e del Regie Buch, è stato necessario verificare le esigenze e i sogni dei futuri inquilini in base alle possibilità offerte dal lotto, alle tecniche e ai costi di costruzione. Questa fase ha evidenziato una forte interazione tra committenti e architetti nella progettazione del singolo alloggio, con gli architetti che hanno esercitato la loro influenza in base alle diverse competenze progettuali degli inquilini. È stato necessario un incontro settimanale per 3 anni per la condivisione di tutte le informazioni necessarie alle decisioni progettuali da adottare.
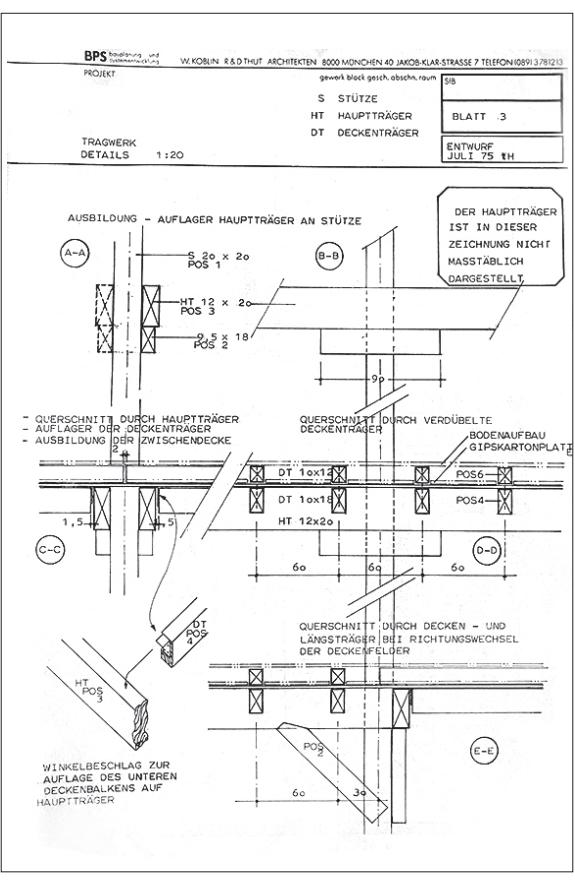
Sistema portante, dettaglio 1:20, 7.1977. Archivio Thut.
Energia solare
Lo spazio comune principale è una grande veranda che collega le sei case a schiera sul lato ovest. Oltre al suo fondamentale ruolo sociale e a quello complementare di ospitare le piante, la serra svolge anche un ruolo di regolazione climatica. In estate, grazie alla protezione solare esterna, la serra ombreggia il piano terra e parte del primo piano dall’esposizione diretta al sole. Inoltre, la ventilazione trasversale è migliorata grazie alle alette di ventilazione nella parte più alta della serra. La ventilazione trasversale è facilitata dal fatto che l’intero edificio è sollevato circa un metro da terra. Il tetto, concepito come tetto freddo, contribuisce inoltre a rimuovere l’aria calda indesiderata accumulata nella parte superiore della casa.
In inverno, alcuni spazi interstiziali (serra, intercapedine tra il terreno e il pavimento del primo piano, sottotetto) vengono chiusi tramite porte, alette e ante a ribalta per creare intercapedini termiche tra gli spazi interni ed esterni (Pufferzone).
I collettori solari integrati sul tetto sud previsti sin dall’inizio, vengono realizzati solamente in un momento successivo. Per questo motivo il tetto presenta un’inclinazione del 60%.
Permesso di costruire
Poiché l’edificio in Neubibergerstraße è stato probabilmente il primo a Monaco ad adottare una struttura in legno di oltre quaranta metri, è stato elaborato un progetto per un’autorizzazione speciale, insieme ai vigili del fuoco. Per rispettare la classe di resistenza al fuoco del 1976, i pilastri sono stati sovradimensionati di quattro volte. Inoltre, per evitare la propagazione dell’incendio da un’unità all’altra, i pilastri centrali di due unità sono rivestiti su entrambi i lati da una lastra di cartongesso e il foro è riempito con lana minerale.
La serra comprendeva l’intera facciata sud, senza alcuna via di fuga diretta verso l’esterno, pertanto non poteva ottenere il permesso di costruire. Il direttore della commissione edilizia locale, entusiasta della proposta innovativa dei giovani architetti, suggerì di progettare due cortili interni provvisori per suddividere la serra in tre sezioni. In questo modo, la serra avrebbe potuto essere approvata.
In cantiere
Le fondazioni puntuali e il seminterrato sono in calcestruzzo e sono stati realizzati, come raccontato dal Sig. Brandl in un’intervista condotta per questa ricerca, dal fratello del Sig. Lederer, che dirigeva una piccola impresa.
La struttura in legno fu realizzata da Merk, un’azienda specializzata di Aichach (nei pressi di Augusta), in due settimane; mentre il tetto, i soffitti, le pareti interne e le pareti esterne furono realizzati in seguito dagli architetti e dai futuri abitanti. Per semplificare ulteriormente il lavoro in cantiere, tutti gli elementi in legno dovevano essere rappresentati con misure precise e consegnati già tagliati dal carpentiere.
Dopo che la struttura portante fu sollevata e fissata dall’impresa edile, il gruppo di lavoro iniziò a lavorare in cantiere, inizialmente con l’aiuto del fratello di Lederer per le parti in calcestruzzo e poi da solo o con l’aiuto occasionale di amici e altre persone interessate. Quattro persone lavoravano costantemente in cantiere, le altre principalmente nei fine settimana, nei giorni festivi e, occasionalmente, la sera, dopo il lavoro. Il signor Brandl, a proposito della costruzione, ha detto: «è stato un periodo piacevole, ma anche stressante perché gli uomini dovevano coordinarsi tra loro e lavoravamo dodici ore al giorno». E la signora Brandl ha aggiunto: «dovevamo lavorare sette giorni su sette […]: la domenica facevamo le cose tranquille, non ci era permesso fare rumore con una sega o altro».
La flessibilità del carico di lavoro è stata un grande vantaggio, soprattutto per chi non poteva dedicare la stessa quantità di tempo al cantiere. Questa flessibilità è stata possibile perché i partecipanti annotavano le ore di lavoro e venivano pagati di conseguenza. A proposito di questo periodo, Ursula Renner ricorda: «non volevamo davvero [partecipare], perché all’epoca ero incinta e pensavo che i soldi fossero troppi per me. Lavoravo a tempo pieno e [pensavo che fosse troppo] costruire una casa. Non avevo tempo. E poi Doris Thut mi convinse che avrei dovuto essere coinvolta ora più che mai, e qui con la casa e il bambino in giardino e così via. E gliene sarò sempre grata, è stato molto positivo per la mia vita».
Riutilizzo e finanziamento
Il signor Brandl rivela che la sua unità abitativa è stata realizzata utilizzando il più possibile materiali riciclati per ridurre i costi. Ha rimosso termosifoni, porte, cucina e bagno dalla casa di suo fratello, che stava per essere demolita, e ha fatto in modo di conservarli in una fattoria vicina per il tempo necessario. L’edificio nel suo insieme fu finanziato principalmente grazie a contratti di risparmio edilizio (Bausparverträge) (stipulati dai genitori), crediti bancari della Stadtsparkasse München e risorse proprie.
Occupazione e modifiche
I Brandl furono i primi a trasferirsi, nell’Unità 3, il 15 luglio 1978, quando l’edificio non era ancora terminato. Da allora, hanno apportato numerose modifiche, rifatto l’isolamento e cambiato le finestre, da soli e con qualche aiuto di professionisti esterni. La modifica più significativa rispetto alla disposizione originale è la divisione della casa in due appartamenti (uno dei quali è abitato da uno dei figli), visibile all’esterno grazie all’aggiunta di una scala a chiocciola in acciaio.
Molti eventi hanno influenzato anche la vita delle altre famiglie, determinando la trasformazione di molte unità: i Thut hanno trasferito il loro ufficio (Unità 1); tre uomini sono morti e due se ne sono andati dopo la separazione; due figli con le loro famiglie si sono trasferiti nella casa.
Inoltre, i Lobo hanno acquistato la casa di Mühlbauer (Unità 2), dopo la sua morte, e vi si sono trasferiti, lasciando la loro casa (Unità 5) alla figlia con la sua famiglia. Il piano terra dell’Unità 2 era utilizzato dalla signora Lobo per lezioni di yoga e ora dalla figlia come spazio espositivo.
Secondo tutti gli intervistati, i bambini erano un collante per la comunità. Una volta cresciuti, le interazioni tra gli abitanti sono diminuite. L’invecchiamento degli abitanti originari, la crescita dei figli e l’arrivo di nuovi inquilini ebbero conseguenze sulla comunità, soprattutto nell’occupazione degli spazi comuni, che alla fine portarono alla divisione della serra. Nel frattempo, alcune relazioni sociali si consolidarono nel corso degli anni, a volte anche al di fuori dei limiti fisici del lotto. Ad esempio, il signor Leder che non vive più lì ha contatti con la signora Renner e Christa Lederer. Ursula Renner e i Brandl, anche se non svolgono più attività insieme nello spazio condiviso, dopo tutti questi anni affittano ancora insieme una casa per le vacanze in montagna.
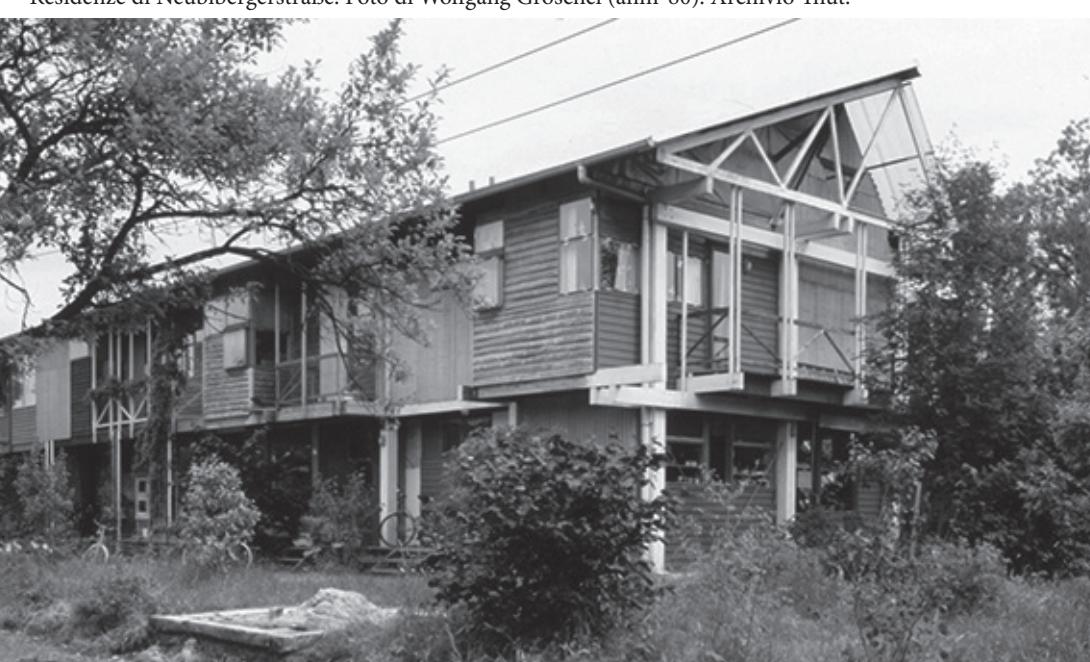
Residenze di Neubibergerstraße. Foto di Wolfgang Gröschel (anni ‘80). Archivio Thut.
Conclusioni
La presente analisi mostra come il risultato raggiunto a Monaco sia dovuto al concetto tecnico e spaziale degli architetti, ma anche al contributo degli abitanti. Il gruppo di persone coinvolte ha lavorato duramente, fatto sacrifici, riposto le proprie speranze in un futuro migliore e, soprattutto, desiderava che i propri figli crescessero in una comunità che condivideva simili ideali. Inoltre, ho cercato di sottolineare i contributi esterni specifici che sono confluiti nel risultato finale, come i vigili del fuoco e la commissione edilizia locale. Questi contributi esterni sono il risultato di un dialogo aperto instaurato dagli architetti e sono stati possibili perché è stato riconosciuto il concetto innovativo alla base di questo edificio. La stessa importanza nella definizione degli spazi è da attribuire al processo di abitazione, che nel tempo ha influenzato lo stato attuale della sostanza dell’edificio. Il progetto può essere considerato un successo, in quanto mantiene le sue promesse di flessibilità, non solo in termini di modifica degli spazi, ma anche in termini di pluralità di usi che offre agli abitanti, anche alle seconde generazioni.
Questo progetto non avrebbe potuto essere realizzato senza l’impegno e la determinazione delle persone coinvolte, ma neppure senza la loro visione di un mondo, critica nei confronti del sistema capitalistico. Questa è la ragione principale per cui è necessario preservarne il risultato edilizio. Ma come? A causa del processo sociale unico che sta alla base della costruzione, gli alloggi di Neubibergrerstraße necessitano di cure particolari e di uno specifico concetto di conservazione. Tutte le modifiche materiali corrispondono ai cambiamenti nella vita delle persone e dimostrano la flessibilità del progetto. Questa flessibilità non era legata solo al cantiere, ma è stata concepita anche per offrire la possibilità di modifiche nel tempo. Alcune famiglie hanno agito autonomamente, come i Brandl; mentre altre, come i Lobo o i Renner, si sono avvalse della consulenza dei Thuts. Questi due approcci hanno prodotto risultati diversi che devono essere valutati in relazione allo spirito originario del progetto.
Per preservare il concetto originale, soprattutto quando la generazione futura avrà preso possesso di tutti gli alloggi, è necessario un piano di conservazione che consideri innanzitutto lo Standard Buch originale. Migliorie tecniche e modifiche allo spazio fisico devono essere accettate purché rispettino il più possibile lo Standard Buch, con il suo concetto strutturale, la sua tecnica, la sua flessibilità planimetrica e le corrispondenti soluzioni di facciata differenziate, nonché le scelte estetiche (con materiali innovativi e soluzioni tecniche semplici).
Il processo di autocostruzione aperto fa parte delle idee progettuali poliedriche e non può essere trascurato in nessun tentativo di conservazione che si dica serio. Pertanto, dobbiamo interpretare questo edificio come avente una forma aperta, con principi strutturali e costruttivi chiari, ma con confini mutevoli tra i diversi ambienti (pareti divisorie; scale) e tra interno ed esterno (facciata; finestre). Da un lato, il piano di conservazione deve preservare le idee degli architetti, come espresso nello Standard Buch, dall’altro deve consentire la modifica da parte degli abitanti.
Per concludere, possiamo affermare più in generale che l’autocostruzione contribuisce alla consapevolezza della creazione dei propri spazi abitativi, al di là delle soluzioni standard e omologanti offerte dal mercato, e al di là degli effetti alienanti del sistema capitalistico che tende a produrre uomini capaci di fare un solo lavoro iperspecializzato. Una parte della comunità degli architetti ha denigrato questo esempio, definendolo impreciso e hobbistico, non capendo affatto il contenuto rivoluzionario di questa esperienza, nella quale i partecipanti assumono consapevolezza rispetto al loro modo di vivere in relazione agli altri. In aggiunta, l’autocostruzione consente l’auto-riparazione che permette di mantenere bassi i costi di manutenzione e di non dipendere dalle prestazioni di professionisti. In ultima analisi, l’autocostruzione determina un risultato estetico che è frutto del proprio lavoro manuale e pertanto più piacevole ed autentico.
BIBLIOGRAFIA
Alexander C., Jacobson M., Specifications for an Organic and Human Building System, pp. 33–56 in: Allen Edward (a cura di), The Responsive House, MIT Press, Cambridge, 1972.
Alexander C., Ishikawa S., Silverstein M., A Pattern Language. Towns, Buildings, Construction, Oxford University Press, Oxford, 1977.
Broome J., Richardson B., The Self-build Book. How to Enjoy Designing and Building Your Own Home, Green Books, Ford House, 1991.
Freundorfer E., Ökohäuser. Grünes Bauen in den 1970/80er Jahren, Master’s thesis, TUM, 2022. https://www.arc.ed.tum.de/en/nb/ lehre/master-thesis/masterarbeiten/ecological-houses-green-buildings-from-the-1970-80s/
Grahame A., McKean J., Walter Segal Self-built Architect, Lund Humphries, London, 2021.
Hegger M., Pohl W., Reiss-Schmidt S., Vitale Architektur. Tradizionen, Projekte, Tendenzen. Einer Kultur des Gewöhnlichen Bauens, Vieweg, Braunschweig, 1988.
Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens III W. W., The Limits of Growth, Universe Books, New York, 1972.
Näbauer R., et al., (a cura di), Selber und gemeinsam planen, bauen, wohnen, Selbsverlag, München, 1979.
Marx K., Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Neuzeitlicher Buchverlag, Berlin-Schöneberg 1919 [Westhafen Verlag, 2018].
Sanders K., Greener buildings, «Nature» 611, November 2022, pp. 18–19.
Thut D., Thut R., Einfluss Technik-Mensch oder Mensch- Technik?, «Das Werk» 59, 8, 1972, pp. 435–437.
Thut D., Thut R., Nach der Genter Straße, «Bauen + Wohnen» 30, 4, 1976, p. 116.
Thompson W., New Left, New Social Forces and Others, in: The Left in History: Revolution and Reform in Twentieth-Century Politics, 186–221, Pluto Press, 1997 (https://doi.org/10.2307/j.ctt18mbdj9.11).
Thut D., Thut R., Randbemerkungen zu Möglichkeiten in der Architektur, in: Joedicke J. (a cura di), Deutscher Architekturpreis 79. Dokumentation, 21–23, Karl Kramer, Stuttgart, 1980.
INTERVISTE
- Doris Thut, in conversazione con Elena Spatz, Zoe Kleinbongartz, Jonathan Hoff, Monaco di Baviera 17.12.2022.
- Lorenz Brandl, in conversazione con Shimizu Shunsuke, Monaco di Baviera 21.11.2023.
- Ursula Renner, in conversazione con Shimizu Shunsuke, Monaco di Baviera 24.11.2024.

Esordio
Chi sono oggi i proletari escursionisti? Piuttosto che col leniniano che fare? la domanda risuona col partenopeo chi sono questi nuovi autonomi? In seguito agli incidenti di piazza del ‘92, la 99posse rispondeva: i nuovi autonomi non sono altro che i vecchi autonomi. Per noi altri, al di là di ogni tentazione identitaria, la cosa non si risolve con la stessa disinvoltura. Solo riepilogando, seppur per sommi capi, la vicenda apeina sarà possibile chiarire perché (per fortuna e purtroppo) non siamo, non vogliamo e non possiamo essere le stesse e gli stessi. Eppure facciamo il nostro itinerario conservando le mappe, i profili, e la memoria dell’APE storica, ovvero facendo nostro anche il suo itinerario. L’Associazione Antialcoolica Proletari Escursionisti sorge dalla scissione della sezione alessandrina dall’UOEI – Unione Operaia Escursionisti Italiani – attiva sin dal 1911. A questo primo singulto rispondono in primis escursioniste e alpinisti «del popolo» di Lecco e Milano. Nel settembre del 1921, stesso anno di fondazione della sezione operaia della Società Alpinisti Tridentini, nella Sala dell’orologio di Palazzo Marino e sotto l’egida

dell’ultimo sindaco socialista di Milano (l’apeino ed esperantista Angelo Filippetti) si tiene il congresso fondativo dell’Associazione. Avrà vita brevissima l’APE storica, appena un lustro prima che le leggi fascistissime la costringano alla clandestinità. Dopo l’ultimo congresso clandestino in Val Cava le tracce di ogni attività sociale si perdono nel fogliame. Ancora un passo indietro. Quando vede i natali il CAO – Club Alpino Operaio di Como – il CAI e le consorelle d’oltralpe sono attive da oltre vent’anni, le guide alpine esistono da sessanta e la vetta più imponente dell’arco montuoso è stata scalata da un secolo. Eppure in quel 1885 accade qualcosa di inedito nel panorama: per la prima volta nel versante sud delle Alpi le discipline delle terre alte si dischiudono alla classe. Questa esperienza e tante delle successive, tra cui la stessa UOEI, finiranno fisiologicamente (in alcuni casi con naturalezza, in altri obtorto collo) per essere assorbite dagli ingranaggi di integrazione sociale del regime fascista o perché apolitiche, o perché animate da elementi incardinati nel ceto borghese e quindi ancorati ai suoi interessi e alle sue alleanze. Al primo congresso, insieme a svariate sezioni apeine, possiamo riconoscere le delegazioni della Società Proletaria Alpinisti (che con gli «escursionisti rossi» milanesi confluirà nell’Associazione), la consorella APEF – Associazione Proletaria di Educazione Fisica, l’Università proletaria, la Camera del Lavoro, la Federazione delle Cooperative e il gruppo ginnastico pompieri, cui si aggregano diversi assessori e il già citato Filippetti. Nell’arco di un paio d’anni, mentre la proposta comincia a contaminare anche gli appennini, da Como arriva una proposta di inno che recita Tra le nevi in cima ai monti – dove l’aria è fresca e pura – là di fronte alla Natura è la nostra libertà. Viva l’A.P.E., avanti avanti, per la nuova Umanità.
Al centro della sua agenda troviamo la lotta per le riduzioni ferroviarie, la costituzione della Federazione Sportiva del lavoro (progetto chiave dello sport popolare, rimasto nel cassetto dopo l’incendio della tipografia di Sport e proletariato nel dicembre 1923), una forma peculiare di lotta all’alcolismo sintetizzata dalla formula temperanza, non proibizione statale, e specialmente la realizzazione di una comunità popolare che unisce all’impegno politico e sindacale l’aggregazione per mezzo delle attività all’aria aperta senza confini di età o genere. Ieri come oggi l’APE si contraddistingue anche per la sua dimensione federale e per l’inspiegabile convivenza di anime e tendenze diverse tra loro. Al suo interno la componente socialista massimalista è per certo maggioritaria sin dagli esordi, ma non mancano esponenti comunisti e ancor più libertari, penso anzitutto ad Amleto Calura nel milanese, a Giovanni Farfallino Giudici nel lecchese, ai fratelli Caglioni «cameralisti» in quota USI della bergamasca e a molti altri. E ancora l’apparire, tra le rubriche scientifiche, di
traduzioni di articoli di Kropotkin e Reclus. Cosa forse più importante la rivista è diretta da una donna, Enrica Viola Agostini, che con penna affilata redarguiva compagni restii ad attribuire alle proprie compagne i bisogni che attribuiscono a loro stessi. Se necessario è lo sport ai lavoratori ancor più è alle lavoratrici.
Resistenza, ricostruzione e caduta
Le riviste mensili e bimestrali dell’APE raccontano con ritmo crescente gli incendi, le bastonate e le altre angherie de i ricostruttori. Un numero speciale è dedicato al delitto Matteotti, di cui la scalata dello Spigolo APE nel gruppo delle Grigne costituirà una sorta di nemesi sportiva, che spero avremo occasione di raccontarci un giorno vis a vis. Quello dell’APE è un antifascismo prima maniera, che narra la compostezza e la coerenza di chi non poteva abbassare la testa di fronte al precipitare degli eventi, e che pur cimentandosi in un territorio non squisitamente politico si trova progressivamente sempre più isolato tra torme di obbedienti al sentimento nero che soffia nel Paese. Nel 1927 un’ultima retata pone in galera quasi venti apeini, solo la trattativa seguita alla liberazione dei superstiti del dirigibile Italia per intervento della rompighiaccio sovietica Krassin li salverà dal girone dantesco delle patrie galere.
Non ha senso procedere in termini corali quando raccontiamo le vicende della resistenza partigiana di quasi vent’anni successiva. In questo frangente non possiamo che ricollegare all’APE storica, e in taluni casi a quella del secondo dopoguerra, le vicende di Farfallino e del gruppo Rocciatori nel Lario orientale, di Carlo Ferretti a Milano, di Marta Pera Pascucci nel senese, di Pierino Vitali nella 112a Brigata Garibaldi e di tante altre persone che si riconoscevano nei legami che l’APE aveva cementato nell’alveo della sinistra rivoluzionaria. All’indomani del 25 Aprile al fianco del Fronte della Gioventù, ai Comitati per lo sport popolare e più avanti all’Unione Italiana Sport Popolare, anche l’APE riprende la sua corsa, senza tuttavia trovare la propulsione di un tempo né in termini di partecipazione né di radicalità della sua proposta. Le prime sezioni a rispondere all’appello sono Milano, Lecco, Lovere, Alessandria, Bergamo, Pavia, Sesto San Giovanni, Meda e Cantù.
Il panorama europeo dello sport popolare, dopo la stagione magica 1918-1936, è stato terremotato prima dell’esito della Guerra civile spagnola, poi dal conflitto mondiale, e nel Belpaese c’è un ulteriore ventennio di tabula rasa da colmare. Anche l’immaginario sportivo, e con esso quello legato alle discipline in alta quota è stravolto dall’Himalayismo e dalle altre linee di fuga dell’alpinismo moderno: le invernali, la ricerca del grado, l’arrampicata sportiva, lo sci di massa. Se nel 1950 trova la sua realizzazione il sogno di sempre, la costruzione del rifugio Alveare alpino, nell’arco di soli trent’anni quasi tutte le sezioni si troveranno in profonda crisi di adesione e di identità, lasciando per diverso tempo la sola succursale lecchese a sventolare la bandiera che cent’anni fa era stata issata dal confine ticinese fino a Firenze e Napoli. Resto sul progetto di una casa alpina a disposizione dei tesserati perché questo progetto era stato rincorso sin dagli esordi dell’Associazione, salvo poi svendere il terreno inizialmente individuato a supporto della cassa del Soccorso rosso. Di qui l’importanza di restituire solidità al consorzio apeino, realizzando quanto causa di forza maggiore avevano impedito trent’anni prima. Il Rifugio prende vita ogni fine settimana con sessioni di lavoro collettivo: scavi di fondazione, opere murarie, collegamento idraulico, cui seguono l’allestimento esterno per gli attendamenti e poi, di anno in anno, un piano superiore, due, fino all’attuale configurazione. L’edificio (poi ceduto alla FIOM e infine privatizzato) è ancora visibile ai Piani Resinelli, sulla strada che porta ai sentieri per il Rifugio Rosalba. Il suo stato di abbandono testimonia la grandeur non ripagata dall’andamento di cassa dell’APE, la progressiva evaporazione di tante sezioni disertate dai più giovani e superate da un approccio più individualistico e performativo alle discipline alpine, ma anche la mutazione genetica di un altipiano di grande pregio naturalistico in località punteggiata di ville, seconde case a vocazione turistica.
Il terzo tempo dell’APE
Nel 2012 qualcosa si rimette in moto a partire dall’alchemico incontro tra attivist* raccolte nel rifugio urbano Piano Terra (il centro sociale del quartiere Isola di Milano) con L’APE di Lecco. Con l’occasione del tour di presentazione del volume Sentieri proletari (Mursia, 2015) e il parallelo riattivarsi dei milanesi si creano, inattese, le condizioni di un rilancio della proposta apeina riveduta e corretta in un contesto evidentemente mutato rispetto a quello di tutte le precedenti fasi del Novecento. Dapprima sono Brescia e Roma a rispondere all’appello, e, da qui in poi in ordine alfabetico, Bergamo, Bologna, Roma e Salerno, oltre a una sezione di area vasta: la Appulo-Lucana. In tempi recentissimi, con una prima iniziativa presso la Casa del Popolo di Grassina, anche la sezione fiorentina (attiva al tempo dell’APE storica) è rinata a nuova vita.

Da qualche anno l’APE si è data tre momenti di convergenza l’anno: il campeggio estivo (itinerante, perché ciascuna sezione ne sia protagonista a turno), l’incontro d’autunno, e una giornata di primavera dedicata alla mobilitazione o alla solidarietà attiva. La giornata di protesta La montagna non si arrende dello scorso nove febbraio, in cui le otto sezioni apeine si sono attivate in forma distribuita e sincrona con altre decine di comitati, associazioni, spazi sociali, si colloca dentro la cornice di questa primavera anticipata. Questi tre momenti sono la chiave che abbiamo trovato per avvicinare e far crescere insieme le differenti sezioni apeine, nonostante le distanze geografiche, le peculiarità organizzative e territoriali, le difficoltà connesse all’organizzazione con strumenti digitali.
Il carattere confederativo dell’APE di oggi è testimoniato dall’assenza di un’unica associazione centrale e suggellato da una Carta d’intenti cui aderiscono le singole sezioni, talune riconosciute in associazione (ASD, APS…), talora del tutto informali. L’alveare, lemma che preferiamo al più tradizionale «il nazionale», è anche il luogo in cui si mette a fattore comune l’affiancamento delle sezioni nascenti e altre forme di mutuo soccorso tra sezioni. Le attività sociali tipiche sono di carattere escursionistico: gite per tutt* e impegnative, infrasettimanali per precari/e e pensionati, gite pigre per i più piccoli, notturne, no oil, cicloape. Tra i progetti più significativi degli ultimi anni non posso non citare la campagna nazionale «Coperte termiche solidali», il gruppo antincendio di Lecco o la nascita dell’archivio digitale apeino a Milano, vero e proprio scrigno di fatti, personaggi, istanze dello sport popolare antifascista degli anni ‘20 del Novecento, così come delle successive peripezie dell’Associazione. Senza dimenticare gli appuntamenti nei «rifugi urbani» che sono le sedi (centri sociali o circoli) delle sezioni apeine. Non in tutte le se-
zioni e non tutti i mesi è possibile mettere in campo ciascuna delle attività passate in rassegna. Talvolta le gite sociali ripercorrono i sentieri e le vicende di tante resistenze, la memoria delle ribellioni, la storia sociale. Altre volte ci guida la curiosità, gli aspetti naturalistici, la presenza di luoghi conviviali in cui ci riconosciamo. Ci sono poi progetti appannaggio di singole sezioni come il «baule del prestito gratuito» di materiali e accessori per l’escursionismo (bacchette, ramponcini, mantelle antipioggia) o trekking urbani ideati e talvolta informalmente «segnati» in alcune delle città in cui siamo presenti, a segnalare un passaggio certamente effimero, ma anche per questo più disponibile a derive psicogeografiche e inattesa serendipità.
La vocazione dell’APE è pubblica e orizzontale (non è un club, per dirla alla rovescia), muoviamo all’insegna della gratuità e del passo condiviso, non accompagniamo, né riconosciamo una
differenza di statuto tra organizzati e organizzatori. Gli incontri della sezione meneghina, a titolo d’esempio, sono mensili e sempre aperti. Solitamente si compongono di un’ora in sessione plenaria, una di lavori di gruppo, e quando possibile di una sintetica restituzione. Il lavoro di tessitura con altre realtà conviviali attive alle pendici di Appennini o nelle prealpi è il pane quotidiano di una soggettività che non cresce per espansione ma per relazione, penso ad Alpinismo Molotov, Alpinismo orizzontale, al CAZ di Genova, al Gruppo Escursionistico Autogestito, così come a rifugi amici gestiti da compa e associazioni cui ci lega una sensibilità comune verso la vita umana, animale e gli ecosistemi che le accolgono.

All’intorno della contestazione olimpica
Le Olimpiadi invernali 2026 offrono una visione della montagna perfettamente speculare all’approccio apeino, di qui la necessità di partecipare ai percorsi di rete e posizionarsi in movimento di fronte ai Giochi più sostenibili e memorabili di sempre. All’insegna della nota economia della promessa sin dal 2018 il ticket Milano-Cortina ha venduto un’idea di mega-evento a costo zero (una contraddizione in termini), da realizzarsi attraverso 400 chilometri di arco alpino già compromesso da monocoltura e monocultura turistica, e specularmente abbandono e carenza di servizi . I Giochi portano con sé un’enorme distrazione di risorse pubbliche a beneficio di infrastrutture per una mobilità privata e fossile, extracosti a ripianamento di investimenti privati, nuovo consumo di suolo per progetti nocivi, imposti e sovradimensionati. Questa non è che la punta dell’iceberg di una visione estrattiva nei confronti delle terre alte fatta di impianti a fune e neve tecnica, pratiche elitarie quali eliski e motoslitte, cave e miniere, impianti industriali di produzione energetica e non ultimo croci di vetta. Questo mosaico di nocività porta con sé inquinamento (acustico, luminoso, ambientale, visivo), riduzione della biodiversità, compromissione del paesaggio e del territorio.
Il nostro è lo sguardo situato di cittadini, ma anche di umani curiosi e sensibili nei confronti dell’arco e della dorsale.
Pensiamo che i monti non siano uno spazio ammaestrabile a uso ricreativo nella nostra piena disponibilità, ma un luogo negoziale tra comunità umana e altre forme viventi e forze geologiche e atmosferiche. La crisi climatica sottolinea l’inadeguatezza piena di un’offerta turistica e sportiva basata su impianti di risalita esausti (oltre 260 quelli in disuso nel Belpaese) che per il 90% dei casi funzionano grazie alla produzione di neve artificiale. A queste contraddizioni si risponde con comprensori sempre più grandi e impattanti, sempre più bacini a discapito della sovranità idrica delle comunità montane, più strade veloci, stanze d’albergo, ristoranti e rifugi gourmet. Prezzi più alti, turisti più internazionali, piste più divertenti, esperienze più instagrammabili, montagne irrimediabilmente più addomesticate all’insegna di uno sfruttamento esperienziale ed estetizzante.

Le prossime sfide dell’APE
Tredici anni fa, un po’ per gioco, un po’ per omaggio, un po’ con l’orgoglio malcelato di far ripartire una cosa grande, abbiamo rimesso in moto la macchina apeina. Forti della relazione con APE Lecco, che sin dal principio ha letto le differenze culturali che ci attraversano ma ha comunque scelto di darci tutta la sua fiducia e mostrare una curiosità non scontata nei nostri confronti, abbiamo cercato una chiave per restituire un carattere peculiare a un organo che non poteva sopravvivere solo in forza di un nome antico e di una postura, si presume, peculiare nel panorama delle attività in quota. Tredici anni costituiscono anche una piena generazione politica, nel senso che le persone (e le sezioni) affacciatesi via via sono molte più di quelle che hanno dato lo start. Questo impone un tema di avvicendamento, dei carichi e delle responsabilità, di disponibilità al cambiamento, di ascolto di nuovi bisogni e sensibilità. La nostra comunicazione, i progetti, le campagne sono sottoposte a una verifica inedita, che impone di accogliere (cosa non facile) che quello che era più importante passi in secondo piano e che altre istanze, altri linguaggi, altre alleanze, vengano in avanti. L’A-PE continua a crescere ma in alcuni casi siamo anche andat* a sbattere, ad esempio laddove un’entità politica (un collettivo, uno spazio) coincideva col drappello fondatore della sezione. In questi casi nei momenti buoni le cose hanno funzionato per tutt* e nei momenti di magra o alta intensità politica l’APE è rimasta di volta in volta ostaggio di interessi terzi. Da queste prove abbiamo imparato a includere con lentezza le manifestazioni d’interesse all’apertura di una nuova sezione, puntando tutto su una fase di ascolto attivo all’interno della mailing list e degli appuntamenti del «nazionale», oltreché su affiancamento e attività intersezionali.
Anche nella relazione tra sezioni più mature, specie se geograficamente distanti, la realizzazione di obiettivi comuni non è mai cosa semplice, in considerazione di ritmi differenti e investimenti diversi sullo sforzo comune, eppure continuiamo a sceglierci e confermarci anno dopo anno, ad affiancarci nel cammino, a supportare le sezioni in affanno.
Il punto d’equilibrio lo ritroviamo proprio nel carattere radicale della nostra proposta: permanere in spazi autogestionari, alternare le attività in ambiente a iniziative e campagne di tutela dell’ambiente
montano e di solidarietà attiva con le persone migranti, avere uno sguardo definito e tagliente sulle nocività: stop a nuovi impianti a fune, rimozione dell’archeologia industriale, ma anche no a eliski e motoslitte, per citare gli esempi più «facili» da visualizzare anche in assenza di confidenza con le attività in ambiente. Ci muove la consapevolezza che la distrazione di ulteriori risorse pubbliche in politiche turistiche, e per questo drenate a mobilità, presidi sanitari, educazione, non può che aumentare il costo della vita e generare più pressione antropica a fianco di un controintuitivo spopolamento. Eppure muoviamo alle terre alte dalle città, nel compresso di una gita sociale, di una due giorni in bivacco, di un campeggio autogestito, di un viaggio. Per questo ci interroghiamo e proviamo a mappare i progetti, le campagne, le occasioni che illustrano una pratica di attraversamento non solo leggero ma attento e complice, attivo e sensibile. Il contesto in cui ci muoviamo è anche quello di una montagna fragile, cartina al tornasole dei cambiamenti climatici, con i suoi ghiacciai esangui, i suoi pendii rimboschiti, i suoi innumerevoli tronchi schiantati da fenomeni estremi, i suoi irrisolti conflitti tra specie.
La pratica del camminare domandando, l’ascolto delle voci di chi attraversa i confini alpini per necessità e non per piacere, la consapevolezza che ciascun luogo non è uno spazio a nostra disposizione e in nostra attesa, ci rimanda alle parole con cui Alex Langer ribaltò il motto olimpico citius altius fortius in: più lentamente, più dolcemente, più in profondità. Laddove tante manifestazioni dell’azione politica, anche quella fatta dal basso e all’interno dei percorsi autogestionari, possono esasperare le dimensioni dell’eccellenza e della competizione, la pratica escursionistica condivisa dissemina conoscenze, promuove la cura, stimola la responsabilità, ci insegna (non senza inciampi, passi falsi e rinuncia agli obiettivi di giornata) a riconoscerci nelle differenze per apprendere l’arte del fare comunità.
Maggiori informazioni sul sito ape-alveare.it

APPROFONDIMENTI Smascherando il mansplaining Mariangela Mombelli
Dichiararsi femministi sembra essere diventata una tendenza. Sempre più maschi dicono di esserlo, e alcuni si spingono persino a elaborare pensieri su come praticarlo. In un contributo recente apparso su una rivista libertaria si legge, tra varie suggestioni, che «nei nostri ambienti l’essere femminista, considerato genericamente, è oggi presentato come un’esigenza talmente inequivocabile da non richiedere la minima giustificazione». Non è molto chiaro cosa ci sia di ovvio, se non che a parlare è un maschio, bianco e cis, e che è proprio sull’esigenza inequivocabile che il femminismo rappresenta nei nostri ambienti che andrebbe avviata una riflessione, a partire dal rapporto tra gli uomini e il femminismo. La parola «femminismo» è complessa e, usata come termine universale, definisce il percorso di rivendicazione storicamente intrapreso dalle donne, volto all’acquisizione di diritti politici, accesso all’istruzione e, in definitiva, parità di status civico tra uomo e donna. Il femminismo, però, non è un movimento unico e organizzato a livello centrale, ma nel corso del tempo si è articolato in molteplici forme, gesti e voci che hanno incarnato, e continuano a incarnare, l’espressione della soggettività femminile in termini di soggettività politica. Gli uomini, come soggetti sessuati inseriti in un determinato contesto storico e culturale, sono parte delle relazioni sociali e materiali e, in questo senso, non possono essere considerati «esterni» alle pratiche femministe, sia in ambienti dove supponiamo che i maschi facciano attivismo antisessista e si trovino d’accordo con premesse femministe, sia in ambienti indifferenti, che si pongono in conflitto con il femminismo. Come ci ricorda il Laboratorio Smaschieramenti, la maschilità è infatti differentemente situata nello spazio delle relazioni sociali e delle rappresentazioni culturali, ma è innegabile che storicamente il maschile – bianco, etero, occidentale – ha costruito se stesso in maniera astratta, svincolandosi dalla determinazione corporea e avocando a sé la possibilità di parlare in modo oggettivo e neutrale su tutto e di
tutti.
Nel femminismo emancipazionista della prima ondata, che si concentrò principalmente sull’ottenimento del suffragio femminile e sulle questioni relative agli ostacoli giuridici all’uguaglianza di genere, il soggetto maschile funziona quasi da modello a cui aspirare poiché rappresenta, nell’Europa industrializzata e coloniale, l’ideale dell’individuo politico, universale, libero. Le premesse emancipazioniste vennero messe in discussione dal femmi-
nismo della seconda ondata, che allargava il dibattito a questioni quali la sessualità, la famiglia, il lavoro e i diritti riproduttivi. Uguali a chi? si chiedeva Luce Irigaray, mettendo le radici del pensiero femminista della differenza. Dalla metà degli anni Settanta alla fine degli anni Ottanta gli obiettivi dei movimenti femministi riguardarono i diritti civili: il divorzio, il diritto all’aborto e a una sessualità libera dai condizionamenti patriarcali borghesi. I collettivi femministi di sole donne teorizzavano e praticavano l’autocoscienza come metodologia di consapevolezza personale e politica: si partiva dal sé, dalla dimensione corporea e sessuata dell’esperienza vissuta come luogo privilegiato del sapere. Nei collettivi femministi la presenza degli uomini non era ammessa, ma quelli erano gli anni in cui alla lotta delle donne si affiancava quella di liberazione omossessuale, i cui militanti si relazionavano al femminismo in maniera positiva partecipando alle loro battaglie per i diritti civili. Anche alcuni maschi eterosessuali, militanti nella sinistra, espressero solidarietà alla lotta femminista, ma pochi di loro iniziarono a intrecciare la critica del sistema politico a una riflessione sull’essere maschi etero nel patriarcato, mantenendo di fatto immutate le relazioni di potere.
All’inizio degli anni Novanta negli ambienti femministi inizia a circolare il concetto di intersezionalità, che consente di evidenziare le relazioni tra i diversi fattori di discriminazione. Le riflessioni femministe sull’intersezionalità, introdotte da Kimberlé Williams Crenshaw, statunitense, docente di legge, nera e femminista, hanno permesso di riconoscere che ognun* di noi può essere oppress* per più di un motivo – quali ad esempio il genere, la classe, l’orientamento sessuale – ma, allo stesso tempo, si può trovare dalla parte del dominio per alcuni privilegi e per alcune caratteristiche. Ad esempio, se sono una donna cis, bianca, lesbica vivrò discriminazioni legate al genere e all’orientamento sessuale, ma avrò allo stesso tempo il privilegio di essere bianca e di essere cis-normata. La prospettiva intersezionale, riconoscendo i rapporti di dominio alla base delle differenze, evidenzia come le discriminazioni rispetto a una categoria non abbiano lo stesso effetto su tutte le persone perché, a seconda di come queste categorie si combinano, le persone sono posizio-
nate nella società in modo differente. In quegli anni, al filone degli studi femministi postcoloniali cominciano ad affiancarsi gli studi sulla sessualità in cui le teorizzazioni queer mirano a decostruire la categoria dell’identità. Nel 1990 Judith Butler pubblica Gender trouble. Feminism and the Subversion of Identity, tradotto in italiano
ventritré anni dopo con il titolo Questioni di genere. Il femminismo e la sovversione delle identità. È un testo provocatorio non soltanto nei confronti della concettualizzazione dei rapporti tra sesso-genere-desiderio eteronormativi, conservatori e patriarcali, ma anche nei confronti delle filosofie femministe che si sono sviluppate nei decenni precedenti. Butler osserva che il femminismo ha inconsapevolmente e ingenuamente attraversato la politica di genere senza realmente decostruire il dualismo tra i sessi, senza tener conto del reale problema performativo del genere-sesso. Il maschile e il femminile sono una costruzione culturale e sociale, e chiedersi cosa è un maschio e cosa è una femmina a volte sembra una scommessa irrisolvibile. Il femminile, il maschile, l’omosessualità, la transessualità, l’intersessualità sono
«esistenze»: occorre guardare a come esistono nel mondo nella loro specificità e nel rapporto con la normatività, dove per «norma», in troppi diversi contesti, si continua a intendere l’uomo bianco, eterosessuale, di classe medio-borghese, occidentale. Questa prospettiva complica il rapporto uomini-femminismi. Jack Halberstam, direttore dell’Institute for Research on Women, Gender e Sexuality della Columbia University, arricchisce il dibattito sulle maschilità mostrando che, da una prospettiva transfemmini-
sta, possiamo parlare di «maschilità senza uomini» quando la maschilità viene performata in corpi non maschili. «Eppure», come scrive il ricercatore, «è evidente come molte altre siano le linee di identificazione che intersecano il territorio della maschilità, distribuendo il potere a essa associato mediante complessi differenziali di classe, razza, sessualità e genere». Guardare alla maschilità in un’ottica intersezionale porta a sottrarci dalla visione maschilità/femminilità e a considerare che quando parliamo di maschilità non parliamo solo, o per forza, dell’essere maschio e va riconosciuta la natura culturale e performativa della maschilità, il cui significato normativo si traduce attraverso i corpi bianchi, cisgenere, eterosessuali, abili e di classe media.
Per tornare al discorso iniziale, ciò che andrebbe questionato – in particolare da «biomaschi», etero, bianchi, occidentali – è il come, qualitativo della relazione, per sua natura complessa e molteplice, degli uomini con i femminismi. Sono proprio le maschilità bianche etero – la cui vita è troppo spesso perimetrata dall’infanzia all’età adulta in un quadro di vantaggi sociali, virilità, machismo e prepotenze varie – quelle che riescono con più fatica a dialogare con i femminismi e a mobilitarsi contro il sessismo e il patriarcato. I maschi antisessisti propongono il cambiamento a partire da loro stessi, attraverso un processo di critica e trasformazione sociale diretto sulle loro stesse pratiche in quanto uomini. Critica che deve mettere in luce il disagio degli uomini, i costi del dover aderire alle norme socioculturali che impongono dei canoni di maschilità e il desiderio di decostruirle. C’è spazio, tanto, perché gli uomini possano dare parola e corpo al loro posizionamento critico rispetto all’ordine simbolico eteropatriarcale che li pone in una posizione di potere, ripensando il concetto di maschilità come egemone nei modelli culturali e creando forme di mobilitazione maschile antisessista che sia coerente e capace di dialogare con le politiche femministe e LGBTQIA+. Senza determinare lo spazio femminista, inteso come teorie, pratiche, linguaggi e simboli. Ovvero senza compiere un’operazione di mansplaining, termine che nasce nel 2008 a seguito di Man Explaining Things To Me, un saggio di Rebecca Solnit, attivista statunitense, nel quale l’autrice racconta l’episodio in cui un uomo pretende di darle lezioni sul tema del processo di industrializzazione del Far West consigliandole di leggere un libro di uno «scrittore importante» ignorando che lo scrittore importante fosse la stessa Solnit.
Bibliografia
Laboratorio Smaschieramenti, Uomo. Smascherare il maschile, pp. 287- 292 in: Marchetti S., Mascat J., M. H., Perilli V. (a cura di), Femministe a parole. Grovigli da districare, Ediesse, Roma, 2012.
Irigaray L., Egales à qui?, «Critique», 43, 480, 1987, pp. 420-437.
Halberstam J., Maschilità senza uomini. Scritti scelti, ETS, Pisa, 2010.
Solnit R., Gli uomini mi spiegano le cose, Ponte alle Grazie, Milano, 2017.
APPROFONDIMENTI
La legge sulla sicurezza n. 80/2025: condizionamenti alle pratiche libertarie e alle lotte anarchiche
Marco Ferrero
La nuova legge sicurezza n. 80 del 2025 rappresenta l’ennesimo atto repressivo di una lunga stagione inaugurata nel lontano 2008 con il «pacchetto sicurezza» (D.L. n. 92/2008 convertito nella legge n. 125/2008) dell’allora Ministro Roberto Maroni. Questo decreto ha introdotto il reato di clandestinità, l’aggravante di status per gli stranieri irregolari, il prolungamento della detenzione amministrativa nei Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) e ha inasprito significativamente le misure di espulsione. Parallelamente, anche per l’effetto del varo del pacchetto Maroni, nel discorso pubblico, l’immigrazione passa dall’essere vista come risorsa economica a essere considerata minaccia degna di criminalizzazione. Inizia la lunga marcia della repressione dei migranti, come paradigma del diverso, del marginale o, meglio, del marginalizzato, ricattato: «accetta qualunque condizione di lavoro, per poter rinnovare il permesso di soggiorno». Precarizzazione funzionale a ridurre il costo del lavoro prima degli stranieri e di conseguenza degli autoctoni e a preparare la nuova narrazione della sicurezza: dalla sicurezza sociale – garantita dal welfare di matrice socialdemocratica – alla sicurezza urbana, appannaggio indiscusso delle destre (con buona pace dei tanti politici della sinistra divenuta centro che inseguendo la destra sul proprio terreno hanno compiuto la propria metamorfosi inconsapevole).
Questa fase repressiva, che avevo analizzato in maniera approfondita nell’articolo Il pacchetto sicurezza: dall’integrazione subalterna degli immigrati alla loro criminalizzazione (in: P. Basso, Razzismo di Stato, edito da Franco Angeli), nell’ormai lontano 2010, è stata caratterizzata dalla progressiva criminalizzazione e marginalizzazione della figura dell’immigrato, rendendo più difficile l’accesso ai diritti fondamentali come l’asilo politico, il ricongiungimento familiare e persino la tutela della salute.
Il testimone di queste politiche securitarie è stato raccolto dal Ministro Marco Minniti con il D.L. 13/2017 (convertito nella legge 46/2017), che ha eliminato il secondo grado di appello per i richiedenti asilo, accelerato le procedure di espulsione e intensificato il controllo e la sorveglianza delle frontiere. Tuttavia, è stato con il Ministro Matteo Salvini che la repressione ha raggiunto livelli inediti con i due «Decreti Sicurezza» (D.L. 113/2018 convertito in legge 132/2018 e D.L. 53/2019 convertito in legge 77/2019). Tali norme hanno ulteriormente smantellato il sistema di protezione umanitaria, introdotto pesanti sanzioni contro le ONG impegnate nei soccorsi in mare, ina-
sprito le pene per l’occupazione di immobili sfitti e ampliato enormemente i poteri discrezionali delle forze dell’ordine. Le politiche migratorie vengono rilette come strumenti di controllo interno, con effetti ripercuotibili sulle pratiche libertarie – come occupazioni e brutale repressione delle proteste.
L’attuale legge sicurezza n. 80/2025 rappresenta un nuovo e pericoloso sviluppo di queste politiche, estendendo per la prima volta in maniera sistematica e massiccia le pratiche repressive anche ai cittadini italiani impegnati in lotte sociali e pratiche libertarie.
In particolare, l’articolo 4 della nuova normativa estende radicalmente i poteri preventivi delle forze di polizia, autorizzando misure cautelari anche in assenza di reati specifici, semplicemente sulla base della «potenziale minaccia alla sicurezza pubblica». Questa formulazione permette una repressione preventiva arbitraria di pratiche libertarie come l’occupazione di immobili sfitti per garantire il diritto alla casa, la creazione di spazi sociali autogestiti o manifestazioni pacifiche di protesta. Tale misura riflette un approccio pericolosamente vicino alle logiche preventive tipiche di regimi autoritari, come storicamente evidenziato da critici libertari come Luigi Fabbri e Errico Malatesta.
L’articolo 6 introduce pene severe per il «favoreggiamento indiretto» dell’immigrazione irregolare, criminalizzando anche chi offra solidarietà attiva, supporto logistico o ospitalità ai migranti, configurando così la solidarietà come un reato. Questa misura intimidatoria è un attacco diretto alle reti mutualistiche che praticano concretamente la solidarietà internazionale, evocando chiaramente la critica di Emma Goldman sulla criminalizzazione della solidarietà e della fraternità sociale.
Particolarmente preoccupante è l’articolo 9, che estende il cosiddetto Daspo urbano oltre il contesto sportivo, applicandolo a persone coinvolte in manifestazioni politiche considerate a rischio. Questa misura limita fortemente il diritto di manifestazione, colpendo principalmente chi denuncia le disuguaglianze e l’esclusione sociale, restringendo ulteriormente gli spazi democratici e di dissenso, come ampiamente denunciato nella tradizione anarchica italiana e da altri teorici contemporanei.
L’articolo 11 introduce poi il «reato di occupazione abusiva con finalità di destabilizzazione sociale», colpendo in modo diretto tutte quelle esperienze libertarie storiche che, attraverso l’occupazione di spazi abbandonati, hanno creato centri sociali, luoghi di aggregazione e abitazioni per i senza fissa dimora. Tali pratiche, che da sempre rappresentano una risposta concreta alla crisi sociale, vengono ora esplicitamente criminalizzate e represse con pene draconiane. La gravità di questa legge risiede anche nell’esplicita volontà di estendere le logiche di controllo e repressione, già ampiamente sperimentate sugli immigrati, alla generalità dei cittadini dissidenti o attivisti. La repressione dello Stato non è mai neutra, ma serve sempre a perpetuare un ordine sociale che privilegia alcuni a scapito di altri.
Quelli che erano spazi di mutualismo, cultura popolare, abitazioni per precari e migranti, ora diventano luogo di rottura dell’ordine pubblico e punibili penalmente.
Ogni corteo, anche pacifico, può essere sciolto preventivamente, con Daspo e sanzioni a carico dei partecipanti. Volontari, o chi semplicemente presta un letto a un migrante, rischiano processi, multe e reclusione. Si criminalizzano compiti elementari di cittadinanza.
Attivisti che promuovono workshop, cineforum critici, o spazi socio-culturali, possono subire la repressione preventiva che queste politiche consentono.
L’impatto concreto della legge 80/2025 sarà devastante per le realtà autogestite, mettendo a rischio tutte le forme di lotta dal basso. Tuttavia, proprio in questo momento di massima repressione è essenziale rilanciare strategie libertarie di resistenza e costruzione sociale alternativa, rafforzando reti solidali, praticando una disobbedienza civile diffusa e organizzando azioni dirette nonviolente.
Il futuro delle lotte sociali passa inevitabilmente attraverso la capacità di rispondere creativamente alla repressione, costruendo alleanze trasversali tra migranti e cittadini, diffondendo pratiche mutualistiche radicate nelle comunità e alimentando quotidianamente la cultura della solidarietà e della resistenza contro ogni forma di autoritarismo e discriminazione. Introduzione di pene severe per chi offra «supporto logistico, alloggio o informazione» ai migranti. Caccia al volontario, criminalizzando migliaia di persone coinvolte in reti mutualistiche, centri d’accoglienza e progetti sociali. Le parole di Emma Goldman: «Le persone hanno solo tanta libertà quanta ne hanno l’intelligenza di volerla e il coraggio di prendersela», ovvero, le libertà vengono compresse mentre si demonizzano l’indipendenza di pensiero e le prassi solidali, come fa la legge 80/2025. In Psicologia della violenza politica (1917), Goldman afferma «Se tali atti vengono trattati con comprensione, si viene immediatamente accusati di farne l’elogio…». Insomma, oggi la solidarietà diventa «favoreggiamento». Chi resiste diventa fuorilegge.
Questa legge rappresenta una significativa escalation del controllo statale, che erode ulteriormente le libertà individuali e riduce lo spazio per il dissenso. Facendo un parallelo con i precedenti storici, la legge riecheggia le strategie impiegate durante gli «anni di piombo» italiani, dove la legislazione d’emergenza è stata utilizzata per reprimere i movimenti politici. L’aumento delle misure punitive, sia a livello centrale che locale, riflette una tendenza più ampia a impiegare politiche adattive e azioni amministrative per controllare la popolazione. Questo approccio segna uno spostamento verso l’uso della punizione per rafforzare la coesione all’interno di una società sempre più frammentata. Tali misure, pur essendo apparentemente volte a rafforzare la sicurezza, spesso servono a soffocare l’opposizione e a mantenere lo status quo.
L’attuale quadro giuridico riflette sempre più uno Stato preventivo che esercita un controllo eccessivo sulla società civile, creando conflitti tra misure di sicurezza e diritti individuali e ciò corrisponde alla tendenza degli Stati di utilizzare sempre più spesso il diritto penale per prevenire danni futuri, intervenendo preventivamente ed estendendo le pene in base ai comportamenti previsti. Questo approccio preventivo spesso porta a trascurare i principi costituzionali, minando le basi stesse di una società democratica.
L’approccio italiano alla sicurezza urbana, caratterizzato da una forte leadership del governo locale e da un legame tra sicurezza e immigrazione, esemplifica questa tendenza. Queste misure colpiscono in modo sproporzionato i gruppi emarginati e gli attivisti politici, esacerbando le disuguaglianze sociali esistenti, il che crea un «divario di sorveglianza» in cui coloro che hanno più bisogno di protezione sono invece sottoposti a un maggiore scrutinio e controllo. Questa dinamica favorisce un ambiente in cui le pratiche statali sono legittimate attraverso un linguaggio che enfatizza la sicurezza e l’ordine, plasmando la percezione pubblica e facilitando l’attuazione di politiche neoliberali.
Questo approccio non è unico, ma è piuttosto una manifestazione di una tendenza globale in cui la punizione viene utilizzata per sostenere le politiche neoliberali e reprimere il dissenso. Questa espansione del potere statale richiede un esame critico del rapporto in evoluzione tra cybersicurezza e società, dove le politiche di sicurezza digitale possono codificare nuove forme di controllo e intervento. Questa intersezione merita di essere esaminata, soprattutto per quanto riguarda la standardizzazione e l’ispezione di varie attività, che collegano il neoliberismo alla riconfigurazione della vita quotidiana. È una tendenza che colpisce le comunità emarginate, che spesso necessitano di strategie per navigare nei sistemi burocratici, rafforzando ulteriormente il loro status di insicurezza all’interno della società.
Il significato di «pubblica sicurezza» è spesso poco chiaro e porta a leggi che violano indebitamente la privacy. La tecnologia avanza rapidamente, superando le tutele legali per la privacy, rendendo necessari principi universalmente vincolanti per proteggere gli individui. L’intersezione tra sicurezza nazionale e politiche economiche complica ulteriormente questo panorama, richiedendo un’attenta considerazione dell’equilibrio tra la protezione degli interessi nazionali e il mantenimento delle libertà individuali.
La legge 80/2025 non è un episodio isolato: è esito di una traiettoria iniziata nel 2008, alimentata da una cultura emergenziale e securitaria che si serve della crisi sociale per strumentalizzare la paura. Contro questo paradigma serve una contro-forza radicata, intelligente e solidale.
Come ripetevano Malatesta e Goldman: sotto la repressione, fiorisce la solidarietà. Oggi, occupare, curare, resistere, raccontare diventano gesti politici, veri antidoti alle logiche dello Stato coercitivo.
L’alternativa c’è: è la pratica libertaria stessa - fatta di mutualismo, azione diretta, organizzazione dal basso: rafforzare i network tra migranti, precari, attivisti (insieme si possono opporre a Daspo e processi); organizzare la difesa legale integrata tra territori per minimizzare l’impatto delle denunce preventive; pensare forme di disobbedienza civile creativa (forme di occupazione simbolica, flashmob urbani, proteste artistiche-nonviolente per attirare attenzione mediatica). È ineludibile strutturare una contro-narrazione e divulgazione: scrivere, documentare, diffondere sulla rete, usare memoria storica e denunciare la logica securitaria, portando testimonianze con al centro storie. Il tutto coinvolgendo ONG, università (sociologi, giuristi) e facendo pressione su parlamentari, media e pubblica opinione, smascherando le menzogne securitarie (come il mito che «gli immigrati aumentano la criminalità»). Infine servirà organizzare pratiche mutualistiche diffuse: mense, doposcuola, sportelli legali, corsi di lingua, punti sanitari: le comunità coese sono più difficili da criminalizzare.
La nuova legge è un attacco, sì. Ma diventa anche una chiamata alle armi - intellettuali, etiche, sociali - per costruire la società che vogliamo.
Bibliografia
Matus Acuña J. P., La Denuncia Del “Populismo Penal” En La Utopia De Tomás Moro. (The Denunciation of “Penal Populism” in the Utopia of Tomás Moro), «SSRN», Jan. 2017 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=3096049).
Ashworth A., Zedner L., Preventive Justice, Oxford University Press, 2014.
Chiaromonte W., Federico V., The Labour Market Needs Them, But We Don’t Want Them to Stay for Good: The Conundrum of Migrants, Refugees and Asylum Seekers’ Integration in Italy, p. 193 in: «IMISCOE research series», Springer International Publishing, 2021 (https://flore. unifi.it/handle/2158/1235668).
Cozzolino A. and D. Giannone D., State Transformations and Neoliberalization in Italy: A Critical Discourse Analysis of Governments’ Political Economy, 1988-2009, «New Political Science», 41, 3, Jul. 2019, p. 443.
Ferrero M., Il pacchetto sicurezza: dall’integrazione subalterna degli immigrati alla loro criminalizzazione, in: Basso P. (a cura di), Razzismo di Stato, Franco Angeli, Milano, 2010.
Gallo Z., The penal implications of austerity: Italian punishment in the wake of the Eurozone crisis, «European Journal of Criminology», 16, 2, May 2018., p. 147.
Gibbon P. , Henriksen L. F., A Standard Fit for Neoliberalism, «Comparative Studies in Society and History», 54, 2, Mar. 2012, p. 275.
Goldman E., Anarchia, femminismo e altri saggi, La Salamandra/Robin Book, 1976 (ristampa digitale 2024).
Inazu J. D., Unlawful Assembly as Social Control, «UCLA L. Review», 64, 2, 2017, p. 52.
Iturralde M., Emergency penality and authoritarian liberalism, «Theoretical Criminology», 12, 3, , Jul. 2008, p. 377.
Orsina G., Genealogy of a Populist Uprising. Italy, 1979-2019, «The International Spectator», 54, 2, Apr. 2019, p. 50.
Ricotta G., Neoliberalism and Control Strategies: the Urban Security Policies in Italy, «Partecipazione e Conflitto», 9, 2, 2016 (http://siba-ese. unisalento.it/index.php/paco/article/view/16316)
Sarre R., Brooks D. J., Smith C. W., and Draper R., Current and emerging technologies employed to abate crime and to promote security, in: Routledge eBooks, Informa, 2015.
Schmitz-Berndt S., Chiara P. G., One step ahead: mapping the Italian and German cybersecurity laws against the proposal for a NIS2 directive, «International Cybersecurity Law Review», 3, 2, Jul. 2022, p. 289.
Tuckett A., Strategies of Navigation: Migrants Everyday Encounters with Italian Immigration Bureaucracy, «The Cambridge Journal of Anthropology», 33, 1, Jan. 2015, pp.113-128.
APPROFONDIMENTI Il pianeta si è accorto degli smartphone Micorriza
Per quanto tempo hai utilizzato il tuo precedente smartphone prima di sostituirlo? Il motivo della sostituzione è stato un guasto? Avevi provato a sostituire il componente non funzionante, tipo la batteria, e provato a installare un sistema operativo più leggero prima di acquistarne uno nuovo? Se le risposte alle precedenti domande sono «meno di dieci anni», «no e no» è perfettamente normale, o meglio, queste sono le abitudini instillate nella stragrande maggioranza degli utilizzatori di smartphone: questi piccoli gioielli della tecnologia sono volutamente progettati per rendere difficoltose o impossibili le pratiche accennate nei quesiti iniziali, almeno finora.
Considerando che nel mondo circa il 70% della popolazione ha almeno uno smartphone, per una stima complessiva che si attesta poco sotto i 6 miliardi e che ogni anno ne vengono prodotti circa 1,5 miliardi e buttati altrettanti; l’impatto che questi apparecchietti hanno sull’ambiente è impressionante anche perché segna un cambiamento rispetto agli altri oggetti elettronici.
Con noi o contro di noi?
Difficile pensare a un momento della giornata in cui non ce l’abbiamo vicino, questi oggetti in brevissimo tempo sono diventati per noi inseparabili; dacché tutti ne abbiamo almeno uno, tutte le operazioni che quotidianamente compiamo per soddisfare le nostre necessità sono state rimodellate per essere compiute attraverso uno smartphone, anche quelle per cui bastava usare semplicemente le mani o parlare con le persone o alla peggio usare il telefono. Si pensi alla consultazione del menu in un ristorante, ai pagamenti, alla prescrizione delle ricette mediche, la consultazione di documenti personali e per finire alle interazioni sociali…
Innegabile che in molti casi si tratta di semplificazioni che ci fanno risparmiare tempo e aumentano le comodità, ciononostante è anche innegabile che molti dei bisogni che ogni giorno soddisfiamo con lo smartphone sono stati indotti in maniera etero diretta da chi attraverso quelle tecnologie ci lucra. La lista sarebbe molto lunga se volessimo considerare tutti i modi in cui diventiamo merce o lavoratori non pagati quando utilizziamo la moltitudine di app presenti su questi «telefoni intelligenti», alcune delle quali sono app già installate al momento dell’acquisto. È doveroso specificare che questi complessi dispositivi a differenza dei loro cugini «computer», fissi o portatili che siano, sono ancora più limitati per quanto riguarda la manipolazione dell’hardware da cui sono composti, i sistemi operativi che li fanno funzionare sono molto più bloccati e chiusi e le applicazioni che ci girano sono vincolate alle regole dei produttori. Inoltre, sono tutti equipaggiati con una variegata pletora di sensori che consentono di registrare qualsiasi tipo di informazione che ci riguarda. Da questo punto di partenza ci limitiamo ad accennare come tutti i dati che si possono raccogliere consentono una profilazione molto precisa delle persone (a che ora una persona si sveglia, che fonti di informazioni consulta, con chi comunica, dove si reca per lavoro o per altri scopi, con che mezzi, che interessi ha, dove ha il conto in banca e come spende i soldi, e via continuando). Chi possiede queste informazioni, che in genere sono le grosse corporations, e in alcuni Paesi questa è anche la migliore delle ipotesi, ha garantito un’inesauribile fonte di ricchezza sia in termini economici, mediante marketing e vendita dei dati stessi, sia in termini di controllo, purtroppo non sono rari gli attivisti e i
giornalisti che subiscono violente conseguenze per il loro operato a causa di un uso poco attento dello smartphone. La letteratura su questi argomenti è molto vasta, sia in libreria che in rete. Di recente Kenobit, poliedrico e prolifico artista e attivista, ha raccontato la sua esperienza di un approccio diverso allo smartphone nel libretto gratuito Liberare il mio smartphone per liberare me stesso.
Evoluzione tecnologica
Ripercorriamo velocemente le tappe fondamentali della storia di questi dispositivi per capire come siamo arrivati a questo punto.
Nella seconda metà del secolo scorso fanno la prima apparizione i circuiti integrati, un insieme di componenti elettronici montati su una piastrina di silicio. Questi chip sono programmati per compiere svariate funzioni, dall’effettuare calcoli a salvare dati, e col passare degli anni si evolvono per diventare sempre più specializzati, potenti e versatili mentre si riducono notevolmente le dimensioni e il consumo di energia. Sul finire degli anni Sessanta compaiono le prime calcolatrici elettroniche con dimensioni tali da essere tenute nel palmo di una mano e nel decennio successivo i computer diventano portatili. Negli anni Ottanta anche i computer si rimpiccioliscono, nascono gli hand held computer
o anche «computer da tasca» come lo Sharp 1211 e il Panasonic RL-H1400. Entrambi vengono prodotti in Giappone che all’epoca era in forte ascesa economica e industriale. Nel 1992 vengono poi annunciati due dispositivi molto innovativi: Newton di Apple e Simon di IBM. Questi sono considerati personal digital assistant (PDA) che in Italia venivano presentati come «palmari», sono minicomputer originariamente concepiti come una agenda elettronica, un sistema non particolarmente evoluto dotato di un orologio, di una calcolatrice, di un calendario, di una rubrica dei contatti, di una lista di impegni/attività e della possibilità di memorizzare note e appunti. Il Simon, presentato nel novembre 1992 come prototipo da IBM, è il primo serio tentativo di fondere un PDA con un telefono cellulare. Cinque anni dopo, nel 1997, l’azienda europea Ericsson è la prima ad usare per la prima volta la parola «smartphone» in occasione del lancio del modello GS88, che unisce molte funzioni di un PDA a quelle di un telefono cellulare, con tanto di schermo tattile e tastiera. È un periodo storico in cui l’Europa sta giocando un ruolo di primo piano nell’industria digitale soprattutto grazie al GSM, uno standard aperto per la telefonia mobile digitale, sviluppato dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni nonché unico ammesso in Europa. In ambito produttivo hanno rilevanza mondiale aziende come Ericsson (Svezia), Siemens (Germania) e soprattutto Nokia (Finlandia). Nel 1999 la RIM, un’azienda canadese fondata nel 1984, presenta un primo dispositivo portatile in grado di gestire e-mail, il BlackBerry 850, e nel 2003 il suo primo vero e proprio smartphone. Contestualmente nel mondo della riproduzione musicale si erano diffusi i lettori MP3, grazie al nuovo formato di compressione digitale che consentiva di mantenere una certa qualità nella riproduzione dell’audio riducendo la memoria utilizzata. Questi dispositivi sono tipicamente piccoli e leggeri, con una batteria e un semplice schermo LCD. Il punto di svolta nella loro storia avviene nel 2001: con una delle tante azzeccatissime manovre di marketing la Apple lancia l’iPod, un lettore che per la sua ampia capacità di immagazzinamento dati, l’innovativa interfaccia utente e il design molto curato conquisterà il mercato e che ovviamente si può gestire esclusivamente con il loro software proprietario iTunes. Forti del risultato ottenuto, alla Apple si lavora per arrivare al primo smartphone, Steve Jobs vuole infatti proporre un «iTunes-phone». Per realizzarlo, nel 2004 Apple si rivolge a Motorola, in quel momento uno dei produttori di punta di telefoni cellulari e così il 9 gennaio 2007 Steve Jobs perfettamente a suo agio sul palcoscenico annuncia l’iPhone. Jobs lo descrive come una combinazione di tre dispositivi: un iPod con schermo tattile, un telefono rivoluzionario e un innovativo dispositivo per la comunicazione via internet. Sebbene non fosse nulla di rivoluzionario a livello tecnico, l’accattivante design e il grande schermo tattile che proponeva un’esperienza utente molto diversa dalle altre, affiancati da una gigantesca operazione di marketing rendono l’iPhone uno status symbol che in breve tempo arriva a dominare il mercato. Grazie alla diffusione di questi piccoli dispositivi che consentono di navigare su internet ne trae vantaggio un’altra giovane azienda che poco dopo dilagherà, Google. Allora la Microsoft che forniva il suo browser Internet Explorer abbinato a Windows, il sistema operativo presente sulla quasi totalità del computer nelle case delle persone, rappresenta il principale competitor per il motore di ricerca. Google inizia a lavorare segretamente a un proprio smartphone ma soprattutto a un sistema operativo innovativo, a disposizione di qualsiasi produttore di smartphone, tecnicamente molto accessibile e soprattutto open source, con tutti i vantaggi del caso. Nel settembre 2007 viene presentato in una versione ancora prematura il sistema operativo Android. Da lì in poi i progressi sono stati notevoli, oltre agli smartphone prodotti da Google, grazie alla licenza libera anche quasi tutte le altre aziende hanno iniziato ad installare Android sui loro dispositivi fino ad arrivare a oggi in cui è presente su circa il 70% di quasi 7 miliardi di smartphone usati nel mondo, davanti ad Apple che si attesta sotto il 30%.
La tavola periodica nella tasca
Per creare tutti i componenti presenti in uno smartphone, dallo schermo alla batteria, sono necessari fino a 70 elementi degli 83 presenti sulla tavola periodica. Questa grande varietà di elementi comprende sia i più comuni come rame, oro, argento, o litio che sono impiegati anche in altri ambiti, ma soprattutto le famose terre rare che sono diventate fondamentali per gli oggetti elettronici. Con la locuzione «terre rare» si identificano 17 elementi: i 15 lantanoidi più l’ittrio e lo scandio. Non sono rare dato che sono distribuite un po’ in tutto il pianeta, ma ci sono concentrazioni diverse e soprattutto la loro estrazione è un processo più complicato dato che richiede ulteriori passaggi. Oggigiorno se ne sente parlare sempre più spesso, questi preziosi elementi stanno cambiando gli equilibri geopolitici. Circa l'80% della produzione mondiale avviene in Cina con effetti prevedibili sui mercati internazionali. Per citare alcuni contesti recenti, il Donbass è ricchissimo di miniere, Trump ha chiesto come ricompensa per gli aiuti già dati all’Ucraina 500 miliardi di dollari in terre rare e altre risorse (accordo che è stato poi modificato), lo stesso infimo personaggio ha manifestato fortemente dall’inizio del suo mandato la volontà di conquistare la Groenlandia, che è un’enorme giacimento di risorse sotto ghiaccio, ancora per poco, inoltre ha firmato l’ordinanza per avviare l’estrazione di minerali dai fondali marini in acque profonde, attività molto critica praticata da pochissimi Paesi. Infine, anche il governo italiano ha presentato il «Programma nazionale di esplorazione mineraria» per riaprire le miniere dopo 40 anni alla ricerca di terre rare e altre materie prime di importanza cruciale.
Le estrazioni di tutti questi materiali comportano un impatto ambientale notevole, si provi a immaginare le moderne miniere, montagne sventrate o aree anche più grandi completamente svuotate, percorse da mezzi mastodontici pesantissimi. Questa attività oltre a distruggere ecosistemi produce grandi quantità di rifiuti estrattivi, sostanze inquinanti che si riversano in acque, aria o suolo ed è l’inizio di un ciclo. Da qui in poi seguono le fasi di raffinamento, lavorazioni industriale più o meno articolate, la creazione dei componenti, l’assemblaggio, l’imballaggio e la distribuzione per arrivare ai rivenditori, ultimo passo prima di essere nelle mani dell’utilizzatore finale. Ognuna di queste fasi consuma un’ingente quantità di energia e risorse e generalmente avviene in parti diverse del mondo. L’alluminio estratto in Brasile viene lavorato in Islanda per poi andare in Cina per creare la scocca di uno smartphone, assemblato in un altro stabilimento, che alla fine sarà venduto negli Stati Uniti. Con filiere del genere per ogni piccola parte l’impronta di carbonio non è trascurabile.
Per impronta di carbonio si intende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra espressa nel suo equivalente di anidride carbonica. I gas serra (Green house gases, GHG) sono responsabili del riscaldamento climatico. Facciamo chiarezza. L’anidride carbonica (CO2) è un gas serra, cioè ha capacità di bloccare e non trasmettere l’energia irradiata dalla superficie terrestre ritrasferendola sotto forma di energia termica, creando quindi una sorta di serra. Esistono sette gas serra con coefficienti di riscaldamento diversi, dato che la CO2 rappresenta 80% del totale si ragiona in emissioni di GHG calcolate in termini di CO2 equivalenti.
Ogni prodotto o servizio nel suo intero ciclo di vita produce emissioni. Le emissioni si possono categorizzare come «incorporate» quando riguardano i processi di produzione, trasporto e smaltimento, oppure «operative» quando si considera il consumo di energia in fase di utilizzo.
Uno smartphone ha una vita media di due anni e mezzo, in cui consuma pochissima energia grazie alla miniaturizzazione dei componenti e al progresso tecnologico. Non consideriamo il consumo indiretto relativo ai datacenter che ospitano i servizi usati dalle varie app, perché molto variabile e decisamente difficile da stimare. A fine vita, quasi sempre determinata dall’obsolescenza programmata su vari fattori o dall’andamento del mercato, la temporanea estensione artificiale dell’individuo moderno diventa un rifiuto difficile da smaltire in maniera consona e soprattutto non riciclabile perché la progettazione dei dispositivi digitali è sempre stata fatta senza considerare il fine vita come una fase nella filiera del prodotto. Nei Paesi più attenti a queste tematiche meno del 20% viene riciclato. Recuperare materie prime da poter riutilizzare non conviene economicamente rispetto all’estrazione. Questa situazione innesca quello che vie-
ne chiamato resource deplation, le risorse naturali vengono consumate più velocemente di quanto possano essere reintegrate, causando una diminuzione della loro disponibilità. Capitano episodi in cui la multinazionale di turno non è in grado di soddisfare gli ordini di acquisti dei propri clienti che a loro volta sono obbligati dalla stessa a comprare nuovi dispositivi per sostituire quelli in produzione e funzionanti ma le cui licenze sono scadute. Nel frattempo, aumentano le tonnellate di rifiuti inquinanti impossibili da trattare che diventano oggetto
resource deplation: le risorse naturali vengono consumate più velocemente di quanto possano essere reintegrate, causando una diminuzione della loro disponibilità
di esportazioni illegali per scaricare i costi ambientali su Paesi privi normative e di strumenti di difesa contro questo tipo di speculazione. Un saggio esaustivo e accurato è Le emissioni segrete di Giovanna Sissa.
Lo smartphone ha l'80 % delle emissioni della sua vita incorporate, cioè l'80% dell’impatto ambientale avviene prima ancora di essere acceso per essere usato e dopo che viene spento per l’ultima volta. Un ciclo di vita con queste percentuali è unico tra gli oggetti elettronici.
Tanti passi in avanti ma l’arrivo è ancora lontano
Questo tragico scenario non è passato inosservato dato che riguarda tutta la tecnologia. Modificando di poco: il numero di elementi impiegati, la durata di utilizzo e le percentuali di riciclaggio, il ciclo di vita descritto in precedenza rimane valido per qualsiasi oggetto elettrico o elettronico, tuttavia solo lo smartphone presenta questi valori imbarazzanti.
Durante la stesura di questo articolo, dal 20 giugno 2025 sono entrati in vigore i regolamenti promulgati dall’Unione Europea sul cosiddetto ecodesign (UE 2023/1670) e sull’etichetta energetica (UE 2023/1669) per smartphone e tablet. Queste misure si applicano a tutte le aziende produttrici che vendono i loro prodotti in Europa e hanno lo scopo di estendere la vita dei dispositivi e fornire più informazioni a tal scopo.
Per ecodesign si intende un approccio progettuale che mira a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti durante l’intero ciclo di vita, dalla progettazione allo smaltimento, per questo motivo il regolamento prevede una migliore disponibilità delle parti di ricambio (batterie, telecamere, altoparlanti), per almeno sette anni e con tempi di consegna più rapidi; aggiornamenti di sicurezza del software (es. Android) per almeno cinque anni. L’etichetta energetica indica quanto un dispositivo sia a prova di caduta e riparabile, considerando anche i cicli di carica della batteria e l’impermeabilità.
Questi nuovi vincoli sono decisamente apprezzabili anche se le riparazioni considerate sono sempre quelle effettuate dai rivenditori a scapito delle riparazioni fai da te tanto che la sezione relativa alla sostituzione semplificata del display, componente che si danneggia più frequentemente, è stata rimossa all’ultimo momento.
I regolamenti sopra citati sono una ridotta espressione istituzionale di una serie variegata di pratiche che si sono diffuse a più livelli e in diversi contesti per superare l’imposizione programmata di sbarazzarsi di un dispositivo ancora funzionante per comprarne uno nuovo.
Il primo esempio di smartphone progettato con ecodesign è stato realizzato nel 2013 nei Paesi Bassi ed è il Fairphone. Nasceva come impresa sociale con open design impegnandosi a utilizzare il più possibile componenti provenienti da un commercio equo e solidale. Fairphone, con la vendita diretta di tutti i componenti di ricambio e le guide alla riparazione autonoma, garantisce un’ampia durata ai propri smartphone.
Negli ultimi anni fortunatamente è fiorito il mercato dei dispositivi ricondizionati (refurbished), gli smartphone usati vengono sottoposti a verifiche, eventualmente riparati, aggiornati e poi rimessi in vendita a prezzi decisamente inferiori rispetto ai nuovi. Questo consente di avere in tasca un oggetto che potenzialmente sarebbe finito in discarica ma perfettamente funzionante e con un notevole risparmio economico.
Un altro ruolo importante è giocato da sistema operativo o firmware. Su ogni telefono o tablet è possibile installare una versione diversa di Android scaricata gratuitamente perché il codice è libero. Questa strada non è alla portata di tutti ma richiede delle specifiche competenze tecniche, anche se in alcuni casi è possibile anche acquistare direttamente uno smartphone con il sistema operativo diverso da quello di fabbrica sul negozio on line di chi sviluppa il software. I vantaggi di avere una rom diversa da quella stock (così vengono chiamate le versioni alternative di firmware) riguardano soprattutto il consumo di batteria, la libertà di scegliere che app usare e un notevole aumento della tutela dei nostri dati. Generalmente queste rom (Read Only Memory) sono più leggere e personalizzabili, e soprattutto non hanno installate tutte le app dei produttori e loro partner che ci si ritrova in uno smartphone appena acquistato. Ce ne sono specificatamente orientate alla privacy come Graphene e Calyx o altre destinate all’uso di tutti i giorni come Lineage che comunque consentono di estendere la vita dei dispositivi. Quando si parla di software libero la fantasia non ha limiti e c’è chi addirittura riesce creare cluster di server (insieme di computer interconnessi) con smartphone obsoleti.
Esistono comunità di utenti dedicate a specifiche rom o specifici modelli, come altre relative alle riparazioni o alle buone pratiche, per esempio per non rovinare la batteria e farla durare di più è meglio tenere sempre uno stato di carica tra il 20% e l'80% e mai tenerla tutta la notte collegata all’alimentazione, come facciamo tutti di solito. La pratica dell’autoriparazione si è diffusa molto data la semplicità con cui è possibile procurarsi i pezzi sostituibili compatibili, c’è chi in Cina è riuscito a comprare tutti i singoli componenti e assemblarsi autonomamente un iPhone per puro scopo dimostrativo. Ifixit.com, che si definisce una comunità online di persone che si aiutano a riparare cose, è uno dei portali di riferimento per trovare guide precise e dettagliate per avere informazioni sul proprio dispositivo. In alternativa ci si può sempre recare presso uno degli ormai tanti negozietti specializzati che effettuano le riparazioni, sono sempre più diffusi anche se ancora sono lontani dal livello raggiunto in India nei mercati di Nehru Place a Delhi oppure Lamington Road a Mumbai. Qui vengono trattati i computer portatili, grazie alle abilità dei tecnici del posto prendono vita i «laptop Frankenstein» partendo da quelli che noi chiamiamo RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), dando la possibilità a chi non può permetterselo di possedere un computer.
In conclusione, esiste un mondo poco conosciuto e anche volutamente celato dietro questi oggetti che ormai fanno parte della nostra quotidianità e di cui si fa fatica a immaginare di vivere senza, Juan Carlos De Martin nel suo Contro lo smartphone lo ha raccontato a 360 gradi.
Le possibilità per percorrere strade alternative a quelle imposte, in questo caso del consumismo, sono sempre tante. Per provare a fare meno danni al pianeta è necessario avere la volontà e un po’ di buon senso oltre alla consapevolezza del contesto in cui ci si muove.
APPROFONDIMENTI Carlo Milani Pedagogia hacker, o dell’autogestione
Che cos’è la pedagogia hacker?
Più facile dire cosa non è. Pedagogia hacker non è un manuale sull’uso «corretto» della tecnologia. Non è un metodo per imparare a diventare hacker. Non è nemmeno un manifesto programmatico.
Ricorriamo a questa espressione da ormai un decennio per descrivere quel che facciamo in maniera evocativa. Il libro pedagogia hacker, interamente e liberamente disponibile anche in formato digitale all’indirizzo https://eleuthera.it/ph, si presenta come una raccolta, un resoconto, una selezione delle nostre attivazioni e attività per ripensare il nostro rapporto con le tecnologie, in particolare digitali. Le attivazioni sono semplici proposte per tutte le persone che vogliono sperimentare relazioni diverse con le tecnologie, mentre le attività sono state messe a punto specialmente per chi ha responsabilità nei confronti degli altri e di gruppi: educatori, insegnanti, genitori, formatori, organizzatori. L’obiettivo è sempre cercare di aumentare il grado di autogestione, individuale e collettiva, giocando con alcune macchine e sistemi che sentiamo affini. Per fare autogestione serve potere: potere di fare, potere di comprendere, potere di modificare le proprie relazioni, potere di disertare sistemi tossici, a cominciare dai GAFAM (Google Apple Facebook Amazon Microsoft).
Da oltre venticinque anni frequentiamo le comunità legate ad https://hackmeeting.org che si definisce «incontro annuale delle controculture digitali italiane». Qui abbiamo incontrato creature simili, che si chiamano hacker. Portare questa attitudine di curiosità, di voglia di autogestione delle tecnologie nelle nostre pratiche di insegnamento, dall’università alle scuole superiori, fino alla formazione con gruppi formali e informali di ogni
Giocare a selezionare le tecnologie di cui ci FIDIAMO, insieme alle persone di cui scegliamo di fidarci tipo, è stato un processo spontaneo. Ormai da un decennio pensavamo a come restituire alle tante persone affini da cui abbiamo imparato le nostre riflessioni sotto forma di attività pratiche: la spinta finale è venuta dalle colleghe di CIRCE - https:// circex.org che ci hanno sostenuto durante la scrittura, e dall’editore, elèuthera, che ci ha aiutato a sgrossare una quantità enorme di materiali eterogenei per strizzarli dentro a un oggetto-libro.
Quindi, la pedagogia hacker è un gioco di fiducia. Giocare a selezionare le tecnologie di cui ci fidiamo, insieme alle persone di cui scegliamo di fidarci. Lo smartphone ci opprime? I social ci assillano? Possiamo farne a meno, o far diversamente. Le tecnologie non sono tutte uguali, e quando il discorso cade sulle tecnologie di solito c’è qualcosa dietro, qualcosa sotto: relazioni disfunzionali con persone e macchine che s’impongono come se non si potesse scegliere altrimenti. Internet è una rete che ci intrappola, piena di insidie? Forse, ma è anche il luogo in cui acquisiamo i superpoteri di parlare a distanza e confrontarci con realtà lontane, diverse, meravigliose. Hacker significa per noi persona curiosa del mondo intorno, che vuole capire come funzionano le cose, metterci le mani, smontarle e rimontarle per dare forma all’immaginazione personale in un immaginario collettivo condiviso.
Fare pedagogia hacker vuol dire praticare uno sguardo strabico, per osservarci mentre interagiamo con le tecnologie, in particolare digitali. I nostri comportamenti, le nostre emozioni e reazioni con le macchine dicono molto di noi. Rabbie e gioie, odi e amori, ansie e angosce, esaltazioni ed eccitazioni, speranze e delusioni fluiscono attraverso i social, gli smartphone, i computer, le reti. Le macchine ci modificano, e noi le modifichiamo, ma spesso non siamo noi a scegliere. Le tecnologie ci vengono imposte, come inevitabili «innovazioni» a cui è impossibile sottrarsi. Diventiamo stranieri a noi stessi, alieni perché alienati dagli strumenti con cui siamo obbligati a convivere. L’alienazione tecnica continua ad aumentare. Fare pedagogia hacker significa ridurre l’alienazione tecnica, che è alla base delle altre alienazioni: psichica, sociale, economica. Imparare insieme a selezionare ed evolvere ciò che ci fa stare bene, mentre limitiamo gli effetti nocivi di quello che ci fa star male, è pedagogia hacker.
Primo, giocare
Il gioco è centrale nella pedagogia hacker. Gioco per noi significa attività appassionata, libera dalle costrizioni economiche e salariali; un’attività che non si relega nel «tempo libero», un’attività che non si limita ai bambini, ma al contrario un’attività necessaria per vivere. Considerare le tecnologie, in particolare digitali, come dispositivi inanimati a disposizione degli umani è una sciocchezza madornale;
Fare pedagogia hacker vuol dire PRATICARE uno sguardo strabico, per osservarci mentre interagiamo CON le tecnologie DIGITALI
ancora peggio quando si ritiene che servano per automatizzare il funzionamento del mondo nel senso di produrre di più, in maniera più efficiente. Purtroppo questo mito è diventato una credenza assolutamente maggioritaria.
Invece le tecnologie in rete, il net-working in inglese (lavoro di rete), con una vecchia battuta, è not-working, non-lavoro: lo stato «normale» delle cose è che non funziona nulla, è tutto rotto. Pronto, mi senti? Non ti funziona il microfono. La camera è in tilt. Spegni e riaccendi. Prova a rientrare. Forse hai un virus. C’è un bug…
In questo contesto ad alta intensità tecnologica gli umani sono sempre più ingranaggi di Megamacchine che non hanno deciso di costruire né di far funzionare, almeno non esplicitamente. Si invocano gli esperti, i tecnici per «risolvere» problemi sociali, che non sono affatto problemi, ma dinamiche di potere che vanno comprese. E invece, di fronte alle disfunzionalità strutturali, si sente ripetere sempre più spesso: «Faccio solo il mio lavoro». Questa è l’espressione tipica dell’ingranaggio, che apparentemente non ha alcuna responsabilità né libertà, ma di fatto contribuisce a risucchiarci e inglobarci nelle propaggini delle catene gerarchiche. Ogni ingranaggio umano tende a favorire la riduzione di altri umani a ingranaggi conformi al proprio ruolo, che agiscono i propri automatismi e possono solo dire di aver obbedito agli ordini, per quanto stupidi e alienanti. Rischiamo di diventare dei Piccoli Eichmann, funzionari delle Megamacchine, direbbe Lewis Mumford.
Perciò noi scegliamo di giocare. Gioco è innanzitutto fare un passo indietro rispetto alle nostre interazioni e osservarci interagire, prestare attenzione alle reazioni dei nostri corpi, alle emozioni che ci attraversano e troppo spesso ci agiscono come reazioni automatiche. Gioco per la pedagogia hacker è esercitarsi a vedere il quadro del gioco che qualcun altro ha allestito per noi e in cui siamo immersi: il Gioco di Facebook, di Instagram, di YouTube, di ChatGPT, della prossima mirabolante tecnologia che si presenta come soluzione auto-magica a bisogni indotti.
Secondo, non dipende (solo) da come la usi
Dipende come la usi: questa espressione viene spesso ripetuta, negli ambiti più vari, quando si riflette sull’impatto della tecnologia sulle nostre vite.
Ma è un’affermazione falsa. Reitera l’idea della neutralità della tecnica, condivisa dal marxismo così come dall’industrialismo, anche da quello sedicente liberale. Secondo Marx esisterebbe una cosa in sé, la macchina, che l’uso capitalistico distorce nei suoi effetti: cioè di per sé la macchina può essere usata bene o male, quindi appunto «dipende da come la usi»1 . Questa idea è funzionale anche a chi vuole addossare al cittadino/consumatore la responsabilità per un presunto «cattivo uso» di una tecnologia di per sé «neutra».
Le TECNOLOGIE digitali di massa IMPLICANO lo sfruttamento DISSENNATO delle RISORSE naturali e umane
Invece, no: non dipende (solo) da come la usi. Le tecnologie digitali di massa implicano lo sfruttamento dissennato delle risorse naturali e umane; sono progettate per favorire l’abuso e l’auto-abuso tossico; prevedono determinati usi e ne escludono altri, o li rendono estremamente onerosi e complicati. In ogni caso, tali tecnologie sono proprietà di alcuni padroni, ergo non possono in alcun modo esser piegate a un obiettivo di convivialità condivisa: sono strutturate per il dominio, non per l’autogestione. Non sono nemmeno riformabili e devono essere abbandonate prima possibile: vanno disertate, per lasciar spazio e tempo ad altre tecnologie, grazie alle quali possano germogliare pratiche di mutuo aiuto.
1 Si veda An.Archos, Razionalità tecnica dominazione, 1 - La macchina*,* in particolare Roberto Marchionatti, Un mito marxiano: macchine e lavoro emancipato, pp. 93-102.
Come fare?
Fra le tante cose imparate in questi anni di ricerca di tecnologie conviviali, su misura per noi, adatte perché appropriate, vogliamo ricordare innanzitutto che nulla è ovvio. Quindi è fondamentale non dare nulla per scontato. Non è scontato che aprendo un rubinetto esca l’acqua, che l’elettricità fluisca nelle prese di corrente, né tanto meno che internet «funzioni», che lo smartphone «funzioni». Così… di chi ci fidiamo quando qualcosa non funziona, a chi andiamo a chiedere aiuto? Acquisire consapevolezza delle nostre abitudini e delle reti sociali che queste abitudini strutturano è un pri-
mo passo.
Spesso ci interpellano insegnanti, educatori, genitori, imprenditori schiacciati dal peso della tecnoburocrazia, e ci chiedono «soluzioni». Ma non esistono soluzioni tecniche a questioni sociali. Il digitale è una questione trasversale, riguarda anche e soprattutto gli adulti. Ci viene chiesto di insegnare a «usa-

re bene» determinate tecnologie, ad esempio i social media di massa. Ciò è impossibile: al limite si possono mitigare gli effetti negativi, mettere in atto tattiche di autodifesa digitale, ma se la digitalizzazione è sinonimo di esternalizzazione presso un fornitore esterno, cioè di delega dell’organizzazione sociale, il tema è sociale e politico prima ancora che educativo. Vietare i social ai minori e contemporaneamente costringerli ad avere a che fare tutti i giorni con Google Classroom (è un esempio scelto fra i tanti strumenti che non rispettano la legislazione europea sulla privacy, GDPR) è un comportamento schizofrenico da parte degli adulti. Così come insistere sull’importanza della privacy (riservatezza) e poi delegare le pubbliche amministrazioni, dal livello locale a quello transnazionale, alle «soluzioni» software e hardware messe a punto da multinazionali a scopo di lucro.
In ogni caso, i social network (reti sociali) esistevano prima del digitale di massa; i social media sono un’involuzione di quelle reti2 , strutturate per favorire l’autopromozione tossica sulle piattaforme private di proprietà di qualche miliardario o di qualche governo.
E l’IA?
Ultima arrivata nel panorama delle tecnologie del dominio, l’IA è un’ottima occasione per fare un po’ di pedagogia hacker.
Con uno sguardo storico, va ricordato che non si tratta di un attore nuovo: dagli anni Cinquanta del XX secolo, con alterne fortune, si spendono favolose quantità di risorse per inseguire questa chimera. Da un punto di vista tecnico, l’IA non esiste, nel senso che, un po’ come il cavaliere inesistente di Italo Calvino, è un involucro di marketing, al momento di grande successo, ma vuoto di contenuti concreti. «L’intelligenza inesistente» è il titolo di un libro di Stefano Borroni Barale, amico e collega di CIRCE, https://altreconomia.it/prodotto/intelligenza-inesistente/: quando si osserva da vicino, come esorta a fare la pedagogia hacker, si scopre che sotto l’etichetta «IA» vi sono tecnologie molto eterogenee fra loro.
Tecnologie diverse e, in ogni caso, in grado di computare molto rapidamente, ma non esattamente intelligenti (la definizione di intelligenza non è comunque condivisa: intelligenza significa far di conto? Scrivere? Dissimulare? Esercitare gentilezza?) né del tutto artificiali, visto che ci sono sempre dietro programmatori, controllori, annotatori, persone. Gli LLM (Grandi Modelli di
2 Ian Bogost, https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/11/twitter-facebook-social-media-decline/672074/
Linguaggio) della serie GPT non hanno molto a che vedere con i sistemi impiegati per risolvere problemi di protein folding, come le proteine si ripiegano, questione fondamentale per mettere a punto nuovi farmaci. Le automobili a guida autonoma, che attualmente richiedono molti occhi e cervelli umani a monitorare per sollevare chi guida dalla necessità di fare attenzione, fanno ricorso a tecniche molto diverse da quelle necessarie per giocare a scacchi: eppure tutte queste cose vengono chiamate «IA».
A nostro parere, questa espressione pericolosamente antropomorfizzante confonde e non aiuta a comprendere come evolvere macchine conviviali. In ogni caso, più una tecnologia è complessa, più un sistema presenta livelli, più è fragile e «semplice» da sabotare, manipolare, rendere instabile. Questa non è necessariamente una buona notizia, anzi: «hackerare» nel senso della pedagogia hacker, in molti casi, diventa impossibile: tecnologie tossiche strutturate in maniera gerarchica vanno semplicemente disertate, senza cercare di «regolamentare» o renderle «etiche» o riformarle. Non tutto si può aggiustare, riparare, adeguare.
La pedagogia hacker propone quindi una selezione di pratiche tecnologiche per imparare dalle e con le persone intorno a noi, per formarci insieme, per diventare umani più autonomi, capaci, potenti. Non in solitudine, ma insieme a persone e tecnologie affini. È una questione di potere. Nessuna garanzia: nel momento in cui diffondiamo potere, questo potrà essere accumulato per strutturare gerarchie, esercitare dominio e ritorcersi contro di noi. Eppure, non si possono ampliare i margini di reciproca libertà se non aumentando ciò che siamo in grado di fare, sentire, comunicare come individui e insieme, cioè il potere individuale e collettivo. Sappiamo bene che non saranno delle istituzioni benevolenti, sedicenti democratiche, a liberarci. Se sentiamo che vorremmo poter fare, dire, comunicare, vivere, amare… e non possiamo, è necessario prenderci quel potere, costruircelo: per questo, in un’era in cui viviamo insieme a macchine estremamente potenti, fonte di enorme potere, cerchiamo di selezionare quelle che fanno al caso nostro, e quei modi di fare che sentiamo affini. Ci diamo da fare, senza illusioni millenaristiche, ma anche senza rimpianti rispetto a un’età dell’oro che non è mai esistita.
In fondo, la sfida principale è sempre la stessa: di fronte a continue catastrofi ambientali, devastazioni, guerre, è necessario rimboccarsi le maniche, perché «se non faremo l’impossibile ci troveremo di fronte l’impensabile!» (Murray Bookchin, L’ecologia della libertà, 1982). Cominciare quindi a immaginare un presente diverso, e agire per realizzarlo, organizzandoci insieme. Le macchine affini possono aiutarci.
[tradotto dall’originale in spagnolo pubblicato sul n. 3 di «Redes libertarias», https://acracia.org/pedagogia-hacker-pedagogiade-la-autogestion-que-es-la-pedagogia-hacker/]

CONVERSAZIONE Conversazione con Pietro Babina a cura della Redazione
Nel gennaio 2025 all’Arena del Sole di Bologna si sono tenute le rappresentazioni dello spettacolo S&B. Sole e Baleno (una favola anarchica) di Pietro Babina (testo) e Alberto Fiori (musica) con Pietro, Alberto e Serena Abrami.
Come è noto ad alcuni nostri lettori, negli anni ‘90 del Novecento, a seguito di alcuni attentati, avvenuti in Val Susa, contro i primi cantieri del treno ad alta velocità, sono arrestati tre giovani attivisti Maria Soledad Rosas (Sole), Edoardo Massari (Baleno) e Silvano Pellissero, che abitano la Casa di Collegno, squat chiuso dalle autorità, le quali attaccano anche altre due case occupate: l’Asilo è sgomberato mentre all’Alcova l’operazione non riesce. Sole, Baleno e Silvano si dichiarano estranei alle accuse.
Sole e Baleno, imputati di associazione sovversiva e soggetti a reclusione preventiva, si suicidano a breve distanza l’uno dall’altra. S&B. Lo spettacolo di Babina riunisce le parabole di Giulietta e Romeo e di Sacco e Vanzetti in un unico dramma in cui si ritrovano i grandi temi della tragedia: amore, morte, potere, ingiustizia, amicizia, idealismo, aspirazione a un mondo migliore. Il regista fa di questa vicenda un’opera di teatro musicale, la cui struttura riprende quella dell’Opera da tre soldi di Brecht/Weil e viene eseguita da due soli attori che ricoprono tutti i ruoli e da un musicista. Non tanto una ricostruzione storica della vicenda di Sole e Baleno, ma una nuova narrazione che raccoglie i temi drammatici principali di quegli avvenimenti, per un racconto emblematico e universale. La storia di due giovani uniti da un amore assoluto – e dal loro idealismo – che si scontrano con un potere e una società che prima reprime e uccide, poi riflette.
Abbiamo intervistato Babina nella primavera del 2025 e proponiamo al pubblico questa chiacchierata sull’arte, sull’anarchia, sul movimento di Genova e sul mondo odierno, lasciando quanto più possibile la forma immediata e discorsiva tipica dell’oralità.
Ci racconti come ti sei avvicinato a questa tragica vicenda e da dove nasce il tuo interesse per essa? Insomma, perché la scelta di Sole e Baleno*?*
La storia è molto lunga, e comincia quando accaddero i fatti. Sono sempre stato di tendenze anarchiche e mi ritrovo in questa idea, che ha molte facce. Mi ritengo vicino all’approccio libertario, se vado in una manifestazione mi aggrego agli anarchici oppure vado da solo; sono sempre stato legato all’anarchia, nel senso che da quando ho una coscienza politica mi sono dichiarato anarchico. Ciò mi ha dato diversi problemi in quanto non sono inquadrabile.
Quando negli anni Novanta c’erano i centri sociali io ero in contatto con quella rete, quindi quando accaddero i fatti di Torino li seguii. Ebbi l’impressione che si trattasse di una tragedia e di una tragedia particolare, tanto che ci dicemmo che sarebbe stato bello farne uno spettacolo. Poi la cosa cadde, ma il progetto l’ho tenuto lì, anche se sembrava non venire mai il momento per concretizzarlo.
Poi c’è stato un incontro determinante: vado all’Interzona a Verona, è la fine degli anni Novanta, e faccio conoscenza con Giovanni Brunetto, un anarchico veronese, un disadattato totale; ero andato lì per fare un festival e mi assegnano come supporto tecnico questo personaggio stranissimo che faceva fatica a parlare e stava negli angoli. Si rivela essere una persona sensibile, intelligente, particolare, uno che ne aveva combinate di tutti i colori e mi dice: «io vorrei lavorare con te, con voi». Io tergiverso, ma lui si presenta ad ogni spettacolo e alla fine è diventato il nostro tecnico ufficiale, si è trasferito a Bologna ed è uno dei miei migliori amici. Lui era amico anche di Sole e Baleno, li conosceva personalmente. Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto fare un lavoro su di loro e ha risposto che aveva tutti i giornali dell’epoca, un archivio coi ritagli di giornale, i volantini di Torino e altra documentazione e che era andato a tutte le manifestazioni. Allora lì ho cominciato a lavorarci, erano gli inizi degli anni Duemila. Volevo fare un’opera musicale, ma non trovavo le situazioni giuste. Nel frattempo faccio un primo lavoro con Alberto sul Candide di Voltaire, ci eravamo trovati bene così ritiro fuori con lui questo progetto su Sole e Baleno: per me è una storia eccezionale, in più è un pezzo della nostra storia. Inoltre c’era stata Genova 2001 che è stato un evento importantissimo e quel che è accaduto a Sole e Baleno anticipava Genova e ciò che ne è seguito, cioè una repressione continua fino al punto a cui siamo arrivati oggi.
In quel momento non volevamo fare quel che poi è venuto fuori in questa versione, ma opera lirica vera e propria: io ho cominciato a scrivere il libretto e lui la musica, abbiamo cercato molti teatri e ricevuto tante pacche sulle spalle ma nessuno che aprisse le porte, e quindi il progetto è caduto nuovamente; torna a chiudersi il cassetto.
Poi arrivano questi tempi, sempre peggiori le cose che accadono oggi, il mondo degli anni Novanta con un certo tipo di attivismo e di modi di vivere scompare, annullato dalle amministrazioni che chiudono le occupazioni, dai social e dagli smartphone che stravolgono le relazioni e il panorama sociale: tempi che vivo con un grande disagio. In questo contesto ho pensato di fare un lavoro sull’Opera da tre soldi, e ho cominciato, coinvolgendo Alberto per la parte musicale, a lavorarci sopra, ma dopo molto lavoro svolto, ci sono stati negati i diritti di rappresentazione a causa della forma che volevamo dare al lavoro e non abbiamo potuto andare avanti. Quindi, ci siamo detti, perché non riprendiamo il progetto su Sole e Baleno e man mano che ci lavoravamo ci sembrava una fortuna, artisticamente parlando, unire Brecht a Sole e Baleno. Così abbiamo usato la struttura drammaturgica dell’Opera da tre soldi, per costruire il racconto di Sole e Baleno. Siamo partiti in autonomia e abbiamo continuato così, mettendo da parte l’idea di trovare dei grandi produttori e arrivando fino in fondo per conto nostro. Per la mia parte ho scritto tutta la storia grazie ai faldoni di documenti, agli articoli, ai libri che avevo a disposizione: l’idea era di «fabulizzare» la vicenda, farne non un teatro giornalistico, ma trasformare la vicenda in una storia che avesse una fascinazione narrativa e man mano che la scrittura andava avanti ho inserito quei fattori di pura fantasia come il personaggio ad esempio quello di Maurizius, che rappresenta il destino, il fato, elementi a cui si può credere o meno, ma insomma nella vita ci sono cose non programmabili, o programmate altrove, cose che accadono inspiegabilmente e cambiano definitivamente il corso della nostra vita, pensa all’amore.
Io ho questo tipo di spiritualità, vengo da una famiglia cattolica che mi ha fatto andare in chiesa e a catechismo, poi a un certo punto ho capito che sono solo chiacchiere, che quei valori non venivano applicati, ma da lì ho introiettato un senso di giustizia, di fratellanza, che non ho buttato via anzi e che ritengo valori positivi. Aiutare gli altri, essere solidali, credere in una giustizia sociale: continuo a essere legato a questi principi, che però non riporto più al divino e che pratico in prima persona e quindi paradossalmente la mia anarchia proviene da un mondo che l’ha combattuta, anche se l’idea che Gesù Cristo fosse un proto-anarchico non è solo un’idea mia.
Così sono riuscito, aiutato nuovamente da Giovanni, che mi ha dato una mano con le cose tecniche e mi ha prestato il materiale gratuitamente, a debuttare con questo spettacolo. Via via nella vita ci sono stati momenti che mi hanno riportato a quella vicenda, e alla fine ce l’ho fatta a realizzare il progetto: se l’avessi fatto allora non avrei fatto le stesse scelte e forse non avrebbe avuto la stessa efficacia, nel tempo sono maturato artisticamente; è stato un lungo lavoro di scrittura, e non ti nascondo che avessi una certa paura: ero sereno con me stesso, ma ero anche pronto all’eventualità che alcuni anarchici contestassero, perché su Sole e Baleno sono state fatte iniziative che non hanno trovato consenso negli ambienti anarchici. So che sono argomenti difficili da trattare, sono stato però molto attento a far sì che la storia corrispondesse al vero, ma cercando di fare in modo che non fosse un freddo reportage giornalistico. Come accade nella canzone anarchica su Caserio, che raggiunge un livello diverso dal punto di vista emozionale: Caserio ha pugnalato qualcuno, quindi in sé non fa un gran gesto, ecco, ma nella canzone traspare invece la giustizia del suo atto, è questo il bello. È il bello dell’epica anarchica.
Nello spettacolo a un certo punto esprimi in maniera poetica e precisa, una delle caratteristiche intrinseche dell’anarchia, e una sua necessità insopprimibile: essere elemento antagonista al potere, limitarlo affinché non debordi. Ti va di approfondire questo tema?
Io non ho una grande formazione teorica, ma credo che l’anarchia sia un’idea intuitiva, si dice che sia un’utopia e come tale una proiezione nel tempo quasi all’infinito, ma essa ha anche, per chi la sente propria, un significato immediato, quotidiano direi; spesso mi trovo in discussioni a tavola con gente di sinistra e di destra che mi dicono che l’anarchia è un’utopia e che non è possibile, perché la gente vuole essere guidata o comandata a seconda degli orientamenti. La mia idea invece è che l’anarchia sia una tensione, so che non si realizzerà mai nella sua totalità, ma questo non vuol dire che non bisogna tentare. È un fine alto, che ci serve per muoversi in quella direzione, l’asticella va tenuta alta, è una necessità per me. Poi mi possono dire che sono matto, perché la gente non riesce ad orientarsi bene sull’anarchia, che è stata ed è un’idea che viene combattuta, ma anche rapinata sia da destra che da sinistra. Quel che mi affascina è anche la questione, centrale per l’anarchia, del rapporto coerente tra mezzi e fini e infatti è l’unica idea che non si è corrotta, perché non ha mai ceduto su questa questione. Questo approccio appare perdente in una corsa al potere, ma è ciò che le ha permesso di non corrompersi: l’anarchia non ha cercato di entrare in parlamento, non si è abbrutita, è l’unica tra le idee politiche dell’epoca moderna, a essere ancora viva e utilizzabile, le altre sono fritte, sono cose della storia, invece l’anarchia è ancora contemporanea, è sempre viva e vedo che anche chi è giovane la vive così, non come una cosa stantia; è un’energia sottesa al consesso sociale, in questo senso è antagonista, e dobbiamo coltivarla e fare sì che resti viva, perché dà un senso altro al vivere sociale e quando la tempesta passerà da lì si deve ripartire; questo è un dato di fatto, io lo vedo e ci credo.
Nell’incontro col pubblico dopo lo spettacolo teatrale hai spiegato in maniera molto lucida il tuo punto di vista, politico e biografico, sulla deriva attuale dell’Europa. Lo puoi illustrare anche ai nostri lettori?
Nel secondo dopoguerra ci sono state idee come il comunismo o il socialismo, che, quando sono arrivato io ai 17-18 anni perdevano pezzi, lasciandomi senza punti di riferimento. Sì, c’era ancora la FGCI, la retorica del 25 aprile, il terrore della bomba alla stazione di Bologna e quindi un certo tipo di identità comunista la nostra generazione l’ha vissuta, e però ha anche visto trasformarsi le feste dell’Unità dalla lotteria con la Skoda alla discoteca e alla fiera campionaria. Insomma sono arrivati gli anni Ottanta e il liberismo si è diffuso ovunque, quindi quella cosa, il comunismo, non aveva più forza. Poi però sono accadute delle belle cose: è crollato il muro, è stato superato quell’obbligo di dovere avere il passaporto per girare in Europa, si è prodotto un senso di fratellanza europea tra i ragazzi di tutto il continente; si girava l’Europa e si era tutti amici, c’era molta curiosità e fermento. Poi c’è stato l’avvento di internet e l’idea che potesse essere una pratica di libertà e un’opportunità di fare del giornalismo indipendente – non sapevamo che sarebbe diventata una trappola come è diventata, con il monopolio delle piattaforme private che aprono e chiudono il rubinetto sulle informazioni come vogliono – comincia a nascere quel movimento no-global che parallelamente alla costruzione di una nuova Europa teneva dentro tutti e che a differenza del movimento della Pantera era un movimento nuovo, scevro dalle vecchie ideologie, e il fatto che ci fosse una gran varietà sociale e politica dentro queste manifestazioni a me, che pure mantenevo le mie idee, pareva bello. Abbiamo vissuto un grande sogno collettivo, pari a quello delle altre generazioni, qualcosa di esaltante. L’Europa unita, e quindi il mondo unito, erano diventati i nostri progetti, l’abbandono dello spirito nazionalista per una fratellanza, per l’abbattimento delle frontiere, il mescolamento di lingue e linguaggi, i viaggi, gli incontri, gli scambi.
Poi si va avanti e si cominciano a vedere i problemi perché i governi incominciano a contrastare in maniera forte i movimenti fino ad arrivare, facendola molto breve, al G8 di Genova, dove si pensava che si dovesse lottare e anche che ci sarebbero stati degli scontri, ma che ci fosse una dialettica, che ancora si potesse contribuire a dare una direzione alla gestione futura del mondo, invece lì è successo quello che è successo. In quelle giornate e anche dopo, ci fu un silenzio totale da parte di tutti i governi presenti sul massacro che si compiva, nonostante siano stati bastonati abbondantemente anche cittadini di altri paesi i cui governanti erano presenti nella famosa zona rossa, segno che non era un programma estemporaneo ed esclusivamente dei «fascisti italiani», dei Berlusconi, dei Fini, ma era un progetto europeo e globale concordato: hanno deciso di alzare il livello della repressione nell’occasione italiana, forse anche per una certa congiunzione tra tipo di governo e impostazione delle forze dell’ordine più predisposto a un’azione di repressione dura, e l’hanno fatto, e così siamo tornati a casa umiliati e feriti, anche chi non le aveva prese personalmente. In quel momento o scoppiava l’ira di Dio, c’era una reazione altrettanto forte, cosa che purtroppo non è successa, forse perché non eravamo pronti, o si sarebbe arenato tutto, cosa che purtroppo è avvenuta. Molti hanno abbandonato l’attivismo, il movimento si è sgonfiato progressivamente, poi è arrivato il 2008, la crisi, la Germania che calpestava i greci e poi una progressione fino al delirio odierno che è la negazione totale di quello che desideravamo e che avremmo potuto avere. Ora è tutto diverso. C’è troppo «bravoragazzismo» – non si spaccano le vetrine! – troppo conformismo. Internet è diventata quello che è diventata, poi l’invasività dei social e degli smartphone, tutta una serie di meccanismi subdoli: o quelli più giovani di me che fanno teatro, muovendosi in un panorama culturale gestito totalmente per bandi, cercano di capire cosa piaccia, quali siano le linee indicate da seguire perché i loro progetti possano essere finanziati e sostenuti e perciò non propongono dal basso una propria visione del mondo, si esprimono all’interno di schemi preordinati dal sistema culturale che ovviamente è gestito dall’alto, o dalle amministrazioni, o dal mercato il quale in un certo qual modo istruisce anche le amministrazioni. Ancora negli anni Novanta si avevano dei politici di riferimento al comune di Bologna con i quali c’era un dialettica, che osservavano cosa accadeva spontaneamente nella città e poi si assumevano la responsabilità di appoggiare o non appoggiare una determinata situazione, con le relative conseguenze e rischi politici ma, ripeto, in una forma dialettica, poi quando hanno cominciato a circolare parole come marketing culturale e sono nati i relativi distretti, è partita anche la dinamica dei bandi, che tendono ad azzerare i rischi politici. La dinamica è la seguente: si indicano le caratteristiche che il progetto deve avere per essere finanziabile e quindi, di fatto, l’amministrazione dirige, decide cosa potrà essere prodotto a livello culturale, è un ricatto del tipo: se vuoi questi soldi fai così. Nello stesso tempo vengono cancellati tutti i luoghi di aggregazione spontanea e vengono sostituiti con luoghi di aggregazione calati dall’alto, soft-coatti.
Prendendo spunto ancora dall’incontro col pubblico e dalla risposta precedente ti va di spiegare a chi legge cosa vuol dire che Genova 2001, come sostieni, sia stata una svolta?
In quegli anni attorno a Genova 2001 c’è stata una presa di coscienza che si stava andando verso una globalizzazione capitalista neoliberista spinta e che se non si voleva andare verso quella deriva, che avrebbe poi fatto risorgere i confini, i nazionalismi e le guerre come forma di controllo, bisognava prendere di petto il tema.
C’è stata una gioventù che ha capito questa cosa e ha cominciato a fare delle rivendicazioni, evidenziando che la piega presa era pessima, in quanto quella in atto non era una globalizzazione dei popoli, ma degli interessi delle multinazionali e degli Stati, i quali in un certo senso sono oggi anch’essi sottomessi alle multinazionali.
Noi volevamo l’abbattimento dei confini, non solo per le merci, ma per gli esseri umani e le culture.
È stata una stagione in cui si è sviluppato un attivismo sul campo che disturbava un certo tipo di politiche e di poteri, frutto di un movimento dal basso molto trasversale, eterogeneo, globale. Seattle, Porto Alegre, Goteborg ecc. davano l’idea di un movimento che metteva in discussione certe politiche, fino a Genova, dove il potere ha voluto dare un segno chiaro e inequivocabile a tutta quella massa di giovani e non solo, facendo sì che gli spazi di dissenso si restringessero poi in maniera drammatica. Le manifestazioni pacifiche sono state assaltate, i media hanno individuato il capro espiatorio nei black bloc, additandoli come infiltrati. Ma non erano infiltrati, praticavano un’altra modalità di lotta, e questa sulle tattiche di lotta è ancora una discussione aperta. Visto come è andata, ognuno può tirare le conclusioni, io credo che una volta fatto il tentativo pacifista e visto l’atto repressivo terribile in risposta, ci sarebbe dovuta essere una reazione di altro tipo da parte nostra. Ricordo che a Bologna, di ritorno da Genova, ci fu una manifestazione in piazza Maggiore con la polizia che non si faceva vedere, stava dietro ai vicoli, ci circondava da lontano e ci fu un dibattito in cui chi sostenne che si doveva reagire duramente a quanto successe rimase minoritario. Da lì, come dicevo prima, un peggioramento progressivo, fino a oggi, che non è, penso, il punto peggiore, peggiorerà ancora: non capisco cosa succederà e come si possa uscire da questa situazione.
Teatro e anarchia sono due elementi che storicamente sono andati insieme, così come musica e anarchia. Tu utilizzi questi strumenti. Hai dei modelli, dei riferimenti culturali a cui ti rifai?
Io mi sono sempre ritenuto anarchico anche nel senso che prendo dappertutto, non ho dei modelli specifici, vado d’intuito, anche mettendo insieme cose che non sembrano poter stare insieme. Per me la creatività è la cosa principale, non il termine vago che spesso si usa oggi della serie «lasciati andare». L’arte è di fondo anarchica perché cerca sempre di rompere gli schemi, porta le cose su un altro livello. Anche un discorso scientifico o economico può fornire la base per un’esperienza artistica. L’arte è non bloccarsi entro regole specifiche, la regola si ricostruisce, di volta in volta ma lungo un percorso. Per me, nella pratica teatrale, la cosa che guida un progetto è la drammaturgia, che non è il testo teatrale sia chiaro, è quello il nucleo duro di uno spettacolo che tutti quelli che partecipano devono seguire: e quasi sempre porterà a sparigliare le carte, a dover praticare un modo diverso di stare e di gestire la scena.
Non è per niente facile spiegare quanto rigore sia necessario, nella pratica artistica, nel non avere schemi prefissati. Quella «del metodo del non metodo» può apparire un’aporia ma la pratica quotidiana dimostra che è possibile e che non si tratta del fare ciò che viene in modo estemporaneo, ma anzi occorre un grande rigore e spirito critico per rimettere in discussione le proprie pratiche, specie quando hanno dato buoni risultati.
Ci racconti a grandi linee quale è stato il tuo percorso artistico e teatrale fino a oggi?
Si parla di trent’anni. Comincio nell'87, quando sono entrato in un’accademia. Appena diplomato, ho avuto una scrittura e ho fatto una tournée; il teatro negli anni Ottanta era vissuto da molti giovani come una cosa vecchia ed era invece il momento del video, così che alla fine di quel decennio c’era una certa depressione nell’ambiente, non si vedeva il teatro come qualcosa di sensato. Io non ero d’accordo, non mi piaceva questa aria depressiva e quindi pensai di fondare una compagnia con alcuni amici dell’accademia per proporre una visione che corrispondesse alla tensione che noi intimamente provavamo e così abbiamo deciso di tentare questa avventura. La prima cosa da fare era trovare uno spazio in cui poter provare. Un giorno girando per la città con la Vespa passai in via Fioravanti, e di fronte a quello che sarebbe poi stato il Link, e dove oggi ci sono i palazzi della nuova amministrazione comunale, vidi una fabbrica occupata su cui campeggiava un classico lenzuolo con scritta spray Fioravanti occupata: entrai e conobbi alcuni soggetti particolari, tra vecchi militanti e nuovi punk, e dopo una riunione si decise che avremmo potuto occupare una saletta al secondo piano. Ci buttammo a capofitto per pulirla e renderla adatta al nostro scopo, dopo due giorni di lavori avevamo finito e uscendo dallo spazio, scrissi con un pennarello sulla porta «Teatrino Clandestino», perché era piccolo e perché era clandestino. Il giorno dopo arrivammo per cominciare le prove ma la fabbrica era circondata dai carabinieri e la ruspa stava abbattendo l’edificio. Perso tutto ci rimase il nome della compagnia Teatrino Clandestino che mi ha accompagnato fino al 2010 quando si è sciolta la compagnia.
Al di là dello spettacolo Sole e Baleno che è politicamente esplicito, in realtà questo legame con l’idea anarchica non è stato il filo della mia attività, solo in un altro caso ho affrontato in modo diretto il tema del potere, un progetto a partire dalle ricerche sull’obbedienza all’autorità di Stanley Milgram, una trilogia, il cui terzo episodio è un film. Insomma ogni tanto ricado in tematiche a sfondo anarchico. Dopo avere fatto produzioni in tutta Europa, nel 2008 il comune di Bologna ci affidò il teatro S. Leonardo, dove sono rimasto fino al 2010, quando ho deciso di andarmene dalla compagnia, facendo finire l’esperienza di Teatrino Clandestino. Quindi comincio a cercare produzioni, qualche volta le trovo, altre volte faccio delle autoproduzioni, come ad esempio un progetto chiamato Eco, una riflessione sul digitale, con le nuove tecnologie di streaming e le implicazioni che oggi sono chiare a tutti, e in particolare in relazione al teatro, progetto che ha avuto pochissimo riscontro. Poi ho iniziato a lavorare col teatro Stabile e allo stesso tempo a fare lavori miei autofinanziati, come appunto Sole e Baleno in ultimo, e prima Macello con le poesie di Ivano Ferrari sul tema della macellazione e dei macelli: progetti un po’ selvaggi e un po’ clandestini. Non sono mai entrato stabilmente nel sistema, certo ho delle connivenze con esso, ma per il mio carattere non riesco a entrarci totalmente in simbiosi e la cosa mi sa che sia reciproca. La vita non è sempre facile, essendo vicino ai sessant’anni ormai, ma è così.
Quali sono i progetti a cui stai lavorando e le tue prospettive prossime di intervento teatrale?
Il prossimo progetto, che debutterà nella primavera del 2026 all’Arena del Sole si basa su un’opera di Sara Kane, drammaturga inglese degli anni Novanta dal titolo Psicosi delle 4:48. La Kane è stata un punto di riferimento, una ribelle, questo è l’ultimo pezzo che ha scritto, poi si è suicidata; tratta delle ultime ore in ospedale prima del suicidio, è un testo delirante, poetico, folle, con una scrittura potente, eterogenea, autobiografica, tra psicofarmaci, medici che non capiscono, deliri.
All’epoca andava molto di moda e io per questo non l’ho voluta affrontare per quanto non potessi non esserne attratto. Ora è molto meno rappresentata, quasi nulla, vuoi anche per quella strenua ricerca di quieto vivere che ossessiona la nostra attuale società, che al contrario negli anni Novanta era avida di sano conflitto, soprattutto in Italia dove ha avuto una storia importante con il Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, e in particolare con Barbara Nativi grazie alla quale l’Italia è stato il primo paese che l’ha tradotta. Ultimamente ho visto a Berlino un allestimento di questo testo e mi ha incuriosito, così tornato a casa ho cercato il volume che giaceva da allora nella libreria e l’ho riletto, e ho avuto una illuminazione: la deriva psicotica su cui si basa tuto il testo sembra esattamente quello che sta accadendo alla nostra società, che non distingue più il vero dal falso, è super medicalizzata, è affannata alla ricerca del senso di vivere, sta tesaurizzando la propria coscienza e il proprio sapere nel mondo digitale, depositando lì il suo sapere per attingere poi da questo recipiente e non più da se stesso – oggi con l’IA sempre di più – e quindi c’è uno scollamento tra il sé e la macchina. La società è in un delirio totale: questo testo può raccontare molto bene, non semplicemente lo stato psicotico di una donna devastata dalla depressione, ma assurgendo a dimensione classica può raccontare la tragedia di un’intera collettività, della nostra società, che ha perso i punti di riferimento e non sa più di cosa fidarsi, è in cerca di amore e di senso, di verità. Farò quindi questo allestimento con l’attrice Petra Valentini e debutterà nell’aprile 2026 all’Arena del Sole e poi ci sarà una tournée e vedremo che seguito avrà. Quella di Sara Kane è sempre stata una scrittura molto politica, ha una scrittura dura, molto violenta e a suo modo è pervasa da uno spirito anarchico, anche se non mi risulta che la Kane abbia mai preso posizione a riguardo, il che non è in contraddizione, quanti lo sono senza saperlo?
Mentre concludiamo questa intervista continua e si amplia l’attacco dell’esercito israeliano nei confronti della popolazione palestinese…
È talmente terribile e palese quello che sta succedendo…. E si collega al discorso che facevano prima riguardo all’idea di Europa e di mondo che avevamo a Genova e che è naufragata. Anche Israele in un certo senso è un paese europeo, con certi principi, che ora vengono totalmente messi da parte, tanto che lo Stato israeliano reprime chi protesta tacciandolo di antisemitismo: è un paradosso folle, che rivela molto di questo sistema devastante, totalmente impregnato di ipocrisia, in cui siamo immersi. Affrontare la quotidianità con questo massacro in atto è difficile. Ho avuto lunghe discussioni con persone che non riescono o non vogliono (questo è un dilemma) fare «uno più uno», che non accettano nemmeno la definizione di genocidio, parola accettata oggi anche dai media ufficiali che a lungo l’hanno tenuta alla larga dai loro titoli. È una cosa incredibile vedere le manifestazioni pro Palestina attaccate e chi vuole la pace tra i due popoli messo in galera. La situazione è molto grave, non so cosa potremmo fare, ma è una delle cose per cui bisogna lottare in qualche forma. Ora è il momento in cui è necessario resistere. La resistenza vera si fa in momenti come questi, bisogna tenere la barra dritta sui principi che non sono modificabili: i diritti degli esseri umani e non solo degli esseri umani, sono immodificabili, non ci può essere nessun motivo per derogare da essi. Siamo in un brutto momento storico: Israele agisce con una spudoratezza sintomatica, agisce senza una opposizione perché la diga è crollata, i peggiori istinti umani si scatenano e fanno mostra di sé.
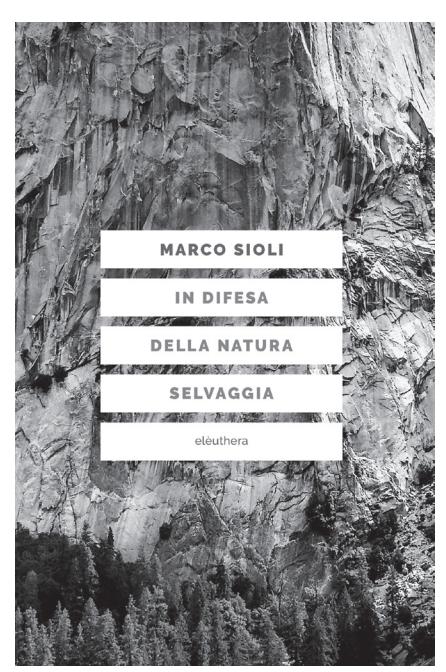
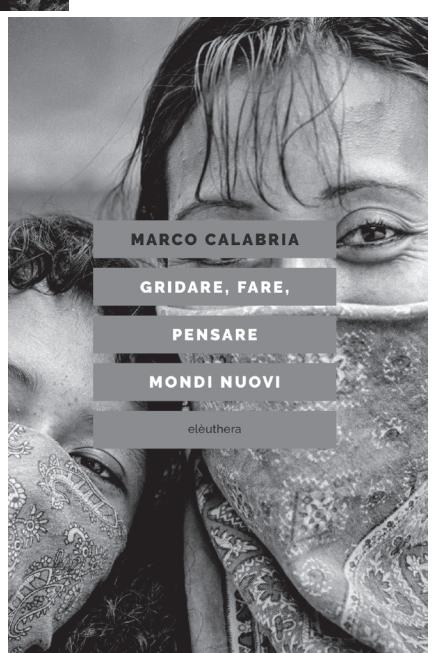

INTERNAZIONALE Matthew Wilson Colin Ward: un’ambigua eredità
Non ricordo esattamente quando mi sono imbattuto per la prima volta in uno scritto di Colin Ward, ma so per certo che è stato uno dei primi anarchici di cui ho letto qualcosa e di questa fortunata coincidenza temporale sarò sempre grato. Detto altrimenti, sono contento sia stato l’approccio particolare di Ward ad avermi inizialmente avvicinato all’anarchismo: non solo ha contribuito a dare forma al mio pensiero, ma ha anche caratterizzato il mio rapporto con la cultura anarchica, rapporto che ben presto avrebbe orientato la mia vita e quella di molti altri in giro per il mondo. Pochi anni dopo il mio incontro con il pensiero di Ward, l’anarchismo si affermò infatti come tratto distintivo nel panorama dei movimenti sociali radicali; e tuttavia si trattava di un anarchismo la cui visione risultava impoverita dall’apparente mancanza di interesse per uno dei suoi migliori esponenti. Vorrei cogliere questa occasione per onorare il lascito di Colin, in modo forse un po’ paradossale, rilevando quanto la sua influenza sulla prassi anarchica contemporanea sembri essersi affievolita nonostante il suo nome sia ancora piuttosto conosciuto. Lo dico volutamente in modo un po’ vago e generico, non per esagerare l’importanza di Ward né per essere ingenerosamente sprezzante nei confronti degli anarchici contemporanei, ma per affermare la necessità di un rinnovato impegno nei confronti di Ward e della sua opera.
Certo, l’anarchismo è un movimento articolato, con una lunga lista di tradizioni e correnti, alcune delle quali apertamente antagoniste tra loro o apparentemente ignare una dell’altra. In questo senso, per molti anarchici, il pensiero di Ward è verosimilmente importante oggi come lo era ieri. Ed è altrettanto vero, come lo stesso Ward ha sottolineato nel suo bellissimo libro Influences, che le idee si insinuano fra e oltre le ideologie, attraverso le generazioni, separandosi così nel tempo e nello spazio – anche a causa del sommarsi delle citazioni – da coloro che le avevano inizialmente formulate. L’influenza di Ward è quindi ovunque attorno a noi, anche se non percepita e indiretta. Eppure, a mio giudizio, negli ultimi venti, trent’anni la cultura anarchica dominante – il «senso comune» anarchico come mi piace definirlo – non si è particolarmente occupato di Ward e ha trascurato molti dei suoi più importanti e lungimiranti insegnamenti. A volte mi chiedo quanti anarchici sotto i quarant’anni citerebbero Ward fra le letture che li hanno influenzati, e a cosa potrebbe assomigliare oggi l’anarchismo se Ward fosse rimasto una figura chiave della cultura anarchica del ventunesimo secolo così come lo è stata per il ventesimo.
La complicata eredità di Colin Ward
Quando Ward entrò per la prima volta in contatto con l’anarchismo, il futuro di quest’ultimo doveva sembrargli piuttosto cupo. Il movimento anarchico nel Regno Unito si era via via assottigliato durante la maggior parte della prima metà del ventesimo secolo, e anche la sua rivitalizzazione durante la guerra civile spagnola venne infine soffocata dalla vittoria di Franco. Di fronte a una sconfitta così recente e di tale portata, con il mondo intero sprofondato nella guerra, non è difficile intuire perché l’anarchismo dovesse sembrare ai più deludente, se non proprio pericoloso. Non fu così per Ward, ovviamente, il quale non solo aderì all’anarchismo, ma sviluppò una propria voce al suo interno, e in un intervallo di tempo considerevolmente breve. Non passò poi molto tempo prima che l’anarchismo si risollevasse, con livelli di adesione e impegno mai visti prima. Nel 1968 era possibile veder sventolare bandiere anarchiche non solo a Parigi davanti alla Sorbona ma, come ci racconta lo stesso Ward, anche a Canterbury1 . Nel dopoguerra, man mano che gli orrori del socialismo di Stato diventavano sempre più evidenti, l’anarchismo non appariva più un ingenuo utopismo, come era stato spesso definito; al contrario, per un numero crescente di persone iniziò ad apparire come l’unica strada possibile per auto-organizzarsi in modo umano e sostenibile. Come racconta Ward: «All’improvviso si tornò a parlare […] del bisogno di un decentramento sociale e politico, della gestione dell’industria da parte degli operai, di potere studentesco, di gestione comunitaria dei servizi sociali»2 . Questi «nuovi anarchici», come li definiva Ward agli inizi degli anni Settanta, spuntavano come funghi, qua e là ma inesorabilmente, in tutto il mondo. Nonostante fosse senza dubbio ispirato e incoraggiato da questa rinascita Ward era tuttavia consapevole, come suo solito, del rischio concreto che questi semi di anarchismo potessero essere ancora una volta sepolti dal peso dello Stato. In Anarchia come organizzazione, il suo libro più noto, si chiedeva «se la gente è riuscita a imparare qualcosa dalla storia degli ultimi cento anni». E, cosa fondamentale, «se gli anarchici stessi avranno abbastanza fantasia e inventiva da riuscire ad applicare le loro idee alla società attuale […]»3 .
Le domande che gli anarchici avrebbero dovuto porsi erano tanto varie quanto vitali e l’opera di Ward potrebbe essere vista sia come un costante richiamo all’importanza di porle, sia come un inventario delle possibili risposte. Come sarebbero costruite e
1 Quanto di questa rinascita sia dovuto all’instancabile lavoro di Ward è una questione irrisolta, ma di certo è stato una figura centrale all’interno della scena britannica fin dai primi anni della sua vita da anarchico.
2 Colin Ward, Anarchy in Action, Freedom Press, London, 2008 (1973), p. 25 [trad. it. Anarchia come organizzazione, elèuthera, Milano, 2019 (1996)].
3 Ibid, p. 38 [trad. it. pp. 16].
assegnate le case in una società anarchica? Come sarebbero educati i bambini? Come sarebbero definiti e affrontati i comportamenti antisociali? Affrontando queste e innumerevoli altre pressanti questioni sociali, Ward aveva certamente lo sguardo rivolto in direzioni facili da immaginare (la storia del pensiero anarchico e i suoi, noti e meno noti, esponenti), ma ha anche cercato risposte ovunque fosse possibile trovarle, sempre con una mente aperta e un approccio non dogmatico. Questo significava leggere anche marxisti e liberali e confrontarsi con discipline come la sociologia, l’antropologia, l’architettura e la pianificazione urbana, letture che di primo acchito non avevano niente a che fare con il pensiero anarchico. Sia come scrittore sia come editore, in modo sottile Ward introdusse gli anarchici a un’impressionante gamma di idee provenienti da tutto il mondo, senza mai sentirsi in dovere di giustificare l’utilizzo di intuizioni utili prese da altri e riproposte sotto una lente anarchica. Gli anarchici hanno troppo spesso ceduto terreno ideologico a destra (come d’altronde hanno certamente fatto anche altri settori della sinistra) abbandonando idee assolutamente buone ritenute però non più valide perché adottate da altri con i quali su altre questioni non saremmo d’accordo. Nella coinvolgente raccolta di saggi Talking House Ward ad esempio scrive: «Non è colpa mia se il managerialismo burocratico si è impadronito delle politiche socialiste con la conseguenza che, nel clima di disillusione, parole d’ordine come autoaiuto e mutuo appoggio sono state tralasciate per essere poi sfruttate dal partito dei privilegiati»4 .
È difficile valutare se la visione dell’anarchismo di Ward sia stata influenzata dalla sua volontà di impegnarsi in una quantità così consistente di lavoro non anarchico, o se sia stata la sua visione dell’anarchismo – plurale, diversificata, rispettosa ed empatica – a dargli la possibilità di selezionare e prendere liberamente spunto da un mondo pieno di ottime idee spesso nascoste in luoghi improbabili. In ogni caso, Ward aveva ben chiaro che per
4 Colin Ward, Talking Houses, Freedom Press, London, 1990, p. 9.
lui l’anarchismo doveva sempre essere pensato in tensione con altre posizioni politiche e sociali; ciò che conta, come scrive nella pagina finale di Anarchia come organizzazione, sono «quei mutamenti sociali, siano essi rivoluzionari o riformisti, attraverso i quali i popoli allargano le proprie sfere di autonomia e riduco-
no la sottomissione alle autorità esterne […]»5 .
Adottando un termine utilizzato sia dalla sua generazione sia da quelle precedenti, Ward era convinto che questi cambiamenti sarebbero avvenuti attraverso l’azione diretta. Azione diretta significava creare «organizzazioni parallele, […] contro-organizzazioni, […] organizzazioni alternative, […] un maggiore controllo da parte dei lavoratori, […] un movimento per la descolarizzazione, […] la terapia comunitaria di gruppo, […] i movimenti per l’occupazione delle
case e le associazioni di inquilini, […] le cooperative alimentari, […] organizzazioni di base di ogni genere […], i giornali comunitari, i movimenti a favore dei servizi sociali per l’infanzia, […] le comuni abitative, […] i consigli di quartiere»6 . In breve, significava costruire un mondo nuovo, per quanto possibile e ovunque fosse possibile, nel guscio di quello vecchio, anche se quel vecchio mondo continuava ad esistere.
5 Colin Ward, Anarchy in Action, cit., p. 172. [trad. it. p. 219].
6 Ibid, pp. 165-66 [trad. it. pp. 210-211].
Gli altri nuovi anarchici
Se il 1968 è stato un anno di svolta per la generazione di Ward, in quanto a cambiamenti profondi dell’immaginario politico, il 1999 ha avuto un ruolo analogo per tutti coloro che come me erano cresciuti negli anni in cui gli yuppi avevano sostituito gli hippy e in cui la prospettiva di rimpiazzare il capitalismo con qualcos’altro sembrava ormai solo una fantasia. Esattamente come gli eventi del Maggio ‘68, la battaglia di Seattle nel novembre di quell’anno fu l’evento istituente sia di una particolare analisi politica sia di un manifesto strategico per un cambiamento sociale basato non sulla presa del potere statale, ma sul potere delle persone che insieme lavorano per costruire un mondo migliore. Durante gli anni Novanta, il significato attribuito al termine «azione diretta» si era in qualche modo discostato da quello che gli attribuiva Ward, per essere sempre più spesso riferito ad atti di sabotaggio, blocchi e altre azioni per lo più illegali rivolte contro obiettivi specifici come i cantieri per la costruzione di nuove arterie stradali o i laboratori per la vivisezione. All’incirca in quel periodo, gli anarchici – e, aspetto da non trascurare, anche molti non anarchici – cominciarono a parlare di prefigurazione. Per la generazione del ‘99 e dintorni, prefigurare significava infatti proprio quel «costruire un mondo nuovo nel guscio di quello vecchio» instancabilmente promosso da
Ward e da generazioni di anarchici prima di lui, anche se con una spolverata di accorgimenti che lo aggiornavano al presente. Il primo e più importante di questi accorgimenti era fare piazza pulita del passato recente per riproporre l’anarchismo del ventunesimo secolo come un fenomeno fondamentalmente nuovo. Sebbene questo sentimento fosse perfettamente comprensibile per tutti coloro che, come me, erano travolti da un’ondata di attivismo percepito davvero come nuovo, il fatto che la coscienza popolare radicale dell’epoca sia stata dominata dall’idea che questa ondata di anarchismo rappresentasse un drastico allontanamento dalle generazioni precedenti, dovrebbe essere fonte di rammarico e di riflessione7 . D’altro canto, questa fuorviante lettura del passato recente dell’anarchismo permise effettivamente di dare una svolta genuinamente nuova alla prassi anarchica. Per la generazione post ‘99 infatti, il termine «prefigurazione» ha assunto un significato molto particolare: anche se l’azione diretta come la intendeva Ward esisteva ancora (spesso sotto la definizione di DIY), la prefigurazione promossa dai «nuovi» anarchici era significativamente orientata verso i mezzi dell’organizzazione politica. I presidi di protesta nella forma di campeggi autogestiti e le contromanifestazioni in occasione dei summit internazionali diventarono le tattiche standard, e il modo in cui venivano organizzati, attraverso la democrazia diretta basata sul consenso, era non solo importante, ma costituiva l’obiettivo principale di questa forma di attivismo; era il modo in cui si organizzavano le cose, più che le cose in sé, ad essere diventato il punto centrale della cultura anarchica. L’enfasi su una concezione così restrittiva, sebbene profonda, della prefigurazione ebbe spesso come conseguenza l’abbandono di quell’approc-
7 Giusto per fare un esempio, David Graeber, il cui lavoro è considerato influente e rappresentativo dell’anarchismo del ventunesimo secolo e che ha contribuito a diffondere l’idea che si trattasse in effetti di un’ondata di “nuovo” anarchismo, non menziona Ward in nessuno dei suoi tre testi principali: Direct Action [trad. it. Rivoluzione: istruzioni per l’uso, BUR, Milano, 2012], Possibilities e Fragments of an Anarchist Anthropology, [trad. it. Frammenti di antropologia anarchica, elèuthera, Milano, 2020 (2006)]. Che lo abbia letto, o che fosse a conoscenza della cultura anarchica di cui Ward era parte, non è chiaro; quel che è certo è che Graeber, e con lui molti altri, presentarono l’anarchismo in cui si impegnavano come nuovo, in un modo difficilmente difendibile. In un sondaggio molto poco scientifico, ho chiesto a sette giovani anarchici sotto i trentacinque anni che cosa pensassero di Ward; tre di loro non ne avevano mai sentito parlare, tre sapevano il suo nome e niente di più e l’ultimo ha risposto: “Beh era un po’ troppo liberale, preferisco Malatesta”.
cio orientato verso la costruzione della comunità a cui faceva riferimento Ward, in favore della creazione di spazi più «puri», non contaminati dal riformismo dei liberali o dall’autoritarismo dei marxisti. L’approccio pluralista e pragmatico all’azione diretta di Ward si è così smarrito nell’arroganza di una generazione convinta che rifiutarsi di scendere a compromessi con quelli che loro percepivano come principi irrinunciabili dell’anarchismo equivalesse ad avere un approccio più radicale al cambiamento sociale. Tutto ciò che poteva essere visto come un compromesso su tali principi era rifiutato o ignorato.
Sia chiaro, né la generazione di Ward né la mia è riuscita a cambiare il mondo in modo profondo, ma mi sono spesso chiesto quanto più realmente ci saremmo potuti avviare verso un secolo anarchico se la voce di Ward non fosse stata soffocata e sostituita da una visione dell’anarchismo che, nonostante i proclami contrari, era notevolmente dogmatica e ideologicamente purista. La disponibilità di Ward al compromesso sarebbe stata rifiutata in toto da molti degli anarchici della mia generazione, ma il suo pragmatismo non era quello di chi da sinistra si è spostato al centro, di coloro i cui ferventi ideali sono stati lentamente intiepiditi dall’idea che il mondo non cambierà mai8 . Ward era fedele ai principi anarchici come chiunque altro, ma questi principi lo portarono a capire il valore di aver a che fare con gli altri anche quando non condividevano completamente la sua idea di mondo. In definitiva, credeva nell’organizzazione della comunità, ma la comunità in questione non era una «bolla» di radicali autoselezionati, bensì la propria cittadina, le scuole in cui si mandano i figli, gli inquilini con i quali si condivide lo stesso padrone di casa.
Nonostante possa passare inosservata in un saggio che è per lo più una spudorata propaganda anarchica, l’insistenza di Ward nel
8 Da questo punto di vista, Ward mi ricorda il grande teorico marxista Stuart Hall. Mi chiedo a volte se fossero a conoscenza dei rispettivi lavori, avevano certamente in comune più di quanto le etichette politiche che li identificavano potessero suggerire.
primo capitolo di Anarchia come organizzazione sul fatto che gli anarchici dovrebbero essere «sufficientemente inventivi e fantasiosi da trovare modi di attualizzare le loro idee oggi alla società in cui viviamo», è solo un esempio di ciò che ha reso Ward una voce così importante. Oltre a essere un ardente sostenitore dell’anarchismo, era anche un pensatore che riconosceva la necessità di mettere in discussione il pensiero anarchico, i suoi postulati e gli occasionali dogmi, per provare a sviluppare un anarchismo all’altezza della complessità del ventunesimo secolo. L’impegno
di Ward verso l’anarchismo non è mai stato scontato, ma assunto con onestà e spirito critico, cosa che ha reso il suo lavoro un percorso infinitamente avvincente anche per il suo empatico rifiuto di scendere a compromessi con gli ideali anarchici, sempre accompagnato da un altrettanto fermo rifiuto, quello di lasciare che un approccio dogmatico e ideologico offuscasse la sua lettura sociologica del mondo. Qualsiasi concezione della società futura potessero avere gli anarchici, Ward non distolse mai l’attenzione dal semplice fatto che a quella società non ci
eravamo ancora arrivati. Ad esempio, non considerò mai lo Stato come una forza potenzialmente progressista, ma bilanciava la sua posizione riconoscendo che difficilmente lo Stato sarebbe scomparso nel prossimo futuro. Fondamentalmente, Ward era interessato a praticare l’anarchismo, a dargli più vita possibile, senza aspettare che il peso dello Stato si facesse meno opprimente, ma al contrario facendolo proprio nel momento in cui grava maggiormente su di noi.
L’intellettuale attivista?
Nonostante quanto sostenuto finora, ossia la mancanza di influenza su una parte della cultura anarchica contemporanea, il contributo di Ward all’anarchismo nel suo complesso non è in discussione. In parte questo è dovuto alle idee che ha presentato, ma vale la pena di fare attenzione anche al modo in cui le ha presentate. La modalità con la quale Ward ha svolto il suo lavoro è infatti tanto ammirevole quanto il contenuto; in qualche maniera, è riuscito a fare una critica delle idee anarchiche e a introdurre un nuovo modo di pensare l’anarchismo senza mai attaccare le posizioni di nessuno. Era allo stesso tempo modesto e persuasivo, e rivendicava con fermezza la sua visione dell’anarchismo senza sentire il bisogno di contraddire o sfidare apertamente quella degli altri.
Per certi versi era l’«intellettuale» ideale per gli anarchici. L’anarchismo ha sempre avuto un rapporto conflittuale con l’idea di intellettuale e con il lavoro intellettuale. In parte questo deriva da una critica più che ragionevole a un certo tipo di intellettuali e al loro approccio, ma in alcuni casi questa diffidenza si è trasformata in un rifiuto complessivo e poco sano del lavoro intellettuale, a prescindere da come fosse prodotto. Negli ultimi decenni, l’anarchismo è diventato sempre più accettato in alcuni ambiti del mondo universitario con molti risultati positivi. Questo riconoscimento ha portato a una crescita nella produzione di articoli accademici che farebbe drizzare il pelo a più di un anarchico, a conferma della loro visione degli intellettuali come di persone completamente disinteressate alla pratica anarchica e scollegate da essa. All’opposto il lavoro di Ward collega splendidamente teoria e azione, è scritto estremamente bene ed è accessibile a chiunque. Non richiede conoscenze pregresse, nessuna competenza accademica e di solito si occupa di questioni molto pratiche pur confrontandosi con una ricca complessità teorica ed empirica.
A cento anni dalla sua nascita, è più che giusto celebrare Colin e le tante cose che ha compiuto. Ma spero che la comunità anarchica possa fare più di questo. Lo scoppio di attività anarchica successiva al 1968 e al 1999 è stato in entrambi i casi piuttosto breve e oggi siamo in una situazione decisamente meno favorevole anche solo rispetto a dieci anni fa. L’assolutismo intrinseco a molta della teoria e della pratica anarchica di inizio ventunesimo secolo ha funzionato per un breve periodo, ma era in definitiva insostenibile. Ward ci ha indicato una via per riflettere su come possiamo impegnarci in un mondo non anarchico senza perdere la radicalità della nostra voce, e ha sempre combattuto instancabilmente sostenendo la necessità di questo tipo di impegno. «Sono felice», disse in una occasione, «di essere un opinionista anarchico che scrive sulla stampa non anarchica»9 . Sembrava anche essere immune, al punto da esserne forse persino divertito, dalle accuse di essere un riformista, un liberale, addirittura un «agente del partito laburista». Ward non aveva tempo per coloro che interpretavano l’anarchismo come il rifiuto di relazionarsi con chi aveva convinzioni differenti, e il suo lavoro fu di conseguenza molto più ricco e, all’epoca, molto più influente. È forse giunto il momento di riprendere Ward e il suo lavoro per raccogliere gli insegnamenti di colui che potrebbe certamente rivendicare – anche se dubito lo avrebbe mai fatto – di essere stato uno dei propagandisti anarchici di maggior successo. Come ho argomentato altrove, abbiamo un disperato bisogno di trovare modi di lavorare al fianco di altri movimenti e tradizioni radicali e progressisti se vogliamo mettere fine all’egemonia capitalista, e in questo compito pochi pensatori possono essere più utili di Colin Ward.
traduzione di Abi Titolo originale: Colin Ward: an Ambiguous Legacy Fonte: “Anarchist Studies”, vol. 32, n. 2, 2024
9 Colin Ward, Notes of an Anarchist Columnist, «The Raven», 3, 4, 1990, p. 319.


Nel lontano settembre del 1923 un male, definito meglio come «Oscuro», si abbatte sulla regione del Kantō in Giappone: un terremoto di devastanti proporzioni che colpisce Tōkyō e Yokohama mietendo più di centomila vittime. Da questo momento ha inizio una tragedia altrettanto immane, che alla prima sembra sovrapporsi con una devastante catastrofe umana e politica. Gli squadroni della polizia militare si distinguono per efferatezza rastrellando, fra i vivi, anarchici e coreani, alla ricerca di un insensato capro espiatorio al disastro sismico, in un consapevole eccidio di oppositori politici e gruppi etnici indicati come «diversi». Nel totale disorientamento delle persone, ben narrato in un testo autobiografico anche dal regista Akira Kurosawa, la scrittrice, giornalista, teorica dell’anarchismo femminista nipponico Itō Noe e il suo compagno di vita e di lotta Ōsugi Sakae vengono trucidati a bastonate in un centro di detenzione della polizia e poi gettati in un pozzo.
Pochi sono a conoscenza della storia dell’anarchismo nipponico, in prevalenza sindacale, composto da elementi di antagonismo fortemente consapevoli del messaggio anarchico e libertario, in numero davvero ragguardevole con elementi di elaborazione teorica molto interessanti che offrono, ancora oggi, soluzioni di studio e di ricerca. Itō Noe è un personaggio unico nel panorama anarchico mondiale. È protagonista di dibattiti pubblici fra donne ed elementi di spicco della politica giapponese, si batte attraverso i suoi testi sulla rivista Seitō per i diritti umani e civili delle donne e dei lavoratori, in un momento storico di espansione capitalista del Giappone senza precedenti nella storia planetaria. Itō Noe nasce nel 1895 da una famiglia poverissima sull’isola di Fukuoka, mentre in Giappone era in corso un inedito scontro generazionale, nel quale si contrapponevano anche con la violenza movimenti di acceso antagonismo. Studiosa appassionata fin da giovanissima, riscosse successo con i suoi editoriali sulla rivista Seitō, divenendone per un periodo caporedattrice, e portò a compimento a scopo divulgativo la traduzione del libro The Tragedy of Woman’s Emancipation di Emma Goldman. Dalla libertaria occidentale trasse l’afflato femminista più autentico e interpretò con estrema coerenza il principio dell’azione diretta per il raggiungimento di obiettivi reali. Fu la compagna di vita e di lotta di Ōsugi Sakae, che collaborò insieme a lei alla traduzione degli scritti di diversi autori anarchici al fine di sensibilizzare i giovani nipponici alla cultura libertaria. Dalla collaborazione fra i due nacque una vorticosa relazione amorosa che fece scalpore nel Giappone dei tempi, scandalizzando i benpensanti per il loro disinibito ménage, interpretato nel rispetto assoluto della libertà individuale e sessuale. L’elaborazione teorica, l’azione diretta, la fondazione di movimenti sindacali, l’infaticabile lavoro di traduzione di classici dell’anarchismo internazionale dimostrano quanto sia fuorviante la convinzione che a oriente del mondo i modelli libertari siano irrealizzabili o incomprensibili.
I movimenti femministi si moltiplicavano e organizzavano a più riprese convegni e incontri in onore di Emma Goldman e Kropotkin. In quegli anni così convulsi Itō Noe si dedicò alla traduzione di altre due opere fondamentali dell’autrice russa: Matrimonio e amore e Minoranza contro Maggioranza. Le pubblicazioni di Itō Noe si moltiplicarono insieme a quelle del compagno Ōsugi, soprattutto negli anni che vanno dal 1917 al 1920. Ōsugi e

Itō ebbero tre figli, due dei quali con i nomi di Emma, in onore dell’amata Goldman, e Nestor, in omaggio al pensatore e attivista ucraino Nestor Machno, che era stato compagno di prigione di Ōsugi per diverse settimane durante il suo soggiorno europeo. Itō Noe incarna ciò che «diverge dai Codici […], dal Diritto costituito e dalla Legge consuetudinaria», e afferma che «tutto ciò deve essere espulso o distrutto». Il fervente senso di rinnovamento in una cornice di forte pressione degli ambienti militari e le corporazioni, che avevano come interesse principale un selvaggio sviluppo economico, determinano in questa donna, coraggiosa come poche, un senso di giustizia e di lotta che la condurranno alla sua tragica fine: «Fu il tempo di una sistematica e programmata caccia alle streghe: cominciò una capillare ricerca di presunti responsabili di azioni di sabotaggio. Moltissimi cittadini indifesi rimasero uccisi nei linciaggi della folla inferocita e aizzata dalla propagazione di false notizie diramate anche dalle autorità nipponiche. In Giappone, già tre anni prima del sisma del Kantō, si verificarono i primi casi di “insofferenza” verso gli oppositori. Infatti si diede inizio a una persecuzione sorprendente di intellettuali e di dirigenti dei movimenti antagonisti al regime».
Successivamente nel contesto sismico dilagò una forma di terrorismo di Stato non isolata nella storia degli eccidi dei movimenti di opposizione al potere e dei loro leader e, oltre a questi ultimi, furono perseguitati anche i lavoratori coreani in centinaia di migliaia residenti in Giappone e specificamente nel Kantō, perché additati come protagonisti di condotte criminali durante le fasi convulse successive al terremoto. Motivando le persecuzioni a discapito di anarchici, socialisti, oppositori in generale e coreani, utilizzando anche la superstizione dei giapponesi, furono allestite milizie di cittadini al fine di dare loro la caccia, con la conseguenza che i coreani vennero massacrati e molti di essi furono dati alle fiamme ancora vivi. Il progetto repressivo fu condotto con violenza inaudita e condusse il Paese all’avvento di Hirohito, con una base ideologica di forte estremismo sciovinista: il Giappone intese presentarsi al mondo come moderno e progressista con leggi liberticide, politiche economiche costellate da un capitalismo selvaggio, leggi emergenziali in termini securitari soprattutto nei confronti degli anarchici, che furono da allora assassinati e quasi completamente cancellati dal quadro politico antagonista. «Dalla sordida retorica del regime, gli anarchici erano stati etichettati come sabotatori di idee positive colpevoli di minare l’ottimismo nazionalista, di essere irriguardosi verso la fede e l’obbedienza all’imperatore, di cospirare contro le istituzioni a favore di forze straniere. La repressione fu senza esclusione di colpi, proprio nel momento in cui il terremoto aveva devastato e reso fragili le coscienze degli uomini. Una logica perversa messa in atto per annientare i propri figli illegittimi come agnelli sacrificali». Fu così che «in venti anni, fino al 1945, più di 75.000 persone furono attenzionate, imprigionate e torturate. Le vittime vennero sottoposte a regimi detentivi inumani e trattate con inusitata efferatezza: pochi riuscirono a sopravvivere alle malversazioni fisiche e psicologiche. Le formazioni politiche più reazionarie, con la collaborazione delle forze dell’ordine e dei militari, riuscirono a costruire un clima culturale di aggressione incondizionata al fine di tutelare la sicurezza».
Itō Noe e il compagno Sakae Ōsugi furono anarchici «universali», propugnavano l’ideale anarchico e lo integravano con aspetti teorici che trovavano riferimento nella prassi e nella realtà della vita di milioni di lavoratori e di individui appartenenti alle classi meno abbienti, in un mondo dalla forte caratterizzazione classista e capitalista, senza subire mai, a differenza di molti esponenti del socialismo nipponico, ma anche di tanti libertari «la folgorazione del culturalismo nazionale, riferimento imprescindibile per le istituzioni e per una larga maggioranza della popolazione educata allo sciovinismo, al consenso e alla sete di conquista».
Bibliografia:
Soriano F., Noe Itō. Vita e morte di un’anarchica giapponese, Mimesis, Milano, 2018.
Pezzica L., Anarchiche. Donne ribelli del Novecento, Shake, Milano, 2013. Toda M., Anarchismo in Giappone, CSL, Napoli, 2021.
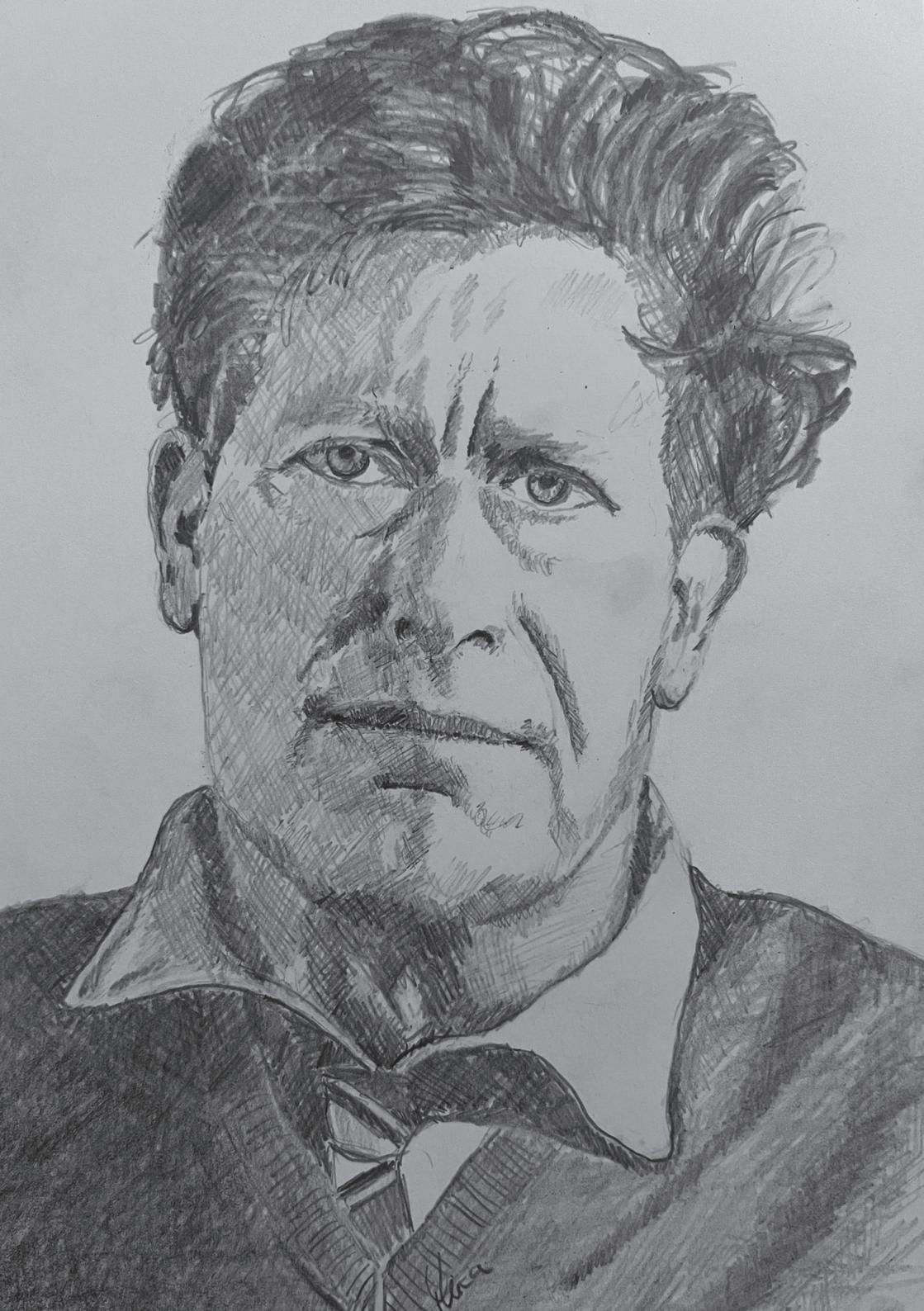
RADICI Paul Goodman (1911-1970) Pietro Adamo
Il film Paul Goodman Changed My Life, girato da Jonathan Lee nel 2011, ci è utile in tre modi diversi. Ci offre una massa di documenti dell’epoca – parliamo degli anni Sessanta – che attesta il momento in cui Goodman esercita la presenza maggiore nell’immaginario pubblico: comizi, manifestazioni, interviste, articoli in rivista, convegni e soprattutto televisione. Abbiamo poi una miriade di intellettuali, operatori culturali, dirigenti scolastici, scrittori, amici, familiari, che ricordano i particolari aspetti della sua vita, non solo quella di militante ma anche quella personale. Compresi alcuni mostri sacri della cultura statunitensi: la scrittrice Grace Paley (spesso in odore di Nobel); il filosofo Michael Walzer, per decenni direttore di Dissent, la principale rivista socialista-democratica americana: il musicista d’avanguardia Ned Rorem, come Goodman protagonista della vita bohémien newyorchese; la critica Susan Sontag, autrice di un celebre saggio su Paul stesso; Fritz Perls, mitico psichiatra alternativo controculturale (a cui Goodman ha prestato la sua competenza culturale in un libro-manuale del 1951 sulla terapia della gestalt); e persino Woody Allen (altro ebreo newyorchese), con una scenetta da Io e Annie (girata, ricordiamolo, un lustro dopo la morte di Goodman). Infine, il film stesso, un atto d’amore-nostalgia che ha esso stesso valore politico.
Però un difetto l’ha. Pur ricostruendo le fasi della vita di Goodman (un po’ meno del suo pensiero), non ne mette in luce quell’aspetto parabolico che le caratterizza, vale a dire quel suo peculiare andamento su e giù, tra oscurità e successo, trascurando un aspetto che a me ha sempre colpito: ovvero, negli ultimi anni di vita, la sua stella si stava nuovamente oscurando e le sue relazioni con i «movimenti» del periodo – Nuova sinistra e controcultura – andavano decisamente peggiorando, riportandolo nella condizione – pensatore minoritario con pochi seguaci illuminati – che lo aveva contraddistinto prima dei Sixties.
Negli anni Trenta il giovane intellettuale newyorchese (è nato nel 1911) ha ambizioni soprattutto di poeta e romanziere. È marginale per definizione: ebreo, anarchico, intellettuale senza lavoro, obiettore di coscienza, bisessuale dichiarato (si sposa e ha figli, ma il suo orientamento è inequivocabilmente omo: nell’unico suo libro a cadenza autobiografica, Five Years, pubblicato nel 1966, racconta delle sue attrazioni sessuali, tutte indirizzate verso maschi). Ma nei primi anni Quaranta Goodman si ritrova coinvolto in uno dei più importanti punti di svolta nella storia dell’anarchismo: anzi, nel più importante. Intorno alle riviste newyorchesi – piccole, pochi numeri, pochi lettori – Politics, Resistance e Retort, si raduna un gruppo di intellettuali che rilegge e rielabora l’anarchismo in modi decisivi (tant’è che noi, oggi, per sottolineare tale operazione, definiamo postclassico l’anarchismo successivo). Con riflessi nella rivista italiana Volontà (in particolare nel direttore Cesare Zaccaria) e in quella inglese Freedom (qui alcuni redattori, e non la direttrice Maria Luisa Berneri e il suo compagno Vernon Richards). I postclassici newyorchesi (tra i maggiori, Dwight Macdonald, Nicola Chiaromonte, George Woodcock, uno dei redattori di Freedom di cui sopra, in Politics; il direttore Holley Cantine in Retort; David Thoreau Wieck, capo carismatico – non so come altro definirlo – di Resistance) sono iconoclasti: rifiutano del tutto la concezione della rivoluzione proposta dagli anarchici delle generazioni precedenti, negandone l’impostazione di classe e di frattura violenta nella storia, riproponendola sotto forma di un’evoluzione dell’immaginario collettivo in chiave libertaria e di liberazione dai miti sociali, politici e culturali dell’esistente (leggi: società borghese + capitalismo); restano al centro della strategia la propaganda, l’esempio, la presenza nelle lotte, ma entro la dimensione locale e circoscritta del piccolo gruppo, nucleo autonomo che rifiuta strutturalmente dimensioni organizzative maggiori e che punta, in primo luogo, alla sopra citata mutazione di immaginario; soprattutto – ed è in questo che sta la maggiore punta creativa, ma anche più controversa, dei postclassici – il piccolo gruppo non è solo strumento di intervento nella vita sociale, ma ambiente in cui vivere, nel qui e nell’ora, la libertà anarchica, nella creazione di relazioni autonome, orizzontali, libere, spontanee, di contro alle convenzioni e alla morale sessuale, politica, economica dell’esistente. Controversa perché per molti la fede nel piccolo gruppo suona come una specie di rinuncia alla redenzione collettiva, alla salvezza del mondo, al riscatto degli oppressi, in favore di una liberazione che è essenzialmente individuale ed esistenziale. Non che il postclassico sia frutto di una rottura completa con il passato: se le linee di discontinuità con l’anarchismo di orientamento rivoluzionario e tendenzialmente comunista sono evidenti, lo sono anche le continuità con certo anarchismo gradualista, educazionista, collettivista (penso agli spagnoli dell’anarchismo sin adjectivos, i Mella, i Lorenzo, i Tarrida del Marmol, l’americana de Cleyre), nonché con quello individualista comunitario all’americana (non quello pseudonietzschiano all’italiana o alla francese).
Goodman è protagonista assoluto in questa rivoluzione. È il più presente, è quello che scrive di più, e sua è la prima vera pubblicazione sul tema, ovvero The May Pamphlet, che nel 1946 raccoglie i suoi principali interventi sul postclassico. Come i colleghi, è anche costruttivo. In uno dei suoi saggi più famosi, «Reflections on Drawing the Line», leggiamo:
Il libertario […] non ha lo sguardo rivolto verso un futuro stato di cose, che cerca di realizzare con mezzi discutibili; piuttosto, da subito attinge, per quanto possibile, alla forza naturale che è in lui, non dissimile da quella che ci sarebbe in una società libera, se non per il fatto che avrebbe un raggio d’azione molto più vasto e sarebbe continuamente accresciuta dall’aiuto reciproco e dal conflitto fraterno. Semplicemente continuando a esistere e operare in modo naturale e libero, il libertario vince, fondando la società; per lui non è necessario sconfiggere. Quando crea, vince; quando corregge i suoi pregiudizi e le sue abitudini, vince; quando sa resistere e sopportare, vince.
«Azione autonoma», aggiunge, «vuol dire vivere nella società attuale come se fosse una società naturale». Da qui le sue perorazioni in favore della piena libertà di sperimentare, della disobbedienza civile, dell’incoraggiamento all’anticonformismo. È anche tra i primi a capire perché la politica di massa come era praticata in precedenza risulta ormai impossibile: in un memorabile articolo pubblicato in Politics, spiega che le classi lavoratrici sono state ipnotizzate dalla Statolatria, ovvero dalla convinzione che lo Stato sia in grado di fornire i mezzi per migliorare la propria situazione sociale ed economica. È quindi in questo contesto filosofico e culturale che prendono forma i principali tratti del suo pensiero politico (intendo i suoi tratti specifici, non quelli che condivide con amici come Mcdonald e Chiaromonte). Innanzitutto la concezione della storia, nella quale Goodman riprende in sostanza i capisaldi della tradizione liberale. In Reflections on the Anarchist Principle¸ pubblicato nella Anarchy del suo sodale e seguace Colin Ward (un altro dei redattori di Freedom sopra citati), ne stende la genealogia: la società per azioni tardomedievale, i liberi comuni, le chiese congregazionaliste, il Bill of Rights, l’autonomia del potere giudiziario, la pedagogia progressista, il movimento per i diritti civili. In un altro saggio è ancora più continuista, per quanto riguarda liberalismo e anarchismo: spiegando la virata reazionaria dei liberali ottocenteschi, impegnati nella difesa dello status quo piuttosto che nel suo cambiamento, «questo è il motivo per cui, sin dall’Ottocento, alcuni di noi liberali hanno scelto di definirsi anarchici». Nella storiografia anarchica vive un mito quasi ridicolo: l’ammirazione goodmaniana per Kropotkin come una qualche sua sottoscrizione delle idee rivoluzionarie e comuniste integrali (cioè fondate su abolizione di scambio, merce, mercato, eccetera) di Le revoltè e La révolte, La conquista del pane e Le parole di un ribelle, e via dicendo. Al contrario, Goodman – che, come quasi tutti i postclassici, ha orrore metafisico per il comunismo, fosse anche libertario – è ammiratore incondizionato – come altri suoi contemporanei, gli urbanisti Ebenezer Howard e Patrick Geddes e lo storico Lewis Mumford – per il Kropotkin di Campi, fabbriche, officine, che legge come un progetto gradualistico della costruzione di una società socialista dal basso, dalle piccole imprese, dalle botteghe artigiane, dalle industrie locali, nell’ambito di una regionalizzazione/specializzazione delle attività e in vista di una «disponibilità di una rete di distribuzione. La vendita è stata semplificata, e la produzione resa possibile organizzando prima di tutto il mercato» (parole e corsivi del principe Kropotkin in persona). Ed è qui, nella fiducia nella creatività della libertà da un lato e nella possibilità di un mercato socialista (o meglio, di un socialismo fondato sul mercato) dall’altro, che Goodman scatena la sua poderosa immaginazione. Riscopertosi saggista agli inizi degli anni Sessanta, con il grande successo di Growing up Absurd (nel quale è tra i primi a comprendere la situazione nuova degli studenti), passa il decennio a suggerire soluzioni nuove, inedite, anticonformiste – Utopian Essays and Practical Proposals, titola una sua antologia del 1962 – per ogni genere di problema o questione sociale e culturale: a incoraggiare una libera sperimentazione in-
tegrale, che dovrebbe vedere protagonisti giovani, studenti, professionisti seri, inventori, tutti disposti (anzi propensi) a mutare l’esistente senza alcuna attenzione per tradizioni, consuetudini, regole precedenti, eccetera. Scrive di scuola, pedagogia, psicologia, sessualità, cinema, pornografia, urbanistica, decentramento, persino scrittura e scrittori, criticando le posizioni tradizionali e incoraggiando l’innovazione, sulle basi pensate dai postclassici di vent’anni prima: anche se l’esperimento fallisce – vista l’opposizione dei poteri forti – crescerà comunque lo spirito di opposizione, la volontà di cambiare, la sensibilità libertaria. È qui che diventa il guru dei giovani, che vedono in lui uno spirito guida: gli studenti che occupano Berkeley nel dicembre 1964 gli telefonano alle tre di notte – si dimenticano che Paul abita sulla costa orientale… – chiedendogli cosa fare. E quando un paio di mesi dopo lui visita l’università, che pullula di sperimentazioni e innovazioni, scrive che si tratta di una «piccola anarchia». Da qui la sua presenza mediatica quasi inossidabile in quegli anni, in cui era percepito come uno dei portavoce delle istanze dei giovani. Ma l’idillio si spezza. Nella Nuova sinistra, inizialmente disposta su posizioni sperimentaliste e anticonformiste, si stende il «marxistese», trionfa il terzomondismo, trotskisti, maoisti e castristi infiltrano gli Students for a Democratic Society (la maggiore organizzazione studentesca del paese). Si diffondono miti rivoluzionari d’antan, inni al proletariato, inviti alla violenza, bombe contro edifici istituzionali. Nella controcultura, invece, cresce uno spirito che Goodman percepisce come irrazionalista, imbevuto di cultura orientale, magia e stregoneria, impermeabile a qualsiasi argomentazione sperimentale (a noi, che abbiamo letto Feyerabend, Illich, Capra e affini sembra più una reazione contro l’alleanza scienza-politica). E Goodman rompe (attirandosi le ire di tutti gli anarchici ancora legati alla mitologia della rivoluzione): in uno dei suoi ultimi – iconoclastici – saggi spiega che l’anarchismo non è ideologia utile alle masse in cerca di redenzione, prone a cadere vittime dell’illusione rivoluzionaria o di qualche demagogo o di qualche totalitarismo (come è sempre accaduto in passato); è invece ideologia per i già liberi e liberati, che già sanno vivere l’anarchia, che già sanno come si fa a conservarla, cioè con la libera sperimentazione integrale messa in atto dai piccoli gruppi.
Pochi mesi prima della sua morte l’inglese Kingsley Widmer recensisce il suo libro New Reformation del 1970, intitolando l’intervento American Conservative Anarchism. Quello di Goodman sarebbe un anarchismo elitista e collaborazionista, ma soprattutto «astorico: poco senso di identità con i movimenti di sinistra, con il sindacalismo, con le classi subalterne; nessun riferimento all’anarchismo italiano, spagnolo o russo; e poca preoccupazione per molte delle dispute tradizionali della sinistra». Ora, mentre Widmer mi sembra un dinosauro incapace di comprendere sia lo sviluppo della storia sia la dinamica dell’anarchismo, queste sue accuse suonano alle mie orecchie come complimenti…
Bibliografia:
Goodman P., Individuo e comunità. Scritti politici, a cura di Pietro Adamo, elèuthera, Milano, 1995 e 2014.
Goodman P., La società vuota, Rizzoli, Milano, 1970.
Goodman P., La gioventù assurda, Einaudi, Torino, 1977.
Goodman Paul e Percival, Communitas, Il Mulino, Bologna, 1970.
Perls F., Hefferline R.F., Goodman P., Teoria e pratica della terapia della Gestalt, Astrolabio, Roma, 1997.

MUSICA
Sperimentare musica fra antagonismo e anarchia
Felice Liperi
«I suoi convincimenti lo avevano portato ad applicare la lotta di classe anche nell’uso degli oggetti più comuni. Non arrivò in tempo a diversi concerti perché si rifiutava di salire a bordo di automobili, strumento che, affermava, rende schiavi del padrone. Autostrada, petrolio, economia, Fiat, Stato, quindi niente automobile. Era un pedone per scelta esistenziale»
Questo ritratto di Enzo Del Re, uno dei più risoluti interpreti del canto politico, rappresenta lo spirito anche di altri artisti coevi accomunati da una intransigenza non ideologica che si opponeva a qualsiasi forma di controllo sociale. Oltre a Del Re, infatti, anche Antonio Infantino e Matteo Salvatore sono stati segnati da una forte capacità innovativa, sperimentale, anche se la loro musica era strettamente legata alla tradizione popolare. Non a caso erano tutti provenienti dal profondo Meridione d’Italia, Salvatore e Del Re, pugliesi ma di due radici diverse, il primo cantautore di Apricena influenzato dalla tradizione del canto narrativo del tavoliere e del foggiano, l’altro, originario di Mola (Bari), è stato una delle figure più radicali della scena politico-musicale degli anni Settanta, mentre Antonio Infantino ha portato alle estreme conseguenze l’uso della musica tradizionale lucana in veste di sperimentatore e innovatore multimediale. Salvatore è stato una sorta di Johnny Cash del folk italiano, cantautore ante litteram, con una storia sempre in bilico fra redenzione e dannazione, omaggiato e rilanciato da musicisti come Teresa De Sio, Lucio Dalla, Moni Ovadia e più di recente Vinicio Capossela. Del Re è invece stato un implacabile sostenitore della canzone militante e un – forse ignaro – vate del ‘77 con canzoni/performance tipo Lavorare con lentezza, diventata un inno anarchico dell’area movimentista. Sono stati artisti molto diversi fra loro, sicuramente separati dall’approccio politico e dall’uso militante della musica, quasi assente in Salvatore e invece fortissimo in Del Re, ma in comune hanno avuto la capacità di reinventare il messaggio popolare attraverso una canzone innovativa fuori degli schemi. Basta pensare al metodo con cui Del Re usava proporre dal vivo il brano Lavorare con lentezza, reinventandolo ogni volta con infiniti aggiornamenti per prolungarne smisuratamente testo, durata e forza antagonista ma anche per sfiancare il pubblico e l’uditorio più attento. Un percorso ben rappresentato dalla sua celebre frase:
«I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono equamente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica che cosa è? La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Io per gli sfruttatori non voglio fare niente, per la classe lavoratrice, alla quale mi onoro di appartenere, sono disposto a sacrificare la mia vita, ma per i padroni non voglio fare un cazzo!»
Si capisce che raccontare una figura come Del Re significa entrare in un tempo diverso, passato, nel quale anche il lessico stesso delle parole utilizzate cambia valore e significato. Un tempo nel quale Del Re voleva che il suo lavoro di cantastorie fosse considerato alla stregua di quello di un operaio salariato che utilizzava come strumento di lavoro un oggetto semplice a portata di mano, spesso una sedia, e chiedeva come cachet una giornata di lavoro di un metalmeccanico. Originario di Mola in provincia di Bari (1944-2011), autodidatta, Del Re è stato uno dei protagonisti insieme a Uccio Aloisi, Tonino Zurlo, i Cantori di Carpino e Matteo Salvatore del folk pugliese d’autore. Inizialmente si era accostato alla musica utilizzando materiali poveri, come cartoni e scatole alla portata di tutti. Poi, oltre a queste percussioni cominciò ad usare un particolarissimo uso della lingua iniziato per scherzo a scuola, che definiva «linguafono» e consisteva nel rumore prodotto dallo schiocco della lingua sul palato, modulato dalle aperture-chiusure della bocca. Di convinzioni fortemente libertarie non aveva e non voleva manager, non registrava dischi ufficiali, ma solo autoprodotti. È alla fine degli anni Cinquanta che comincia ad esibirsi rifiutando contributi e pagamenti sentendosi un «anarchico» non irreggimentabile. Negli anni Sessanta alterna le sue esibizioni al lavoro con il padre, esportatore di frutta, al mercato ortofrutticolo di Firenze. Dopo l’alluvione del 1966 incrocia il cammino proprio con il musicista e performer Antonio Infantino partecipando alla realizzazione di Ho la criniera da leone (perciò attenzione) suonando le più diverse percussioni e come seconda voce in molti brani di quell’album. Successivamente entra nel cast della seconda edizione dello spettacolo Ci ragiono e canto realizzato con la regia di Dario Fo. Una edizione del 1969 nella quale vengono utilizzate canzoni nuove, composte ad hoc, legate alla attualità eseguite ancora da Del Re e Infantino: Povera gente e Avola, ispirate, la prima, alla nuova emigrazione dal Sud verso il Nord Italia e il Nord Europa, la seconda alla strage di braccianti avvenuta nel 1968 durante una manifestazione sindacale nel piccolo paese del siracusano. Nel frattempo continua la collaborazione con Infantino con cui lancia un provocatorio spettacolo-performance intitolato Scatola 3 che rappresenta la volontà di far convivere memoria popolare e sperimentazione. Anche il repertorio rifletteva questa impostazione, accompagnava le canzoni in dialetto e in italiano con recitativi monodici sempre segnati da ritmi ossessivi determinati dalla percussione della sedia che lasciavano ampio spazio all’improvvisazione, senza però porsi minimamente il problema di virtuosismi o intonazioni ben fatte. Con il suo fedele cappelluccio rosso, che portava anche nella celebre apparizione al Concertone del Primo Maggio 2010, Del Re era uso lanciarsi dal vivo in performance imprevedibili e provocatorie, vere maratone senza fine perché, secondo la sua celebre dichiarazione, sosteneva di voler rimanere sul palco fino a quando l’ultimo spettatore non fosse andato via, per rappresentare la ripetitività del lavoro in fabbrica. Ha interpretato molte canzoni sue e di altri autori, ma le più celebri rimangono la citata Lavorare con lentezza e Tengo ’na voglia e fa niente che spesso univa in un’infinita performance dal vivo. Qualcuno l’ha definito un «corpofonista» cioè un performer che usava i suoni emessi dal corpo in una specie di litania su base ritmica, una sorta di rap corporeo che rendeva ancor più originale il suo stile all’interno della storia della nostra canzone dato che, salvo forse alcuni performer per voce ed elettronica come l’artista elettro-rap Iosonouncane, nessuno ha mai portato a questa estremizzazione della produzione sonora. Visionario e anticipatorio basta pensare a Lavorare con lentezza utilizzato nel 1977 dall’emittente radiofonica bolognese Radio Alice come sigla di apertura e chiusura delle proprie trasmissioni raggiungendo una popolarità straordinaria perché sembrava scritto per quel movimento che esaltava la fantasia al potere, il rifiuto del lavoro salariato e la libertà sessuale. Matteo Salvatore (Apricena, 1925 – Foggia, 2005) è stato un cantastorie e autore italiano, cresciuto con gli insegnamenti di Vincenzo Pizzicoli, «portatore di serenate» cantante cieco, suonatore di violino, mandolino e chitarra. Così Salvatore racconta l’avvio della sua vita musicale nello spettacolo di Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti, Craj:
«Popolo del paese, sentite, sentite, sentite. Io sono Matteo Salvatore. Perciò non c’è da essere incantati, basta che sentite due storielle… la prima volta che sono andato a imparare la chitarra è stato da un vecchio cieco e mi sono affezionato. Non c’era niente da fare. Disoccupazione al massimo. Stavo a casa di questa persona e suonavo notte e giorno. Perché i nostri
padri erano disoccupati. E che ti volevi mangiare? Niente! E questa era la vita. Andavamo a giocare, nonostante la fame che si poteva tagliare con il coltello»…
Grazie anche all’incontro con Pizzicoli il suo rapporto con la tradizione musicale è sempre stato filtrato da una forte personalità che l’ha reso capace di tenersi in bilico fra tradizione e canzone d’autore. Autore atipico e irregolare della musica folk pugliese, dotato di una voce estremamente duttile e di uno stile chitarristico sobrio ed elegante, è stato un singolare poeta e cantastorie di vicende di miseria, amore e sopraffazione che affondano le radici nel Gargano della sua infanzia. La fame. Da lì sono sempre partite le sue canzoni spesso animate da grande ironia e pungente autoderisione. Perché come nei drammi di Verga, Salvatore racconta come in quella sua gioventù vissuta ad Apricena, la sorte si accanisse contro i poveracci, come il lavoro nei campi durasse poco perché arrivavano concorrenti da zone ancora più povere sempre delle Puglie che accettavano paghe addirittura più basse, ma non c’era acrimonia perché, ricorda il cantautore erano «padri di famiglia anche loro. I forestieri venivano dal Gargano, con la falce nell’occhiello dei pantaloni, le scarpe erano zampitte» (i piedi nudi). Tutte storie adolescenziali che poi andranno a confluire nel suo repertorio musicale, alimentandolo di ironia e spirito irriverente che colpiva anche l’intoccabile chiesa e i suoi servitori. Il momento svolta per la sua carriera si presenta con il trasferimento a Roma, dove una donna del suo paese lo convince a cantare nelle trattorie romane. Indossati i panni del posteggiatore, canta con la chitarra canzoni napoletane ai tavoli di «Giggetto er Pescatore», ai Parioli e a Trastevere dove incontra Claudio Villa. Per la Vis Radio, l’etichetta del reuccio, incide La morte traditrice, Lu pugliese a Roma, Lu vecchie, Lu Limone, Cuncettina, I maccheroni a cui seguono Padrone mio ti voglio arricchire con cui raggiunge una certa fama, poi La bicicletta/Il venditore ambulante del 1961 e Francisco a lu paese/Lu piscatore. Comincia a farsi conoscere non solo per la voce ma per una narrazione che presenta una Puglia sconosciuta, segnata da forti contraddizioni economiche, ricca di risorse ma povera di intervento pubblico. Però nella sua vita i guai non finiscono mai, mescolando arte e sentimento, nel 1973 la sua carriera si interrompe in modo drammatico quando viene arrestato con l’accusa di avere ucciso Adriana Doriani, sua compagna e collaboratrice. Pochi giorni dopo Salvatore farà alcune ammissioni dichiarando che la morte di Doriani poteva essere avvenuta fortuitamente alla fine di un litigio. Quattro anni dopo, per l’interessamento di amici e estimatori, fra cui Renzo Arbore, Mariangela Melato e altri artisti, viene organizzata una colletta che permetterà alla famiglia Salvatore di incaricare un ottimo penalista del foro di Roma a riaprire il caso che otterrà la revisione del processo e la scarcerazione. Ma per la sua carriera il processo e la carcerazione peseranno drammaticamente, un fatto insostenibile in un periodo in cui la scena musicale italiana alternava il rock duro al folk politico. Muore a Foggia il 27 agosto 2005. Teresa De Sio così lo ha ricordato:
«Matteo è stato un vero uomo del Sud. Della vita ha conosciuto la durezza e la dolcezza, l’aspro e il passionale, e queste cose le ha sempre trasformate in musica. Quando ho incontrato Matteo per la prima volta per me era già una leggenda, conoscevo a memoria le sue canzoni, le cantavo, sapevo della sua vita difficile e turbolenta. Pensavo che avrei trovato un uomo “domato”. Invece lui era una tigre. Una tigre sulla sedia a rotelle. Mi sembrò che in lui ci fosse una vena di follia, ma non di quella follia che è elusiva della realtà, anzi, Matteo emanava un’intera “versione del mondo”, poeticamente compatta, diversa e niente affatto subalterna. Se fosse stato un ragazzo degli anni settanta sarebbe stato una sorta di Syd Vicious».
Antonio Infantino è stato un altro «incontrollabile» esponente dell’avanguardia etno-rock anni Sessanta e Settanta, da lucano, vero anticipatore della rilettura moderna della pizzica. Un performer fuori dal tempo, con il corpo profondamente radicato nella memoria del sud lucano e lo spirito proiettato nel futuro della sperimentazione. Per questo sarebbe sminuirne il peso se si presentasse solo come il musicista che ha anticipato la rilettura in chiave contemporanea della taranta. In pieni anni Settanta costituì i Tarantolati di Tricarico, con l’intento di rilanciare tutta la potenza iterativa e rituale del tarantismo musicale, solo che, a differenza dei musicisti salentini lui è intervenuto fin dall’avvio della sua attività in veste di grande sperimentatore e innovatore. Inizia l’attività artistica a Milano nel 1966 al Nebbia Club, accompagnando le sue poesie con pochi accordi di chitarra. Infatti la prima attenzione, da parte di Giangiacomo Feltrinelli e Fernanda Pivano, riguarda proprio la poesia che porta alla pubblicazione di un libretto dal titolo provocatorio «I denti cariati e la patria». Negli anni Sessanta, come già ricordato, lo troviamo a fianco di un incontrollabile performer come Enzo Del Re sul palco del Folkstudio di Roma. Nel 1967 Dario Fo lo chiama a partecipare alla seconda edizione di Ci ragiono e canto con Avola, un titolo che racconta la condizione del lavoro bracciantile nella zona dell’omonimo paese siciliano. Ma è anche un esempio illuminante del suo modo personale di utilizzare il messaggio musicale per raccontare il contesto meridionale. Infatti Avola richiama lo stile dei canti di protesta in modo originale e autonomo, esattamente opposto a quello di folk singer come Matteo Salvatore o Rosa Balistreri, altri narratori della miseria e dello sfruttamento meridionale, che trasferiscono nelle loro ballate temi emersi dalla realtà sociale del profondo Sud. Con Infantino il mezzo diventa invece anche il messaggio cioè a dire che la performance, se non il vero mantra musicale, forma di cui Infantino è stato il più potente interprete in ambito folk, è la rappresentazione sonora del racconto contadino in tutta la sua asprezza e alterità. Non a caso le sue formazioni sono una travolgente macchina percussiva e poliritmica, impegnata in una performance iterativa e rituale, con un palcoscenico ingombro di strumenti e musicisti. Un doppio viaggio nello spazio e nel tempo: un frammento di Lucania con la sua musica popolare piena di strumenti percussivi: piatti e pelli, cupa cupa, tamburelli, riti di possessione e trance. Ma questa sua urgenza performativa non andava a scapito dell’attività discografica come mostra il citato «Ho la criniera da leone», primo album che propone un musicista capace di sviluppare il suo sentimento visceralmente legato alle radici popolari poi proiettato su una dimensione sperimentale. Un’anarchia sonora che assorbe gli stili e i princìpi musicali della sua terra, ne studia i temi popolari e sociali per mezzo dei quali le sue sono storie di sofferenza e povertà. Così i canti di raccolta delle olive (L’Aliv), i canti carnevaleschi infiammati dalla sfrenatezza dei ritmi, le testimonianze dell’occupazione delle terre da parte dei braccianti (Avola) o ancora le filastrocche infantili stravolte e ossessive (La gatta mammona), si trasformano in ingredienti che fanno del suo gruppo una compagine unica e trascinante. Ma la sua biografia presenta testimonianze di come si spinga ancora oltre il confine della ricerca, a partire dall’incontro con Alvin Curran e il gruppo Fluxus con cui approfondisce la sua attenzione verso la sperimentazione che porta alla realizzazione dell’happening La calata dei pastori a cui partecipano Edoardo Bennato e il nucleo fondatore di Napoli Centrale. Sono occasioni in cui l’artista torna a marcare la continua convivenza fra dimensione performativa e memoria, così pure l’incisione nel 1975 de I tarantolati, un album seminale per l’imminente folk revival perché non si propone solo di recuperare le forme della tradizione popolare ma di utilizzarle in senso innovativo e sperimentale. Qui sta la vicinanza con formazioni progressive rock (Osanna, Canzoniere del Lazio, Carnascialia) che si muovevano con gli stessi intenti di Infantino ma a partire dal rock. L’esordio incendiario di quel progetto marchierà a fuoco anche il nome del nuovo gruppo di Infantino: i Tarantolati di Tricarico, a sottolineare una radicalità di intenti e un forte legame con la tradizione e che vedrà il coinvolgimento di 150 musicisti più o meno stabili che si muovono intorno alla sua voce abrasiva e roca e al ritmo ossessivo della chitarra battente. Eredità di questo lavoro sono due nuovi progetti discografici: La morte bianca e Follie del divino spirito santo, rivelatori di come Infantino abbia sempre reinterpretato il messaggio popolare, non da folk singer di riproposta ma da musicista, intrattenitore e performer che utilizza ogni materia per costruire il proprio progetto sonoro. In questo senso rimane una figura unica nel mondo del cosiddetto folk revival come l’amico e sodale Enzo Del Re, così vicino per tanti versi al suo lavoro, con cui ha sempre condiviso un messaggio musicale militante animato da spirito anarchico. Se il patrimonio popolare era infatti per Del Re uno strumento di protesta e di battaglia, Infantino ha tenuto su piani separati impegno e musica, mentre il suo principale obiettivo era inventare qualcosa di nuovo, sperimentare, partendo dalle forme e dagli stili della tradizione popolare non solo del Sud Italia. Negli anni seguenti sarà impegnato in altre esperienze teatrali e musicali in tutta Europa e nel 1979 realizza La tarantola va in Brasile, un documentario sonoro sulla musica brasiliana che lo vede al fianco di artisti quali Toquinho. Tornato in Italia realizza Tricolore triste un album tratto dallo spettacolo omonimo in cui porta avanti una ricerca sulla voce come suono e strumento. Dopo molti anni di attività anche l’impegno a fianco del compositore Luigi Cinque non lo allontana dai territori tradizionali, la sua presenza al centro di un gruppo in cui figurano, oltre a Cinque, musicisti come Lucilla Galeazzi, Badara Seck e Fausto Mesolella, sono la conferma di una costante ricerca senza perdere di vista la memoria dei luoghi d’origine. Un messaggio così fotografato da Vinicio Capossela che lo ha sempre ammirato:
«Oltre al suo aspetto da profeta, e alle canzoni ancora oggi davvero sperimentali, rimasi travolto dall’energia dei ragazzi, dai loro tamburi artigianali, ricavati da pneumatici da camion e pelli tese, dai loro cupa cupa, strumenti arcaici confezionati con materiali post-industriali».
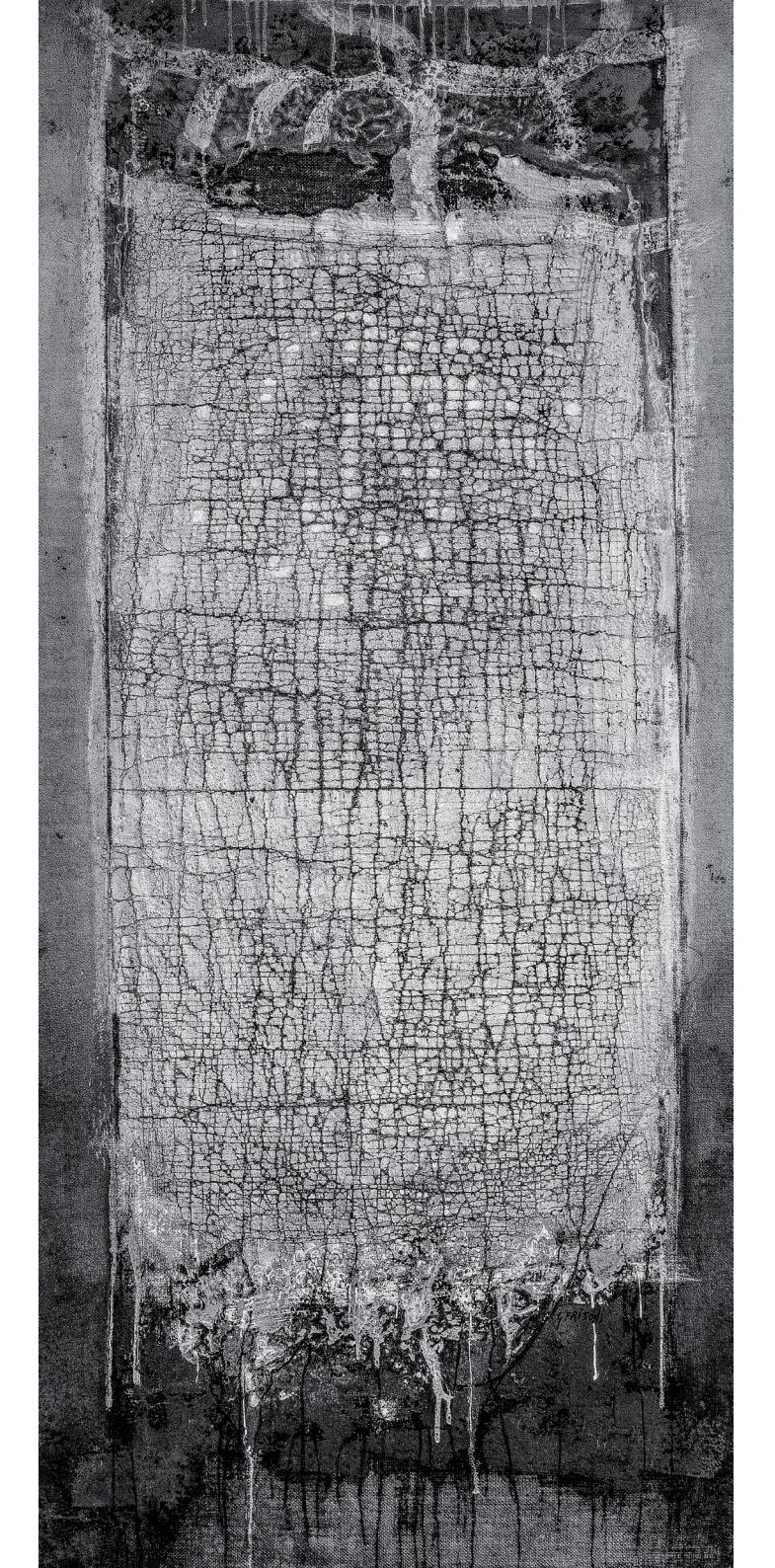
P E R C O R S I DI VISIONE Uno sguardo non indifferente Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri
Sono molte le atrocità nel mondo e moltissimi i pericoli. Ma di una cosa sono certo: il male peggiore è l’indifferenza. Elie Wiesel
Le parole di Elie Wiesel, sopravvissuto all’Olocausto e Premio Nobel per la pace, assumono un significato ancora più profondo in questi tempi complessi. L’indifferenza è quel distacco emotivo che, di fronte alle ingiustizie e alle sofferenze altrui, ci consente di voltare lo sguardo da un’altra parte, rivelandosi così una delle minacce più sottili alla nostra umanità. Paradossalmente, sono proprio la sovraesposizione mediatica e il consumo superficiale delle immagini, tipici del nostro tempo, a produrre un effetto anestetizzante sulle coscienze, rendendo abituale l’orrore. In questa cornice, il cinema, grazie allo «sguardo non indifferente» di alcuni registi e registe, ci costringe a guardare ciò che preferiremmo ignorare e a provare ciò che spesso scegliamo di non provare. L’indifferenza ha un raggio d’azione vastissimo e, spesso senza che ne siamo pienamente consapevoli, tocca gli aspetti più profondi del nostro vivere. Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto e complesso, quello che vogliamo proporre è un percorso di visioni per esplorare come il cinema, può essere uno spazio di consapevolezza e responsabilità capace di porre domande scomode e sollecitare a un confronto autentico con le conseguenze dell’indifferenza, sia individuale che collettiva.
Poche pellicole incarnano il concetto di «sguardo non indifferente» con la forza di No Other Land. Vincitore dell’Orso d’Argento alla Berlinale e dell’Oscar come Miglior Documentario nel 2025 – eppure introvabile negli Stati Uniti, dove nessun distributore l’ha comprato – il film rappresenta in maniera esemplare il potere dell’immagine come strumento di testimonianza e resistenza. È stato realizzato da un collettivo di registi israelo-palestinesi uniti in un progetto comune, due dei quali – Basel Adra, attivista palestinese e Yuval Abraham, giornalista israeliano – sono anche protagonisti, voce narrante, sguardo e coscienza. Siamo a Masafer Yatta, una regione semi-desertica nel sud della Cisgiordania occupata, sottoposta al pieno controllo militare israeliano. L’area è stata dichiarata «zona di tiro», destinata all’uso militare, e come tale da svuotare dei suoi abitanti attraverso saccheggi, demolizioni e la privazione dei mezzi di sussistenza. Il film mostra gli aspetti più brutali del colonialismo israeliano in Cisgiordania, non si concentra sul dinamismo del conflitto, ma sulla sua reiterazione: documenta lo schema degli sgomberi e la sistematicità della distruzione che si ripete nel tempo, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Lontano da ogni spettacolarizzazione, lo sguardo della macchina da presa, mostrando la metodicità della violenza, spinge a riflettere sul tempo immobile e ciclico che definisce la tragedia quotidiana della Palestina. Durante le riprese Basel e Yuval riflettono sulla necessità stessa di filmare: a cosa serve «mostrare», si domanda Basel, se il cinema non riesce a scalfire l’indifferenza, ma si limita a suscitare un’emozione passeggera, uno sdegno che non diventa azione né consapevolezza? In questo senso, No Other Land non è un film che documenta l’ottimismo o la speranza, ma esplora il potere della testimonianza attiva come strumento di trasformazione, anche in un contesto in cui il cambiamento appare quasi impossibile.
Uno sguardo non indifferente è quello della regista macedone Teona Strugar Mitevska, la cui filmografia si distingue per un impegno politico lucido e una costante interrogazione delle strutture di potere. In Dio è donna e si chiama Petrunya (2019), ambientato nella Macedonia contemporanea, la regista racconta la storia di una giovane donna, laureata in storia ma senza impiego, che casualmente infrange un rituale religioso – il tuffo nelle acque gelide di uomini a torso nudo per recuperare un crocifisso di legno lanciato da un sacerdote – riservato agli uomini, facendo così esplodere le tensioni latenti tra religione, Stato e patriarcato. La protagonista, accusata di nulla se non di essere fuori posto in quanto donna, diventa simbolo di una ribellione silenziosa ma radicale contro l’ordine sociale. Quasi divertita da tutto ciò che le succede attorno, Petrunya prende coscienza di non aver bisogno della «croce»: può lasciarla nelle mani della Chiesa, dello Stato, della polizia, di qualunque struttura e tradizione patriarcale che necessita invece di un pretesto per affermarsi. Lei è libera e, come tale, si aggira stringendo tra le braccia il busto di un manichino: quello di una donna che non esiste se non nell’immaginario di chi vuole controllarla.
In L’Appuntamento (2022), Teona Strugar Mitevska cambia registro ma non intensità. Ispirato a una storia realmente accaduta alla sceneggiatrice bosniaca Elma Tataragic, il film si svolge in una Sarajevo post-conflitto, dove una donna si ritrova faccia a faccia con l’uomo che le ha sparato durante l’assedio. Lo spazio chiuso dell’incontro è denso di silenzi e sguardi trattenuti: non c’è vendetta né redenzione, solo la convivenza forzata tra vittima e carnefice, emblema di una pace apparente che non risolve ma rimuove. L’Appuntamento è un’indagine introspettiva profonda sui traumi della guerra che permangono anche dopo le armi con tutti gli interrogativi su colpa e perdono, sulle tensioni tra memoria e oblio, tra giustizia negata e bisogno di andare avanti.
In entrambi i casi, per la regista macedone il cinema è un atto politico: non tanto perché denuncia apertamente, ma perché scava sotto la superficie del reale, espone ciò che viene rimosso e restituisce complessità a ciò che la società tende a semplificare. Il suo sguardo non indifferente insiste sul dettaglio, sul corpo, sul gesto come forme di resistenza a ogni narrazione dominante. Alcuni film riescono a raccontare le realtà sociali di un Paese con maggior efficacia rispetto a tanti servizi giornalistici: è il caso del cinema iraniano che, nonostante la censura e la repressione, continua a denunciare la vita sociale e politica del paese attraverso un linguaggio cinematografico ricco di simboli, metafore e allusioni che veicola messaggi di resistenza. È un cinema che rischia, resiste e testimonia: nonostante la censura, gli arresti e le condanne, registi e registe non smettono di raccontare con le immagini ciò che il regime vuole oscurare. Il male non esiste (2023) di Mohammad Rasoulof pone al centro il tema della pena di morte, che in Iran non colpisce soltanto chi si è macchiato di reati gravi ma anche i dissidenti, oltre a essere prevista anche in caso di blasfemia, possesso di droga, adulterio o contrabbando di opere d’arte. Stando ai dati di Amnesty International, nel 2024 in Iran si è registrata una media di un’esecuzione capitale al giorno, barbara prassi ancora condivisa da troppi Paesi, tra cui Cina, Giappone e Stati Uniti. Il regista, autore di numerose opere precedentemente censurate, è stato condannato a dieci anni di prigione e costretto, nel 2017, a lasciare l’Iran. Il film è composto da quattro episodi, ciascuno caratterizzato da una propria struttura narrativa – dal dramma familiare all’azione, dal sentimentale al thriller – che ruotano intorno a quattro personaggi le cui storie, seppur diverse, si intrecciano attorno al tema della pena di morte. Ciascuno dei quattro protagonisti dovrà misurarsi con una scelta destinata a cambiare la propria esistenza: accettare o rifiutare il ruolo di boia nelle esecuzioni per impiccagione, nella consapevolezza che, punendo i colpevoli e accompagnandoli alla morte, finirà per condannare anche la propria coscienza. In quanto esseri umani, siamo chiamati a confrontarci con le implicazioni etiche delle nostre azioni, anche quando queste rientrano in un quadro normativo che impone ordini da eseguire. L’adesione a regole ingiuste o a comandi imposti dall’alto non può automaticamente assolvere chi li mette in pratica: il fatto di agire «per dovere» o «per legge» non elimina la dimensione personale delle scelte. La storia, non solo quella recente, è piena di esempi in cui l’obbedienza cieca ha portato a violazioni gravi della dignità umana. In questo senso, ogni atto compiuto, anche nel rispetto di un ordine superiore, resta inscritto nella sfera della responsabilità soggettiva e chiama ciascuno a una presa di posizione consapevole.
Un altro sguardo scoraggiante sulla società iraniana è offerto da Il mio giardino persiano (2024), di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha, registi a cui il regime ha sequestrato il passaporto e impedito di accompagnare il film alla Berlinale. Si tratta di una commedia amara e malinconica, punteggiata da una sottile ironia, che racconta la vicenda di Mahin, un’anziana vedova dall’indole indipendente, cresciuta nell’Iran pre-rivoluzionario e forse per questo incline a sfidare le regole della Repubblica Islamica. Quando una giovane finisce nel mirino della polizia morale, Mahin sceglie di esporsi per difenderla, animata da un profondo senso di giustizia e da un desiderio di affetto che la società le nega. Nel corso di una serata, all’interno del rifugio domestico, si crea un inatteso legame con Faramarz, un tassista solitario, che apre uno spiraglio di umanità e tenerezza in un mondo oppressivo. Ma anche i momenti di dolcezza si rivelano fragili, destinati a infrangersi contro una realtà politica che vieta alle donne non solo la libertà pubblica, ma persino la possibilità di vivere l’intimità senza colpa. Il film si chiude con una scena dal forte valore simbolico, che trasforma il gesto privato in un atto di resistenza, restituendo voce e dignità a chi non ha il diritto di scegliere.
Ci spostiamo in Romania per parlare di Animali Selvatici (2022) di Cristian Mungiu, autore capace di raccontare la contemporaneità rumena con uno sguardo sulla società come elemento umano collettivo. Basato su un fatto di cronaca realmente accaduto nella regione della Transilvania – dove coabitano da sempre rumeni, ungheresi e tedeschi – il film racconta la sollevazione indignata e impaurita degli abitanti di una piccola comunità all’arrivo di tre operai provenienti dallo Sri Lanka, regolarmente assunti in un grande panificio solo per raggiungere il numero minimo di dipendenti necessario a ottenere i finanziamenti dell’Unione Europea. Questo luogo marginale e periferico si trasforma nel palcoscenico delle contraddizioni della globalizzazione: un villaggio ormai spopolato, dove, da un lato, nessuno è disposto ad accettare il salario minimo offerto dalle aziende, e, dall’altro, vengono rifiutati proprio quei lavoratori extraeuropei che, soli, accetterebbero quelle condizioni. Il film affonda la lama nei mali che attanagliano la società europea: razzismo e rifiuto del diverso, populismo e crisi della democrazia, impoverimento e crescita delle disuguaglianze. La forza della pellicola sta nella sua capacità di non esprimere giudizi morali, mostrando invece come le contraddizioni del sistema economico globale creino tensioni apparentemente insanabili tra le comunità locali e i flussi migratori. Quando la comunità si sente minacciata dall’arrivo degli «estranei», la razionalità cede il passo alla paura dell’altro: gli Animali Selvatici sono gli stessi abitanti del villaggio che, spinti dalla paura e dall’insicurezza, regrediscono a comportamenti primordiali, trasformandosi in un branco che agisce secondo logiche territoriali e di sopravvivenza.
Andiamo in Africa. Mentre l’attenzione mediatica globale si concentra su altri scenari di crisi, il Sudan resta una delle guerre più dimenticate del nostro tempo, un conflitto che si consuma nell’indifferenza generale nonostante la sua devastante portata umanitaria. A ricordarci questa realtà rimossa interviene la regista franco-tunisina Hind Meddeb, autrice di numerosi lavori in zone dimenticate tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente. Con il documentario Sudan, Remember Us (2024), presentato alle Giornate degli Autori all’interno della Mostra del Cinema di Venezia, Meddeb ci porta in un Sudan immediatamente successivo alla destituzione, tramite un colpo di stato, del dittatore Omar al-Bashir, portandoci dentro lo scenario di una guerra civile che continua ancora oggi a lacerare il paese.
La regista racconta i sogni dei giovani e delle giovani attivisti e attiviste sudanesi che, con parole, poesie e canti, lottavano per la libertà, sfidando il potere e la repressione. Senza il sogno che animava le loro azioni, la potenza dell’immaginazione e la forza delle loro espressioni artistiche non sarebbero stati e state in grado di rovesciare il regime precedente. Il loro sogno era un’esistenza basata sull’autosufficienza, la giustizia, la libertà e la dignità, un sogno che svanì quando, dopo cinquantasette giorni di sit-in rivoluzionario a Khartoum, l’esercito irruppe, massacrando centinaia di persone e distruggendo ogni speranza di un nuovo Sudan.
I film citati, nella loro diversità stilistica e tematica, non offrono facili consolazioni, ma invitano a una riflessione profonda sui meccanismi di potere, sulle ingiustizie sociali e sulle responsabilità individuali. Quando l’autorità – sia essa religiosa, statale o economica – impone narrazioni univoche che escludono o emarginano, il danno non riguarda solo chi subisce direttamente la discriminazione, ma corrode il tessuto stesso della società. Adottare uno sguardo non indifferente, come quello scelto da registi e registe che spesso operano in condizioni difficili e pericolose, significa allora riconoscere e denunciare le connessioni tra ideologie conservatrici e interessi economici, tra retorica nazionalista e disuguaglianze sociali. Ma significa anche, per noi spettatori e spettatrici, assumerci la responsabilità del nostro sguardo, che non dovrebbe mai essere neutrale: solo lasciandoci coinvolgere, rinunciando alla distanza protettiva di cui godiamo e accettando il rischio di lasciarci trasformare dalla visione di questi film, possiamo far nascere una consapevolezza capace non solo di resistere, ma anche di agire per produrre un cambiamento.

V O C A B O L A R I O POLITICO Anarchismo e democrazia Francesco Berti
1. La posizione radicalmente antistatale dell’anarchismo
Il rapporto tra anarchismo e democrazia può essere ricostruito, teoricamente, a partire dalla concezione stessa di anarchia. Va tuttavia tenuto presente, sullo sfondo, l’articolato contesto storico-politico di riferimento in cui si è sviluppato il dibattito. L’anarchismo, come movimento politico e in quanto dottrina definita, auto-consapevole e riconoscibile, è sorto, in Europa, nella seconda metà del XIX secolo, in un periodo di forte espansione dell’economia capitalista e di assoluto dominio degli Stati nazionali, la cui organizzazione interna stava evolvendo verso forme più liberali, ma era ancora lontana dagli standard democratici conseguiti nel XX secolo, soprattutto dopo la Seconda guerra mondiale. In ambito anarchico e libertario, il dibattito teorico sulla democrazia, nel Novecento, ha invece ovviamente risentito della sconfitta del movimento anarchico nelle rivoluzioni, degli insuccessi della strategia insurrezionale, dell’esperienza dei totalitarismi e del consolidamento degli Stati democratici dopo la fine del nazifascismo. Infine, negli ultimi anni, il rapporto tra anarchismo e democrazia non può che essere ripensato alla luce della crisi di legittimità delle liberal-democrazie, dei processi di rinnovata verticalizzazione delle organizzazioni di potere in ambito pubblico e privato, del risorgere dei nazionalismi, in chiave populista, dell’evoluzione dell’economia globale.
Secondo l’anarchismo classico, l’anarchia è un insieme di individui e comunità libere che vivono senza arché, nelle quali cioè è abolito, in principio e in pratica, ogni rapporto di dominazione tra gli esseri umani. Così Michail Bakunin (1814-1876), il «fondatore» del movimento anarchico: «Non ci interessa molto che l’autorità si chiami chiesa, monarchia, stato costituzionale, repubblica borghese, oppure dittatura rivoluzionaria. Noi le destiamo tutte, e le rifiutiamo allo stesso modo, in quanto fonti certe di sfruttamento e di dispotismo» (Bakunin 1984: 167). «L’uomo non è veramente libero che tra uomini egualmente liberi», scrive ancora Bakunin, «e poiché è libero solo in quanto umano, la schiavitù di un solo uomo sulla terra, essendo un’offesa al principio stesso di umanità, è una negazione della libertà di tutti» (Bakunin 2000: 96).
L’anarchismo di matrice socialista – quello a noi certo più familiare e prossimo – ha immaginato l’assenza di dominio come contemporanea abolizione dei rapporti di dominazione politici e pubblici, compendiati nel potere dello Stato, ed economici e privati, che trovano la più compiuta espressione in età moderna nell’economia capitalista.
Per ogni anarchismo – socialista o individualista, organizzatore o anti-organizzatore, rivoluzionario o pedagogista, etc. – l’anarchia è, in ogni caso, una società senza Stato, senza governo, in quanto senza dominio; una società orizzontale, fondata sull’autogoverno dei produttori, sulla confederazione tra comunità libere, in condizione di autogestione. Sul piano teorico, il ripudio dello Stato in quanto Stato ha comportato, come suo corollario, il rifiuto della democrazia come sua possibile specifica forma di governo. La critica della democrazia dei moderni da parte degli anarchici si è appuntata, in particolare, sul rigetto del concetto di delega del potere e perciò sul rifiuto dell’istituto della rappresentanza politica, sulla denuncia del centralismo burocratico. In breve, per l’anarchismo classico la forma liberale e democratica dello Stato è apparsa poco più di un paravento atto a occultarne la natura irriducibilmente autoritaria e classista. Come Kropotkin (1842-1921): «Il sistema rappresentativo fu la dominazione organizzata della borghesia e scomparirà con essa. Per la nuova fase economica che si annuncia, noi dobbiamo cercare un principio diverso di quello della rappresentanza. La logica delle cose lo impone» (Kropotkin 1921: 181). Così Bakunin: «Uno stato forte può avere un unico solido fondamento: la centralizzazione militare e burocratica […]. Nella repubblica il popolo viene derubato e oppresso […] in nome della “volontà popolare”» (Bakunin 1984: 96).
Se è tuttavia molto chiaro cosa l’anarchismo classico ha rifiutato e criticato, spesso con ottimi e persuasivi argomenti, il discorso si fa decisamente più sfumato e per alcuni aspetti più problematico riguardo a ciò che l’anarchismo ha immaginato e proposto, in sostituzione dello Stato. Ed è in riferimento a questo secondo aspetto che può rientrare un discorso più costruttivo e aperto sulla relazione tra anarchismo e democrazia.
L’anarchismo classico, come altre tendenze radicali del socialismo – per esempio, il marxismo – fa propria la convinzione che, una volta liberata dal dominio politico e dallo sfruttamento economico, la società sarà in grado non solo di abolire lo Stato, ma anche la sfera politica. Nell’anarchia, il politico, riassorbito nel sociale, viene ridotto a un esercizio di statistica sociale, a una pratica puramente amministrativa. Ciò in virtù dell’illusoria credenza, di ascendenza illuminista, secondo cui gli esseri umani, una volta liberati dagli apparati coercitivi e dalle ideologie autoritarie, finalmente posti in una condizione di uguaglianza e libertà, saranno naturalmente portati a condividere gli stessi valori e fondamentalmente a volere le stesse cose. La società libera – secondo questa visione – è dunque una società anarchica e una società anarchica sarà una società composta prevalentemente di anarchici.
Qui è possibile rinvenire un problema piuttosto consistente, di cui l’anarchismo classico pare poco avvertito. La società anarchica, come prospettato – sia pure assai vagamente – dall’anarchismo ottocentesco, è una società che, in quanto rifiuta l’eteronomia e ogni struttura coercitiva, confida sul fatto che il conflitto tra gli esseri umani è determinato essenzialmente da questioni relative alla proprietà o al potere. Una volta che la società avrà conseguito un alto tasso di giustizia sociale ed avrà abolito i rapporti asimmetrici di dominazione, gli uomini non potranno che convivere pacificamente tra di loro. In una società libera, vagheggiata solitamente come una sorta di eden terreno, resa comunità da una fratellanza e comunanza universali, fondata su un ethos fortemente interiorizzato da tutti i suoi membri, la gestione dei conflitti residuali, in assenza di leggi coercitive, polizia, tribunali e di corpi specializzati nel mantenere l’ordine sociale, sarà affidata allo strumento della riprovazione morale, alla vigilanza popolare diretta oppure alle cure mediche (cfr. per tutti Malatesta 1975: 165-168).
Occorre ammettere che questa prospettiva non solo appare oscillare tra un utopismo astratto e tendenze inconsapevolmente autoritarie, ma pure entra in un conflitto irriducibile col principio della libertà individuale che l’anarchismo, diversamente dalle correnti autoritarie del socialismo, pone tra i suoi valori fondanti e tra gli obiettivi primari della sua azione politico-sociale, anche nelle sue varianti più collettiviste. L’esistenza di una effettiva libertà individuale, infatti, è destinata per definizione a produrre – tanto più in una società complessa qual è quella moderna – una pluralità di vedute, di modi di concepire il mondo che non può che comportare un caleidoscopio di pratiche individuali e sociali differenti, in alcuni casi difficilmente armonizzabili tra di loro in modo spontaneo e pacifico. Questo aspetto non può che determinare a sua volta un conflitto strutturale nella società, che necessita, per essere regolato, di uno spazio pubblico di mediazione, per non generare caos, risolversi in violenza generalizzata o provocare l’insorgere di strutture di dominio.
Tra gli autori dell’anarchismo classico che più si sono fatti apprezzare per aver intuito la natura del problema si può favorevolmente citare Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865). Proudhon infatti, nell’ultima parte della sua vita, abbandonò l’illusione di individuare un sistema in grado di annullare la struttura conflittuale della realtà e si sforzò di elaborare delle soluzioni capaci di permettere la coesistenza di forze antinomiche e antagonistiche, inevitabile cascato di una società libera. Nel Principio federativo, il pensatore francese indicò nel sistema politico confederale e nel mutualismo economico la migliore approssimazione politica possibile all’ideale del socialismo libertario. In questa stessa opera, Proudhon affermò che la democrazia e l’anarchia rappresentano i due «regimi» idealtipici – mai realizzabili nella loro purezza nella storia – che hanno come carattere peculiare il principio della «divisione del potere». La democrazia, ossia il «governo di tutti da parte di ciascuno», e l’anarchia o autogoverno, ovvero il «governo di ciascuno per sé». Per (l’ultimo) Proudhon, dunque, il «regime» anarchico è dunque un parente stretto della democrazia, poiché fondato sulla libertà e sulla divisione del potere. Specificamente, l’anarchia è quel sistema in cui, «ricondotte tutte le funzioni politiche alla regolamentazione dei soli rapporti di produzione, l’ordine sociale risulterebbe unicamente dalle transazioni e dagli scambi» (Proudhon 1979: 15-16).
Con Proudhon, primo pensatore anarchico ad essersi qualificato come tale – ma fu anche deputato all’Assemblea nazionale, nell’incandescente 1848 –, la questione delle affinità, oltre che delle differenze, tra anarchismo e democrazia, si affacciò per la prima volta con una certa rilevanza. Ma fu solo alcuni decenni più tardi, all’acme della lotta anarchica contro lo Stato e il Capitale, in un periodo in cui il movimento anarchico, in molti paesi, stava cominciando a perdere terreno nei confronti del socialismo legalitario e riformista, che il tema del rapporto tra anarchismo e democrazia acquisì una rilevanza straordinaria e paradigmatica, in un celebre e drammatico confronto.
2. La polemica Malatesta-Merlino
All’inizio del 1897, Francesco Saverio Merlino (1856-1930), sino a quel momento uno degli esponenti di punta del movimento anarchico italiano e internazionale, diede l’avvio a un confronto-scontro pubblico, che si sviluppò attraverso articoli e lettere pubblicate in varie testate («Messaggero», «Avanti!», «L’Agitazione»), con l’amico e sodale Errico Malatesta (1853-1932), il leader principale dell’anarchismo italiano. Il confronto tra i due, che segnò il passaggio di Merlino dall’anarchismo a una posizione di socialismo riformatore dai tratti fortemente liberali, investì alcuni dei fondamenti teorici stessi dell’anarchismo, andando ben oltre la questione della partecipazione degli anarchici alle elezioni, che fu uno degli oggetti principali del contendere.
A distanza di tanti decenni, un giudizio equilibrato su questo scontro potrebbe portare a riconoscere molti meriti agli argomenti addotti da Malatesta in relazione alla questione tattica – partecipare o meno alle elezioni –. Sembra però opportuno, al contempo, riconoscere che, sul piano teorico, Malatesta non riuscì a controbattere in maniera convincente alle tesi di Merlino rispetto ad almeno due problemi fondamentali: il concetto di delega del potere e la questione concernente il principio decisionale da adottare in una società libertaria.
Per quanto riguarda il primo punto, Malatesta osservò che laddove, in una società anarchica, si determinasse la necessità di ricorrere a dei rappresentanti, questi dovrebbero essere investiti di un mandato rigidamente imperativo, in modo tale che il mandatario non sia altro che il mero «portaparola dei suoi mandanti o l’esecutore delle loro volontà» (Merlino, Malatesta 1949: 19). Rispetto al secondo, concordò con Merlino sul fatto che «in tutte quelle cose che non ammettono soluzioni contemporanee, o nelle quali le differenze d’opinione non sono di tale importanza che valga la pena di dividersi ed agire ogni frazione a modo suo, o in cui il dovere di solidarietà impone l’unione, è ragionevole, giusto, necessario che la minoranza ceda alla maggioranza». Ma subito aggiunse, perentoriamente, che tale cedimento, in una società anarchica, «deve essere l’effetto della libera volontà, determinata dalla coscienza della necessità». L’adozione di un criterio maggioritario non dovrebbe di conseguenza mai divenire un «un principio, una legge», e non potrà prevedere e comportare, l’utilizzo della forza (Merlino, Malatesta 1949: 16). «La società anarchica», specificò Malatesta, «deve essere fondata sul libero accordo»; essa non può dar luogo, nel tentativo di risolvere i conflitti che possono darsi al suo interno, a un «potere moderatore, che col pretesto di garantir la giustizia a tutti, ridurrebbe tutti in servitù» (Merlino, Malatesta 1949: 20).
Va osservato che questi criteri – il mandato rigidamente imperativo e il principio del libero accordo – risultano difficilmente applicabili in una società articolata e pluralista. Il libero accordo, in particolare, è in grado di provocare la paralisi della vita sociale o di indurre una unanimità forzata. Anche il mandato imperativo risulta di difficile attuazione in una struttura sociale complessa, che deve coordinare la volontà e l’azione in una scala di centinaia di migliaia o di milioni di persone. Malatesta immaginava la società libertaria come un assoluto, come il principio idealtipico di Proudhon, una comunità tendenzialmente perfetta che non può tollerare nessuna forma di imposizione o di violenza organizzata, pena la fine dell’anarchia.
D’altro canto, nella polemica, anche Merlino sembra commettere una evidente forzatura, laddove scrive che in una società libertaria, dove la struttura del potere è decentrata, nella quale gli interessi collettivi sono amministrati da funzionari «capaci, revocabili e responsabili, che agiscono sotto il sindacato diretto del popolo, gli sottomettono gli atti più importanti (referendum)», la coazione è ridotta al minimo. «L’essenza della democrazia», prosegue Merlino, sta nell’assenza di una coazione simile a quella che si dà in un regime autoritario, «e nella ricerca delle forme di amministrazione che lasciano il meno possibile all’arbitrio degli amministratori». «In questo senso», così conclude il ragionamento, «non v’è differenza sostanziale tra democrazia e anarchia», perché «governo del popolo – niente oligarchia – significa in sostanza non governo. Il governo di tutti in generale (democrazia) equivale al governo di nessuno in particolare (anarchia)» (Merlino, Malatesta 1949: 28). Come si può vedere, Merlino si spinge ben oltre l’idea proudhoniana di una parentela – sul piano delle forme “pure” di regimi politici – tra democrazia e anarchia. Egli forza la similitudine, sino ad arrivare a una equivalenza inaccettabile. Il governo di tutti, infatti, non può mai essere equiparato al governo di nessuno, proprio perché quei «tutti», secondo lo stesso Merlino, sono necessariamente portati a dividersi in maggioranze e minoranze e alle prime è attribuito il diritto di imporre le proprie decisioni alle seconde, al limite con la forza. Benché non fossero queste le intenzioni dell’autore, la posizione di Merlino, se assunta come tale, porta a una sottovalutazione della dimensione liberale che deve svilupparsi in relazione ad ogni struttura di potere, anche minima, anche laddove il potere sia “diffuso” e partecipato al massimo grado possibile. La democrazia, in quanto teoria politica, risponde alla domanda «chi è il legittimo titolare della sovranità? », ma nulla dice su quanto potere debba essere attribuito a chi comanda. Nella misura in cui il potere è attribuito a qualcuno, ai fini della tutela della libertà dei singoli e delle minoranze, sorge l’esigenza di cautelarsi da questo potere comunque attribuito e dislocato; sorge la necessità di stabilirne i confini, attraverso regole formali.
3. Il revisionismo di Berneri: democrazia libertaria e comunalismo
Un trentennio dopo questa polemica, Camillo Berneri (1897- 1937), uno degli ultimi autori dell’anarchismo classico, ma anche, per molti versi e soprattutto, il primo degli anarchici post-classici, sembra riprendere, in alcuni scritti databili intorno al 1926, rimasti inediti per molti anni, la polemica tra Malatesta e Merlino, senza citarla. La riprende nelle argomentazioni, chiarendo e risolvendo brillantemente alcune delle contraddizioni in cui le posizioni dei suoi predecessori si erano, per dir così, incagliate.
Pensatore ancora più eterodosso di quelli che l’avevano preceduto – a ben considerare, non esiste e non può esistere una vera “ortodossia” in un pensiero antiautoritario, che si vuole per definizione aperto e plurimo – Berneri riflette criticamente sulla “tradizione” anarchica, che tenta di attualizzare alla luce di una profonda e lucida consapevolezza: una società libertaria, modernamente intesa, non potrà mai essere una società organica fondata su una filosofia olistica. Dovrà invece costituirsi come società aperta, non-dogmatica, rispettosa dei diritti dei singoli e delle minoranze, pluralista e non negatrice del conflitto.
Per Berneri, i classici sono una fonte a cui attingere criticamente, non il deposito di un verbo sacro da ripetere dogmaticamente. È necessario aggiornare il pensiero di Proudhon, Bakunin e Pisacane «al lume delle enormi esperienze di questi anni di delusioni e sconfitte», adattarlo «alle situazioni sociali e politiche di domani», non indulgere «nella ripetizione di dottrinari luoghi comuni», che isolano l’anarchismo «nel nostro tempo» (Berneri 2002: 131-132). Rispetto a una serie di questioni, relative all’applicazione dei principi astratti alla prassi politica, il pensiero dei classici si rivela ai suoi occhi insufficiente: contiene indicazioni generiche, quando non è addirittura privo di indicazioni: «il problema delle rappresentanze, il problema dei rapporti intercomunali, il problema della surrogazione dello Stato: tutto questo ha soluzioni o strettamente parziali o del tutto insufficienti perché ottimistiche nelle soluzioni o anacronistiche nelle impostazioni». Occorre considerare che «la politica è calcolo e creazione di forze realizzanti un approssimarsi della realtà al sistema ideale […] in un dato momento sociale e politico» (Berneri 2002: 132).
Di qui l’urgenza di pensare e proporre un «anarchismo attualista, consapevole delle proprie forze di combattività e di costruzione delle forze avverse, romantico col cuore e realista col cervello, pieno di entusiasmo e capace di temporeggiare, generoso e abile nel condizionare il proprio appoggio» (Ibid.). Gli anarchici, osserva Berneri, criticano le soluzioni relative alla futura organizzazione sociale proposte dalle forze di sinistra, «ma soluzioni diverse non ne danno» (Berneri 2002: 130).
Secondo Berneri – sul punto decisamente discutibile, perché la questione del lessico ha un’importanza non indifferente – gli anarchici tendono a confondere lo Stato col governo. L’anarchismo è «scuola politica sorta contro l’ipertrofia burocratica, giudiziaria, poliziesca e militare dello Stato moderno, ma disposta ad accettare l’autorità, quando tutti partecipino a costituirla ed a controllarla. L’anarchismo nega lo Stato-governo, non nega lo Stato inteso come sistema di rappresentanze, di organi di collegamento e direttivi» (Berneri 2002: 125).
Secondo l’anarchico lodigiano, «vi è Stato in qualsiasi società i cui membri sono governati da leggi» (Ibid.). In qualunque struttura sociale organizzata è necessaria «una, sia pur minima, autorità dei rappresentanti e dei dirigenti». «La volontà delle maggioranze non è sempre conciliabile con quella delle minoranze. Qualunque forma politica presuppone la subordinazione delle minoranze. Quindi autorità.» (Berneri 2002: 126). Riflettendo sui compiti che attendono l’anarchismo una volta liberato il paese dalla tirannide fascista, Berneri perviene alla conclusione che l’obiettivo degli anarchici italiani dovrà essere quello di dare «alla rivoluzione italiana un indirizzo autonomista, sul terreno sindacale e quello comunale». Sotto il profilo della lotta più strettamente politica, gli anarchici dovranno agire in un ambito «liberale democratico», attraverso «l’agitazione su basi realistiche, con l’enunciazione di programmi minimi» (Berneri 2002: 131). Una posizione, come si può vedere, molto vicina a quella a suo tempo espressa da Merlino. Con un importante, necessario e decisivo distinguo. Quasi echeggiando Agostino di Ippona, che aveva distinto tra la Città di Dio (civitas Dei), città mistica non realizzabile compiutamente nella storia, e Città di questo mondo (civitates huius mundi), realizzazioni storiche della socialità umana e determinazioni empiriche del principio metafisico, Berneri opera una distinzione tra «L’Anarchia», ossia «la città ideale», principio assoluto di perfezione e armonica convivenza tra gli uomini, che mai potrà darsi come tale nel mondo storico, e «lo Stato libertario», ossia una democrazia liberale riorientata in senso libertario e socialista, che deve essere inteso come «la sua approssimazione storica. L’Anarchia è religione, lo Stato libertario è politica» (Berneri 2002: 126).
Preziose indicazioni di un programma di azione politica, che rimasero in un cassetto.
4. Dalla teoria alla prassi: intermezzo rivoluzionario
Sul piano della prassi politica rivoluzionaria e del rapporto che in essa si determinò tra anarchismo e democrazia, i due episodi maggiori – benché non gli unici: si potrebbero citare utilmente, tra le altre, anche la vicenda della rivoluzione messicana, la Repubblica bavarese dei consigli, l’epopea degli anarchici coreani in Manciuria e Corea negli anni Trenta e Quaranta; più recentemente, l’esperienza (neo)zapatista e quella del confederalismo libertario curdo – sono naturalmente quello delle comunità autogestite promosse dagli anarchici in Ucraina, negli anni della guerra civile seguiti alla rivoluzione bolscevica (1918-21) e la rivoluzione spagnola, scoppiata nell’ambito della guerra civile (1936-39). Del primo esperimento non moltissimo pare lecito dire, in virtù delle caratteristiche che gli furono proprie: l’estrema brevità in termini temporali, la mancanza di informazioni approfondite al riguardo, il fatto di essere fortemente legato alla figura carismatica del leader del movimento, Nestor Machno (1889-1934). Recentemente, uno studioso ha definito l’embrione di organizzazione politico-sociale-economica approntata dagli anarchici ucraini nelle zone da loro controllate una «democrazia militare» (Shubin 2012: 60). Un aspetto, tuttavia, vale la pena di essere sottolineato. Da parte anarchica si è messo in rilievo che nelle provincie sottoposte all’amministrazione libertaria fu proclamata e garantita la libertà di stampa e di organizzazione per tutte le forze rivoluzionarie (Machno 1971: 256-257; Arschinov 1954: 162-163; Volin 1950: 467-468). Segno che la «democrazia militare» libertaria, anche nella fase più intensa della lotta armata, si contraddistinse per il proposito di tutelare il valore della libertà «negativa», senza il quale il potere democratico del popolo finisce inevitabilmente per risolversi in una nuova forma di oppressione e di repressione della diversità e del dissenso.
Quanto all’esperienza spagnola, va ricordato che la CNT, il sindacato anarchico nel quale confluiva una parte considerevole del movimento operaio e contadino spagnolo, alla vigilia della guerra civile elaborò un programma abbastanza dettagliato, relativo all’organizzazione della rivoluzione e della società libertaria, una volta che fossero state create le condizioni per instaurare il «comunismo libertario». Nella risoluzione adottata al Congresso di Saragozza del maggio 1936, si legge che la struttura socio-politica della società spagnola avrebbe dovuto fondarsi sul trinomio: individuo, comune, federazione. A una rete organizzativa economica fondata sui consigli di fabbrica, di officina, di coltivazione, di produzione e di statistica, si sarebbe affiancato un sistema politico-amministrativo decentrato, basato sulla libera comune. Questa avrebbe avuto come perno il consiglio comunale. Il progetto, che prefigurava un embrione di organizzazione politica regionale e nazionale, su base confederale, prevedeva sistemi elettivi e deleghe del potere (Peirats 1977 1: 173-184). Risulta al contempo chiaro che il modello sociale che fu alla base della elaborazione dei rivoluzionari spagnoli in prossimità della guerra civile era – e non poteva che essere – sempre quello di una comunità omogena, composta da persone che la pensano fondamentalmente nello stesso modo, che non deve regolare una vivace conflittualità e nella quale la politica tende a risolversi in una pratica amministrativa.
La realtà sul campo espresse inevitabilmente una situazione assai diversa, che portò gli anarchici spagnoli a entrare nel governo repubblicano in nome dell’unità antifascista e per creare le condizioni per il trionfo della rivoluzione sociale, scoppiata in molte regioni della Spagna, in specie dove gli anarchici costituivano la forza trainante del movimento rivoluzionario, come in Catalogna e Aragona. La CNT-FAI dapprima entrò nel governo catalano (Generalitat, settembre 1936), infine partecipò attivamente, con propri ministeri, al governo nazionale di Madrid (novembre 1936). Sull’opportunità o meno di questa scelta molto si è discusso e scritto: in ambito libertario, col passare degli anni, i giudizi si sono fatti sempre più critici. Va rilevato che dalle giustificazioni addotte dagli organi confederali dell’epoca traspare una chiara impreparazione teorica – da cui non poteva che discendere una incertezza pratica – ad affrontare una situazione peraltro altamente prevedibile, dal momento che gli anarchici non costituivano, neppure in Catalogna e Aragona, la maggioranza assoluta tra le forze antifasciste. Così, si passò da un iniziale «negazionismo» in merito al problema del potere e dello Stato (l’ingresso della CNT-FAI nella Generalitat avrebbe magicamente annullato il carattere governativo dell’istituzione, rendendolo un organismo neutro «adatto alle circostanze attuali» (cit. in Semprum Maura 1996) – fino a un giustificazionismo del governo nazionale con una ibrida e improbabile formula anarco-leninista: «il governo, attualmente, in quanto strumento regolatore degli organi dello Stato, ha cessato di essere una forza di oppressione contro la classe operaia, così come lo Stato non rappresenta più l’organismo che divide la società in classi» (così «Solidaridad Obrera» del 4 novembre cit. in Peirats 1977: 293).
L’incapacità di pensare e proporre una soluzione diversa da quella della democrazia «borghese» in salsa social-comunista fu emblematicamente riassunta da García Oliver (1901-1980), uno dei principali leader dell’anarchismo spagnolo, divenuto nel novembre del 1937 ministro della giustizia nel governo di Madrid. Questi riassunse il dilemma a cui, a suo parere, si trovarono di fronte gli anarchici catalani dopo la vittoriosa repressione dell’insorgenza fascista di luglio, una volta che il presidente della Generalitat Companys chiese l’entrata nel governo regionale della CNT-FAI: «La CNT e la FAI decisero a favore della collaborazione e della democrazia, rinunciando al totalitarismo rivoluzionario che doveva condurre allo strangolamento della rivoluzione attraverso la dittatura confederale e anarchica» (cit. in Peirats 1977 1: 218). L’alternativa poteva essere concepita e posta nei termini di García Oliver, proprio perché l’anarchismo non aveva elaborato i contorni di una democrazia libertaria. L’alternativa alla democrazia «borghese», una forma storica di potere politico, non era pensata nei termini di una diversa e più avanzata in senso libertario – ma sempre storica e perciò imperfetta – forma di democrazia, capace di regolare in modo diverso la complessità e il pluralismo politico e sociale, ma nei termini di un «assoluto», di un ideale perfetto, l’anarchia. Una condizione che, per realizzarsi, richiede una società omogenea e una situazione in cui gli individui e i gruppi sociali fondamentalmente non hanno gravi motivi per cui confliggere. Solo pensando in questi termini, forse, gli anarchici spagnoli avrebbero potuto risolvere, in una chiave libertaria, quel dualismo del potere – tra il potere reale espresso dalla rivoluzione e quello fittizio del governo (Berti 1986: 41) – che si era presentato a suo tempo a Lenin, una volta rientrato in Russia nell’aprile del 1917.
5. Riflessioni recenti
Il declino del movimento operaio, il consolidamento della democrazia capitalista nel mondo occidentale, la crisi del sistema sovietico, il crollo del comunismo e la lenta fuoriuscita dai regimi del «socialismo reale», da un lato; la perdita di incidenza politica dell’anarchismo, la sua rigenerazione, in vesti in parte mutate, a partire dalla fiammata «rivoluzionaria» del ‘68, dall’altro; per giungere fino ai nostri, critici, giorni… In questo ottantennio che ci separa dalla fine del secondo conflitto mondiale le riflessioni anarchiche intorno al tema della democrazia sono state davvero molte e non potranno essere qui neppure sommariamente ricordate. Si darà conto di alcuni passaggi, alcuni nodi problematici, alcuni autori, senza pretesa alcuna di esaustività. Pare utile, anzitutto, ricordare almeno un dato storico-culturale di grande rilievo. Dopo l’isolamento degli anni Cinquanta, l’anarchismo trova una nuova vitalità grazie all’impulso sessantottino. Questo, tuttavia, se contribuisce a uno svecchiamento culturale, fornendo ai movimenti libertari nuovi strumenti epistemologici per una critica radicale del potere, dall’altro segna, per altri aspetti, il de profundis della visione rivoluzionaria, come era stata concepita a partire dalla Rivoluzione francese, e soprattutto della rivoluzione proletaria, quale era stata teorizzata e praticata dalla sinistra rivoluzionaria. Il ‘68, infatti, è solo in parte minoritaria legato alle lotte del movimento operaio e molto più una rivolta che una rivoluzione. Un avvenimento, insomma, che sembra avvalorare le riflessioni critiche sulla prospettiva rivoluzionaria sviluppate dal grande libertario Albert Camus (1913-1960). Il rapido riflusso nella seconda metà degli anni Settanta e successivi induce una parte del movimento libertario a riprendere, più o meno consapevolmente, la visione problematizzante di Camillo Berneri, in vista di un ripensamento dello spazio pubblico democratico in termini libertari. Un tema che sembra ricomprendere, legandole quasi in un invisibile filo, molte idee e riflessioni, sviluppate in ambito anarchico non solo, ma più in generale in una più ampia area libertaria, in cui possono essere situati numerosi pensatori, gruppi e movimenti, appartenenti al socialismo liberale, al marxismo o post-marxismo consiliarista, alle correnti democratiche radicali, all’ecologismo. In ambito strettamente anarchico, deve essere senz’altro ricordata la sferzante critica alla democrazia capitalista, soprattutto di marca statunitense, portata da Noam Chomsky (1928-), in nome di una visione antiautoritaria e autogestionaria che si richiama esplicitamente agli autori e alle esperienze dell’anarchismo classico (Chomsky 1987 e 2003). Ma è stato probabilmente Murray Bookchin (1921-2006) l’autore che, in ambito anarchico statunitense, ha saputo sviluppare più profondamente una teoria del potere libertario, su base municipalista e confederalista (Bookchin 1993), a partire dal ruolo della città nella storia (Bookchin 2021), all’interno di una concezione radicalmente ecologica, che ripensa in termini non gerarchici i rapporti sociali nelle comunità umane e nella relazione tra l’uomo e la natura. Una riflessione che è stata recentemente fonte profonda di ispirazione per Abdullah Öcalan (1948-) (Öcalan 2011) e per il movimento di liberazione curdo che ha dato vita, nel Rojava, a un esperimento di organizzazione politica e sociale fondato su tali principi (Dirik e altri 2017). A una sensibilità bookchiniana vanno ricondotti gli apporti di diversi pensatori, come Pietro Toesca (Toesca 1998), Takis Fotopoulos (Fotopoulos 1999), John Clark (Clark 2023), le riflessioni dei quali invitano a ripensare lo spazio pubblico come spazio di democrazia partecipativa e diretta, anche attingendo ad altre tradizioni di pensiero e di pratiche comunitarie, non occidentali.
In ambito francese, molto rilevante risulta il contributo fornito da alcuni dei più importanti esponenti della rivista «Socialisme ou barbarie», come Cornelius Castoriadis (1922-1997). Quest’ultimo, in particolare, si è interrogato sulla ricerca di uno spazio radicalmente democratico, dove rifondare la politica in vista di un superamento dell’eteronomia e della realizzazione di una piena autonomia dei soggetti, della loro partecipazione effettiva «a ogni potere esplicito esistente nella società» (Castoriadis 1989: 88). Anche grazie al confronto con le tesi di Castoriadis, Eduardo Colombo (1929-2018) ha definito l’anarchia come la «figura di uno spazio politico non gerarchico, organizzato per e dall’autonomia del soggetto dell’azione», che deve necessariamente prendere le forme della democrazia diretta, «spogliata del criterio di maggioranza» (Colombo 2008: 10, 35).
Il tema della collocazione storico-ideologica dell’anarchismo, delle aporie del pensiero anarchico, di una riformulazione dei rapporti tra anarchismo e democrazia, è stato al centro di un ampio dibattito che si è sviluppato, in Italia, soprattutto nelle pagine della rivista «Volontà» e all’interno suo collettivo redazionale negli anni Ottanta e Novanta del Novecento. Esso si riallaccia, sullo specifico punto, alle riflessioni elaborate da Luce Fabbri (1908-2000) che, di fronte alla minaccia totalitaria, invitava gli anarchici, negli anni Cinquanta, a riscoprire i punti di contatto concettuali con le correnti liberali, democratiche e socialiste. In particolare, Fabbri puntualizzava la necessità di riscoprire le radici liberali dell’anarchismo, in modo che esso contribuisse a evitare le derive cesaristiche o totalitarie della democrazia, dal momento che la democrazia, in quanto totale, «non è necessariamente liberale». Per Fabbri, l’anarchismo doveva tornare «ad avanzare le esigenze che il vecchio liberalismo avanzava contro la democrazia giacobina da un lato e contro l’assolutismo monarchico dall’altro […] un ritorno alla realtà concreta costituita dalla persona individuale e dalla sua sfera d’azione», da un lato; dall’altro la partecipazione degli individui alle organizzazioni sociali, locali, nazionali e internazionali, purché fondate «su vincoli federativi di coordinazione» (Fabbri 2023: 167; 200-201).
Secondo Giampietro (Nico) Berti (1943-), compito precipuo dell’anarchismo del XXI secolo è quello di fare i conti con la mancanza di una «scienza politica anarchica»: «il vero problema dell’anarchismo contemporaneo è rappresentato dal suo ineludibile confronto-incontro con il liberalismo e la democrazia», considerando che la liberal-democrazia costituisce «la soluzione storicamente più avanzata […] del problema della convivenza umana». Non ne rappresenta, tuttavia, «la sola storicamente possibile»; piuttosto, essa è «l’unica condizione storica possibile per il suo superamento in direzione anarchica» (Berti 2012: 354-355). In questa direzione riflette anche Amedeo Bertolo (1941-2016), secondo il quale «democrazia e anarchia» non sono «riducibili l’una all’altra ma (a determinate condizioni) neppure antitetiche». Più precisamente, l’anarchia costituisce un «al di là quantitativo e qualitativo» rispetto alla democrazia, «un di più e insieme un altro». Un di più, in senso democratico, perché porta la logica democratica alle sue estreme conseguenze, ed esige una forma piena, in senso diretto, di democrazia; un altro, in quanto è «un principio di organizzazione della realtà che va oltre lo spazio politico […] e addirittura lo nega». La democrazia libertaria – o anarchia possibile – si configura come uno spazio multilivello, la cui esistenza sarà data non solo dall’applicazione radicale dei principi democratici – tenendo tuttavia presente che «fuori dalla piccola dimensione la delega si impone» e che «fuori dalla forte omogeneità si impone un meccanismo decisionale diverso dall’unanimità» – ma anche dall’estensione dell’ethos libertario alle sfere del sociale e dell’economico, perché la comunità dei liberi non può che essere anche la comunità degli uguali (Bertolo 2017: 68, 74-75).
6. Una conclusione aperta
In una delle più acute riflessioni sul tema, Francesco Codello sosteneva, alcuni anni fa, che «il rapporto tra democrazia e anarchia è all’ordine del giorno più che mai» (Codello 2015: 139). Alla luce della ulteriore crisi e involuzione delle democrazie reali – dato che le parole non sono mai neutre e risentono ovviamente delle opinioni, dei giudizi e delle tendenze culturali delle diverse epoche storiche – è difficile capire se la parola democrazia, comunque declinata, conserverà in futuro quella accezione positiva che ha acquisito a partire dalle rivoluzioni di fine Settecento, dopo secoli in cui, in età romana, medievale e moderna, era entrata nel novero dei termini impronunciabili. Al di là del nome, tuttavia, rimane viva oggi, come lo rimarrà in futuro, per ogni società libera e libertaria, l’esigenza di istituire, conservare e migliorare, se possibile, una serie di cose che, almeno per un certo periodo storico, la democrazia liberale, in maniera imperfetta e spesso incompleta certamente, ma altrettanto sicuramente in modo vero, ha saputo garantire: il pluralismo sociale, i diritti di libertà e la partecipazione politica; la conflittualità regolata dal governo delle leggi; il potere del demos, la sua volontà, e le garanzie per i singoli, i gruppi sociali, le minoranze politiche, etniche e religiose.
La denuncia necessaria delle mistificazioni della democrazia non dovrebbe mai portare alla condanna della democrazia come pura mistificazione, se davvero l’anarchia vuole essere qualcosa di diverso, e soprattutto di migliore, di quanto l’umana sapienza ed esperienza, anche grazie alle lotte degli oppressi e degli sfruttati, è riuscita ad esprimere negli ultimi secoli.
Riferimenti bibliografici
Arschinov P., Storia del movimento machnovista, Edizioni RL, Napoli, 1954.
Bakunin M., Libertà uguaglianza rivoluzione, Antistato, Milano, 1984.
Bakunin M., La libertà degli uguali, a cura di G. Berti, elèuthera, Milano, 2000.
Berneri C., Anarchia e società aperta, a cura di P. Adamo, M & B Publishing, Milano, 2002.
Berti G.D., La dimensione libertaria di P.-J. Proudhon, Città Nuova, Roma, 1982.
Berti G., Libertà senza Rivoluzione. L’anarchismo fra la sconfitta del comunismo e la vittoria del capitalismo, Lacaita, Manduria-Bari, 2012.
Berti N., Anarchismo alla prova: politica e potere, «Volontà», 4 (1986), pp. 38-42.
Bertolo A., Al di là della democrazia, in Anarchici e orgogliosi di esserlo, elèuthera, Milano, 2017.
Bookchin M., Democrazia diretta. Idee per un municipalismo libertario, elèuthera, Milano, 1993.
Bookchin M., Dall’urbanizzazione alle città, elèuthera, Milano, 2023.
Castoriadis C., Potere, politica, autonomia, «Volontà» 4 (1989), pp. 59-89.
Clark J., Dallo Stato alla comunità. Il mondo di domani, elèuthera, Milano, 2023.
Colombo E., Lo spazio politico dell’anarchia, elèuthera, Milano, 2008.
Chomsky N., La quinta libertà, elèuthera, Milano, 1987.
Codello F., Democrazia e anarchia, «Libertaria» 2015, La pratica della libertà e i suoi limiti, a cura di L. Lanza, Mimesis, Milano, 2015, pp. 127-143.
Di Cesare D., Democrazia e anarchia. Il potere nella polis, Einaudi, Torino, 2024.
Dirik D. e altri, Rojava: una democrazia senza Stato, elèuthera, Milano, 2017.
Fabbri L., Critica dei totalitarismi, elèuthera, Milano, 2023.
Fotopoulos T., Per una democrazia globale, elèuthera, Milano, 1999.
Kropotkin P., Parole di un ribelle, Casa Editrice Sociale, Milano, 1921.
Makhno N., La rivoluzione russa in Ucraina, La Fiaccola, Ragusa, 1971.
Malatesta E., Pagine di lotta quotidiana, scritti 2° volume, Movimento Anarchico Italiano, Carrara, 1975.
Merlino F.S., Malatesta E., Anarchismo e democrazia, Roma-centro editore, Roma, 1949.
Öcalan A., Confederalismo democratico, Iniziativa Internazionale, Köln, 2013.
Peirats J., La C.N.T. nella rivoluzione spagnola, vol. 1, Dalla Prima Internazionale al 1936, Antistato, Milano, 1977.
Proudhon P.-J., Del principio federativo, Mondoperaio, Edizioni Avanti, 1979.
Semprun Maura C., Libertad! Rivoluzione e controrivoluzione in Catalogna, elèuthera, Milano, 1996.
Shubin A.V., Nestor Machno: bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria e rivoluzione contadina (1917-1921), elèuthera, Milano, 2012.
Toesca P.M., Teoria del potere diffuso. Federalismo e municipalismo, elèuthera, Milano, 1998.
Volin, La rivoluzione sconosciuta, Edizioni RL, Napoli, 1950.
Goffredo Fofi
(Gubbio, 15 aprile 1937 – Roma, 11 luglio 2025)
Goffredo Fofi, il libertario «intollerante», l’eretico nonviolento, ha vissuto una militanza pedagogica, come novello Socrate, il tafano che disturbava il consueto, l’ovvio, il banale delle nostre esistenze. Il bastian contrario che agitava il bastone d’appoggio come simbolo della rivolta esistenziale prima che politica. Il critico cinematografico, teatrale e letterario, l’animatore di riviste che hanno arricchito una gran fetta dei movimenti di emancipazione, di lotta, di sperimentazione. «Resistere, studiare, fare rete e … rompere i coglioni»: questo il suo monito. Goffredo Fofi, il disturbatore della quiete del perbenismo sociale, culturale, politico, di destra e di sinistra. La sua salutare intolleranza verso ogni forma di autoritarismo, comunque mascherato, ha disturbato sempre i nostri narcisismi, le nostre abitudini, il nostro adagiarci, accendendo in ciascuno di noi nuove sfide, nuove domande, tanti punti interrogativi. Il suo instancabile attivismo, il suo peregrinare curioso e inesauribile, lo hanno portato come un viandante indefesso dentro una molteplice varietà di realtà sociali e culturali che continuano a esistere nonostante tutta la bruttezza di una parte di questo mondo. Goffredo, un essere umano a tutto tondo, ricco e plurale come ogni essere che accetti di riconoscersi nella sua realtà fatta di positivo e negativo, di speranze e di disillusioni, di fermezza ideale e di contraddizioni inevitabili.
Anche la nostra rivista ha perso un riferimento importante e critico. Ci sentiamo parte di quelle minoranze attive di cui Fofi è stato illuminato interprete. In un’intervista-conversazione pubblicata nel numero due (giugno 2022) di «Semi sotto la neve» così lo stesso Goffredo ci diceva: «Il piccolo gruppo ha un valore non solo come difesa dalla opprimente bruttezza della storia e della società, che lascia oggi poco spazio alla solidarietà, ma come luogo di esperienze che rafforzino la nostra capacità di capire e di agire». Raccogliere quel che riusciamo, nei nostri limiti, di questa testimonianza vissuta sarà una nostra sfida e un nostro impegno.