Numero Completo 11

INDICE
| ESPERIENZE | Editoriale | 3 |
|---|---|---|
| - L’accoglienza come stile di vita - Bergwaldprojekt: |
Silvia Rizzo |
9 |
| in azione per il clima, tra boschi e brughiere - La filosofia e il carcere. Esperienze e riflessioni |
Tibor Lepel Pierpaolo Casarin |
19 31 |
| APPROFONDIMENTI | ||
| - Seminare chiarezza - Gli ingredienti per la salute in un’ottica globale: |
Giorgio Fontana |
45 |
| conoscenza, fiducia e collaborazione | Pamela Boldrin |
52 |
| vax. Emozioni, relazioni e crisi della fiducia - No - Guardare alle cause della povertà per ribellarsi, |
Francesco Spagna |
58 |
| già troppo si è atteso | Guido Candela |
62 |
| CONVERSAZIONE | ||
| - con Stefano Anastasia | a cura della Redazione |
85 |
| INTERNAZIONALE | ||
| - Negatività e positività dell’anarchismo. Un inestricabile ma contraddittorio dualismo |
Tomás Ibáñez |
99 |
| RADICI | ||
| - Federica Montseny | Valeria Giacomoni |
109 |
| - Élisée Reclus | Francesco Berti |
115 |
| MUSICA | ||
| - Arcivescovo dell’anarchia? Il Bob Dylan «cattivo» | F.S. | 127 |
| PERCORSI DI VISIONE | ||
| - (Non) visioni dal carcere femminile M. |
Mombelli e E. Ruggeri |
133 |



Editoriale
Ribellarsi è giusto. Ribellarsi è oggi un dovere etico. Ciò che stanno facendo gli studenti serbi, le moltitudini turche e della Georgia, gli oppositori israeliani al governo Netanyahu, molti cittadini degli Stati Uniti, pochi ma valorosi abitanti di Gaza, le donne in Iran, così come tante altre persone in tanti altri luoghi del pianeta, nella nostra realtà europea, in contesti geografici, culturali, politici diversi: uomini e donne in rivolta ci interrogano sul nostro presente, ci inducono a pensare un futuro diverso. Da quando è uscito il primo numero di questa rivista (febbraio 2022) sono trascorsi pochi anni, ma gli accadimenti della storia sono stati tanti, veloci, sconvolgenti, producendo anche tra di noi nuovi interrogativi, nuove sfide, nuove possibilità. La strada che abbiamo scelto consapevolmente, di valorizzare il propositivo e il positivo che le esperienze libertarie di oggi ci evidenziano, lo sforzo di trovare e di interrogare tutte quelle realtà spontanee, antiautoritarie, mutualistiche che prefigurano un altro modo di relazionarci socialmente, resta il senso profondo e più importante della nostra rivista. Non dimentichiamo e non trascuriamo però l’importanza e la scelta strategica della rivolta permanente, individuale e collettiva, la rottura dell’immaginario dominante, la volontà di opporre non solo resilienza ma anche resistenza a una deriva autoritaria e pericolosamente totalitaria della po-



litica contemporanea. Ecco perché, seppure con spirito critico e autocritico, desideriamo considerarci parte attiva dentro ogni movimento che combatta contro ogni forma, visibile ma anche nuova e nascosta, di dominio.
La bellezza e la carica creativa di movimenti spontanei di ribellione rappresentano per noi il valore aggiunto che illumina e alimenta la speranza. Ma tutto ciò non può illuderci e indurci a cercare scorciatoie che, pressoché sempre, si sono rivelate produttrici di nuovi poteri, nuove disuguaglianze, una volta consolidatesi in sistemi autoritari. Non vogliamo dimenticare il senso profondo della profezia di Étienne de La Boétie quando già nel 1500 ci ammoniva circa lo spettro reale della «servitù volontaria». Oggi, in un’epoca in cui vediamo una ricerca affannosa e irrazionale di nuovi capi, di nuovi uomini (o donne) soli al comando, di nuovi santoni e nuovi dei, noi dobbiamo opporre una visione grande, aperta, che ridia alle persone la potenza straordinaria del sogno, della possibilità concreta di vivere le nostre relazioni umane secondo pratiche di solidarietà, di rispetto, di autonomia, di libertà, di amore.
Senza una «Visione» il necessario e indispensabile pragmatismo si traduce in miseria e pratica dell’ovvietà, produce e alimenta una politica sloganistica e meschina, tipica dei nostri squallidi governanti. Ma questa speranza non è illusione, non è fuga mistica dalla cruda realtà, ma consapevolezza che, come ripeteva spesso Colin Ward, ci rende consci che non può esistere una società totalmente totalitaria, così come non potrà esistere una società completamente libertaria, ma che permangono all’interno di queste forme di aggregazione umana, spazi, interstizi, momenti in cui sono presenti in maniera contrapposta e irriducibile



la libertà e la tirannia. Ed è su questa consapevolezza che trova senso il nostro agire a favore della libertà che va ampliata, ma anche difesa nelle sue forme seppur incomplete, quando viene minacciata da un dominio incalzante.
Abbiamo la fortuna, sì perché è stata la casualità che ci ha fatto nascere in questa parte di mondo, di abitare in un’area geografica come quella europea, e dobbiamo esserne consapevoli. Ma questo ha poco a che vedere, in prospettiva, con la nostra idea di abitare una terra senza diventarne i proprietari. Dobbiamo pensarci sempre come «stranieri residenti» e rilanciare un’idea, anche di Europa, diversa da quella ufficiale e istituzionale di una nuova superpotenza tra altre potenze. La via di salvezza è il federalismo integrale, quello che riporta la centralità di un processo decisionale ai livelli più bassi possibili, quello che pensa a una «scissione al posto della fusione» (per dirla ancora alla Colin Ward), una pluralità di società e non a una società unificata e di massa, un federalismo appunto integrale che comprenda una gestione comune dei beni comuni, forme spinte di mutualismo, relazioni di mutuo appoggio, valorizzazione delle diversità e molte altre cose ancora.
Considerando tutto ciò, e molto altro, nel nostro piccolo noi continuiamo a proporre ai nostri lettori, semi continui di vita piena e libera, riflessioni e approfondimenti, conversazioni e articoli che stiano dentro questa strada, difficile, rischiosa, ma libera. Ci mancano contributi di pensiero e di riflessione su tanti temi e argomenti, e per questo cerchiamo sempre nuovi collaboratori e nuove collaboratrici, che mettano la propria sensibilità e la propria competenza al servizio di una comune causa. Siamo una rivista di tendenza ma vogliamo anche essere una fucina di confronto, senza sterili polemiche e avulsi da ogni dogmatismo.



In questo numero un’amica (Silvia Rizzo) e due amici (Pier Paolo Casarin e Tibor Lepel) ci raccontano tre diverse esperienze: una di accoglienza e di sostegno a persone “straniere” fatta da altre persone che sconfessano, con la loro quotidiana opera solidale, altri pensieri e comportamenti di violenta intolleranza; una efficace e difficile attività di studio e ricerca, ma anche di solidarietà attiva e non parolaia, in un luogo, il carcere minorile, di sofferenza e di violenza; infine un’attività ecologica in Germania, con protagonisti volontari e volontarie, che offre un esempio di pratica e di operosità autogestita e solidale. Il tema, a noi particolarmente caro, del carcere e delle sue possibili alternative, è l’oggetto della conversazione di questo numero con Stefano Anastasia garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per la Regione Lazio e portavoce della Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà. Poiché siamo consapevoli che quella che viene sociologicamente definita come «devianza sociale» in realtà è anche il prodotto di condizioni di disagio sociale, culturale ed economico, pubblichiamo un saggio sul tema della povertà oggi in Italia (Guido Candela) che, al di là dei freddi numeri, rappresenta un monito e uno stimolo per lottare per ridurre il più possibile e il più in fretta possibile le disuguaglianze che caratterizzano questo nostro mondo. Altri tre approfondimenti arricchiscono questo numero: due intorno ai temi della scienza, della medicina, delle prese di posizione contrastanti che anche nel nostro ambito libertario la drammatica e recente epidemia di Covid ha scatenato (Pamela Boldrin e Francesco Spagna). Infine un prezioso contributo di Giorgio Fontana che ci interroga sul significato più profondo di questi «semi» che vogliamo far germogliare liberamente. Riprendiamo poi con un articolo di Tomás Ibañez la discussione su ciò che noi chiamiamo «anarchismo propositivo e positivo» (discussione aperta da



Francesco Codello nel numero 8 di questa rivista), proponendo uno sguardo in parte diverso ma sicuramente arricchente per questa riflessione così importante per noi. Le due «Radici» sono dedicate rispettivamente a Élisée Reclus (Francesco Berti) ecologo anarchico ante-litteram e caposcuola della geografia sociale, e a Federica Montseny (Valeria Giacomoni) discussa ma interessante figura di donna che è stata protagonista della rivoluzione spagnola nonché per un breve periodo ministro della Catalogna liberata. Infine un contributo di Francesco Spagna su Bob Dylan e uno di Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri che recensiscono ancora film che riteniamo interessanti per i nostri lettori.
Insomma ancora materiale da discutere, interrogare, rilanciare. In direzione sì «ostinata e contraria» ma anche, soprattutto, utile ad alimentare un sogno e una speranza di reale e profondo cambiamento nei nostri cuori e nelle nostre menti.


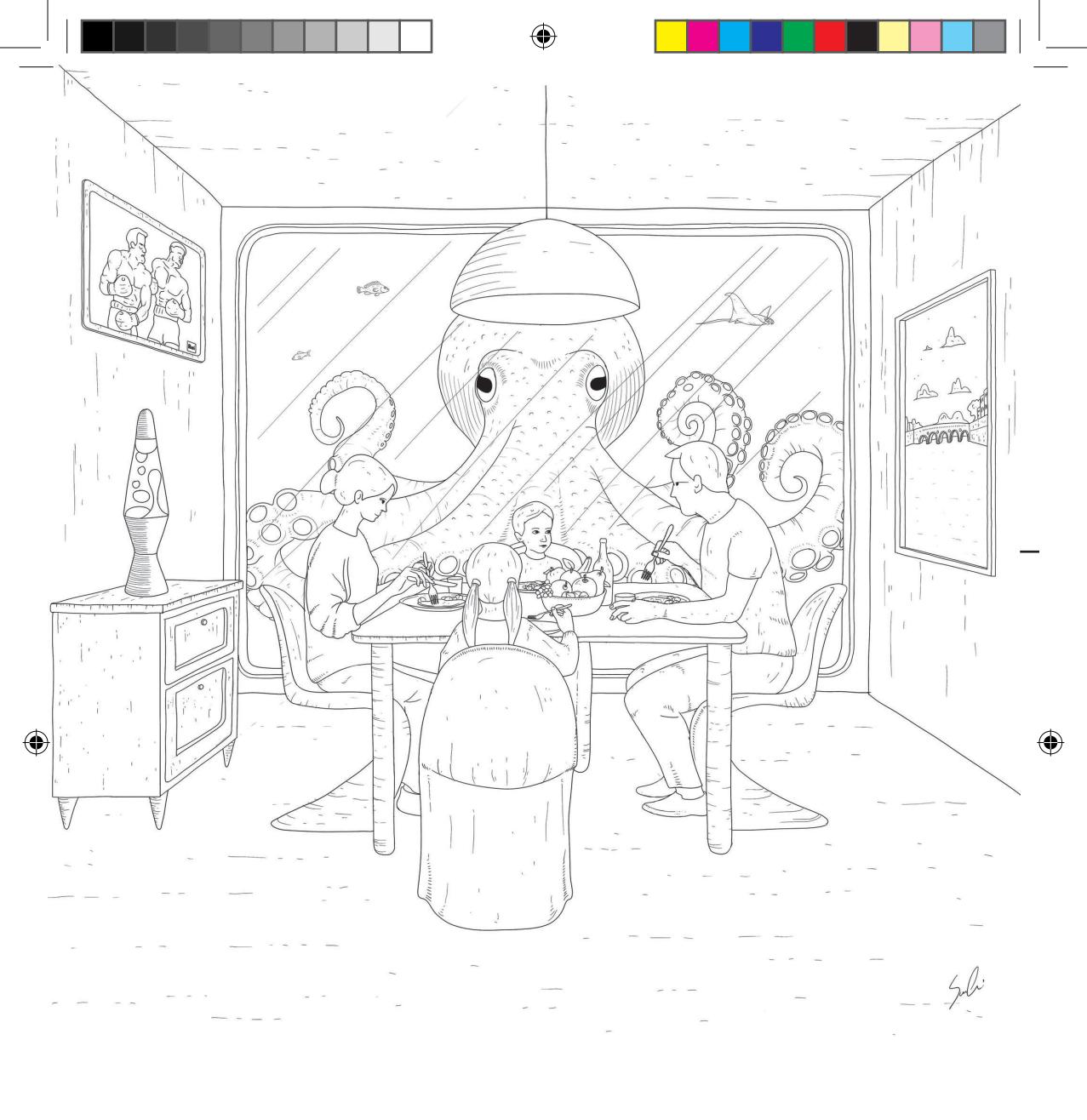
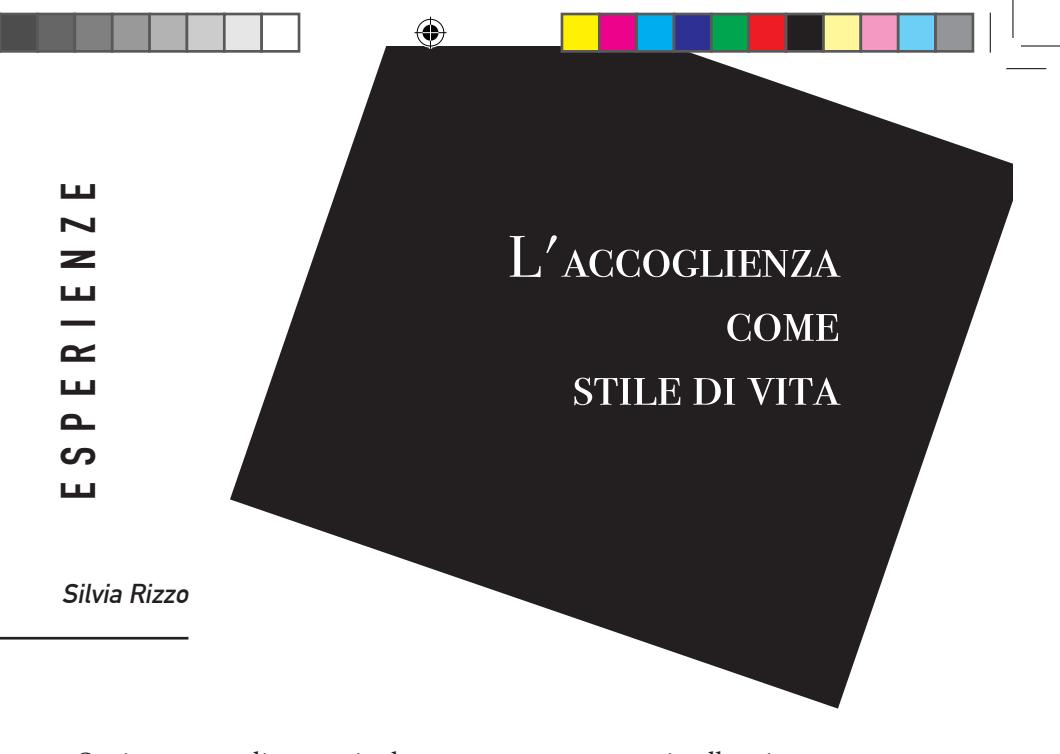
«Ospitare, accogliere, aprire la casa sono sempre stati nelle mie corde: mi dà energia e gioia. In più, accogliere persone che vengono da altri paesi significa dire sì alla vita, in quanto quelle persone sono portatrici di sogni e progetti, ma anche di grandi sofferenze. Da ottobre del 2023 è entrata in famiglia Feven, studentessa che aveva vinto una borsa di studio all’Università di Venezia e per questo, nonostante fosse incinta di 7 mesi, è partita dall’Etiopia lasciando un marito che aveva appena sposato. Con l’entrata di Feven a casa, ero diventata una minoranza bianca perché stavo già ospitando un giovane rifugiato eritreo sempre tramite Refugees Welcome. Precedentemente ho avuto altre esperienze di accoglienza: due ragazzi che in quanto diventati maggiorenni erano usciti dalla tutela del Comune e avevano bisogno di una casa. Il primo è stato un ragazzo albanese che è rimasto un mese, il secondo un ragazzo pakistano con cui ho convissuto per undici mesi. Successivamente una mia ex studentessa bengalese delle scuole serali come iniziativa personale. Per l’accoglienza di Feven, oltre a quelle che ho scritto sopra, ci sono altre due motivazioni. La prima riguarda la mia storia personale: sono stata una madre sola fin dall’inizio della mia prima e unica gravidanza, così quando ho saputo che c’era una giovane donna in un paese di cui non conosceva nemmeno la lingua e senza




nessun supporto morale e affettivo, mi sono detta che non avrei potuto lasciarla da sola. La seconda motivazione è legata all’illusione di contribuire, anche se in piccolissima parte, a rendere più umano un mondo che non ha più compassione per i piccoli, vedi la strage di bambini a Gaza e negli altri conflitti.
La convivenza sta andando a gonfie vele, la realtà ha superato qualsiasi aspettativa: meglio di così non può andare. Fra noi si è creata una bellissima armonia e in più ho la gioia di vedere Afkin, la bambina, crescere. Da qual-
che giorno ha iniziato a camminare e a dire qualche parola tra cui “nonna”, che sarei io, e lo scrivo con molto orgoglio. Ci tengo a evidenziare un’altra conseguenza dell’accoglienza di Feven e di Afkin: il fatto che ha rinforzato vecchie amicizie e ne ha fatto nascere di nuove: attorno a noi si è creata una rete informale di solidarietà fatta da amiche nuove e vecchie, vicine di casa che ci sostengono nella fatica di accudire una bambina di poco più di un anno. È un fiorire inaspettato di bontà e generosità.
L’associazione Refugees Welcome, mi ha messo in contatto con Feven, ha dato anche un contributo economico notevole, ma il “lavoro” di cura, di sostegno, di disbrigo della burocrazia rimane a carico della famiglia accogliente. In sintesi, dal mio punto di vista, è una bellissima esperienza dove l’arricchimento umano di cui gode chi ospita supera di gran lungo le fatiche che ci sono».
Questo è quanto ci racconta Giovanna e questo è ciò di cui si occupa l’associazione Refugees Welcome.
Ma facciamo un passo indietro per capire come la questione dell’immigrazione e la sua gestione segnano profondamente la vita delle persone, fanno la differenza tra la vita e la morte, tra l’accoglienza e l’inclusione da una parte e il respingimento dall’altra; tra la realizzazione dei desideri e l’impossibilità di realizzarli; tra il soddisfacimento dei bisogni e dei sogni e il crollo delle illusioni.



Partirei da un presupposto fondamentale: le Nazioni Unite riconoscono tra i Diritti Umani universali non-derogabili la libertà di movimento:
Articolo 13. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Il diritto fondamentale ad abitare la Terra-casa comune di «tutti i membri della famiglia umana». La libertà di movimento è condizione indispensabile per il libero sviluppo della persona.
E ancora all’Articolo 12 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, concluso a New York il 16 dicembre 1966, si specifica ulteriormente e arricchisce il contenuto dell’articolo 13 della Dichiarazione universale, in particolare stabilendo che la libertà dentro uno stato è «dell’individuo che vi si trovi legalmente», e che tale diritto non può essere oggetto di restrizioni tranne quelle che, previste dalla legge e compatibilmente con tutti gli altri diritti fondamentali, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, nonché gli altrui diritti e libertà.
Ma questo diritto che è universale non è garantito a tutti anzi è negato a troppi, quindi è un privilegio per pochi. Certamente al diritto di emigrare fa da contraltare l’idea che bisogna essere «liberi di scegliere se migrare o restare». Rivendichiamo anche il diritto a non emigrare: «La scelta di non emigrare, ossia la possibilità di vivere in pace e con dignità nella propria terra». Certo un obiettivo lontano ma possibile sarebbe quello di garantire libertà di scelta se emigrare o restare, ma molto spesso le condizioni di molti paesi sono tali per cui partire, andar via, diventa una necessità, pena la propria incolumità che potrebbe essere minacciata. A volte emigrare non è una scelta libera ma l’unica scelta possibile per la sopravvivenza: conflitti, disastri naturali, l’impossibilità di vivere una vita degna e prospera nella propria terra di origine, costringono milioni di persone a partire. Il più delle volte i migranti scappano per povertà, per paura, per disperazione.



Aggiungo però che spesso si cerca un futuro migliore per sé, non solo per sfuggire a guerre o persecuzioni, ma per perseguire il miraggio di una vita migliore in base al proprio talento o alle proprie inclinazioni, per uno sviluppo integrale della persona che il proprio paese d’origine potrebbe non garantire.
Se, quindi, esiste questo diritto universale a emigrare deve esistere un nostro dovere ad accogliere. Questo dovrebbe essere l’obiettivo di un paese con una visione inclusiva e aperta all’accoglienza.
Ed è questo l’obiettivo di Refugees Welcome, rendere il nostro paese accogliente, creando le condizioni per bypassare le leggi che negli ultimi anni lo hanno reso sempre più respingente e arroccato. Inoltre, come dice Amos Oz, «mettersi nei panni di…» è una buona pratica.
Proviamo ad immaginarci nei panni di chi deve andar via perché la
sua vita potrebbe esser in pericolo, o chi sceglie di lasciare la propria casa, la propria terra in cerca della realizzazione di sogni che sarebbe impossibile nel paese nativo.
Pensiamo al dramma di chi parte e intraprende il suo viaggio verso una vita migliore. Ognuno di loro ha un duplice vissuto tragico, quello che lo ha spinto a partire e ad abbandonare la sua famiglia, la sua cultura e il suo mondo, in fuga da guerre o lotte tribali per ritrovarsi in un mondo a lui del tutto ignoto. Un vissuto
tragico che sta nel viaggio sempre doloroso, interminabile e irto di pericoli, vessazioni, umiliazioni, sia quello per mare attraverso il Mediterraneo o il game attraverso la rotta balcanica, con la paura di non farcela, ma con la determinazione e il coraggio di chi vuole a tutti i costi farcela. Viaggi che li espongono a rischi terribili: o essere inghiottiti dal mare o essere arrestati, o respinti. Viaggi che possono durare anni, costretti a lavorare per pagare o gli scafisti o chi ti riporta oltre confine, o spesso incarcerati perché clandestini. Spesso partono giovanissimi, minorenni.



Prendere atto di questo e avvicinarsi a chi arriva, accoglierlo diventa un imperativo categorico, un dovere di umanità e solidarietà. Senza lasciare fuori nessuno. Ovunque decidano di costruire il loro futuro si spera che ci sia sempre una comunità pronta ad accogliere, proteggere, promuovere e integrare tutti, senza lasciare fuori nessuno. Parliamo di fratellanza e di amicizia sociale. Ma questo non solo in un approccio cristiano, accogliere è un impegno soprattutto in una visione laica, direi semplicemente umana.
Per non girarsi dall’altra parte!
All’indifferenza bisogna rispondere prendendo posizione, dire da che parte stai, essere «partigiani».
Una scelta di buone pratiche, di antirazzismo, di resistenza all’indifferenza.
Una scelta di coerenza ideologica, di azioni concrete, coerenti con un’idea di società plurale e in vista della creazione di una rete di solidarietà.
Sappiamo che molto spesso i cambiamenti nella società non vengono dall’alto, dalle leggi, ma viceversa sono i cambiamenti nella società, nelle pratiche quotidiane che impongono una trasformazione, e una legislazione che prenda atto delle trasformazioni in atto nel tessuto sociale e cambi in maniera radicale l’approccio alla questione immigrazione-integrazione-accoglienza.
In tale prospettiva Refugees Welcome si colloca, nella volontà di cambiamento di un modello di accoglienza che, allo stato attuale, non sempre è funzionale all’integrazione e all’inclusione. Infatti

l’accoglienza in famiglia come percorso di integrazione è un modello di accoglienza diffusa, dal basso grazie al quale l’inclusione è assicurata.
Parliamo di inclusione. Un tempo si parlava di tolleranza, ma le parole dicono la realtà: «tollerare», inizialmente sembrava un termine accettabile, presto ci si è resi conto



che il termine aveva un retrogusto di accettazione dell’altro, poi si è passati al concetto di «accoglienza», poi al termine «inclusione» che però nel suo etimo ha, ancora, un concetto di chiusura. Forse il termine più adeguato è quello di inter-azione, agire insieme, concetto che consente di trasformare un paradigma e muoversi collettivamente, di superare la polarizzazione e la dicotomia tra noi e coloro che devono essere tollerati o accettati o integrati, ma rimanda a un noi con loro, per camminare insieme in un percorso di crescita collettiva.
Dinanzi alla fotografia delle strutturali criticità all’interno del sistema di accoglienza non ci possiamo fermare alla denuncia, bisogna passare a una proposta collettiva, dal basso, essere in prima linea: ci chiama in causa a livello di responsabilità individuali.
Il volontariato esiste laddove ci sono buchi e carenze nello stato e svolge un ruolo di supplenza finalizzato alla creazione di una rete di solidarietà.
Quindi l’obiettivo di Refugees Welcome che è l’accoglienza di rifugiati all’interno di famiglie di qualunque tipologia, dalla famiglia con figli ai single, alle famiglie arcobaleno, consente di dare prospettive, opportunità, possibilità di costruirsi una vita autonoma in linea con i desideri di chi viene ospitato, per migliorare la condizione di partenza. Costruiamo un ponte tra le comunità di accoglienza e la vita in autonomia. Laddove non arrivano le istituzioni arriva la società civile. Noi svolgiamo un ruolo di supplenza laddove le istituzioni sganciano e chiudono il sostegno al ragazzo o alla ragazza, una volta concluso il progetto, spesso noncuranti delle loro reali condizioni. Spesso non sono del tutto autonomi economicamente,
non riescono a trovare alloggi che per loro sembrano preclusi, non sono in grado di procedere nel loro percorso in autonomia. L’ideale sarebbe un’accoglienza integrata tra enti locali e terzo settore.
Ma qual è il valore aggiunto dell’accoglienza domestica?



Mettersi al loro fianco, aiutarli nel nuovo percorso di vita e a farli sentire parte di una comunità, dare prospettive, opportunità, possibilità di costruirsi una vita autonoma in linea con i loro desideri di migliorare la condizione di partenza. Certamente l’accoglienza ha fatto la differenza nella vita di Feven:
«Mi sento incredibilmente for-
tunata e benedetta per la gentilezza che ha cambiato la mia vita quando sono arrivata in Italia. Arrivare in un nuovo paese mentre ero incinta non è stato facile, e una delle sfide più grandi che ho affrontato è stata trovare un posto dove vivere. In un momento in cui tutto sembrava incerto, ho avuto la fortuna di incontrare qualcuno che non solo mi ha offerto una casa, ma mi ha dato qualcosa di ancora più prezioso: una famiglia. Sono venuta in Italia perché ho ricevuto una borsa di studio e, sebbene sapessi di essere incinta in quel momento, non volevo perdere questa opportunità. Mi aspettavo che non sarebbe stato facile, ma la realtà che ho affrontato è stata ben oltre ciò che avrei potuto immaginare. I pagamenti della mia




borsa di studio erano in ritardo e molte persone non erano disposte ad affittare una casa a una donna incinta. È stato un periodo incredibilmente difficile: ho esaurito tutti i miei risparmi e mi sentivo completamente persa. Finalmente, attraverso un’assistente sociale che ho contattato, sono stata presentata all’Associazione Refugees Welcome. Grazie a loro, ho incontrato Giovanna, che era disposta a ospitarmi e non ha voluto lasciarmi sola in un momento così difficile. In lei ho trovato più di una persona che mi accoglieva a casa sua; ho trovato una madre, una famiglia e una fonte di conforto e forza. Il suo calore e la sua generosità mi hanno dato la stabilità di cui avevo bisogno per proseguire i miei studi. Grazie al suo sostegno, ora sono vicina a concludere il mio percorso di studi, un traguardo che una volta sembrava così lontano e difficile. Anche i membri dell’Associazione Refugees Welcome sono diventati per me come una famiglia. La loro gentilezza e il loro supporto hanno trasformato il mio percorso in modi che non avrei mai potuto immaginare. Sarò sempre grata per l’amore e il sostegno che mi hanno accompagnata in uno dei momenti più difficili della mia vita. È un promemoria che, anche nei momenti più duri, ci sono persone disposte ad aprire il loro cuore e la loro casa, e la loro gentilezza può cambiare tutto».
Inoltre, come dice Feven, è un’opportunità anche per conoscere più velocemente il contesto sociale e culturale del paese ospitante e creare più facilmente una rete di rapporti sociali, migliorare la conoscenza della lingua, consentire uno scambio interculturale, ma soprattutto un sostegno al raggiungimento dei loro progetti di vita e delle loro aspirazioni. Ospitare in casa un rifugiato è un’esperienza profonda di scambio e condivisione che fa bene a tutti. Conoscersi, guardarsi in faccia, relazionarsi in un rapporto ravvicinato consente di conoscere la persona per ciò che è, liberandola da pregiudizi e stereotipi.
L’accoglienza fa bene a tutti è uno degli slogan di Refugees Welcome. Come ci racconta Linda, «L’idea di ospitare un rifugiato era già nei nostri progetti durante la malattia di mio marito. Così quando il male se l’è portato via, per me è rimasto un sogno da realizzare.



Gli amici di Refugees Welcome mi hanno supportato in questo e mi hanno fatto incontrare Muhammad, ragazzo pakistano di 21 anni, in cerca di “tranquillità e di un luogo accogliente dove poter studiare”. Queste sono state le richieste di quel ragazzo infreddolito barricato dentro al suo piumino, che abbiamo incontrato una fredda mattina nebbiosa a San Donà di Piave. Dal cappuccio uscivano solo i suoi grandi occhi neri che raccontavano di lui, della sua dolcezza e della sua forza.
È stato a casa con me 17 mesi. Mi ha ridato l’energia per ricominciare a vivere. Ha condiviso con i miei figli le gioie della famiglia. Ha imparato la lingua, è andato alla scuola serale, ha preso la patente e si è comprato un’auto, la sua “Ferrari rossa”, come la chiama lui. Ora abita da solo in un appartamento in affitto. Ci sentiamo spesso e ci vediamo con piacere, assieme al resto della famiglia allargata, che lo considera membro a tutti gli effetti». È il racconto di Linda che con grande slancio ha deciso di accogliere Muhammad nella sua casa. Un’esperienza di accoglienza straordinaria, tra le più riuscite, che ha consentito a Muhammad di realizzarsi lontano dal suo paese.
Ma oltre all’obiettivo finalizzato all’accoglienza del singolo per fare la differenza per la persona accolta, tutti insieme possiamo fare la differenza per una nuova idea di rapporto col migrante.
Refugees Welcome si prefigge, infatti, finalità di più elevato profilo.




Innanzitutto l’idea di promuovere una cultura dei diritti, per tutelarli decostruendo una politica di privilegi. Provare a produrre un cambiamento, pensare che un nuovo modello di accoglienza sia possibile per consentire l’inclusione e che l’interazione venga garantita. Altra finalità è quella di cambiare la percezione della realtà del fenomeno migratorio che certe politiche sciagurate hanno mistificato e ingigantito sia nei numeri sia nella qualità, trasformando ogni essere umano in un clandestino delinquente, dannoso per la nostra sicurezza! Altra finalità è decostruire pregiudizi e stereotipi, liberare dalla paura dell’altro e del diverso, valorizzare la diversità per creare un’abitudine alla diversità.
Diventiamo protagonisti di un cambiamento di paradigma.
Refugees Welcome Italia ETS è un’associazione che fa parte del network internazionale nato nel 2014 a Berlino e che si è diffusa in 15 paesi del mondo! Nel dicembre del 2015 è nata anche in Italia, strutturata in gruppi territoriali. Oggi è in 30 città in Italia, 17 regioni coinvolte, 400 convivenze attivate, più di 200 attivisti.
È un’associazione che si occupa di accoglienza in famiglia diretta e dal basso.
Cosa puoi fare tu?
Basta andare a questo link https://refugees-welcome.it/cosa-puoi-fare-tu/ che invia alla piattaforma in cui iscriversi sia per chiedere ospitalità, che per offrire ospitalità a casa, sia per diventare un mentore e affiancare un rifugiato nel suo percorso verso l’autonomia, sia per chi sceglie di collaborare con l’associazione come attivista. Spesso i rifugiati vengono iscritti dagli operatori quando un ragazzo/a deve uscire dalla comunità di seconda accoglienza ma non è ancora autonomo anche se ha completato il suo iter sul piano burocratico. L’inserimento nella famiglia avviene al termine di un percorso con un protocollo preciso finalizzato alla conoscenza reciproca, alla valutazione di idoneità e di compatibilità al fine di garantire una convivenza che sia più efficace e felice possibile. Inoltre la famiglia verrà seguita da un tutor in modo che questa non venga mai lasciata sola nel periodo dell’accoglienza fino all’autonomia del/della ragazzo/a ma possa sempre far conto sugli attivisti e sulla comunità dell’associazione per affrontare e risolvere i problemi laddove questi potrebbero sorgere.


ESPERIENZE
Bergwaldprojekt – in azione per il clima, tra boschi e brughiere
Tibor Lepel
Ho scelto il mese di settembre per partecipare al mio primo Bergwaldprojekt. Ero tornato da poco in Germania, il mio paese d’origine, con la mia compagna italiana, dopo 16 anni trascorsi in Italia. Settembre è un mese ideale: non troppo caldo, ma ancora piacevole, nella Foresta Nera, appena sopra Friburgo, la città più soleggiata della Germania. Il momento perfetto per lavorare a contatto con la natura e per riavvicinarmi al movimento ecologista del mio paese, che avevo lasciato pochi anni dopo la laurea in ingegneria della pianificazione territoriale. Così mi sono iscritto alla mia prima settimana di volontariato nel bosco.
Il Bergwaldprojekt (Progetto del bosco di montagna), di cui avevo sentito parlare da poco, è un’associazione fondata nel 1990 che si occupa del ripristino di ecosistemi compromessi attraverso la piantumazione di alberi, ma non solo. Un’associazione che fa sentire la propria voce anche nell’attivismo contro il cambiamento climatico, riuscendo a farsi riconoscere sia dal movimento ecologista, sia dal mondo istituzionale delle foreste statali.
Ispirata da un’associazione svizzera dedicata al ripristino dei boschi di montagna, oggi si occupa anche di prati e delle preziose brughiere che in Germania sono state prosciugate o «bonificate»



al 99% nel corso dei secoli, come molte delle «lande desolate» di cui non si sapeva come sfruttarle economicamente.
Il nostro lavoro nel bosco ha l’obiettivo ambizioso di affrontare due delle crisi più gravi del nostro tempo: il cambiamento climatico e l’estinzione massiccia delle specie, entrambe causate dall’attività umana. Ma come si possono affrontare temi così globali e complessi con un gruppo di volontari in un piccolo angolo della Foresta Nera?
Già sul tram verso il nostro punto d’incontro vedo alcuni zaini spuntare e sempre più persone con l’aspetto caratteristico di chi è pronto a trascorrere una settimana nel bosco. Arrivati alla fermata finale del tram, dove inizia il fitto verde della foresta, ci accolgono due immancabili VW Transporter e Paoline, la capo forestale del Bergwaldprojekt, insieme ai suoi due assistenti, tutti con un grande sorriso in faccia.
Non è un caso che la responsabile del progetto sia una donna: Paoline è una delle tante professioniste laureate in scienze forestali che lavorano per l’associazione Bergwaldprojekt, la quale ha come obiettivo dichiarato quello di aumentare la presenza femminile in un settore storicamente dominato dagli uomini.
Interessante notare che i partecipanti ai campi di volontariato nei boschi sono equamente distribuiti: 50% donne e 50% uomini, senza necessità di riservare posti specifici per uno o l’altro genere. Paoline durante tutta la settimana non fa emergere alcun dubbio sulla sua competenza straordinaria. Saliamo per circa mezz’ora lungo i tornanti fino alla casetta della forestale, dove
il nostro gruppo di quindici volontari troverà rifugio. Ci troviamo a mille metri sopra il livello del mare; piove e fa freddo. Mi ero dimenticato che il mese di settembre in Germania può essere così diverso.
Nonostante la pioggia, tre ragazze del gruppo montano le loro tende intorno alla casetta, che consiste in una



stanza unica al pian terreno con una grande stufa al centro e una sala al primo piano dove dormiremo sui nostri materassini portati da casa. In una parte del pian terreno Axel e Dagmar, una coppia di cuochi sulla sessantina, hanno preparato un pasto di benvenuto per noi. Appena sfornato, accoglie un gruppo misto per età e provenienza: ci sono studenti, lavoratori dipendenti, insegnanti, medici e pensionati; veterani del Bergwaldprojekt affiancati da volontari alle prime armi.
Negli anni a venire, nei progetti, incontro attivisti del clima con a carico venticinque processi penali, non avendo ancora varcato la soglia dei trent’anni, a confrontarsi in lunghe serate su senso e impatto del proprio agire con impiegati dell’Unione Europea e bancari in un anno sabbatico di riflessione sulla propria vita. Le esperienze intellettuali prevalgono e forse proprio per questo il gruppo trasmette una forte voglia di fare.
Alcuni numeri
Il Bergwaldprojekt organizza ogni anno circa 200 progetti settimanali in tutta la Germania. Dalle Alpi alle isole nel Mar Baltico come nel Mare del Nord, passando per tutte le regioni del paese, e affrontando in ognuno di questi progetti dei temi locali, offrendo ogni anno la mano d’opera di 5.000 volontari. Ai 5.000 volontari si aggiungono 400 accompagnatori esperti, molti a loro volta volontari, ma con un nucleo di professionisti a contratto a tempo indeterminato e libero professionisti pagati in modo dignitoso. Una storia di successo, considerando che tutto è iniziato da un gruppo di giovani vicini a Greenpeace, il cui obiettivo era affiancare alle tradizionali azioni di denuncia dell’ambientalismo del tempo anche una proposta di intervento concreto nella natura. All’epoca si parlava della prima morìa dei boschi, il Waldsterben, un termine che entrò nel vocabolario internazionale poiché rappresentava la prima volta in cui si osservava una morìa massiccia delle foreste. Si pensava allora che il problema potesse essere risolto con l’introduzione di catalizzatori nelle automobili e filtri



nelle ciminiere delle grandi industrie. Oggi, la morìa degli anni ‘80 viene attribuita a una prima ondata del cambiamento climatico che stiamo vivendo attualmente.
Il Bergwaldprojekt mirava a incoraggiare le persone a vedere in prima persona lo stato della natura, comprendendo attraverso il contatto diretto con essa e sperimentando al contempo che è possibile agire per il cambiamento. Si può dire che la missione principale del progetto fosse e sia tuttora la trasformazione ecologica e sociale della società attraverso l’esperienza diretta. «Se in tanti cambiamo qualcosa, possiamo cambiare tanto».
Oggi esistono campi integrativi che prestano particolare attenzione ai portatori di handicap e campi dedicati ad adolescenti in difficoltà. Soprattutto attraverso le scuole e altre collaborazioni istituzionali, ma anche grazie al lavoro con aziende, si riescono a coinvolgere volontari provenienti da contesti diversi rispetto all’utenza tradizionale: il tedesco bianco laureato con una predisposizione all’ambientalismo.
Oltre al lavoro pratico, il nostro gruppo nella Foresta Nera è animato dalla voglia di conoscersi e scambiarsi idee – un ottimo ingrediente per le serate in cui non mancheranno né cibo né bevande, come accadrà in tutte le serate successive.
Un’altra costante che ci accompagnerà durante la settimana nella Foresta Nera sarà la pioggia e il freddo: la temperatura media non supererà mai i tre gradi. Ma siamo in Germania; non esiste il clima sbagliato, solo vestiti inadeguati. Non so se fossi l’unico a pensare che lavorare nel bosco con questo clima fosse impossibile, ma nessuno ha opposto resistenza all’invito di Paoline a salire sui bus alle sette del mattino per iniziare la nostra prima giornata di lavoro.
Arrivati a destinazione, ci mettiamo stivali e giacche da pioggia, portando con noi motoseghe, attrezzi, secchi e caschi. L’attrezzatura del Bergwaldprojekt, come ho imparato nel corso degli anni, non ha nulla da invidiare a quella dei professionisti del settore. Ogni volontario impara sul posto come utilizzare ma anche come prendersi cura del materiale di lavoro; anche questa è una




lezione su come gestire al meglio le risorse a nostra disposizione. L’unica cosa che manca sono i grandi macchinari: qui si lavora a mano, in zone sensibili dove l’uso di attrezzature pesanti potrebbe causare più danni che benefici.
Nel nostro caso, il compito consiste nella costruzione di barriere contro l’erosione in un canale formatosi nel bosco sotto la stazione di una funivia. In montagna, ogni strada tagliata nelle pendici e ogni casa costruita hanno un impatto sulla stabilità del terreno. Paoline è l’unica persona del gruppo con la patente e l’esperienza necessaria per utilizzare la motosega nel bosco. Spetta a lei scegliere e tagliare gli alberi, che poi scortecciamo noi stessi sul posto prima di utilizzarli per costruire potenti casseri con i tronchetti tagliati su misura. Ci ispiriamo al lavoro iniziato nello stesso luogo un anno prima. I progetti del Bergwaldprojekt, o più in generale i lavori nel bosco, spesso durano più di un anno: si valuta l’operato precedente, si impara dagli errori e si apportano le necessarie correzioni.
Il committente di questo lavoro è la forestale comunale di Friburgo, proprietaria del bosco. Il Bergwaldprojekt opera esclusivamente su terreni pubblici e su richiesta di enti pubblici. A



Friburgo collabora da molti anni, costruendo un rapporto di reciproca fiducia e stima grazie alla qualità del lavoro svolto. L’esperienza dimostra che la qualità del lavoro svolto da volontari guidati da esperti è eccellente. Ad esempio, la cura con cui un volontario pianta un albero fa sì che la percentuale di alberi che attecchiscono e superano i primi anni di vita sia superiore a quella degli stessi lavori eseguiti da professionisti del settore, che piantano quotidianamente.
Alluvioni e siccità
La nostra settimana sotto la pioggia sarebbe stata sicuramente un’ottima occasione per piantare alberi, ma anche per osservare dal vivo se il nostro lavoro contro l’erosione funziona. Mentre da anni la pratica di piantare alberi ha conquistato un posto fisso nell’immaginario collettivo della lotta al cambiamento climatico, il lavoro di contrasto al deflusso dell’acqua dalla montagna è molto meno noto. In realtà, il compito rimane sempre lo stesso: favorire la naturale capacità degli ecosistemi di regolare il flusso dell’acqua. Dobbiamo aiutare
a rallentare l’acqua, trattenerla e rilasciarla gradualmente, in modo da prevenire inondazioni iniziali e siccità successive.
Importante sapere che l’aumento delle inondazioni e delle siccità che stiamo osservando negli ultimi anni, in Germania, Italia e in molte altre parti del mondo, ha due cause principali. Da un lato, con l’aumento delle temperature globali, i jet stream – i venti costanti provenienti da ovest – si sono notevolmente affievoliti. Le


aree di alta e bassa pressione si spostano molto più lentamente, creando condizioni climatiche più stabili e durature: a volte ci sono forti piogge, altre volte periodi prolungati di siccità. Quando piove, lo fa abbondantemente; quando c’è secco, rimane tale a lungo.
A questa situazione si aggiunge il fatto che abbiamo ridotto la capacità della natura di mitigare questi fenomeni. Attraverso bonifiche, canalizzazioni e impermeabilizzazione del terreno, portiamo rapidamente l’acqua fuori dagli ecosistemi naturali verso valle, in direzione dei fiumi, dove
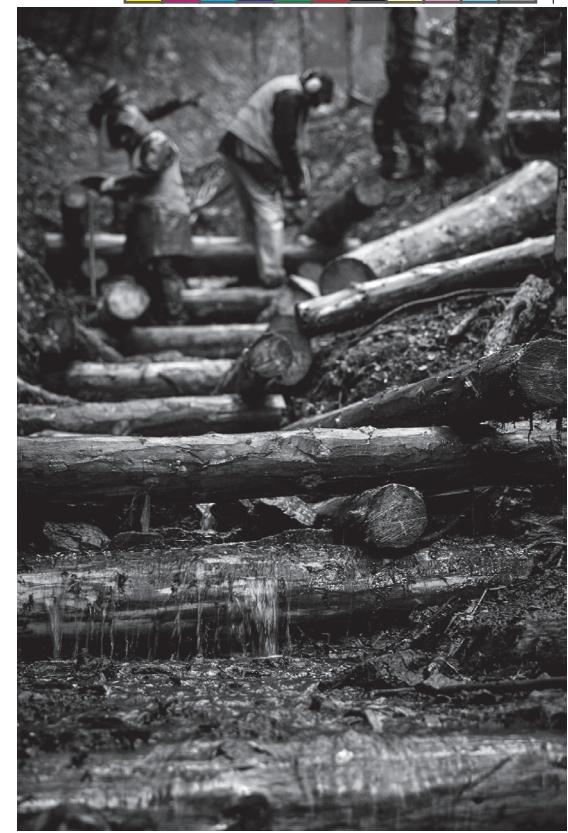
dopo un breve momento di «eccesso» essa scompare nel mare.
La Germania ha vissuto tra il 2018 e il 2022 un periodo di estrema siccità in quattro dei cinque anni, una situazione alla quale gli alberi delle foreste tedesche non sono riusciti a resistere. Attualmente, l'80% degli alberi è gravemente danneggiato e oltre il 5%, corrispondente ad oltre 700.000 ettari di bosco, è morto. I primi a soffrire sono stati i boschi meno naturali, come le monoculture di abete rosso, un albero originario della Scandinavia che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato piantato al posto delle foreste di faggi e querce, che sarebbero la naturale vegetazione in quasi tutto il paese.
Durante il nostro ultimo giorno sopra Friburgo, abbiamo avuto la fortuna che il capo forestale ci mostrasse le zone più belle del suo bosco, dove si trovano anche faggeti con un’età che supera i 200 anni. Ci vorrà del tempo prima che si possa rivedere un bosco così sano e resistente in tutta la Germania.


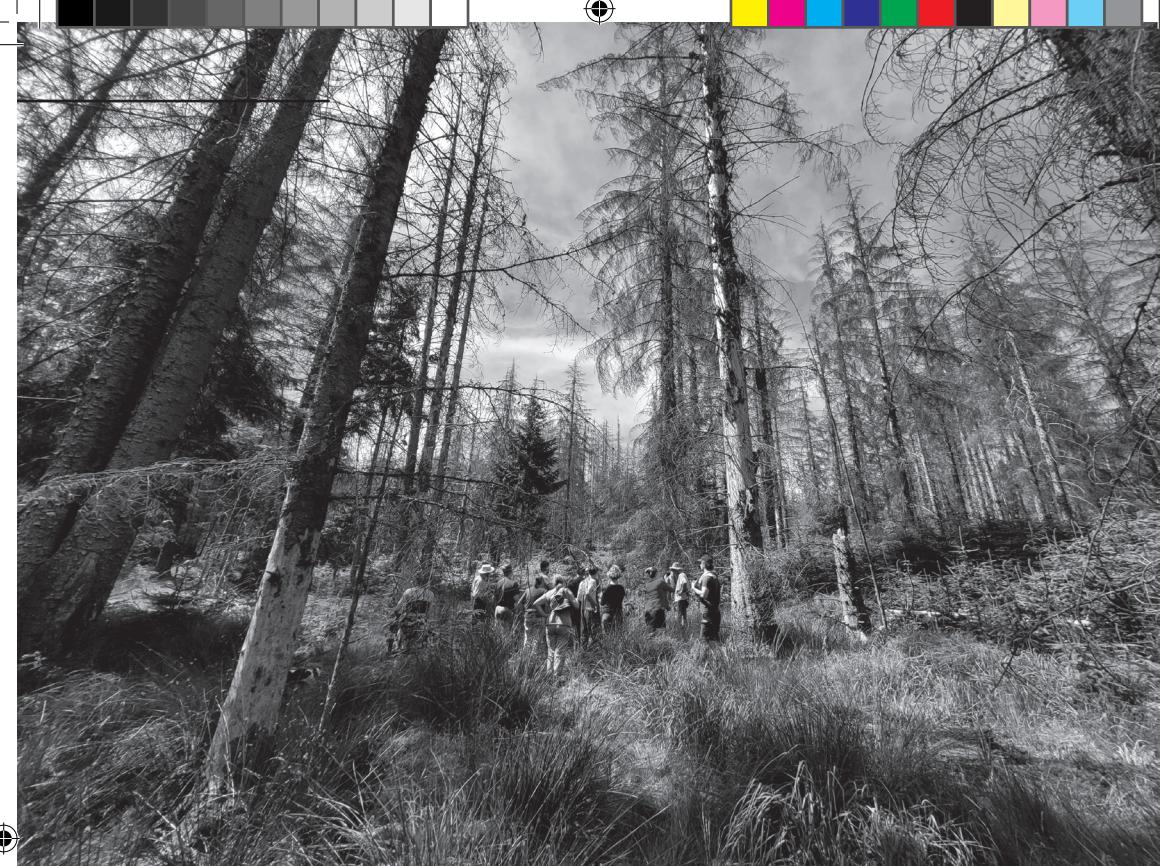
Una settimana di giugno nella brughiera
Ancora una volta Bergwaldprojekt, in azione per il ripristino di ecosistemi compromessi. Oltre al lavoro nei boschi, l’associazione si sta dedicando intensamente al recupero di un altro ecosistema: la brughiera. Questo ecosistema è tipicamente diffuso nei climi freddi ed è caratterizzato da un terreno completamente saturo d’acqua, dove vivono piante altamente specializzate che svolgono un ruolo fondamentale nel contrastare il cambiamento climatico.
Una torbiera sana ha la capacità di estrarre continuamente CO2 dall’atmosfera e di depositarla sotto forma di torba. Gli strati di torba accumulati nel corso dei secoli possono raggiungere spessori di diversi metri. Ciò che sorprende e che è noto solo a pochi è che le torbiere del mondo, che coprono insieme non più del

3% della superficie terrestre, contengono il doppio del carbonio presente in tutte le foreste del pianeta messe insieme. Tuttavia, il problema è che solo una brughiera sana e satura d’acqua riesce ad accumulare CO2. Non appena la torba entra in contatto con l’aria, questo processo si inverte: la torba si decompone e rilascia CO2 nell’atmosfera.
In Europa centrale, a causa delle bonifiche delle brughiere, che sono state trasformate in pascoli, e dello sfruttamento della torba come combustibile o per il giardinaggio, l'80% delle brughiere oggi emette CO2 anziché accumularla. In Germania, le torbiere bonificate sono responsabili ogni anno del 7% delle emissioni nazionali di CO2, un valore superiore a quello del traffico aereo! Questo rappresenta un enorme problema, ma anche un grande potenziale di intervento per il clima.
Alcune di queste aree sono sicuramente difficilmente recuperabili, poiché i terreni sono stati trasformati in terreni agricoli da agricoltori che desiderano continuare a produrre. Stanno nascendo solo in questi ultimi anni dei progetti sperimentali per un utilizzo agricolo delle brughiere, introducendo per esempio l’allevamento di bufali d’acqua o la raccolta di canne da palude particolarmente adatte alla produzione di materiali isolanti. Il lavoro del Bergwaldprojekt si concentra su terreni che non sono coinvolti in questi conflitti d’uso: spesso si tratta di aree circondate da boschi, che sono state bonificate e poi abbandonate, ma che continuano a perdere acqua e quindi emettono CO2.
Un esempio è lo Hunsrück (catena montuosa), situato tra la Mosella e il Lussemburgo, dove abbiamo lavorato con una quindicina di volontari. Il cuoco del gruppo è un parrucchiere che scambia il suo salone con un furgone per seguire i campi del Bergwaldprojekt per circa venti settimane all’anno.
La sua cucina è rigorosamente vegana, con un’unica eccezione: un taglio di selvaggina per i non vegetariani. Ma questa è un’altra storia, una delle tante che si raccontano durante le lunghe serate trascorse insieme.



In questo progetto, invece di trovarci immersi nel bosco, ci troviamo nel fango di un vecchio canale di drenaggio che attraversa una brughiera di circa due ettari. Il nostro compito consiste nel chiudere il canale. Per farlo, abbiamo bisogno degli attrezzi giusti: una motosega, diverse assi di legno, grossi martelli e molte pale e carriole per trasportare una montagna di segatura mista a cippato di legno.
La tecnica sviluppata dal Bergwaldprojekt, basata su anni di esperienza, prevede la creazione di una barriera di legno per chiudere il canale di drenaggio. Fondamentale riempire tutto il canale con quella miscela di segatura che, nella sua struttura naturale, assomiglia alla torba, fino a coprire completamente la barriera di legno. Quest’ultima non deve assolutamente entrare in contatto con l’aria; altrimenti si decomporrà col tempo e riaprirà il vecchio canale. Alla fine, il tutto viene ricoperto con le tipiche piante della brughiera.
Ci divertiamo molto e ridiamo parecchio. Per chi ama ingegnarsi con legno e attrezzi, sentire gli elementi e immergere mani e piedi nel fango, oltre a percepire la fatica nei muscoli alla sera, questo progetto è un vero paradiso. La soddisfazione è immediata: mentre in molti lavori forestali i risultati si vedono solo dopo anni, la chiusura di un canale di drenaggio offre risultati visibili fin da subito. L’acqua si ferma e viene trattenuta dall’effetto spugna della segatura, che viene poi coperta da piante prelevate dalla brughiera stessa.
Di fronte alla crisi ambientale, non siamo semplici spettatori di eventi che ci piovono addosso senza poter fare nulla. In alcuni casi, possiamo fare la differenza attivandoci. Credo che uno degli aspetti più significativi della partecipazione al progetto sia proprio questo: uscire dal fatalismo, avere una visione realistica di ciò che ci attende nei prossimi anni e valutare cosa possiamo fare ora per contribuire al cambiamento. Agire. Non con un clic, un «mi piace», una donazione e via, ma attraverso azioni concrete nella natura, nel mondo reale, con le mani nella terra, anche se non è la nostra professione.



Il cambiamento climatico causato dall’uomo è una realtà. Più aspettiamo a fermare le emissioni di gas serra, più devastanti saranno le sfide che ci attendono. Tuttavia, esiste quasi sempre anche una componente umana legata al modo in cui gestiamo l’uso del suolo. È qui che possiamo comprendere le nostre possibilità di intervento. Il lavoro manuale di gruppo apre le persone e crea fiducia, permettendo di parlare sia della situazione globale sia delle esperienze personali. Sullo sfondo delle attività quotidiane non scivoliamo mai nella disperazione; si discute di scelte vegane e della necessità di una caccia consapevole per garantire al bosco una rigenerazione naturale. Questi argomenti possono sembrare in conflitto, ma coesistono quando c’è spazio per ascoltarsi.
Chi partecipa a un progetto del Bergwaldprojekt per piantare alberi può trovarsi a dover considerare anche la necessità di abbattere alberi per aumentare la biodiversità. Confrontandosi con la realtà, le soluzioni diventano meno nette e ideologiche; si impara a mettere in discussione vecchie certezze e si comprende che ogni situazione concreta è unica e va valutata singolarmente. Fondamentale agire con consapevolezza e coscienza.



Alcune informazioni sull’organizzazione
L’associazione gestisce attualmente un budget annuale di circa 4 milioni di euro. La gestione operativa è affidata a un direttivo, eletto dall’assemblea dei soci votanti, composto da un massimo di 25 membri. Questo gruppo è formato da operatori esperti nei vari settori e l’ingresso avviene esclusivamente su proposta di adesione da parte del gruppo stesso. Questa scelta è stata adottata per proteggere l’associazione da possibili acquisizioni ostili attraverso l’assemblea dei soci.
Oltre ai soci votanti, esiste un ampio numero di soci sostenitori.
Il lavoro del direttivo è supportato e indirizzato da un consiglio di esperti scientifici di diversa natura e supervisionato da un organo di controllo. Oltre alle attività sul campo, il Bergwaldprojekt fa parte dell’Alleanza per il clima, una rete di associazioni tedesche che opera a livello politico come lobby per la natura e il clima, proponendo nuove leggi.
È possibile partecipare ai progetti del Bergwaldprojekt gratuitamente: si offre lavoro in cambio di vitto e alloggio. Solo il viaggio di andata e ritorno deve essere sostenuto autonomamente. Per ulteriori informazioni: www. bergwaldprojekt.de



La filosofia e il carcere. Esperienze e riflessioni con molto tempo e poco spazio a disposizione.
Pierpaolo Casarin
Premessa
Prima di ogni descrizione di esperienze così implicanti e considerevoli realizzate all’interno dei sistemi penitenziari vorrei condividere una perplessità, un dubbio. Un movimento forse ingenuo che intende interrogare il concetto di carcere in generale e il nostro rapporto con la visione di mondo che tale istituzione totale porta con sé in particolare. Immagino che nella mente e nel cuore di ogni anarchico, di ogni libertario, di ogni soggetto con un briciolo di umanità, innanzi a un sistema che per definizione privi la libertà ad altri uomini e donne, si facciano avanti diverse tensioni e diverse reazioni. C’è chi pensa che la cosa migliore da fare sia allontanarsi nel modo più netto dal problema, dal fenomeno, da tale luogo. Non solo sperare di non averci a che fare in quanto soggetti potenzialmente incarcerabili (inutile che sia io qui in questa rivista a ricordare quanti episodi incredibili in questo senso vi siano da raccontare), ma anche e soprattutto come cittadini che non intendono, con la loro azione e i loro pensieri fornire conforto ed energia a un sistema che in ultima istanza privi, a prescindere dall’azione commessa, altri soggetti



del bene forse più prezioso ovvero della libertà. Chiudere qualcuno in una cella dove ci sono sbarre e poco spazio a disposizione, dove tutto sembra disumano non può e non deve essere ritenuto qualcosa a cui abituarsi, qualcosa su cui non riflettere radicalmente. Detto ciò, forse premessa necessaria e non certo capace di dipanare la matassa, sono a mettere in luce qualcosa di implicante che dentro le mura del carcere è avvenuto tanto tempo fa e anche e soprattutto che sta avvenendo ora, in modo ben più definito e strutturato. Qualcosa che ha a che fare proprio con la filosofia. Troviamo conforto nelle celeberrime righe conclusive de Le Città invisibili di Calvino quando Polo indica una strada possibile. Percorso impervio, faticoso, impegnativo ovvero riconoscere nell’inferno ciò che inferno non è. Anche nel carcere si tratta di provare a individuare ciò che, pur fra le sbarre, in celle poco ridotte, carcere non è. Vale davvero la pena leggere e rileggere le righe quasi come un esercizio, una pratica mobilitante e al tempo stesso autoeducante:
«L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto da non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e sapere riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio»1 .


1 Italo Calvino, Le città invisibili, Mondadori, Milano 2002, p.164.

La filosofia all’Istituto Penale per minori Beccaria di Milano
Iniziamo con alcuni accenni riferiti a un progetto che ho avuto la possibilità di realizzare presso l’Istituto penale per minori Cesare Beccaria di Milano. Stiamo parlando di oltre vent’anni fa e mi permetto di riportare questa esperienza, che mi vedeva coinvolto direttamente come operatore, soprattutto perché rappresentava il primo intervento educativo presso la struttura penitenziaria per minori di Milano caratterizzato da un approccio filosofico. C’era allora e ancora oggi c’è chi ritiene che la filosofia si possa incontrare solo in determinati e definiti contesti: scuole superiori dove risulta essere presente come materia di studio, nei licei con due o tre ore settimanali negli ultimi tre anni e naturalmente nelle Università. Ecco le residenze abituali della filosofia, luoghi rispettabili, raccomandabili, seri. C’era allora e c’è ancora chi sfida questa convinzione che ruota intorno all’esclusività di questi luoghi come unici territori della divulgazione del sapere filosofico, immaginando una pluralità di spazi disponibili alla condivisione dell’esperienza filosofica. Ecco che divengono possibili ulteriori contesti per pensare insieme, luoghi estremi, come le carceri appunto. Con questa visione parlavamo di «estremismo filosofico» quando avevamo realizzato quella esperienza, quasi una provocazione, una sfida coraggiosa di cui avevo avuto modo di lasciare traccia in un contributo per la rivista FilosoFare2 e di cui qui andiamo a ripercorrere alcuni passaggi. Ricordo che in quelle circostanze avevamo pochi alleati, molta freddezza. Per fortuna qualche amico. Dalle pagine del portale di Filosofia Fuori Le Mura ricavammo un prezioso incoraggiamento: «Semmai la filosofia sia stata un privilegio è il momento che diventi un diritto, quello per ognuno di potersi chiedere del senso del proprio esistere e vivere, delle proprie scelte e azioni. Sarà come il diritto di un privilegio necessario. Se poi


2 Pierpaolo Casarin, Estremismo filosofico: l’esperienza nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, in Alessandro Volpone (a cura di), FilosoFare. Cura e orientamento al valore, «Quaderni di pratica filosofia», n. 2, Liguori editore, Napoli 2009, pp. 147-162.

la filosofia si occupa di questioni ultime ed estreme è sui luoghi estremi e ultimi che deve essere portata per sentire se ha qualcosa da dire o se non debba essere invece abbandonata come un giocattolo rotto. E’ il momento in cui l’autodisciplina degli studi si apra alle vicissitudini»3 . Negli scritti di Giuseppe Ferraro ulteriori stimoli: «lo spazio della filosofia in carcere è educativo, etico. Il fine è dar luogo ad una comunità dialogica, non per rifare la storia della filosofia, ma per passarsi la parola lungo un cammino di ricerca»4 . Le attività presso l’Istituto penale per minori di Milano, in realtà, non erano iniziate con l’idea di sviluppare un percorso di natura filosofica. Il progetto pensato e realizzato dal circolo Gattonero-Gattobianco dell’associazione Arciragazzi5 , nella sua fase iniziale, attorno al 2001, intendeva coinvolgere i giovani detenuti all’esterno della struttura, evidentemente nei momenti di permesso concessi dal magistrato, con l’obiettivo di condividere esperienze significative di socializzazione. Venivano organizzate escursioni, attività ludiche, attività laboratoriali di natura artistica e creativa6 . In buona sostanza si pensava di far incontrare i giovani detenuti,
avvicinamento al teatro con la supervisione del regista Renato Sarti. Attività legate allo sviluppo delle competenze informatiche sono state suggerite e sviluppate con
grande abilità da Antonella Eberlin.


3 Il portale Filosofia Fuori Le Mura mira ad una pratica di dislocazione della filosofia nelle scuole, per le strade, tra i giovani, nei centri di accoglienza, nelle carceri, negli ospedali. (www.filosofiafuorilemuta.it).
4 Giuseppe Ferraro, L’innocenza della verità, Filema Editore, Napoli 2008, p. 26.
5 Arciragazzi è un’associazione educativa nazionale fondata da Carlo Paglierini nel 1981 con l’obiettivo di valorizzare e consolidare il protagonismo sociale dei ragazzi e delle ragazze. Ha sedi in molte regioni italiane con diversi circoli e diecimila soci. Arciragazzi comitato milanese opera sul territorio dal 1983 e da allora ha attivato una significativa rete di relazioni con il sistema dei servizi socio-educativi e del tempo libero. L’associazione Arciragazzi, in virtù dell’impegno e delle attività dei suoi circoli è da sempre attiva come ente del terzo settore alla costruzione di un nuovo sistema di protezione sociale, con particolare attenzione alle forme di prevenzione e di contrasto del disagio giovanile e dell’emarginazione sociale, e più in generale alla promozione dei diritti dei ragazzi. A partire dalla primavera 2001 Arciragazzi promuove e sviluppa in modo continuativo, utilizzando finanziamenti pubblici e privati, progetti rivolti ai giovani detenuti presso l’IPM Cesare Beccaria. 6 Presso il circolo Arciragazzi Il Cerchio di Via Rovetta a Milano, è stato possibile realizzare un murales grazie alla preziosa collaborazione della maestra di arte Margarita Clement. Presso il Teatro della Cooperativa è stato promosso un


spesso provenienti da culture diverse, con gli abituali frequentatori dei circoli Arciragazzi al fine di creare momenti di confronto e di scambio. L’idea di fondo era quella di permettere, facilitare relazioni fra coetanei. Non solo, si cercava uno sguardo diverso sulla città e sul modo con il quale era stata fin a quel punto abitata, con l’intenzione di scoprire nuove possibilità, valorizzare i talenti non del tutto espressi, mettere in gioco i desideri, in qualche modo evadere (termine rischioso dato il contesto di cui parliamo) da certi stereotipi. Tutto questo lavoro avveniva all’esterno della struttura e solo raramente il gruppo di educatori, anzi sedicenti educatori, del progetto in questione (chi vi scrive, Emilia Covello, Stefano Fascioli, Antonio Monzeglio, Umberto Grigolini) entrava dentro le mura della struttura per trascorrere del tempo con i ragazzi e le ragazze. Scriviamo sedicenti educatori perché in realtà nessuno dei soggetti sopra nominati possedeva il titolo di educatore. Tutti laureati in filosofia con l’eccezione di Antonio Monzeglio, laureato in scienze politiche. Rimane il dato che alcuni interventi di rilievo educativo venissero svolti da soggetti non precisamente definibili educatori, ma da uomini e donne che, evidentemente, desideravano sviluppare un percorso, avere una prossimità con certe realtà. Potremmo anche dire che in carcere prima della filosofia entra-



rono i laureati e le laureate in filosofia. A partire dal 2005, in conseguenza di alcuni episodi7 avvenuti sia all’interno sia all’esterno della struttura carceraria il magistrato ha negato la possibilità a molti giovani detenuti di partecipare a progetti che trovavano sviluppo all’esterno delle mura. Ci siamo trovati costretti a ripensare le linee del nostro intervento. Che fare? Soprattutto, che pensare? La risposta fu proprio nella direzione del pensare. Provare a pensare insieme ai ragazzi. Lavorammo ispirati dalla proposta di Lipman, dal movimento educativo della philosophy for children8 . Del resto non potevamo più uscire dalla struttura, non si poteva più andare in montagna, realizzare attività laboratoriali nei centri sociali della città, frequentare il Teatro della Cooperativa di Niguarda. Non rimaneva che condividere, con i giovani ospiti del Carcere minorile milanese, due antiche categorie filosofiche ossia il tempo (parecchio) e lo spazio (ristretto). L’esperienza del Beccaria, ripensandola a distanza di diversi anni, mostra entusiasmo e forse anche una certa dose di improvvisazione tuttavia rimane un percorso di particolare valore anche in termini di autoformazione per chi vi scrive e per chi ha avuto la possibilità di viverla.
8 Cfr.: Matthew Lipman, Il prisma dei perché, Liguori editore, Napoli, 2004.
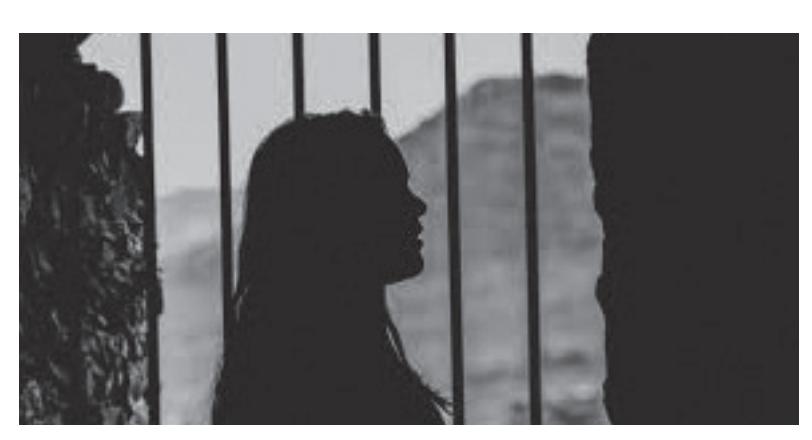


7 Tensioni all’interno della struttura e un’evasione di un detenuto nel corso di un’attività esterna.

Progetto Carcere. Università degli studi di Milano
Di tutt’altro rilievo, per quantità e qualità, l’esperienza progettata e realizzata dall’Università degli studi di Milano nel corso degli ultimi anni. Ne descriveremo alcuni aspetti anche e soprattutto grazie ad alcune riflessioni che ho avuto il piacere di condividere con Stefano Simonetta, Lucrezia Sperolini, Lucia Manzoni e Giada Collauto, rispettivamente professore e coordinatore dell’intero progetto, Phd student all’Università di Westminster e studentesse di Filosofia e Beni culturali dell’Università di Milano. Il loro contributo è risultato davvero prezioso9 e mi ha permesso di raggiungere una, mi auguro sufficiente, consapevolezza intorno alla fisionomia di tale esperienza.
Un progetto che dalla sua nascita, nel 2015/2016, grazie appunto all’iniziativa di Stefano Simonetta, professore di storia della filosofia medioevale e prorettore delegato ai Servizi agli studenti e al diritto allo studio, ha saputo coinvolgere duecentocinquanta studenti. L’università milanese svolge, dal 2016 per ogni anno accademico, all’interno delle case di reclusione di Opera e Bollate, dei moduli didattici che prevedono la partecipazione congiunta di studenti e studentesse dall’esterno e di persone ristrette. I moduli e i laboratori rappresentano non solo una fondamentale occasione di studio e approfondimento per i soggetti in condizione di detenzione, che non possono seguire le lezioni universitarie all’esterno, ma forniscono anche un’opportunità arricchente sul piano umano, culturale e personale per studenti e studentesse che sono chiamati


9 Il lavoro di ricerca di Lucrezia Sperolini trova ulteriore articolazione in un contributo che ha trovato spazio nel numero 14 del 2023 della rivista Open Access di filosofia e cultura Nóema diretta da Rossella Fabbrichesi, professoressa di Filosofia teoretica del Dipartimento di Filosofia. Le riflessioni di Stefano Simonetta provengono sia da colloqui informali che ho avuto il piacere di condividere con lui sia da alcuni passaggi dell’intervista che Simonetta ha rilasciato a Ornella Sgroi nel fascicolo del Corriere della Sera del 4 febbraio 2025 dedicato all’Università di Milano in occasione dei suoi cento anni. Con Lucia Manzoni e Giada Collauto ho avuto modo di instaurare delle conversazioni informali e poi ho chiesto loro una breve riflessione scritta che ho riportato integralmente.

in causa nel progetto. Stefano Simonetta sottolinea il fatto che tale progettualità abbia reso possibile l’iscrizione gratuita all’Università per i soggetti in esecuzione penale interna o esterna fino al conseguimento della laurea anche oltre il momento della conclusione della pena. Si tratta di una modalità finalizzata al mantenimento dell’interesse per lo studio anche una volta concluso il periodo di detenzione. Inizialmente molti detenuti sembrano iscriversi per avere qualche attività da svolgere in carcere, attenuando così la fatica della condizione a cui sono sottoposti, strada facendo la situazione sembra cambiare e prevale la passione e l’interesse reale per lo studio che viene proseguito anche all’esterno della struttura penitenziaria una volta conclusa la pena. A motivare ulteriormente è il fatto, prosegue Simonetta, che i docenti dell’Università
vanno in carcere a fare lezione per offrire agli «studenti ristretti» l’esperienza dell’aula, promuovendo classi miste con iscritti esterni liberi che scelgono questi corsi. Al centro del progetto si colloca la rete dei tutor costituita da 220 figure. Studenti universitari che, con cadenza settimanale, si recano in carcere per studiare insieme a studenti ristretti dello stesso corso di laurea, o di corsi affini, scegliendo insieme gli esami, portando loro i libri e i materiali necessari e creando le condizioni per un confronto continuo. Ogni
detenuto può condividere il percorso di studi insieme a un tutor. Si tratta di un’esperienza molto importante che non solo favorisce lo studio, ma permette a tutte le figure coinvolte nell’attività di vivere una dimensione relazionale molto significativa. La posta in gioco del progetto è certamente, conclude Stefano Simonetta, la possibilità per i soggetti detenuti di comprendere la potenzialità trasformatrice ed emancipatrice dello studio e della ricerca.



Ci pare interessante leggere alcune testimonianze dei soggetti in gioco. Prima le parole di un detenuto e poi quelle di due tutor, Lucia Manzoni e Giada Collauto. Da un passaggio della lettera personale di L. gentilmente trasmessa da Lucrezia Sperolini:
Pochi sanno che gli studenti “interni” hanno molte restrizioni e limitazioni che si traducono in difficoltà aggiuntive nello studio in generale. A volte difficoltà facilmente superabili, a volte difficoltà che scoraggiano il proseguo degli studi. I tutor giocano un ruolo importante in tutto questo e non parlo solo del portare i libri allo studente, aiutarlo a prepararsi e fare le prove d’esame. A volte subiscono anche loro queste difficoltà e limitazioni e solo una ferrea pazienza e un credo illimitato nella missione che svolgono può dargli forza e convinzione nel proseguire. Spesso, dinnanzi all’impotenza del loro assistito detenuto, sono loro stessi che si adoperano per abbattere/affievolire queste difficoltà aggiuntive per ottimizzare il tempo a loro disposizione e migliorarne il luogo e il percorso di studio, facendosi portavoce delle problematiche, da illustratori, da mediatori e da risolutori laddove possibile. Altre volte il contesto e la condizione dello “studente assistito”, gli chiede anche una bontà d’animo che delinea il rapporto umano, quindi il loro sostegno supera il confine dello studio senza mai perdere di vista l’obiettivo maestro. Trovano sempre parole giuste da spendere per ravvivare e alimentare la voglia di studiare nei “loro” studenti. Sono pazienti, ascoltano, stimolano, condividono. Loro sono la prima linea anche nell’agevolare e garantire, all’interno del carcere, il sacrosanto diritto all’istruzione dei detenuti. In un luogo “sterile” in fatto di interazioni e scambi culturali, loro se ne fanno portatori e stimolatori.
Ecco le riflessioni di Lucia Manzoni, tutor del progetto e studentessa di filosofia:
Ho pensato di rileggere le lettere scritte dal mio studente A. per poter trasporre in maniera fedele quella che è stata la mia esperienza come volontaria. E ho concluso che l’unico reale motivo per cui volevo farlo era quello di dare spazio a un’esigenza documentaristica, quasi a valore di testimonianza. Di testimonianze ce n’è un gran bisogno a mio parere. Soprat-



tutto in realtà che vengono costantemente rimosse dal nostro vivere quotidiano. Tuttavia non credo che sarebbe la cosa più giusta da fare. Per quello che concerne me, infatti, devo dire, che ciò che ha avuto maggiore significato non può essere ricondotto a un prendere atto o un portare con sé come traccia indelebile. Certo, anche quello è avvenuto. Ma ora che ci penso con attenzione, mi sembra che io non abbia portato via con me nulla. Ciò che intendo dire è che non si è trattato mai di un prendere e riporre da qualche parte. La mia esperienza nel carcere di Opera è stata più simile a un “incorporare”. È come se avessi fatto esperienza di una vita che non avrei mai visto altrimenti. Non nel senso che l’ho vissuta. Quello no, non accade. Ma nel senso che l’ho attraversata, l’ho incontrata, qualche volta respinta, non sempre capita. Però mi è arrivata direttamente incontro, senza fingersi diversa. E io, in maniera un po’ goffa, ho cercato di essere pronta a dialogare con lei. È davvero difficile dire cosa di quella vita abbia filtrato o se io abbia filtrato qualcosa. Mi ricordo distintamente le sorprese che conoscere questa vita ha portato con me tra cui la profonda sensibilità e intelligenza di chi l’aveva subita. Non solo questo. Anche il calore, l’apertura la curiosità disinteressata, nonostante la consapevolezza che io sarei stata solo di passaggio. Che cosa porta con sé tutto questo? Nulla perché è l’“in sé” dell’entrare in una vita completamente ignota e estranea che permette un’acquisizione non circoscrivibile. Ho in me il segno di ore senza tempo passate in un luogo dimenticato in cui, eppure, c’è tanta vita che vuole vivere. E spero che, nell’incontro costante con essa, ci saranno più corpi attraversati e meno vite che assumono l’arduo compito di essere anche testimonianza. Una testimonianza fatta di vivida sofferenza e speranza sempre più evanescente.
Alcune riflessioni di Giada Collauto, studentessa di Beni culturali sempre impegnata come tutor nel progetto:
La mia esperienza presso il carcere - casa circondariale - di Bollate è durata cinque anni, dal 2019 al 2024. Ho seguito tre studenti, due dei quali hanno abbandonato lo studio, cosa che inizialmente ho vissuto quasi come una sconfitta personale. In base a ciò che ho visto e le soggettività con cui sono entrata in contatto, direi che la scelta di iscriversi ad un cor-



so di laurea quando si hanno attorno mura carcerarie non è dovuta a possibili opportunità lavorative una volta fuori, ma più alla voglia di ri-scoprirsi umani, appassionati di qualcosa. Questo è tanto più vero se consideriamo che molti studenti hanno davanti ancora tanti anni di reclusione, e alcuni dei corsi di laurea più frequentati siano quelli afferenti a studi umanistici. È il caso di tutti e tre gli studenti che ho seguito, che hanno scelto l’indirizzo di Beni Culturali perché volevano approfondire e riscoprire l’interesse per la storia, la letteratura e le arti figurative che magari avevano in gioventù. Ho visto questi ragazzi mossi da curiosità. Non c’è un fine “utile” in questo senso, ma l’aver frequentato un corso di laurea ti dà la possibilità di essere visto in modo diverso una volta fuori. Quel che ho visto più di tutto è stato il desiderio di confronto con l’esterno, la volontà di farsi conoscere al di là del reato commesso, e di dimostrarlo a noi tutor e a sé stessi. Iscriversi all’università in carcere è anche un modo per passare il tempo, è innegabile: tante volte, programmando il prossimo incontro con uno studente, questo mi ha risposto che sarei potuta venire in qualunque momento, che lui tanto non avrebbe avuto altro da fare. Ci sono state delle indubbie difficoltà, una buona parte degli studenti ha origini straniere e ha difficoltà con la lingua e la comprensione dei libri di testo. C’è chi ha conseguito il diploma superiore presso il carcere, o chi molti anni prima, e il supporto da parte del tutor è anche quello di accompagnare lo studente nell’imparare a imparare, nell’acquisizione di un metodo di studio.
Il «Progetto Carcere» rappresenta l’esito di un accordo tra l’Università degli Studi di Milano e il PRAP (Provveditorato Regionale di Amministrazione Penitenziaria) della Lombardia, al fine di garantire l’esigibilità del diritto allo studio universitario all’interno delle carceri lombarde indicate come poli universitari penitenziari. Il diritto allo studio è mantenuto dalle persone che si trovano in una condizione di privazione della libertà e, scrive Lucrezia Sperolini, «dovrebbe essere tutelato dall’art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario, che, nel comma 1, lo considera tra i principali strumenti di cui deve avvalersi il trattamento del condannato, con l’obiettivo di agevolarne gli opportuni contatti



con il mondo esterno»10. Alla luce di questa situazione Lucrezia Sperolini mette in evidenza il significato profondo del compito di portare l’Università, intesa come istituzione ma anche come comunità di ricerca, all’interno delle carceri. Mi colpisce molto questa modo di intendere l’Università come comunità di ricerca, uno sguardo promettente. Il concetto di comunità di ricerca11 risulta essere centrale nella proposta della Philosophy for children di Lipman e Sharp, ereditato dal pensiero di Peirce e Dewey. Ricerca e comunità portano con sé istanze autocritiche e dimensioni pratiche. La comunità di ricerca non va intesa come processo fine a sé stesso, ma si mostra con un obiettivo da raggiungere, si tratta di un processo che si spinge fin dove conduce l’argomentazione. Lo scopo potrebbe essere il raggiungimento di sensibilità e consapevolezze critiche e autocritiche. Di rilievo nella visione della Philosophy for children-community proposta da Lipman risulta essere il pensiero caring. Una particolare cura attribuita sia al contenuto sia al processo di processo condiviso. La cura alle modalità di questo processo risulta essere ciò che permette la creazione di un clima fertile, di una sensibilità spiccata che permette di generare apprendimento e legami virtuosi. Anche in carcere. Elemento di grande rilevanza risulta essere quello di rendere possibile la fruibilità di un diritto. In questa prospettiva Lucrezia Sperolini ci suggerisce alcune riflessioni di Luca Decembrotto dove si sottolinea quanto le opportunità di formazione universitaria «fornite in modo continuativo, accessibili, flessibili, garantite allo stesso livello di qualità di quelle offerte all’esterno, abbiano il loro fondamento nella democratizzazione, nell’uguaglianza e nell’inclusione»12. Se si riconosce e valorizza il ruolo


10 Lucrezia Sperolini, La formazione filosofica come pratica di soggettivazione nel contesto penitenziario. Una riflessione attraverso Foucault, in «Rivista Noéma» n. 14 Anno 2023, pag. 80.
11 Cfr. Pierpaolo Casarin, Philosophy for children: tempi e spazi in divenire, in Propositi di filosofia 1, Pierpaolo Casarin, Silvia Bevilacqua (a cura di), Mimesis edizioni, Milano-Udine 2021.
12 Cfr. L. Decembrotto, Educazione, carcere e diritti, in Università e carcere. Il diritto allo studio tra vincoli e progettualità, in L. Decembrotto - V. Friso (a cura di), Guerini e Associati, Milano 2019, p, 79.

dell’istruzione e dell’Università come possibili strumenti di lotta all’esclusione sociale di alcuni soggetti, non si può non sottolineare il valore etico e politico di un’idea di conoscenza come esperienza sociale, «attraverso cui sviluppare, oltre l’apprendimento delle nozioni, la possibilità di sperimentarsi e sperimentare la stessa collettività in senso liberante, democratico e tollerante»13, favorendo, tempi di confronto di segno opposto rispetto a quelli solitamente sperimentati in carcere. In questo modo, aggiunge Lucrezia Sperolini, «la presenza delle Università e degli studenti all’interno delle carceri diventa l’occasione per creare una dimensione collettiva di sapere che, contro le discipline normalizzanti e deresponsabilizzanti, possa portare avanti una dimensione di confronto, dialogo e riflessione critica»14. La posta in gioco sembra essere data dal riconoscersi in una comunità che avverta la necessità di trovare un equilibrio capace di determinare la possibilità di rispondere alla richiesta di sicurezza della società con l’idea che, scrive Simonetta, «la sicurezza collettiva si trovi nei diritti individuali e non nella loro contrazione»15.


13 Ivi, p.83.
14 L. Sperolini, La formazione filosofica come pratica di soggettivazione nel contesto penitenziario. Una riflessione attraverso Foucault, in «Rivista Noéma» n. 14 Anno 2023, pag. 81.
15 S. Simonetta, Raccogliere la chiave gettata via. Lezioni di filosofia entro le mura delle carceri, in In cattedra. Il docente universitario in otto autoritratti, C. Cappelletto (a cura di), Raffaello Cortina Editore, Milano 2019, p. 312.



1.
Semi sotto la neve, benissimo. Ma quali? La gramigna non vale quanto il frumento, è un’ovvietà e ciò nonostante occorre ribadirlo: ragionare proprio su quanto a noi appare scontato, ritornare ai fondamentali, evitare l’incantesimo di immagini così belle ed efficaci come l’embrione della pianta che attende sotto la fredda coltre, invisibile ma vivo. Tra le tante possibilità di semina ne suggerisco dunque una: chiarezza.
L’idea non è mia. La prendo dall’editoriale di Volontà del luglio 1948, dove si tirano le somme dei primi due anni di lavoro, mentre «il distacco tra popoli e Stati non è mai stato evidente come oggi, per chi osa guardare la verità». Erano i tempi dei blocchi contrapposti e della Guerra fredda, ma la situazione è poi tanto diversa oggi? «Tutto è malcerto», prosegue il corsivo. «E non è solo malcerto per noi, spettatori e vittime del gioco. Anche ci lo fa non sa affatto dove andrà a finire: sa solo che si batte – come una belva affamata, ma senza la scusa della fame, e in pretesa d’umano – per vincere, contro altri che anch’essi si battono per vincere e basta». Non sembra un pezzo scritto oggi?
Criticando «la facile via delle fantasie intellettuali» e facendo piazza pulita dei «problemi grandiosi», sorge una nuova con-


sapevolezza: «la bellezza non è più di palcoscenico, che basta guardarla: va cercata e creata nello stesso tempo, che è tanto più difficile, ma tanto più concreto. E solo così ci si trova alla statura vera dell’uomo, in contatto con i nostri veri problemi. Si pensa per lavorare e per amare, si lavora si ama si lotta, si costruisce». E dunque:
Vogliamo aiutare i nostri compagni di servitù, a battersi quando si battono per sé: il che include aiutarli ad orientarsi, a capire, soprattutto quando illudendosi di battersi per sé si battono in realtà contro i loro stessi fratelli, a favore dei comuni nemici, che accade assai sovente e bisogna aver coraggio di denunziarlo. Vogliamo quindi, prima di tutto, insistere nel dire la verità, rifiutando le tattiche i compromessi, vogliamo eccitare al dubbio, alla rinascita dello spirito critico, denunziando l’errore profondo dei dogmi delle tesi definitive.
L’editoriale, non firmato ma intriso tutto dello spirito di Giovanna Caleffi, chiudeva con una «duplice parola d’ordine» ben evidenziata: «Rompere barriere, seminare chiarezza» — appunto. Proviamo a sviluppare questi spunti, adattandoli allo scenario contemporaneo.
2.
Rompere barriere può significare innanzitutto aprirsi a una discussione schietta ma autentica, evitando il proverbiale dialogo fra sordi. E qui incontriamo subito una difficoltà. C’è da tempo un automatismo per cui appare sufficiente restituire il proprio vissuto come se per magia attivasse qualche cambiamento: rendendo chi ascolta più consapevole, o empatico, o disposto ad agire. Ma è troppo facile. Mi pare anzi che tale spinta continua a raccontarsi e rovesciare emozioni su chi ascolta – siano essi dieci o centomila – implichi il triste fraintendimento di una bella parola: il pubblico non è più il contraltare del privato, bensì appunto un parco di ascoltatori passivi. Un’audience.



Ci sono molte ragioni alla base di un simile narcisismo di massa e della disperazione che comporta, ma non è mio scopo affrontarle. Mi limito a osservare come i problemi sociali rischino di essere ridotti all’orizzonte dell’io: e il lessico individuale è tanto inoppugnabile quanto sterile, perché non consente di avviare una conversazione su basi comuni. Specie quando si tratta di temi dolorosi: l’ostensione retorica del trauma è la fine del dialogo, erge barriere ancora più alte fra le singole persone. Alla nuda testimonianza di un dolore o di un’esperienza si può reagire solo con la compassione, o l’indifferenza, o con un’altra testimonianza di pari grado; non è nemmeno l’inizio del lavoro che serve,
cioè dare forma e senso a questo coacervo. Anche perché sotto l’apparente democrazia delle emozioni resta comunque una disparità narrativa. Il mercato delle storie è diseguale: la testimonianza di chi è già noto troverà sempre più sponda e interesse: e in cambio di cosa, poi? Due giorni di apprezzamento superficiale, due giorni di polemiche, fine. Allora si rilancia: sempre più traumi, sempre più polemiche a seguire; del resto abbiamo un sistema giornalistico ed editoriale che corteggia
tali reazioni perché il metodo «funziona» — o così pare. Ma per funzionare la macchina necessita continuamente di benzina narrativa: e così qualsiasi argomento, da un lutto familiare a Gaza, diventa uno spunto per riscuotere dividendi sociali. Ancora una volta non si rompe alcuna barriera, al più si arruolano sostenitori o avversari irriducibili. È la logica schmittiana dell’amico/ nemico che tanto piace alla società dello spettacolo: darsele di santa ragione mentre altri plaudono o si danno di gomito o passano alla rissa successiva. Una caricatura del conflitto.
Perché il problema è quando tale pratica della testimonianza senza filtri viene rivendicata — anche con un certo orgoglio quale attività critica o politica. Se persino gli intellettuali si usano



senza pudore come prodotto indiscriminato e ultima spiaggia per contare qualcosa, allora il rischio è enorme: abdicare a una forma di responsabilità legata tradizionalmente a quel ruolo. Il privilegio della parola pubblica implica un dovere preciso, e seminare chiarezza è uno dei modi per interpretare questo dovere. In Punto di fuga di Peter Weiss, un pittore amico dell’io narrante afferma:
Un nome deve essere menzionato di continuo, […] altrimenti viene dimenticato in questa competizione incessante, in questo susseguirsi di talenti». Il tutto in un paese «dove non c’erano discussioni e prese di posizione sulle questioni estetiche, ma solo malevolenza e tacita condanna.
Ma a farne le spese è proprio il vigore dell’arte in gioco, la capacità creativa dell’amico. Nel libro di Weiss l’oggetto di questa severa critica è la Svezia dei primi anni Quaranta: nuovamente, l’Italia contemporanea appare tanto diversa? La denuncia ridotta a sfogo, la repulsione verso la prudenza e l’approfondimento a mente fredda, lo scarso senso del contesto, il vittimismo: sono gli stessi mezzi dei nostri avversari, e ogni libertario sa che mezzi dubbi corrompono anche il più nobile dei fini.
3.
Seminiamo chiarezza, invece. Diffidando innanzitutto delle affermazioni insieme perentorie e vaghe: dove la prima caratteristica darà alla prosa il vigore di chi usa le parole come magli, mentre la seconda consentirà in ogni caso di sfuggire alle obiezioni; e se qualcuno non ha inteso è colpa sua o del suo analfabetismo di ritorno. Uno stile del discorso classista ma trasversale a qualsiasi ideologia.


La chiarezza è invece cifra di dirittura etica. Non significa rimuovere la complessità di un problema, bensì affrontarla con pazienza; mostrare apertamente i propri limiti, allargare lo sguardo, avere il coraggio di esporsi. Una lingua chiara obbedisce alla medesima norma indicata da Popper per distinguere le teorie scientifiche dalla pseudo-scienza: è falsificabile. Non teme di offrirsi alle critiche perché crede nel dialogo e nel conflitto autentici — nel rompere le barriere, appunto — e si prende la briga di argomentare, poiché ha in perenne sospetto l’autorità. Non è allora un caso che autori e autrici del campo libertario abbiano sempre preferito stili nitidi: bastano cinque righe di Malatesta per rendersene conto.
Ma, proprio perché occorre rompere le barriere, è forse meglio ricorrere a un nome più universalmente apprezzato: Primo Levi. In Dello scrivere oscuro leggiamo ad esempio: «parlare al prossimo in una lingua che egli non può capire può essere malvezzo di alcuni rivoluzionari, ma non è affatto uno strumento rivoluzionario: è invece un antico artificio repressivo, noto a tutte le chiese, vizio tipico della nostra classe politica, fondamento di tutti gli imperi coloniali»; e ancora, con una nettezza che combina splendidamente stile e morale: «chi non sa comunicare, o comunica male, in un codice che è solo suo o di pochi, è infelice e spande infelicità intorno a sé. Se comunica male deliberatamente, è un malvagio, o almeno una persona scortese, perché obbliga i suoi fruitori alla fatica, all’angoscia e alla noia».
Chi detiene il privilegio della parola pubblica dovrebbe impegnarsi a seminare chiarezza affinché chiunque possa partecipare al discorso non come il fruitore di un oracolo intellettuale bensì come individuo in grado di dare un contributo. Perché a differenza dell’oscurità, del segno irriducibile e dunque non seminabile del singolo, il parlar chiaro sarà forse meno seducente; ma di certo è più generoso.



4.
Cosa dovrebbe allora fare chi oggi si pronuncia con qualche speranza di parlare a un pubblico più o meno vasto? Ecco, appunto: dovrebbe innanzitutto fare qualcosa, invece di cogliere ogni occasione di cronaca per intervenire alimentando il proprio capitale intellettuale. Altrimenti si ricade nella vecchia divisione del lavoro e nella sua versione impegnata: sporcati tu le mani mentre io mi occupo delle parole.
Non mi si fraintenda: il «populismo del fare» ha creato una nefasta diffidenza verso la riflessione critica. Ma la necessità di pensiero è divenuta anche un alibi particolarmente sgradevole, frutto in fondo di privilegio, per cui la minima mossa – dalla frasetta sagace al meditabondo editoriale retorico, passando per l’intervista indignata – è spacciata come atto di coraggio o resistenza.
Quanto diversa è invece l’esperienza di chi si impegna materialmente in un’attività di sindacalismo di base, boicottaggio, sciopero, occupazione, aiuto
umanitario, volontariato, insegnamento, gestione di un circolo o di un gruppo di acquisto solidale o di una palestra popolare e così via. Diversa perché protegge dalle indebite generalizzazioni, dalle formule che somigliano più a comodi sortilegi che a suggerimenti concreti; e perché obbliga al confronto con gli altri, dentro e fuori la realtà in cui si agisce: insegna il valore della negoziazione e del conflitto autentici. Se democrazia non è una parola vuota, è in questi casi che si realizza compiutamente.
Alla chiarezza nel parlare andrebbe dunque accostata un po’ di parsimonia; e il tempo risparmiato, investito in atti concreti. C’è un’indulgenza estrema nei confronti delle parole, soprattutto da parte di chi le usa ogni giorno e trae da esse danaro o riconoscimento sociale. Si può dire tutto e tutto si dice, pensando che



basti a tacitare la coscienza; ma non basta: occorre dunque rompere materialmente le barriere, mentre si semina chiarezza. A tal proposito vorrei attingere ancora da Volontà. Ecco quanto scrive Caleffi per il ventesimo anniversario dell’assassinio di suo marito, Camillo Berneri:
Ed egli ci ammonisce così, oggi, nella disperante passività che ci circonda da ogni lato, che la forza dei nostri nemici è fatta tutta della nostra debolezza, della nostra mancanza di iniziativa e di coraggio, della nostra rinuncia ad agire. Ci dice: non vi innamorate soltanto delle idee, che è un piacere sterile. Abbiate fede nell’azione: e tu nella tua azione, prima di tutto.
«Disperante passività» è un’espressione che potremmo usare tranquillamente anche oggi. Ma più importante è l’argomento a seguire: limitarsi ad amare le idee conduce alla vanità, in entrambi i sensi della parola; dà linfa al proprio narcisismo e non realizza alcun effetto concreto. «Ma noi non siamo così, non ci riguarda», diranno lettori e lettrici di questa rivista. Ci riguarda, invece: se non altro per avere coscienza delle storture del discorso pubblico, e delle forme in cui anche noi – che immuni non siamo – possiamo sempre cascarci. Alla vanità opponiamo allora e appunto la volontà. Piergiorgio Bellocchio riassume tutto nel suo Diario del Novecento, così:
La prima preoccupazione di chi scrive, di chi si rivolge a un pubblico sconosciuto, indiscriminato, è – dovrebbe essere – di ridurre al minimo la fatale quota di equivoco. Dunque, parlare chiaro, scrivere chiaro. Ma il «paternalismo» che il padre-maestro trasmette al figlio-allievo non è composto solo di idee, opinioni, immagini. Non è solo l’opera. Del «patrimonio» fa parte anche, e non secondaria, il comportamento del padre-maestro, lo stile di vita: che può essere il miglior supporto morale e vitale del suo pensiero o può contraddirlo, o addirittura svilirlo, vanificarlo.



Gli ingredienti per la salute in un’ottica globale: conoscenza, fiducia e collaborazione
Pamela Boldrin
Possiamo dire che la pandemia da coronavirus è ormai alle nostre spalle, sebbene il virus sia ancora in circolazione ma a bassi livelli endemici, eppure, la pubblicazione nel 2025 del nuovo «Piano Nazionale di comunicazione del rischio pandemico»1 ci ricorda che dobbiamo essere preparati quando una nuova pandemia si presenterà. Questo ultimo piano è stato accompagnato da dichiarazioni dai tratti pungenti fatte ai mass media, soprattutto da parte di politici al governo, riguardo al fatto di garantire la libertà, oltre che la salute. Il riferimento, più o meno velato, è nei confronti delle polemiche riguardo le misure restrittive che in epoca Covid sono state applicate. Nel documento si afferma che rimane comunque imprescindibile il ricorso ai vaccini, affiancati però da altre strategie di contenimento possibili. Per quanto riguarda le eventuali restrizioni alla libertà personale, queste potranno essere applicate solo attraverso leggi o atti con forza di legge, non mediante l’utilizzo di strumenti amministrativi come i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM). Il documento si prefigge anche di potenziare la sanità, ampliando le sue risorse, e migliorare la comunicazione istituzionale all’insegna della trasparenza.

1 https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_722_0_file.pdf

Quanto depositato rispecchia molte delle vicissitudini che abbiamo visto scorrerci davanti durante i difficilissimi momenti della pandemia. Molta sofferenza, ma anche molte divisioni ideologiche che hanno lacerato le nostre comunità umane, in tutto il mondo.
Uno dei punti più delicati è stata l’adesione ai vaccini. Forse, è utile cominciare dai dati per ragionare su come possiamo orientarci nei confronti di questa modalità di prevenzione.
Un articolo utile a questo scopo, dell’Istituto Mario Negri2 , mette a confronto i dati della letteratura scientifica prodotta da più gruppi di lavoro, sparsi nel mondo. Scopriamo, innanzitutto, che sono stati somministrati oltre 13 miliardi di dosi dei vari vaccini anti-Covid, dunque ci sono moltissimi dati a disposizione. Nella scienza ciò significa maggior robustezza dei risultati.
Si è sentito parlare molto del rischio di alcuni eventi avversi post-vaccinali, come i fenomeni di trombosi venosa. In realtà, sono stati rarissimi, con un’incidenza di 28 casi su 100.000 dosi, ovvero lo 0.02%. Rinvio al documento sopraccitato per un approfondimento più completo.
Quello che conta, in sunto, è che possiamo constatare che nonostante l’urgenza di avere dei vaccini disponibili prima possibile, sono stati rispettati ampiamente i limiti di sicurezza ed efficacia. Un altro dato importante riguarda anche la durata della copertura vaccinale: i primi studi segnalavano una veloce caduta dell’effetto immunizzante, ma, sul lungo tempo, si è visto che non è così e una certa quota di protezione rimane.
Nonostante il conforto dei dati, sappiamo che i vaccini hanno causato e causano molte resistenze. Il problema principale è la diffidenza nei confronti della scienza, da un lato, e delle aziende farmaceutiche, dall’altro. In qualche modo, una certa inquietudine nei confronti di un approccio vaccinale di nuova generazione in un momento di urgenza come una pandemia globale è comprensibile e giusta. La ricerca scientifica non è esente da



rischi ed errori, ma forse più di tutto a destare scetticismo sono i forti interessi che le case farmaceutiche hanno in ballo. È importante ribadire che la scienza definisce come suo metodo di lavoro universale un percorso che prevede di autocorreggersi qualora emergano prove che mettono in evidenza degli errori. Tuttavia, sappiamo bene che dove ci sono corposi interessi economici, possono esserci persone poco interessate a correggere il tiro, se questo procura loro un danno economico. La cronaca ci narra di tristi vicende in cui alcune aziende farmaceutiche hanno continuato a distribuire farmaci incuranti degli effetti collaterali. A tal proposito, un film francese del 2016 è esemplare nel raccontare un caso di questo
tipo: 150 milligrammi (disponibile anche in italiano) narra del caso di un farmaco antidiabetico di nome Mediator, il cui effetto collaterale ad azione dimagrante (non elencato nel foglietto illustrativo) lo rendeva appetibile anche a molte pazienti (soprattutto donne) desiderose di dimagrire. Il farmaco provocava danni al cuore, tante pazienti subirono interventi di cardiochirurgia e molte di loro morirono prematuramente. Il primo a segnalare a livello europeo la pericolosità del farmaco fu il farmacologo italiano Silvio Garattini, nel 1998. Rimase inascoltato e solo la battaglia di una coraggiosa pneumologa francese, Irène Franchon, portò al ritiro del farmaco in Francia nel 2009, nonché al risarcimento delle vittime francesi (non di quelle italiane).
Come possiamo reagire di fronte a un fatto del genere? Qualcuno potrebbe decidere che, vista la corruzione di alcune persone all’interno del sistema farmaceutico, è meglio non fidarsi e stare alla larga da tutto quello che esce dalle case farmaceutiche, magari optando anche per la diffusione di disinformazione e sfiducia. Qualcun altro, con sguardo più critico, mi permetto di ag-



giungere, potrebbe consolarsi evidenziando invece la possibilità di autocorrezione insita dentro il grande apparato che si avvale della scienza, soprattutto quando esso è composto anche da molte persone perbene che lavorano in modo etico e sono pronte a denunciare un malfunzionamento.
Non possiamo negare che la medicina, che non ruota totalmente attorno ai farmaci, nasce però assieme al concetto di pharmakon, cioè, dal greco antico: veleno e rimedio. Occorre un uso sapiente dei principi attivi per ottenere beneficio dall’uso di questi, tenendo a bada gli effetti tossici, soprattutto oggi che assistiamo spesso all’abuso di molti farmaci. Eppure, se andiamo a cercare il parere di farmacologi autorevoli, come Garattini, scopriamo come sia possibile riscontrare un prezioso lavoro di divulgazione per un uso corretto dei medicinali. Nel suo ultimo libro3 il professore, che tra l’altro ha fondato l’Istituto di Ricerca Mario Negri, denuncia come troppo spesso vi sia il ricorso a farmaci in modo diseducativo o inutile, se non dannoso. La classe medica promuove troppo poco stili di vita salutari basati su una sana alimentazione e un buon esercizio fisico, nonché mediante limitazione o astensione da sostanze problematiche. Le persone, in generale, spesso si sentono più confortate dall’assunzione di un farmaco in più, piuttosto che da un vizio di meno. Tra i prodotti delle farmacie troviamo anche tanti integratori, che hanno un importante quota di mercato, nonostante si rivelino addirittura inutili in molti casi. Per non parlare dell’omeopatia: un giro d’affari enorme creato attorno al nulla (nessun esperimento scientifico ne dimostra l’efficacia). Gli antibiotici, punto dolente, sono troppo spesso assunti a sproposito e l’Italia è il peggior paese europeo, da questo punto di vista. A denunciare tali fatti sono varie personalità autorevoli del mondo della scienza, persone dentro il sistema, come in questo caso.
È importante comprendere che per poterci fidare di un impianto di conoscenza dobbiamo continuare a informare noi stessi, me-


3 S. Garattini, Farmaci. Luci e ombre, Il Mulino, Bologna, 2025.

diante fonti autorevoli, perché sbandierare sfiducia e fake news rischia di sgretolare uno dei più importanti sistemi su cui si basano le nostre democrazie: la libertà scientifica. In un’epoca in cui il populismo dilaga con i suoi fantasmi, cioè disinformazione e lotta contro il pensiero critico e fattuale, dobbiamo sostenere i sistemi di conoscenza basati sulla razionalità e l’autoverifica. La scienza è certamente tra questi e la diversità delle vedute di chi lavora al suo interno è garanzia di continuo confronto, di possibili smentite e correzioni. Come ogni altro fatto umano, purtroppo, non mancano né gli errori né le frodi, ma è supportando con un buon grado di fiducia e pensiero critico il lavoro di chi opera con un metodo aperto al confronto che manteniamo il sistema più sano possibile, cercando di prevenire l’abuso di potere. Cosa succede quando le persone sfiduciano la scienza? Un esempio eclatante ce lo abbiamo sotto gli occhi. Le manovre di taglio e silenziamento della ricerca scientifica ad opera del presidente Donald Trump fin dall’inizio del suo secondo mandato possono essere per noi un’occasione di riflessione. La posizione antiscientifica di Trump è manifesta da tempo, è lecito essere abbastanza certi che chi lo ha votato sia d’accordo con lui su questo. Tra l’altro, ha nominato come segretario alla Sanità Robert Kennedy Jr, noto per le sue posizioni complottiste e no-vax. A un mese dall’inizio della sua amministrazione, i tagli alla ricerca sono già devastanti e la presa di posizione più esplicita è stata resa manifesta dal suo numero due J.D. Vance, che ha dichiarato: «Le università e i professori sono il nemico».
Fortunatamente, in un sistema costruito sulla democrazia e la pluralità, gli anticorpi si sono già messi in moto, infatti la comunità scientifica internazionale sta prendendo posizione contro le iniziative ai danni della ricerca, legate anche alla politica dei tagli indiscriminati di Elon Musk, a proposito di abusi di potere. Tra le prime reazioni troviamo quel-



la dell’autorevole rivista scientifica inglese Lancet, con questo slogan: «La salute deve essere un bene sociale, un beneficio per le società, un motore delle economie e un percorso verso lo sviluppo». La comunità scientifica è stata chiamata a unirsi e a reagire, infatti al coro si sono poi aggiunti il British Medical Journal, Science e Nature.
Quello che sta accadendo è che una solida e diffusa rete umana di stampo non politico sta insorgendo contro un’istituzione politica, urlando a gran voce la minaccia che questa comporta per la libertà e la giustizia. In questo preciso frangente, è la comunità scientifica stessa che si sta rivelando una preziosa forma di anticorpo contro l’attacco virale di un governo. Ad ammalarsi sarà la democrazia se non lavoriamo sul concetto di rete sinergica e solidale, nella quale dobbiamo rientrare in quanti più possibile, non solo le figure di scienza. Come si fa? Non basta agganciare simbolicamente le nostre mani come fossero le ife dei funghi nel sottosuolo, dobbiamo anche trasmetterci sani contenuti di pensiero e azione.
Tornando ai vaccini, essi rappresentano una delle forme più etiche di cooperazione globale per la salute delle persone, perché, se, in quanto comunità di viventi a stretto contatto, accettiamo di condividere un basso grado di rischio, possiamo usufruire di un grande vantaggio collettivo, che è la massimizzazione della salute. Abbiamo bisogno di riporre fiducia nei gesti che occorre fare per concretizzare la solidarietà, per questo necessitiamo di un apparato scientifico più sano possibile. Questo non avverrà allontanandoci da esso, se vogliamo che la tragicità dell’esempio trumpiano almeno possa tornarci utile, ma insistendo sulla necessità di collaborare assieme verso la ricerca della conoscenza, pronti all’errore e fiduciosi nelle correzioni.



NO VAX . EMOZIONI, RELAZIONI E CRISI DELLA FIDUCIA
Francesco Spagna
Durante il Covid, il conflitto che si creò tra due posizioni, relativamente alle vaccinazioni obbligatorie e alla limitazione della libertà di movimento, lacerò la società nel suo complesso. In particolare l’ambito libertario (nella sua accezione più ampia), sensibile ai temi della libertà e della natura, fu attraversato e avvelenato da questo conflitto, che divise amicizie, passò dentro le stesse famiglie. Si produssero due fronti, una contrapposizione radicalizzata, insanabile, che tendeva a chiudere le stesse possibilità di dialogo. Si produsse una forma di othering, di costruzione dell’altro come diverso (e come nemico) all’interno della galassia libertaria (che da questo othering avrebbe dovuto essere immune). Proviamo qui, anche emotivamente, a ritrovare le parole, con l’aiuto della prospettiva dell’antropologia medica e dell’impostazione dell’OBI (Othering and Belonging Institute), che prova a contrastare ogni forma di othering attraverso un bridging, cercando di gettare un ponte; e anche con un ricordo di Ivan Illich e della sua Nemesi medica.
Ricordiamo tutti, durante la pandemia, l’imposizione dei vaccini e del green pass e la ribellione del movimento cosiddetto No vax. Non sprechiamo parole. Quello che si cerca di fare con questo articolo non è un’analisi sociologica, né tantomeno politica.



L’intento è qui semplicemente di risvegliare emozioni, un intento ingenuamente umanizzante. Ogni parola, sì, dovrebbe qui essere tra virgolette. Calcoliamone circa un chilo e prendiamoci la libertà di scrivere e leggere senza questo peso. Proviamo a immaginare e tematizzare le due contrapposizioni come si sono formate in seno a quella parte della nostra società che, in varie forme e in senso ampio, è fatta di persone che coltivano una sensibilità libertaria. Per questo tentativo facciamo tesoro dello schema interpretativo dell’antropologia medica. L’antropologia medica è una branca dell’antropologia culturale che cerca di tematizzare le rappresentazioni di salute e malattia sia dal versante delle istituzioni medico-sanitarie, sia da quello dei malati o dei pazienti. Cerca di ritagliarsi uno spazio interpretativo neutrale, un punto dal quale agire la sua leva universalistica e umanizzante e accogliente rispetto alle diversità umane e culturali. Quella dell’antropologia è una prospettiva di soggetti nomadi, direbbe Rosi Braidotti, che si muovono, in questo caso, tra istanze che non sono mai puramente ed esclusivamente politiche, morali, sociologiche o biomediche.
Tornando a noi, nella mente di una parte di persone si è formata l’idea che il Covid e l’imposizione vaccinale fossero interpretabili come un tentativo di controllo, su larga scala, della salute, della libertà di movimento e della natura delle persone. Nella mente di un’altra parte di persone la pandemia da Covid è stata interpretata come espressione di un mondo fuori controllo, un
sistema sanitario in un neoliberismo deragliato, che di fronte alla crisi pandemica non aveva potuto contare né su previsioni di scenari possibili (da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) né perciò aveva soluzioni a portata.
Un sistema che, su scala globale, raggranellò tutte le risorse di ricerca medica a disposizione, per

dotarsi più rapidamente possibile di vaccini. Trovati i vaccini, la campagna vaccinale fu imposta attraverso lo Stato e l’esercito. Alle restrizioni del lockdown seguirono quelle di muoversi e lavorare per coloro che non erano ancora vaccinati. Si determinò, per diversi mesi del 2021, una vera e propria dittatura vaccinale. Riprendiamo le due posizioni: nella mente delle persone che interpretavano la dittatura vaccinale in sé e per sé e la pandemia in buona parte come una costruzione narrativa, l’altra parte appariva nemica e piegata al sistema di controllo. La contrapposizione fu assolutamente trasversale. Coinvolse allo stesso titolo (nello stesso ambito libertario) medici, accademici, insegnanti, professionisti o persone che svolgevano ogni tipo di lavoro o che avevano fatto la scelta di coltivare la terra e vivere secondo natura. La parte che, per semplificare, possiamo chiamare del Sistema fuori Controllo (SfC) diede fiducia (prendendosene i rischi) ai medici, ai virologi, ai mezzi di informazione e alle strutture socio-sanitarie. La parte invece del Sistema di Controllo (SdC) tolse la fiducia. La contrapposizione fu insanabile. Rovinò amicizie, mise genitori contro i figli. Terribile, se pensiamo che avvenne tra persone che, prima della pandemia, potevano condividere un medesimo modo di pensare.
Va qui certamente chiarito che chi scrive, considerando la crisi pandemica come (in buona parte) reale e non come una costruzione narrativa, ha preso posizione come SfC; emotivamente, tuttavia, vorrebbe ritrovare amicizia e solidarietà con l’altra parte. Impossibile? Senza provare a convincere? Senza praticare un othering, senza costruire l’alterità dell’altra parte?
Se apparteniamo alla medesima sensibilità libertaria, l’idea è di rifiutarci di fare othering, di concordare su questa idea.
Possiamo inoltre concordare su una posizione quale quella di Ivan Illich: nel suo libro La nemesi medica, Illich fa capire come a volte sia lo stesso sistema medico a risultare nocivo alla salute, e a determinare l’insorgenza di alcune patologie. Tuttavia, ciò non significa che questo danno sia intenzionale. Niente di più distante delle visioni semplificate e teorie complottiste riguardo



a esseri umani cattivi che tramano per il male, la lucidità e raffinatezza del pensiero di Illich. Le multinazionali farmaceutiche hanno un potere immenso, sì: possiamo criticare questo potere e denunciarne gli abusi e i crimini, senza dimenticare che magari solo qualche ora fa ci siamo giovati dell’effetto di un’aspirina. Possiamo contestare come l’abuso di antibiotici abbia generato patologie, ma mentre scriviamo questo dobbiamo essere consapevoli che senza l’invenzione della penicillina molti dei nostri avi sarebbero morti, dunque neppure noi forse saremmo mai nati.
Al di là del voler convincere, proviamo a giustapporre, semplicemente, slogan e affermazioni sulle quali possiamo essere comunque d’accordo, anche se sono tra loro contrastanti:
Lo Stato uccide; non esistono “cattivi” ma rapporti di potere e logiche di profitto; i mezzi di informazione mentono; chi scrive sui giornali non necessariamente è al servizio del potere; il sistema opprime e ci tiene sotto controllo; la retorica del sistema è farci credere che tutto sia sotto controllo…
Senza perdere di vista il principio dal quale tutti siamo partiti, il mutuo appoggio.
Bibliografia
Braidotti R. Soggetti nomadi, Castelvecchi, Roma 2023 [2011].
Eriksen T. H., Fuori controllo, Einaudi, Torino 2017.
Illich I., Nemesi medica. L’espropriazione della salute [1976] Kkien International publishing, prima edizione digitale, 2022.
Spagna F., La forza dell’antropologia medica: una risorsa da far maturare nella formazione alla professione, «Etica per le Professioni», Dossier: Professioni Accoglienza, 2, 2016, pp. 101-109.



Guardare alle cause della povertà per ribellarsi, già troppo si è atteso
Guido Candela
… mi possono arrestare: ma non tradirò mai i poveri, gli indifesi, gli oppressi: non aggiungerò al disprezzo con cui sono trattati dai potenti l’oblio od il disinteresse dei cristiani […] riprendo la mia libertà totale, la mia «permanente franchigia» di uomo che non ha mai chiesto di essere dove è e mi sento libero, «anarchico», a Dio solo soggetto! (Giorgio La Pira, Lettera a Amintore Fanfani, 27 novembre 1953, in Deidda e Montanari, 2023).
1.
La povertà è la manifestazione esplicita della disuguaglianza, due facce della stessa medaglia: «La povertà e la disuguaglianza incidono negativamente sulla salute, l’istruzione, la coesione sociale, la stabilità politica ed economica» (Acocella 2023, p. 91). La povertà è facile da riconoscere – salta agli occhi – ma è complessa da misurare.



Si definisce povera una persona che ha un reddito inferiore a un certo valore; a livello internazionale (un valore medio mondiale) si considera la soglia di 2,15 dollari al giorno per persona, in Italia dal 2022 la soglia per una famiglia di due componenti è di 1.150 euro al mese. In questo caso si parla di povertà assoluta poiché non si fa riferimento al reddito comparato degli altri. Mentre si definisce povertà relativa quella che guarda all’intera distribuzione dei redditi, misurata tramite indici analitici (solitamente la percentuale del reddito complessivo detenuta dal 10% più povero versus quella detenuta dal 10% più ricco) oppure da indici sintetici, fra i quali il più usato è il coefficiente di Gini. La povertà relativa non coincide necessariamente con quella assoluta.
Un indicatore rilevante nello sviluppo e nel ciclo economico di un paese è la quota di persone a rischio di povertà (il cosiddetto tasso di povertà) che è quella percentuale di popolazione che ha un reddito inferiore al 60% del reddito mediano. È quindi una misura mobile che varia con il reddito medio e mediano, cioè quel reddito che divide in due la distribuzione ordinata in senso crescente dei redditi.
La misura della povertà è diversa a seconda del reddito cui si fa riferimento: il reddito lordo; il reddito disponibile, al netto di oneri e tasse; il reddito prima o dopo i trasferimenti pubblici, il sostegno dello Stato a favore delle famiglie. Confrontare la distribuzione dei redditi prima e dopo i trasferimenti consente di valutare l’efficacia della politica pubblica, poiché i tassi di povertà effettivi possono muoversi in direzioni diverse, aumentare o diminuire, a seconda dell’efficacia e della modalità con cui il governo attua i trasferimenti (Acocella 2023, p. 102 e sgg.).
Infine, la diseguaglianza può essere riferita al reddito, il guadagno mensile della persona, oppure al patrimonio, il fondo di «roba», di cespiti finanziari e di moneta di proprietà della persona. Sono due nozioni di povertà diverse ma fortemente correlate: la persona che ha poco reddito, ha anche limitate proprietà



patrimoniali, se non è non catturata da un’incoerente tensione al consumo imitativo, che induce lei o lui a indebitarsi e ad «arrangiarsi» per disporre di roba che consenta un atteggiamento ostentativo.
Come si dà una misura della povertà, altrettanto si dà una misura della ricchezza, spesso usata come riferimento al top dei mercati dell’arte: gli Hight Net Worth Individual (HNWI), sono persone che hanno un patrimonio netto disponibile «liquido» di un milione di dollari; i very-HNWI hanno una disponibilità di almeno cinque milioni di dollari; gli ultra-HNWI possiedono una ricchezza disponibile di oltre 30 milioni di dollari.
2.
Nel mondo fra gli Stati e negli Stati fra le persone permangono sacche di estrema povertà e importanti diseguaglianze perché i poveri sono impediti o non sono motivati nel ribellarsi: «Che i ricchi sappiano almeno che i poveri sono alla loro porta e fanno la posta agli avanzi dei loro festini» (Paolo VI, enciclica Populorum Progressio, 1967, n. 83). Ciò accade perché: i) le democrazie illiberali (Mulieri 2024), le oligarchie e le dittature laiche o religiose rendono i poveri in «servitù volontaria» (de La Boëtie 2014); ii) le democrazie liberali narrano delle tall tales, dei racconti esagerati di eventi reali che si ispirano a «particolari» teorie economiche oppure a specifiche pratiche politiche, che Joseph E. Stiglitz (2024), premio Nobel per l’economia nel 2001, riferisce a Friedrich von Hayek e Milton Friedman oppure a Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Queste narrazioni sono parabole che sostengono come la ricchezza di pochi sia nell’interesse di tutti, a prescindere dell’eventuale filantropia dei magnati o per effetto dei trasferimenti pubblici che gli Stati sviluppati possono permettersi, come welfare state o reddito di cittadinanza. Sono racconti che portano «la gente alla rassegnazione passiva che fa tanto comodo a quelli che hanno in mano il potere e i quattrini» (Mazzi 2023, p. 155).



Il modello dello sgocciolamento sostiene che le risorse di capitale e la libera iniziativa, concesse ai «bravi ragazzi» della borghesia per realizzare investimenti e innovazioni a fronte di un rischio personale (Schumpeter 2002), causano uno sviluppo economico che inevitabilmente e automaticamente si riversa a cascata, sgocciola da un sacco bucato (trickle down), fino a lambire positivamente ogni strato della popolazione. Facendo leva sulla dinamica della concorrenza e del mercato, sull’efficienza, sulla produttività e sulla libera sovranità dei consumatori, l’azione dei bravi ragazzi, pur motivata dall’interesse personale, coinvolge tutti perché tutti ne traggono vantaggio, seppure in modalità e quantità differenti.
Il modello dell’alta marea percorre lo stesso concetto ricorrendo alla parabola di una marea che lambisce tutte le barche, sia le navi dei ricchi, sia gli scafi della classe media, sia i piccoli “gusci” dei più poveri: «l’alta marea solleva tutte le barche, anche le più piccole» (John F. Kennedy in Sorensen 2008, p. 227). L’alta marea è metafora dello sviluppo economico che solleva tutte le barche, non lasciandone indietro nessuna e se anche volesse discriminare tra le imbarcazioni, una marea che non incontri chiuse naturali o artificiali non potrebbe farlo.
Il modello della torta, con una logica vicina a quella della marea, guarda al «sovrappiù» del sistema economico – il di più che si ottiene oltre il reintegro dei beni consumati nella produzione – come una torta da spartirsi fra chi ha concorso a produrla. Il taglio della torta può generare fette più grandi e fette più piccole, per alcuni solo briciole; ma i possibili conflitti sublimano in accondiscendenza se la torta crescendo avvantaggia tutti. Cosicché ogni fetta possa aumentare senza che altra diminuisca, e chi ha briciole possa aspirare ad avere una fetta. Se invece la torta non aumenta o si riduce i conflitti si esasperano, poiché alcuni possono avere di più solo se altri hanno di meno.
Questi tre modelli narrano storie diverse ma tutte con lo stesso «lieto fine», lo sviluppo economico diluisce ogni diversità distributiva, sospendendo i conflitti: «volevano fornire un argomento



morale a favore del capitalismo, un ragionamento in grado di difendere le disuguaglianze di reddito, ridotte per gli standard moderni ma comunque tali che molte persone le consideravano già moralmente scandalose» (Stiglitz 2024, p. 39).
La teoria del secchio bucato, invece, va direttamente al cuore del problema denunciando l’inefficienza di ogni atto redistributivo del reddito: «I soldi devono essere portati dal ricco al povero in un secchio bucato. Una parte di essi semplicemente svanisce nel trasferimento» (Okun 1990). Secondo questa teoria l’atto redistributivo, in particolare quello attuato forzatamente col trasferimento pubblico, sarebbe in contraddizione con l’efficienza, poiché diminuisce l’incentivo ad assumere rischi e a investire, bloccando quello sviluppo economico guidato dei ricchi capace di generare un vantaggio seppur diverso per ognuno, donna o uomo che sia.
I modelli fondati sullo sviluppo contrastano, però, con un’analisi empirica che ha contrapposto alla loro narrazione l’osservazione delle realtà: il modello dell’elefante. Un modello empirico che denuncia la crescente diseguaglianza globale (Lakner - Milanovic 2016), misurando la crescita dei redditi mondiali in una distribuzione divisa in percentili. Il modello individua quattro zone: la coda dell’elefante è formata dai poveri con una crescita di reddito vicina allo zero; il torso mostra lo sviluppo più consistente dei redditi con un picco verso il centro (la mediana) della distribuzione; la base della proboscide indica una classe di profonda stagnazione; infine la proboscide, che si eleva verso l’alto, è il percentile più ricco della popolazione, che gode di una crescita forte del reddito: sono gli HNWI. Si tratta di un’evidenza che misura un vantaggio nello sviluppo goduto prevalentemente dalla classe media e dai super ricchi. Inoltre, rigorose analisi storiche condotte da Stiglitz e da Paul Krugman, poi confermate da Thomas Piketty e Anthony B. Atkinson, hanno rilevato che le forti disuguaglianze nella distribuzione del reddito hanno un effetto negativo sulle capacità di crescita di una comunità, esiste cioè una relazione inversa tra sviluppo e uguaglianza.



Poiché questi modelli non trovano reale corrispondenza, potremmo ricorrere all’esercizio intellettuale proposto Mark Twain, che dal 1863 al 1895 modificò storie edificanti con lieto fine, reinventando il loro finale. Infatti, avversati dall’osservazione empirica, i tre modelli si presentano veramente come delle tall tales, per cui merita irriderne le conclusioni: non è vero che che «tutti vissero felici e contenti» toccati da uno sviluppo «buono». Proviamo allora a ripercorre l’idea di Mark Twain.
Il modello dello sgocciolamento non dice di colui, di colei o di coloro che hanno il controllo del sacco. Se col tempo, proprio per il suo uso, i buchi da cui sgocciola la ricchezza tendono a occludersi (come fa il calcare depositandosi nel braccio della doccia) coloro che possiedono il sacco – se non costretti dalla ribellione dei poveri – potrebbero non avere motivo di fare manutenzione, cosicché il finale della storia diviene ben diverso da quello narrato: se da un lato aumenta la ricchezza dall’altro senza manutenzione dei fori sempre meno sgocciola di ciò che i ricchi producono. Il più rimane per loro.
Il modello dell’alta marea non dice che la marea spesso arriva con irruenza, cosicché solleva le navi dei più ricchi ma crea un’onda che getta «le più



piccole sugli scogli» (Dentico 2020, p. 91). Quindi anche questa narrazione vede un diverso finale: solo le navi dei ricchi si alzano con la marea e rimangono padrone del mare, alcuni restano attaccati ai rottami galleggianti delle loro piccole barche (sono i poveri), mentre altri sono costretti a trovare rifugio a terra (sono gli scarti). Né i ricchi hanno interesse – se non costretti dalla ribellione dei poveri – a usare della loro ricchezza per investire in barriere che regolino l’arrivo della marea.
Il modello della torta non dice chi ha la proprietà del coltello con cui si tagliano le fette, dunque non vi è motivo di pensare che col crescere della torta il coltello rimanga nelle stesse mani, né che il vecchio o nuovo proprietario voglia – se non costretto dalla ribellione dei poveri – mantenere le precedenti partizioni (confermandone l’angolo al centro): cosicché il crescere del sovrappiù potrebbe acuire e non evitare i conflitti.
Anche la teoria del secchio bucato merita un diverso finale. Chi ha la proprietà del secchio? Se è dei ricchi, costoro – se non costretti dalla ribellione dei poveri – non hanno alcun interesse a stagnarlo per evitare le perdite, poiché queste sono la giustificazione della secolarizzazione della loro ricchezza; se invece il secchio fosse dei poveri questi avrebbero interesse a stagnarlo, purché siano lasciate loro le risorse per finanziare il restauro. Allora anche questa teoria potrebbe avere un duplice finale à la Twain: i ricchi vogliono tenere i poveri in povertà affinché questi non abbiano le risorse per acquistare un buon secchio o per aggiustare i buchi del vecchio. La teoria del secchio bucato è in palese contraddizione con l’economia del Noi che invece, in quanto economia di comunità, può ridistribuire senza sprechi: è la logica dell’Io che sostiene alla radice l’ipotesi del secchio bucato (Candela 2021).
In estrema sintesi i tre modelli e la teoria hanno un grave difetto logico, frutto di un’eccessiva semplificazione della realtà, un’ipotesi omessa che, se inserita, modificherebbe la loro conclusione. Non sono definiti tutti i titoli di proprietà. Ecco perché non sono in grado di dare evidenza al ruolo di colui, di colei o di coloro che possono controllare il sacco, il flusso della marea, il coltello



o il secchio, avendone la proprietà o avendone semplicemente il potere di farlo. Cionondimeno, il genio di Mark Twain insegna che, una volta ammessa la mutabilità dei racconti, i loro finali possono essere molti. Allora proviamo ad andar oltre. Immaginiamo che, una volta ascoltato il narratore, uno dei «presenti», Jean-Jacques, suggerisca che, se non lo facessero i ricchi, la manutenzione del sacco o del secchio, il controllo della marea o del coltello potrebbe essere delegato a un super partes – che Jean-Jacques identifica nello Stato – cosicché il lieto finale sarebbe di nuovo agibile. Tuttavia, si dovrà avere fiducia che lo Stato sia per sempre «benevolente», capace di tutelare i poveri, ma allorché fosse «di parte», dalla parte dei ricchi, la distopia del nostro diverso finale si confermerebbe. Dunque, dal punto di vista libertario, tutto si riassume nella conclusione che queste analisi economiche non possono né vedere né riconoscere il dominio come causa di povertà. Un errore che Nicola Acocella non commette quando, dopo avere osservato i dati dello sviluppo e della diseguaglianza, afferma: «Le diseguaglianze tendono a riprodursi nel tempo, in quanto generano un elemento conservatore specialmente nell’atteggiamento dei più ricchi, i quali hanno normalmente le leve del potere» (Acocella 2023, p. 113).
Ma se ci fosse un «passante», Michail, che udendo il racconto si fermasse chiedendo al narratore: perché limitarsi a modificare solo il finale e non mettere in discussione anche le premesse? È proprio necessario che nella storia vi sia un sacco contenitore, dei natanti di tanta diversa dimensione, un secchio come diaframma fra ricchi e poveri, o una torta tagliata in fette e non distribuita secondo i bisogni? Cambiamo le premesse – suggerisce Michail – e proviamo a narrare ben altri racconti in cui non prevalga l’egoismo ma il mutuo appoggio, la solidarietà, l’etica della cooperazione (com’è nell’utopia di Piëtr Kropotkin, di Enrico Malatesta, di Gustav Landauer), il dono non lo scambio mercantile (com’è nella speranza di Francesco) e una «finanza che fa vivere i poveri [e non quella] che li divora» (Bruni 2024, p. 120)… e otterremmo finali ben più lieti.



3.
I nostri finali à la Mark Twain e la proposta del passante, oltre a fornire le ragioni per comprendere la povertà e la tendenza dei ricchi a sostenere dinamiche anti-egualitarie, suggeriscono l’opportunità di cambiare il punto di vista: considerare le cause della povertà e della disuguaglianza, puntando direttamente al cuore del problema. La facciamo ponendo la nostra attenzione dalla fine del 1800, in altre parole trascurando quel mondo del passato (non totalmente passato) che generava (ma genera tuttora) povertà con la sottomissione, la servitù, la schiavitù, il saccheggio e la distruzione.
a) Il capitale del XIX secolo. Ai decenni di fine Ottocento data l’ascesa, in Europa e negli Stati Uniti d’America, di un nuovo modo di produrre e consumare, il capitalismo. Un’ascesa che si erge su un precedente lungo inizio, perché il capitalismo aveva bisogno, come dimostra Karl Marx (2024), sia di una accumulazione primaria, concentrata nelle mani dei ricchi, i «capitalisti», sia di un «esercito industriale di riserva», disoccupati affamati disposti al lavoro «sotto padrone» effetto della recinzione delle terre e dell’impedimento all’uso libero dei beni comuni, i «proletari». In quel tempo, che partendo dal Settecento si colloca fra l’Ottocento e il Novecento, il capitalismo fu violento, maestro sia nel generare ricchezza concentrata in poche mani sia nel causare povertà e morte. Il procedere del capitalismo, dal suo inizio alla sua ascesa, è ben descritto dallo storico ed economista Maurice Dobb, guardando prevalentemente all’Inghilterra ma volgendo lo sguardo anche ad altri paesi: «Il processo di differenziazione dava luogo, da un lato, allo sviluppo di uno strato di ‘padroni’, dall’altro, allo sviluppo di un’offerta di lavoratori poveri, se non effettivamente privati di ogni proprietà, disponibili per l’impiego salariato. Nei secoli seguenti le recinzioni [eseguite anche in maniera diretta e violenta] e la concentrazione delle proprietà terriere avrebbero completato il processo che privava della pro-



prietà lo strato più povero della popolazione, separandoli dai mezzi di produzione e creando un proletariato» (Dobb 1962, p. 158). In realtà, ricorda Dobb, c’erano anche «vagabondi e mendicanti», ma il loro numero non era così elevato perché una parte di loro che cercò di installarsi sui terreni comuni rivendicando la propria libertà, con la trasformazione delle terre comuni in proprietà private fu cacciata; laddove ciò non bastò «gli imprenditori ricorsero al reclutamento coatto di mano d’opera» (Ibidem, p. 168), come avvenne in Inghilterra nelle miniere. Questo processo ha richiesto molto tempo finché il XIX secolo vide completata la transizione del sistema economico in un capitalismo pienamente sviluppato «insieme con la formazione di una classe diseredata di potenziali operai salariati» (Idem, p. 175).
Tuttavia, dal 1848 in Europa «Il ‘popolo senza pane’ si alza in piedi da Vienna a Parigi, da Milano a Palermo ed entra nella storia, dando vita a una sollevazione transnazionale di carattere sociale. Una rivoluzione che percorre l’Europa e si scaglia contro apparati statali vecchi e nuovi, ottenendo risultati notevoli» (Ateneo libertario, 2020, p. 13). È con l’enciclica Rerum novarum di Leone XIII (1891) che il linguaggio socialista si affaccia alla Chiesa cattolica, ma solamente come riferimento a una microlingua politica ed economica che ebbe il solo effetto di dare evidenza al lavoro povero (Candela e Mussoni 2024). Se inizialmente i risultati del Quarantotto dell’Ottocento furono effimeri, nel Novecento si consolidarono per effetto della nascita delle organizzazioni dei lavoratori, del diffondersi di idee socialiste, libertarie, anarchiche e comunitariste (Senta 2015 e 2024). Guardando all’esperienza di questo lungo tempo di lotte e di rivendicazioni, dobbiamo riflettere sul fatto che non è la proprietà del capitale cui i lavoratori devono puntare per eliminare la miseria (come sostiene Marx e come accade dopo la Rivoluzione di Ottobre 1917 in Russia) ma alla proprietà del prodotto (come sostiene Proudhon: Candela 2014; Candela - Mussoni 2024), che si realizza: i) con le cooperative di produzione, di lavoro e di consumo, come teorizzano Gustav Landauer e Martin Buber (Radici, 2024); ii) con la gestione comunitaria dei beni co-



muni (Ostrom 2006; Jourdain 2024); iii) con le imprese «civili» (Becchetti, Bruni e Zamagni 2014); iv) col diffondersi dell’autogestione anarchica (Candela e Senta 2017; Candela 2021). Gli anarchici hanno avuto un importante ruolo nel sostenere queste rivendicazioni, scrivendo una storia che è spesso trascurata (Ateneo libertario, 2020). Una bella e interessante riduzione artistica di questi due momenti del capitalismo dell’Ottocento e del Novecento può essere percepita paragonando il film Compagni di Mario Monicelli (1963), in cui si narra della richiesta, soffocata nel sangue, di pane delle prime organizzazioni del lavoro nell’Ottocento, con il film Bread and Roses di Ken Loach (2000) dove si dà visione di un Novecento in cui i lavoratori lottano per ottenere oltre il pane anche un mazzo di fiori, per l’appunto di rose.
b) La guerra. La guerra del passato, che vedeva in armi paesi confinanti, è divenuta la guerra del presente: un conflitto dove le «nuove armi» (missili e droni) coinvolgono sia paesi confinanti sia paesi lontani. Mentre le guerre del passato creavano morte prevalentemente fra militari e in più fra i civili, le guerre del presente creano morte fra i militari ma di più fra i civili (Strada, 2022). Inoltre, vi sono paesi che impegnano la loro terra nella guerra e altri in cui la loro terra non è toccata. Se si riflette sul fatto che tutti perdono nella guerra e non ci sono più spazi di ricchezza per il paese vincitore (come accadeva nelle guerre di conquista e di saccheggio), si impone comunque una distinzione fra paesi con la propria terra in guerra e paesi senza la propria terra in guerra. Il paese senza la propria terra in guerra aumenta la produzione di armamenti e il relativo indotto, generando ricchezza e reddito per coloro che sono interessati e cointeressati in queste produzioni, capitalisti e lavoratori. Mentre, il paese con la propria terra in guerra soffre di una devastazione che genera povertà immediata e perdurante, una povertà che non si risolve neppure con la ricostruzione, anche dopo molti anni.
Gli anarchici si sono sempre schierati contro le guerre, «azione di uno Stato contro un altro» (Landauer, 2023, p. 135), perché



generano potere, miseria e corruzione. Per impedire le guerre Landauer propose, nel 1911, l’azione diretta più «classica» dell’anarchia, lo sciopero generale. La guerra è il più vile degli sprechi e lo spreco si basa sul lavoro di altri: «se vogliamo impedire ogni guerra, tutti noi, cioè la popolazione attiva, dobbiamo cessare ogni attività [… ] se ogni uomo, ogni donna, ogni bambino […] scendono in sciopero, allora non sarà più possibile nessuna guerra» (ibidem, pp. 136-137).
c) Il capitale del XXI secolo. Thomas Piketty nel suo libro Il capitale nel XXI secolo (2018, ma è del 2014), utilizzando una grande quantità di dati di venti paesi, delinea le caratteristiche di un capitalismo che, sfruttando il suo isomorfismo, si presenta come «nuovo» nel XXI secolo. Infatti, il capitalismo nel XX secolo non ha sofferto delle contraddizioni su cui Marx fondava la predizione di una «fine apocalittica» – caduta tendenziale del tasso di profitto, immiserimento crescente della classe operaia, crisi di sovraproduzione – anzi la storia ha visto ciò che Marx non aveva previsto: i «Trenta gloriosi», gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta del Novecento, che hanno generato prospettive ottimistiche di crescita e di diffusione della ricchezza. Tuttavia anche il capitalismo di questo secolo trova, secondo Piketty e il suo gruppo di ricerca, la sua contraddizione in un tasso di profitto che si mantiene maggiore del tasso di crescita naturale (demografica e tecnologica): un disequilibrio che conferma la tendenza del capitalismo a generare diseguaglianze causando dinamiche anti-egualitarie; disuguaglianze che si riscontrano sia all’interno del lavoro sia nella distribuzione del patrimonio. Infatti, le serie pluriennali di Piketty riconoscono due tendenze: nella distribuzione crescente del reddito da lavoro l’ultimo 10% dei lavoratori più ricchi guadagna il 45% del reddito complessivo; nella distribuzione crescente dei patrimoni l’ultimo 10% dei proprietari più ricchi possiede il 90% del patrimonio complessivo (Piketty 2018, pp. 247-248). Il capitalismo contemporaneo è dunque una società profondamente diseguale che va oltre



la contrapposizione fra le due classi del marxismo, capitalisti e lavoratori, poiché grandi diseguaglianze si manifestano anche all’interno del lavoro. Sia per Piketty sia per Stiglitz (2024) sono ineguaglianze tali da minare in profondo l’equilibrio sociale e la democrazia stessa, ma le soluzioni da loro indicate sono: per Piketty, il ricorso a regole che regolino il mercato e alla redistribuzione realizzata tramite imposte sul reddito, sul patrimonio e sulle eredità (Piketty 2020); per Stiglitz, servirsi di un «pacchetto di politiche che comprendono regolamentazioni, prezzi e investimenti pubblici» (Stiglitz 2024, p. 69). Comunque entrambi allineati sulla «fiducia» di uno Stato benevolente.
Nel capitalismo di questo secolo non sono mutate solo le relazioni industriali e sociali, diverse da quell’imprenditore intraprendente nel produrre beni reali del capitalismo del 1900; il nuovo capitalismo si è rivolto alla «esaltazione» del debito (Graeber 2024), della moneta e della finanza, spingendo verso forme estreme di consumismo: «Lo spirito del capitalismo vincente del XXI secolo non è più quello calvinista che ha ispirato il capitalismo del XX secolo. Con il passaggio di millennio ha vinto, inaspettatamente, lo spirito [della roba] non più investita e accumulata, ma solo consumata […] È proprio il consumo, infatti, il protagonista dell’economia globale di oggi, non più il la-
voro (tantomeno il lavoro dell’imprenditore)» (Bruni 2024, p. 48).
I due film che narrano questa trasformazione del capitalismo sono Too Big to Fall di Curtis Hanson (2011) e The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese (2013): le loro narrazioni sono ben diverse da quelle dei film di Monicelli e di Loach.
All’interno degli Stati, i prezzi e salari si sono livellati verso il basso, SVANTAGGIANDO in particolare i lavoratori non qualificati esposti alla competizione dei lavoratori immigrati, in una «guerra» fra poveri per ottenere una qualsiasi occupazione



d) La globalizzazione. La globalizzazione è il passaggio a scala mondiale, realizzato da istituzioni private, delle interrelazioni sia fra Stati nazionali sia fra persone di diversa nazionalità, implementato tramite la mobilità dei beni, dei capitali finanziari, delle idee e delle comunicazioni (Held et al, 1999). La Prima globalizzazione anticipa la Prima guerra mondiale, mentre la Seconda globalizzazione inizia dopo il 1970 con caratteri molto diversi dalla prima, per effetto di un progresso tecnico che ha ridotto i costi di trasporto e ha consentito la crescita di un’economia digitale. Tuttavia, pur portando all’efficienza, effetto della delocalizzazione, della specializzazione produttiva, della mobilità dei fattori produttivi e dell’immediatezza delle comunicazioni, la globalizzazione può «non accompagnarsi ad una accresciuta concorrenza: le maggiori interrelazioni possono anche portare alla monopolizzazione dei mercati» (Acocella 2023, p. 116); gli effetti positivi della globalizzazione, se ci sono stati, si sono limitati al breve periodo.
Dunque, la seconda globalizzazione neoliberista – «liberista» in quanto richiede uno Stato il più possibile minimale, «neo» in quanto assume una posizione non dissimile dalla dottrina del laissez faire (Stiglitz 2024, p. 30) – dopo gli iniziali effetti positivi legati alla nuova “energia” del mercato ha manifestato importati mutamenti nella distribuzione del reddito e della ricchezza. All’interno degli Stati, i prezzi e salari (non i profitti e le rendite di monopolio che sono aumentati) si sono livellati verso il basso, svantaggiando in particolare i lavoratori non qualificati esposti alla competizione dei lavoratori immigrati, in una «guerra» fra poveri per ottenere una qualsiasi occupazione. Inoltre, la globalizzazione ha avuto importanti effetti nella distribuzione del reddito fra i gli Stati: se ha permesso ad alcuni paesi di emergere dal sottosviluppo, però «non ha contribuito a frenare il processo di marginalizzazione che ha caratterizzato negli ultimi decenni una parte dei paesi meno sviluppati, ma, talvolta, potrebbe averlo rafforzato, per numerose ragioni» (vedi: Acocella 2023, p. 140 e sgg.).



È la globalizzazione che ha reso «liquida» la società occidentale del XXI secolo. Zygmunt Bauman indica esplicitamente il lavoro come uno degli elementi della vita che ha subito le più profonde trasformazioni passando dalla società solida alla società liquida (Bauman 2006 e 2014; Bauman e Leoncini 2017). Così com’è mutata la percezione della felicità – afferma il sociologo – il lavoro è passato dallo «stato del lavoro» alla «ricerca del lavoro». Nella società solida, fare lo stesso lavoro per lungo tempo era considerato una connessione di eccellenza, di affidabilità e di efficienza, nella società liquida chi fa lo stesso lavoro per tanto tempo è considerato un lavoratore immobile, impaurito dai cambiamenti, quindi inefficiente. La vita liquida è caratterizzata dal dinamismo nel tempo, nello spazio e nei luoghi. Nella vita liquida «tutto è possibile, ma nulla può essere fatto con certezza» (Leoncini 2023, p. 33), conseguentemente la persona è alla ricerca costante e incessante di nuove connessioni, altre opportunità di lavoro che possano creare maggiori guadagni. Però, ogni connessione è costantemente messa in discussione, perché deve affrontare interferenze che distruggono le opportunità di ieri e aprono le opportunità di oggi. Il cambiamento del lavoro, che nella società solida era ritenuto un inciampo necessario ma temporaneo per il tempo dovuto per passare a nuove stabilità, nella società liquida diviene una prova di vitalità. Questo cambiamento modifica sostanzialmente modi e comportamenti del lavoro, richiede nuove abilità, competenze, capacità e il lavoratore deve comunque essere rapido, pronto all’azione e disposto ad affrontare errori non solo successi. Nella società liquida la partita non è mai finita, anche in termini lavorativi tutto può essere stravolto in pochissimo tempo proprio perché il guadagno sembra alla portata in ogni dove e in ogni momento, ma nulla si può afferrare con certezza (Leoncini 2023): si cerca l’ultima tendenza premiata dal mercato. Tuttavia, il premio è provvisorio e nell’inseguirlo si può vincere o sbagliare. Chi vince ottiene piccoli o grandi guadagni, generando un’ampia differenza fra i redditi da lavoro, ma chi perde diviene un «esubero» (Bauman



2006), uno scarto della «economia che uccide» (Francesco, esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, n. 53, 2013; Tornielli e Galeazzi 2015; Candela - Mussoni 2024). Il dramma della disoccupazione della Società solida diviene la tragedia della società liquida. Essere «in esubero» significa essere in sovrannumero, non necessario, inutile, un esubero che trasforma la donna o l’uomo in pattume, in una parola: un «rifiuto» (Bauman 2005). Gli anarchici hanno sempre denunciato i danni della globalizzazione neoliberista, fin dal Wall Street Movement e dell’impegno come attivista e come studioso di David Graeber (Graeber et al., 2022). Ciò che gli anarchici cercano è la globalizzazione della libertà: «nostra patria è il mondo intero, nostra legge è la libertà» (Pietro Gori, Stornelli d’esilio, 1895).
e) I cambiamenti climatici. Sono movimenti lenti del clima sulla Terra, ma quando si fanno sentire provocano grandi mutazioni. Chi pensa al deserto sahariano non immagina un passato rigoglioso che pur si vede nella testimonianza degli wadi, solchi che si osservano in paesi aridi o nei deserti e che furono corsi d’acqua del passato, mentre oggi si riempiono, creando devastazioni, solo per le piogge eccezionali e transitorie, pericolose per gli uomini e inutili per l’agricoltura; proprio in Africa l’australopiteco, Lucy, trovò le condizioni favorevoli che diedero origine all’evoluzione degli ominidi, nella valle del fiume Awash nella regione dell’Afar in Etiopia, da lì migrando per riempire il mondo di homo sapiens sapiens.
I cambiamenti climatici dell’antropocene stanno generando mutamenti che possono e potranno essere devastanti, creando sia nuovi deserti sia nuove alluvioni (Antonioli - Soto 2022). Sono cause di altra povertà: la sopravvivenza risulta impossibile sia per chi abita terre vieppiù aride, sia per chi abita terre destinate a essere sommerse. Ma sono anche fonte di ricchezza per coloro che, avendone i mezzi, sanno avvantaggiarsi delle nuove condizioni, sfruttando queste opportunità per merito o per fortuna. I cambiamenti climatici dell’antropocene non sono solo



l’esito del succedersi naturale delle ere geologiche ma anche l’effetto del comportamento degli uomini. La deriva climatica è infatti da collegare sia alla sovrapproduzione (anche di armamenti) del capitalismo di mercato e del capitalismo di Stato, sia al consumismo diffuso del capitalismo di mercato, sia alla mobilità e al consumo energetico della globalizzazione – che inscatola informazione energivora nei big data – sia alle guerre che «infuocano» con le armi la Terra. Capitalismo, guerre e globalizzazione sono concause dell’emissione eccessiva di CO2, generando un effetto serra. Dunque, tutto si ricollega nel cambiamento climatico come causa della povertà. Gli anarchici si sono sempre attivati per la salvaguardia della Terra, sia nell’anarchismo recente di Murray Bookchin (2021), sia alle radici dell’anarchismo sia europeo, Élisée Reclus (2020) e Piëtr Kropotkin (2023) furono geografi di rilievo, sia americano, espresso dal vivere la natura di Henry David Thoreau (2021). Prescindendo – se si vuole – dall’anarco primitivismo di John Zerzan e dall’ecologia profonda di Arne Næss (Candela 2014, parte terza).
4.
La povertà è indicata come causa dei flussi migratori, ma i migranti possono avere diverse motivazioni che li inducono a passare le frontiere (2019):
· Migranti in cerca di lavoro. Nel capitalismo del XIX erano principalmente i capitalisti che si muovevano nel mondo cercando di sfruttare spazi di consumo fuori di sé, rivolgendosi alle periferie dei paesi non capitalistici – come sostiene Rosa Luxemburg (2021) – mentre nel capitalismo del XXI secolo sono principalmente i lavoratori che dalle periferie dei paesi capitalisti si muovono nel mondo cercando occupazione là dove il capitale è disponibile e i capitalisti cercano il lavoro povero e non qualificato che manca loro.



- · Migranti della globalizzazione. Le migrazioni sono rese possibili sia dalla diffusione globale e veloce delle comunicazioni, sia dalla grande mobilità della globalizzazione. L’informazione crea conoscenze, a volte vere ma sovente alterate dai media e dalle «favole» urbane, sulle opportunità di vita in ogni dove: «la spazzatura informativa [per cui] gli individui agiscono in base alla mis- o alla dis-informazione» (Stiglitz 2024, p. 53). La mobilità legale o illegale di delle persone insegue queste opportunità, nella speranza di una vita diversa e migliore, come narra il film Io Capitano (2023) di Matteo Garrone. Tuttavia, l’informazione alterata e la mobilità illegale generano un’illusione senza speranza che porta uomini, donne e bambini al limite della sussistenza e alla morte, perché scartatati dai mercati (Gilberti - Queirolo Palmas, 2024).
- · Migranti in fuga dalla guerra. Sono migranti in cerca di sicurezza e di sopravvivenza, che portano seco poco o nulla di ciò che hanno, scappando per quanto sia possibile dalle ferite morali e materiali causate dalla guerra. La foto scattata da Nick Ut nel 1972 di Kim Phúc, la bambina che fugge nuda e piangente dai bombardamenti al napalm in Vietnam, è divenuta il simbolo degli orrori delle guerre. Migranti che migrano sperando nel cibo, nella salute e nel calore umano della solidarietà (Gatti 2023).
- · I migranti climatici. Muta il clima e i nuovi poveri sono coloro che abitano terre non più fertili colpite dagli effetti di un clima devastante. Queste persone migrano perché la miopia economica e politica, continuando a non provvedere e non prevedere, ha tolto loro la possibilità di vita là dove vivevano.
Confrontando le motivazioni delle migrazioni con le cause della povertà, ci accorgiamo della loro quasi perfetta coincidenza. Allora vorremmo concludere evitando la trappola logica del fermarsi alla causa prima piuttosto che risalire alla causa remota. Così pensando, pare evidente che le migrazioni, uno dei fatti



caratterizzanti questo Millennio in tutti i continenti, non sono l’effetto della povertà – la causa prima – ma le cause remote sono da cercare nel post-capitalismo di un mercato che non fa sconti, nelle guerre diffuse della Terza guerra mondiale “a pezzi”, nella globalizzazione neoliberista, nella deriva climatica.
Il dramma del secolo non sono le migrazioni, ma sono le stesse grandi cause che dal 1800 generano povertà, apparentemente inamovibili se non vi sarà ribellione a quella manifestazione del dominio che si riflette nelle democrazie illiberali, nelle dittature, nei modelli economici che continuano a sostenere che tutto si risolve con lo sviluppo economico, con il tasso di incremento del Prodotto Interno Lordo (PIL): un falso mito. Se volgiamo l’attenzione alle cause remote, potremmo concludere che né la carità dei ricchi, né l’aiuto di un capitale filantropico, né il portare il nostro sistema socio-economico «a casa loro», né il welfare dei paesi sviluppati – che pur ha alleviato alcuni mali sociali – potranno risolvere l’annoso problema della povertà e l’impellente problema delle migrazioni.
Le cause remote della povertà e delle migrazioni sono da cercare nel fallimento di questa società nel perseguire una logica del Noi globale e universale, che comprenda le generazioni attuali e future, la flora e la fauna. Non sembrerebbe troppo difficile farlo se non si avesse paura di cambiare «fuggendo da un mondo» che forgia un’educazione fondata su false narrazioni e regole che «cercano di costruire tenacemente dei figli-burattini», incapaci di esprimersi con una «libertà indomita, irresponsabile, ingenua, rischiosa, imprudentissima, e stupenda» (Bruni 2024, p. 64). Ma forse non è poi così facile, se Luigino Bruni riferisce questa libertà al Pinocchio di Collodi. Eppure bisognerebbe iniziare da qui, perché la povertà è fuori e dentro ogni Stato, e subito, perché già troppo si è atteso.



Bibliografia
Acocella N., Le terribili quattro. La politica economica alla prova di crisi, stagnazione, povertà, globalizzazione, Luiss University Press, Roma, 2023.
Antonioli M. e Soto A., Un nuovo regime climatico. L’antropocene e noi, «Semi sotto la neve», n. 2, 2022, pp. 47-52.
Ateneo Libertario, Una storia trascurata. Cronologia anarchica 1848- 2012, La Fiaccola, Ragusa, 2020.
Bauman Z., La vita tra reale e virtuale, Egea, Milano, 2014.
Bauman Z., Vita liquida, Laterza, Bari, 2006.
Bauman Z. - Leoncini T., Nati liquidi, Sperling & Kupfer, Milano, 2017.
Becchetti L. - Bruni L. - Zamagni S., Microeconomia. Un testo di economia civile, il Mulino, Bologna, 2014.
Bookchin M., Per una società ecologica, elèuthera, Milano, 2021.
Bruni L., Il campo dei miracoli. Viaggio economico nei capolavori della letteratura, Marsilio, Venezia, 2024.
Candela G., Economia, stato, anarchia. Regole, proprietà e produzione fra dominio e libertà, elèuthera, Milano, 2014.
Candela G., Verso un’economia comunitaria, elèuthera, Milano, 2021.
Candela G. - Mussoni M., Economia e persona nel pensiero libertario e nel pensiero cristiano, Franco Angeli, Milano, 2024.
Candela G. - Senta A., La pratica dell’autogestione, elèuthera, Milano 2017.
De La Boëtie E., Discorso della servitù volontaria, Feltrinelli, Milano 2014.
Deidda B. - Montanari T. (a cura di), Disobbedienza profetica. La Firenze di Milani, Balducci, Brandani, La Pira, Mazzi, Turoldo, Santoro, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2023.
Dentico N., Ricchi e buoni? Le trame oscure del filantrocapitalismo, EMI, Bologna, 2020.
Dobb M., Alcune questioni di storia del capitalismo, «Statistica», anno XXII, n. 2, pp. 147-196, 1962.
Gatti R., Un giorno in mare, «Semi sotto la neve», n. 4, 2023, pp. 9-21.


Gilberti L. - Queirolo Palmas L., Boza! Diari dalla frontiera, elèuthera, Milano, 2024.
Graeber D., Debito. I primi 5000 anni, Il Saggiatore, Milano, 2024.
Graeber D., Belhai Kacem e Dubrovsky N., Dialoghi sull’anarchia, elèuthera, Milano, 2022.
Held D. - Mc Grew D. - Goldblatt D. - Perraton J., Global Transformation, Stanford University Press, Stanford, 1999.
Khosravi S., Io sono confine, elèuthera, Milano, 2019.
Kropotkin P., Campi, fabbriche e officine, elèuthera, Milano, 2023.
Jourdain E., L’autogoverno dei beni comuni, elèuthera, Milano, 2024.
Lakner C. e Milanovic B., Global Income Distribution: From the Fall of the Berlin Wall to the Great Recession, in «The World Bank Economic Review», 30 (2), pp. 203-232, 2016.
Landauer G., La comunità anarchica, elèuthera, Milano, 2023.
Leoncini T., La società liquida. Che cos’è e perché ci cambia la vita, Il sole 24 ore ed., Milano, 2023.
Luxemburg R., L’accumulazione del capitale, PGreco ed., Milano 2021.
Marx K., Il capitale, libro I, Einaudi, Torino, 2024.
Mazzi don E., Incontro con gli operai disoccupati del monte Amiata, in Deidda e Montanari, 2023.
Mulieri A., Contro la democrazia illiberale, Donzelli, Roma, 2024.
Okun A.K., Eguaglianza ed efficienza. Il grande trade off, Liguori, Napoli, 1990.
Ostrom E., Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia, 2006.
Piketty T., Capitale e ideologia. Ogni comunità ha bisogno di giustificare le proprie disuguaglianze, La nave di Teseo, Milano, 2020.
Piketty T., Il capitale nel XXI secolo, Bompiani, Milano, 2018.
Radici. Profili di un’anarchia propositiva, supplemento al n. 9 di «Semi sotto la neve», Omaggio a Roberto, ottobre, 2024.
Reclus E., Storia di un ruscello, elèuthera, Milano, 2020.
Schumpeter J., Teoria dello sviluppo economico, Etas libri, Milano, 2002.
Senta A., Pane e rivoluzione. L’anarchia migrante, elèuthera, Milano, 2024.



Senta A., Utopia e azione. Per una teoria dell’anarchismo in Italia, elèuthera, Milano, 2015.
Sorensen T., Conselor: A Life at the Edge of History, HarperCollins, New York, 2008.
Stiglitz J.E., La strada per la libertà. L’economia e la società giusta, Einaudi, Torino, 2024.
Strada G., Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 2022.
Thoreau H.D., Walden ovvero Vita nei boschi, Edizioni Crescere, Varese, 2021.
Tornielli A. e Galeazzi G., Papa Francesco. Questa economia uccide, PIEMME, Milano, 2015.



Conversazione con Stefano Anastasia
a cura della Redazione
Docente di filosofia del diritto e di materie criminologiche, garante delle persone private della libertà per la Regione Lazio, cofondatore di Antigone, Stefano Anastasia è autore di studi fondamentali sul problema carcerario. Tra questi, segnaliamo: L’appello ai diritti. Diritti e ordinamenti nella modernità e dopo, Torino, Giappichelli, 2008; Metamorfosi penitenziarie. Carcere, pena e mutamento sociale, Roma, Ediesse, 2012; Abolire il carcere. Una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, con L. Manconi, V. Calderone e F. Resta, Milano, Chiarelettere, 2015; nuova ed. 2022; Populismo penale: una prospettiva italiana, con M. Anselmi e D. Falcinelli, Padova, Cedam, 2015; nuova ed. 2020; Le pene e il carcere, Milano, Mondadori Università, 2022.
Stefano, tu sei professore di filosofia del diritto e di molti altri insegnamenti legati alla criminologia all’Università di Roma Unitelma Sapienza. Sei anche garante delle persone private della libertà per la Regione Lazio. Da decenni ti occupi di questioni carcerarie e sei stato tra i fondatori dell’Associazione Antigone. Vuoi descrivere in sintesi questo tuo percorso così appassionato di studio e di vita?

Quando mi chiedono di me, mi torna sempre in mente il Buffalo Bill di De Gregori, che si ritrova con i suoi cinquant’anni, con un contratto con il circo «Pace e Bene» a girare l’Europa: è diventato quel che è senza sapere perché, o forse solo per una scelta (e una passione) giovanile («la locomotiva ha la strada segnata, il bufalo può scartare di lato e cadere. Questo decise la sorte del bufalo, l’avvenire dei miei baffi e il mio mestiere…»). Così io, nel mio piccolo, intorno ai venti, avevo tre passioni: la politica, la storia e il diritto. Non avendo giuristi in famiglia, venendo da una famiglia piccolo-borghese, di cui sarei stato il primo laureato, non ho avuto il coraggio di iscrivermi a Giurisprudenza: mi sembrava più semplice continuare gli studi storici iniziati al liceo. Ma in realtà, in quegli anni, in me prese il sopravvento la politica, e da enfant prodige dei giovani comunisti della mia città, mi ritrovai a fare quasi a tempo pieno il dirigente nazionale della Federazione Giovanile Comunista. La mia prima epurazione, a soli ventidue anni, mi portò a occuparmi di diritti dei minori, e così a entrare in relazione con il Centro per la riforma dello Stato, allora presieduto da una personalità carismatica come Pietro Ingrao.
Lì ho conosciuto il mio primo maestro di cose giuridiche, il grande magistrato e scrittore sassarese Salvatore Mannuzzu, prestigiosi intellettuali come Pietro Barcellona e Stefano Rodotà, e i relatori delle mie tesi di laurea e di dottorato, Franco Cassano ed Eligio Resta. Mannuzzu mi volle a lavorare con lui, nella sezione giustizia del Crs, ed essendo un po’ approssimativo nei miei rudimenti di diritto (nel frattempo Giuseppe Cotturri, che dirigeva il Crs, mi aveva convinto a riconvertire i miei studi storici in quelli di Scienze politiche) mi diede da leggere Rushe e Kirchheimer e mi mise a seguire il gruppo di lavoro sul carcere, composto da magistrati come Sandro Margara e da molti operatori penitenziari, a cui partecipavano parlamentari come Mario Gozzini, Giglia Tedesco, Ersilia Salvato, e da cui nacque la prima ricerca italiana sul sentencing penitenziario, coordinata da Massimo Pavarini e Giuseppe Mosconi.



Inevitabilmente a Botteghe Oscure mi dissero di occuparmi di giustizia, proprio mentre il gruppo di Curcio decideva di chiudere la propria esperienza con la lotta armata. Con Nichi Vendola, che mi passava il testimone in materia, ci trovammo subito impelagati nelle proposte di «soluzione politica» per i reati politici degli anni Settanta e Ottanta, e così entrai in relazione con Mauro Palma, Rossana Rossanda e Luigi Ferrajoli e, soprattutto, entrai per la prima volta in carcere: era il 1988, con Beppe Vacca e Mariella Gramaglia andammo a incontrare Curcio e gli altri, allora a Rebibbia.
Quando nel 1991 subii la mia seconda epurazione fu naturale seguire gli insegnamenti di Peppino Cotturri, praticare la «militanza senza appartenenza» e sperimentare nuove forme di «cittadinanza attiva»: ne nacquero, con Mauro Palma, «Antigone», con Grazia Zuffa «Forum droghe», con Franco Corleone la «Società della Ragione», con Luigi Manconi «A buon diritto».
Nel frattempo mi mantenevo facendo lo sherpa parlamentare e continuavo a studiare. All’Università ci sono arrivato molto tardi, grazie a Eligio Resta e Tamar Pitch, che mi volle a Perugia. Inevitabilmente, dentro l’Università ho portato me stesso, le mie passioni e la mia storia, e così a Perugia, con il mio amico Carlo Fiorio, abbiamo messo su una delle prime cliniche legali in carcere, cui partecipavano nei primi anni decine di studenti. Poi, dopo Carlo, sono stato nominato garante dei detenuti in Umbria, mentre succedeva la stessa cosa nel Lazio, dove sono stato riconfermato nel 2021. «Avevo pochi anni e vent’anni sembran pochi, poi ti volti a guardarli e non li trovi più…».
Partiamo dalla famosa affermazione di Montesquieu, secondo la quale è dalla bontà delle leggi penali che dipende principalmente la libertà del cittadino. Sei d’accordo con questa prospettiva? Montesquieu scriveva nella prima metà del Settecento. È davvero ancora così centrale la questione penale, così essenziale per determinare il grado di libertà di cui i cittadini godono in una società?



Montesquieu ci parla da un secolo in cui il pubblico si risolveva nella relazione tra autorità e libertà, essenzialmente regolata dal diritto penale. Oggi le libertà della persona dipendono assai più dalla complessa macchina amministrativa che dovrebbe essere finalizzata a garantire non solo i diritti civili di libertà, ma anche quei diritti sociali che dovrebbero liberare la persona dai condizionamenti ereditati dal proprio contesto sociale e familiare. Ciò detto, il penale resta un indicatore fondamentale delle condizioni di libertà delle persone in un dato contesto socio-giuridico: la gerarchia dei valori astrattamente tutelati dal diritto penale rappresenta l’idea di libertà dominante nella società (se non sulla società); le procedure e i risultati dei processi di criminalizzazione rappresentano le condizioni reali delle libertà in quel determinato contesto. Per me il carcere è essenzialmente questo: il deposito reale della dimensione simbolica del penale e ci fa vedere quel che la società esclude, i diritti non garantiti, le libertà dimidiate.
Nei tuoi studi hai dato conto dell’evoluzione del sistema penale e hai messo in luce il nesso tra la struttura politico-economica della società, le leggi penali e il carcere. Come è evoluto il complesso delle leggi penali e del sistema carcerario, dal welfare state all’attuale «populismo penale»? E in cosa esattamente consiste quest’ultimo?
Nel secondo Novecento europeo-occidentale, l’affermazione dello Stato sociale di diritto, con il suo corredo di diritti riconosciuti su base universalistica, non solo consentiva di distinguere nettamente il condannato dal suo reato e quindi dalla sua pena, ma soprattutto di immaginare le forme e i luoghi di esecuzione della pena, a partire dal carcere, come luoghi di recupero e di reintegrazione di una devianza concepita innanzitutto come effetto di disfunzioni sociali. L’idea rieducativa inscritta nella nostra Costituzione, laicamente intesa come offerta di opportunità per il reinserimento sociale di persone svantaggiate, è tutta den-



tro questa idea della universalità dei diritti e della responsabilità sociale delle istituzioni pubbliche.
La svolta neoliberale di fine Novecento, invece, ha messo in discussione proprio quelle premesse: l’universalismo dei diritti fondati sulla dignità di ciascuna persona umana in quanto persona e la responsabilità pubblica nel comportamento deviante. Ne è seguito, insieme al progressivo smantellamento del welfare state novecentesco, l’affermazione di un universalismo ristretto ai capaci e meritevoli e la piena responsabilizzazione individuale – innanzitutto penale - del comportamento deviante, di qualunque comportamento deviante. Qui si inserisce il populismo penale, o – come io preferisco dire – l’uso populista del penale. L’affermazione della svolta neoliberale ha accompagnato la cd. seconda globalizzazione, quella di fine Novecento, che ha visto esaurirsi le capacità della politica degli Stati infracontinentali nella regolazione dell’economia. Nella libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi, agli attori politici statali non è rimasto altro che garantire il benessere possibile per le maggioranze e confinare le minoranze, interne o migranti, attraverso riduzioni di status e internamenti, penali o amministrativi. In questo contesto si affermano le ideologie e i movimenti populisti, capaci di produrre mobilitazione e consenso politico nella contrapposizione ai «nemici del popolo», senza che sia messa in discussione la distribuzione ineguale delle risorse a livello planetario e interno ai singoli ordinamenti giuridici.
In questa forma di «democrazia passiva», in cui i cittadini sono chiamati non a partecipare, ma a manifestare periodicamente il proprio consenso agli attori politici che si propongono di governare le turbolenze di un sistema economico-sociale fuori dal proprio raggio di azione, il penale si presenta come uno straordinario strumento, forte del suo capitale simbolico, dato dalla sua ambivalente origine nei culti sacrificali: un ceto politico che non riesce più a governare i fondamentali dell’economia e del benessere sociale consolida o afferma il proprio status attraverso l’individuazione di capri espiatori intorno al cui sacrificio reale o



immaginario mobilitare il consenso delle labili maggioranze su cui si basano le nostre democrazie.
Quali sono i maggiori vizi del sistema penale attuale nella patria di Cesare Beccaria?
Dal mio punto di osservazione, il problema principale del sistema penale italiano è che tende a occuparsi di tutto, costruendo una ideale cassetta degli attrezzi repressivi applicabile per una gran parte dei comportamenti umani. A questa tendenza letteralmente «panpenalista» segue un inevitabile tasso di discrezionalità nei fatti riconosciuta agli apparati, siano essi di polizia che inquirenti, che possono scegliere con un sensibile arbitrio cosa perseguire e cosa no. Nel processo, poi, non è assicurato il diritto di difesa pure previsto dalla Costituzione. O meglio: è assicurato astrattamente, attraverso la libera rappresentanza da parte di avvocati di fiducia, mentre concretamente la gran parte delle persone sottoposte a indagini e chiamate a giudizio non hanno un’adeguata tutela dagli istituti previsti a tale scopo, il gratuito patrocinio e la difesa d’ufficio. In fase di esecuzione penale, poi, nella grande maggioranza dei casi l’amministrazione penitenziaria e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte non garantiscono un’adeguata offerta finalizzata al reinserimento sociale in condizioni di autonomia e legalità, producendo – di fatto – un aggravamento delle condizioni soggettive che hanno portato in carcere gli autori di reato, incrementando il rischio di recidiva. Un sistema sostanzialmente fallimentare, che sta in piedi soltanto perché le sue vittime in gran parte non hanno voce e diritti.
Una parte considerevole della popolazione carceraria in Italia è composta da detenuti che scontano pene inferiori ai 10 anni. Quanto potrebbe incidere una seria politica di depenalizzazione dei reati sul problema del sovraffollamento carcerario?



Quello della depenalizzazione è un mantra ripetuto da tutte le persone ragionevoli e anche da quelle che non lo sono quando vogliono provare a dire cose ragionevoli. Qualche volta ci si è anche provato, salvo poi rimangiarsi le scelte compiute (celeberrima la depenalizzazione dell’oltraggio a pubblico ufficiale nel 1999, ripenalizzata nel 2009 e che oggi – visti i contenuti del dl sicurezza – potrebbe diventare addirittura un reato ostativo ai benefici penitenziari). Ma se si vuole affrontare quello che Massimo Pavarini chiamava «il diritto penale della prigione», quello che produce incarcerazione, bisognerebbe depenalizzare innanzitutto la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti, che costituisce la causa di incarcerazione di un terzo della popolazione detenuta.
Il disagio sociale e lo scarso tasso di istruzione di una parte della società sembra avere una stretta relazione con la criminalità. È così ingenuo pensare che una politica maggiormente inclusiva e di redistribuzione delle risorse economiche, unita a un nuovo impegno per elevare il livello di istruzione di alcune categorie di cittadini (per esempio, gli stranieri) possano essere misure preventive ancora efficaci nel combattere la criminalità? Il dibattito massmediatico attuale sembra spesso più concentrato sulle soluzioni che prospettano l’eliminazione dei «criminali» piuttosto che su quelle volte a sradicare le cause che li producono…
Non c’è dubbio che una parte della devianza è frutto di condizioni di vita marginali, in cui l’istruzione superiore e il lavoro legale continuano a essere preclusi a segmenti importanti della cittadinanza, ma quella che una volta si chiamava «prevenzione primaria» sembra uscita dai radar delle politiche di sicurezza. Eppure, se poi si vuole fare reinserimento sociale nella legalità all’esito delle pene proprio questo va fatto: offrire opportunità di istruzione, formazione e lavoro. Perché allora non investire prima, piuttosto che esporsi alla facile critica di chi dice che bi-



sogna andare in carcere perché lo Stato ti aiuti? (ammesso che lo faccia…)
Per gli stranieri la questione è ancora diversa: se non gli si offre la possibilità di soggiorno legale in Italia è inevitabile che per mantenersi e mandare a casa le rimesse debbano lavorare nel migliore dei casi in nero, nei peggiori al servizio delle organizzazioni criminali. E così per i minori stranieri non accompagnati: se si smantellano le reti territoriali di accoglienza, è prevedibile che siano accolti da chi pensa di sfruttarli nello spaccio di strada.
In una delle tue opere recenti, Le pene e il carcere*, hai dedicato ampio spazio alla spiegazione del nesso esistente tra la questione della sicurezza e le politiche penali, mettendo in luce come il bisogno crescente di sicurezza, e in specie di sicurezza penale, sia legato alla «solitudine del cittadino globale», più libero rispetto al passato ma «privo di reti di protezione». Puoi illustrare questo punto, davvero fondamentale per comprendere quel «desiderio di carcere» che si è fatto sempre più insistente negli ultimi anni?*
È stato il grande sociologo anglo-polacco Zygmunt Bauman a evidenziare come nel nostro tempo si sia realizzato il rovesciamento del disagio della civiltà moderna individuato da Freud nella penuria di libertà: come allora, in una società orientata a produrre sicurezza, la domanda sociale era orientata alla libertà individuale; oggi, in una società fondata sulla libertà individuale, il bisogno di sicurezza torna in primo piano. Il problema poi è che siccome il modello sociale neoliberale è fondato sulla erosione delle forme pubbliche di garanzia dei diritti sociali, inevitabilmente il bisogno di sicurezza viene anch’esso declinato in forme individualistiche, come prevenzione dal rischio di vittimizzazione e non più come domanda di protezione sociale universalistica. Facile, a questo punto, per gli imprenditori politici della paura farne un asset strategico di consenso attraverso l’uso populistico del penale.



Nella medesima opera, scrivi che «i diritti dei detenuti presi sul serio costituiscono un principio di erosione dell’istituzione carceraria tanto quanto essa ne è naturalmente refrattaria». A che punto è questa lotta di erosione, a favore dei diritti dei detenuti, in Italia, oggi?
È una lotta che si fa sul campo, palmo a palmo, in un contesto mai così difficile. Eppure, ogni tanto, qualcosa passa e se riesce a essere sostenuto, giorno per giorno, in ogni istituto, può erodere l’idea segregativa dell’istituzione penitenziaria. Penso per esempio alla sentenza della Corte costituzionale dello scorso anno, con cui è stato riconosciuto il diritto alla sessualità delle persone detenute. Nell’ideologia segregativa del penitenziario il sesso è vietato o coatto, non certamente qualcosa legato alla libera espressione di soggettività della persona detenuta. Per questo l’Amministrazione penitenziaria ha resistito più di un anno per dare attuazione a quella sentenza: perché le sue culture più retrive non potevano tollerare che le persone detenute, proprio come noi, potessero vivere liberamente una cosa così intima come la sessualità. Oggi finalmente il passo è stato fatto e i primi incontri riservati dei detenuti con i propri partner si sono svolti: questo cambierà il modo di vivere la detenzione, il rapporto con le proprie famiglie e il riconoscimento della dignità dei detenuti da parte degli operatori penitenziari. La fatica di questo risultato dà la misura di un’altra piccola erosione che si è realizzata: non per tutti, non per sempre, ma si è realizzata.
Come collochi la battaglia condotta contro il 41 bis due anni or sono da Alfredo Cospito? Che effetto ha avuto a tuo avviso sull’opinione pubblica? Pensi sia servita a sensibilizzare almeno una parte della cittadinanza su una misura così estrema quale è appunto il 41 bis?
È stata una battaglia importante, che ha suscitato attenzione e consapevolezza in una buona parte dell’opinione pubblica che



prima viveva il 41bis come l’hic sunt leones della tradizione coloniale. Si è preso consapevolezza che misure di estremo rigore, chiaramente lesive di diritti fondamentali della persona, si giustificano solo se assolutamente necessarie, in casi eccezionali e per una durata limitata nel tempo. Tutto ciò che il 41bis, per come è scritto e come viene applicato, di fatto non fa. Bisognerebbe riprendere quella battaglia e continuarla: perché, per esempio, le competenti commissioni parlamentari non fanno un’indagine conoscitiva su come il 41bis è effettivamente applicato? L’ex-Garante nazionale e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura l’hanno fatto più volte, perché il Parlamento non torna sull’indagine della Commissione diritti umani del Senato nella XVII legislatura, presieduta da Luigi Manconi, e non la aggiorna?
Parlando di pene disumane, non si può non ricordare che nel nostro ordinamento penale è tutt’ora in vigore quella pena di morte a vita che è, di fatto, l’ergastolo, che coinvolge in Italia molte centinaia di detenuti. L’aumento degli ergastolani nelle carceri italiane è davvero impressionante, da qualche centinaio all’inizio degli anni Novanta ai quasi 2000 attuali. Il caso di Carmelo Musumeci sembra però evidenziare che sono ancora possibili degli spazi di libertà nel sistema penale, persino per i detenuti sottoposti all’ergastolo ostativo. Qual è il tuo punto di vista sull’argomento?
Conosco bene il caso di Musumeci, che ho seguito per Antigone, dal Ministero, quando ero a capo della segreteria di Luigi Manconi sottosegretario alla giustizia, e poi da docente, essendone stato correlatore della laurea magistrale a Perugia. Carmelo i suoi spazi di libertà è stato innanzitutto capace di costruirseli da solo, per molti anni pagando anche in prima persona la sua continua (e legittima) rivendicazione di diritti. Poi, grazie a un’ottima difesa e a un tribunale pronto a prendersi le sue responsabilità, è riuscito a uscire dal vicolo cieco dell’ergastolo ostativo. Purtroppo non è così per tutti, e neanche per molti. Anzi: la titubanza



della Corte costituzionale a dichiarare l’illegittimità dell’ergastolo ostativo ha dato il destro a Governo e Parlamento di varare nel 2022 una revisione della normativa forse ancora più rigida che in passato per cui credo che non si possa smettere di chiedere di superare questo istituto che, di fatto, viola l’articolo 27, comma 3 della Costituzione, sia perché tradisce la finalità rieducativa della pena, sia perché la pena senza termine costituisce di per sé un trattamento contrario al senso di umanità.
Tu scrivi che «i concreti sistemi penali di cui l’umanità fa esperienza non hanno alcuna obbligata naturalità, né sono il prodotto conseguente di una razionalità astratta, ma sono intimamente legati alle concrete modalità del vivere sociale e delle sue capacità autoriflessive». La battaglia abolizionista del sistema penitenziario è un antico cavallo di battaglia dell’anarchismo e del pensiero libertario di fine Ottocento e inizio Novecento. Essa ha avuto un nuovo sussulto alla fine del secolo scorso, ma trova ancor oggi alcuni illustri sostenitori. Pensiamo al recente volume di Giuseppe Mosconi, Decostruire la pena. Per una proposta abolizionista*, che fa leva su un tema molto discusso recentemente, quello della giustizia riparativa. Credi davvero che, in tempo di populismo penale, sia possibile un salto di paradigma così forte? O non è realisticamente più opportuno mirare a una riforma del sistema penale, che sia in grado di eliminare o contenere le sue più rilevanti storture?*
Io penso che sia necessario innanzitutto distinguere l’abolizionismo penale da quello penitenziario. Su questo secondo versante non c’è veramente più molto da dire: il carcere come luogo di esecuzione delle pene è una istituzione storicamente determinata di cui potremmo fare a meno scommettendo sulle molte altre forme di restituzione del debito che gli ordinamenti giuridici contemporanei già conoscono, ma che oggi sono riservati agli autori dei reati meno gravi e ai ceti sociali benestanti. Prati-



cando quotidianamente gli spazi stretti del diritto per garantire dignità e diritti alle persone incarcerate, mi muovo invece con cautela sul piano dell’abolizionismo penale, che porterebbe con sé anche la fine delle garanzie che il sistema penale riserva agli indagati, agli imputati, ai condannati e ai detenuti. Ma siccome il superamento di qualunque istituzione è, innanzitutto, una storia di pratiche, è inutile stare a parlarne in astratto: vediamo se e come la giustizia riparativa e le altre forme di giustizia relazionale saranno capaci di sottrarre materia del contendere alla tradizionale giustizia autoritativa, senza rinunciare nel frattempo alle garanzie che quest’ultima può continuare a riservare a chi sia chiamato a rispondere davanti a un giudice delle proprie azioni e dei propri comportamenti.




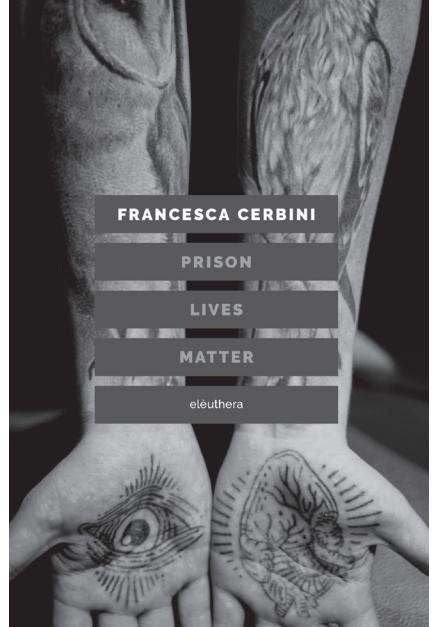




NEGATIVITÀ E POSITIVITÀ DELL’ANARCHISMO. UN INESTRICABILE MA CONTRADDITORIO DUALISMO
Tomás Ibáñez
Quando ho acceso il computer per iniziare a scrivere questo testo, sono stato tentato di intitolarlo: «Elogio ardente della negatività dell’anarchismo», poiché il mio scopo era proprio quello di riflettere su quella dimensione inevitabile, e spesso sottovalutata, dell’anarchismo. Tuttavia, mi sono subito reso conto che questo mi costringeva a mettere da parte molto di ciò che costituisce l’anarchismo: in particolare, rimaneva marginalizzato tutto quell’aspetto positivo che lo definisce. Quindi, per porre rimedio a questa sfortunata amputazione, non ho avuto altra scelta che intraprendere la scrittura di un secondo articolo, questa volta intitolato: «Entusiasta apologia del sogno anarchico e delle sue intermittenti forme di realizzazione». Ora, poiché il mio impegno era quello di consegnare un unico articolo a Redes Libertarias, alla fine ho deciso di abbandonare quel primo titolo e di fondere entrambe le riflessioni in un unico testo. Sarebbe inutile raccontare qui questo aneddoto, tipico della sfera privata di chi scrive e privo del minimo interesse sostanziale, se non fosse perché la scelta di unire le due riflessioni ha avuto per me l’effetto benefico di mettere in luce la natura intrinsecamente dilemmatica dell’anarchismo stesso. In effetti, da quando ho preso quella decisione, ho iniziato a percepirlo come un’entità simile alla divinità bifronte nota come Giano nell’antica Roma, dotata di due volti diametralmente opposti, ma indissolubilmente uniti.

La radicale negatività anarchica
Per illustrare la negatività anarchica, possiamo fare riferimento a Michail Bakunin, che vedeva nella «passione per la distruzione una passione creativa», o a Max Stirner, che riteneva che «l’elimi-
nazione delle idee fisse» (i suoi famosi spettri), che permeano le nostre menti, fosse la condizione per distruggere la nostra docile sottomissione all’esecrabile autorità dell’ordine costituito. Ora, a parte questi riferimenti storici, questa negatività si basa, a mio parere, su due delle diverse caratteristiche fondamentali dell’anarchismo. Il primo consiste nel rispetto scrupoloso dell’autonomia degli individui e dei gruppi, nonché del principio inalienabile di auto-organizzazione. Che nessuno pensi o decida per te, che nessuno
organizzi la tua vita o la forma della tua lotta, sono espressioni che risuonano fortemente nella sfera anarchica. Questo rispetto porta l’anarchismo a respingere in modo inequivocabile ogni tentazione di iniettare dall’esterno i principi che devono guidare le lotte, le forme che devono assumere, gli obiettivi che devono perseguire. Tutti questi elementi devono formarsi all’interno delle lotte stesse ed essere opera diretta dei loro protagonisti, senza che nulla provenga dall’esterno per canalizzarli (nemmeno l’anarchismo stesso). Questa è la condizione necessaria per non violare la piena autonomia di quanti si ribellano ai dispositivi di dominio, oppressione e sfruttamento che governano le nostre società. Risulta inoltre che, se l’autonomia è veramente valoriz-



zata, come l’anarchismo si propone di fare, non si può ignorare che l’autonomia si ottiene solo praticandola, e che questa peculiarità impedisce qualsiasi tipo di intervento esterno al processo autonomo stesso. L’autonomia è parte integrante dell’azione che si propone di conseguirla, ovvero l’autonomia non può essere conseguita in nessun altro modo se non attraverso il suo stesso esercizio. Rispettare l’autonomia di chi dirige le lotte implica quindi il rifiuto di ogni avanguardismo o dirigismo e richiede di astenersi dal formulare proposte positive (siano esse organizzative, di definizione di obiettivi o di definizione di modalità di azione) che non nascano dalla lotta stessa.
Partendo da queste considerazioni di base, non resta che impegnarci a contribuire allo smantellamento dei meccanismi e degli strumenti di oppressione che impediscono l’esercizio dell’autonomia, senza introdurre in tale esercizio i nostri quadri, principi e obiettivi, poiché questi sono stati predefiniti in altri contesti e in altre circostanze storiche. L’anarchismo si presenta così come uno strumento di distruzione dell’esistente, consentendo alle pratiche sviluppate nelle lotte di dare forma ad alternative, conquiste materiali e principi generali, tracciando gradualmente, attraverso pratiche situate, il percorso da seguire. Ciò non significa che quando gli anarchici si impegnano in una lotta debbano lasciare le proprie armi, idee e proposte fuori dal campo di battaglia: le portano con sé e sarebbe assurdo chiedere loro di abbandonare il loro modo di pensare, di essere e di agire. Si tratta semplicemente di lasciarsi trasportare il più possibile dalle dinamiche che la lotta richiama, anziché cercare di indirizzarla con decisione, poiché c’è sempre la possibilità di ritirarsi da essa se, a un certo punto, entra in conflitto con le proprie convinzioni e presupposti.
La seconda caratteristica fondamentale dell’anarchismo, in relazione al tema qui affrontato, si fonda sul suo rifiuto radicale di riprodurre ciò che intende combattere, cioè di generare a suo modo effetti di dominio e meccanismi di oppressione. Per usare un’espressione che devo al compagno Rafa Cid, per essere coe-



rente con le sue premesse l’anarchismo deve essere letteralmente indominante, cioè privo degli effetti del dominio. Ora, nella misura in cui siamo pienamente immersi e immerse nel sistema che stiamo combattendo, è inevitabile che esso lasci nel nostro modo di essere e nelle nostre proposte certe tracce di ciò che lo caratterizza. Ciò significa che è difficile impedire che la logica del dominio lasci il suo segno su ciò che pensiamo e costruiamo, perché lo facciamo sempre dall’interno del sistema in cui viviamo. Formulazioni e implementazioni radicalmente estranee al sistema esistente e contrarie alle sue caratteristiche possono na-
scere solo da ciò che esso non controlla né contamina. In altre parole, il nuovo, la creazione radicale, emerge in spazi che sfuggono al sistema, e ciò significa che questo «nuovo mondo che portiamo nei nostri cuori» può essere concepito e può emergere solo dall’esterno del sistema che combattiamo, cioè dalle sue rovine. Di conseguenza, il compito dell’anarchismo è quello di provocare il crollo del sistema, riducendolo a semplici rovine su cui possono germogliare fiori davvero diversi, il che lo colloca chiaramente nell’ambito della negatività radicale. Per questo dice-
vo che ciò che abbiamo la capacità di proiettare prima di aver distrutto ciò che esiste, poiché si forma in ciò che proiettiamo, ne porterà sempre i segni. Per questo motivo Max Stirner sosteneva la sostituzione del concetto di rivoluzione, volto a promuovere una forma sociale sostitutiva di quella esistente, con il concetto di insurrezione permanente contro l’ordine costituito. Un’insurrezione che non cerca di rovesciare l’istituzione sociale attuale e sostituirla con una nuova istituzione sociale emergente



da un’ipotetica rivoluzione, ma piuttosto si limita ad attaccare in ogni momento quella esistente, che risulta insopportabile. Sia che consideriamo la prima delle due caratteristiche dell’anarchismo che ho menzionato, sia che prendiamo in considerazione la seconda, è chiaro che l’anarchismo pone al centro del tavolo la resistenza al sistema vigente, lasciando che questa resistenza al potere costituito crei le condizioni per costruire, sulle rovine di ciò che è stato abbattuto, le linee guida di valori diversi da quelli esistenti e di forme sociali alternative a quelle vigenti. Ciò di cui l’anarchismo è responsabile in questo processo è, fondamentalmente, contribuire alla distruzione dell’ordine costituito e continuare a praticare la resistenza non appena siano state stabilite forme sociali alternative. Queste, tra l’altro, non sono prefigurate nell’anarchismo, ma saranno alla fine create dalle lotte autonome stesse nel processo di distruzione del capitalismo.
L’imprescindibile sogno anarchico
È certamente il secondo volto dell’anarchismo a spiegare perché ispira tanto fervore a tutti quelli che si sentono nelle sue corde, in contrasto con la sua ostinata negatività, intimamente legata ai principi che lo definiscono. La gioia di sentirsi parte di una straordinaria tradizione di lotta e di una magnifica esperienza storica che ignora i confini e trascende le culture è importante per la nostra autodefinizione in quanto anarchici, tanto quanto lo sono l’insieme degli scritti libertari che forgiano la nostra identità e plasmano una cultura condivisa, o le pratiche di solidarietà e sostegno reciproco che tessono lo spazio libertario. Non importa quanto insormontabili possano sembrare gli ostacoli che l’utopia che ci ispira deve affrontare, la speranza di superarli alla fine è fondamentale per incoraggiare lo spirito di lotta e persino per mantenere l’intensità della resistenza. Sebbene la negatività venga identificata come la prospettiva più coerente dell’anarchismo, è pur vero che lottare per qualcosa e non solo contro qualcosa,



così come perseguire obiettivi e cercare di far sì che altri li condividano, dà un forte impulso alle lotte e gli conferisce un tono diverso, molto più conviviale e ottimista di quello che emana dalla pura negatività.
Costruire e vivere nel presente alcuni aspetti del sogno anarchico, sperimentare l’empatia tra compagni e compagne nel calore di idee e desideri condivisi, sentire l’unità nello sviluppo di progetti comuni e l’entusiasmo di partecipare alla loro realizzazione: tutto questo è insostituibile nella configurazione dell’anarchismo. Immaginare ciò che non esiste, ma che potrebbe realizzarsi, e accarezzare le promesse che si annidano nell’utopia, sono elementi che contribuiscono a forgiare un’identità che ci fa sentire parte di una comunità sincera, nella quale ci immergiamo per nostra scelta e decisione, e non in base a obblighi legali, lavorativi, nazionali, di genere o familiari, tra le tante altre fonti di determinazioni attribuite. Ora, è possibile che quegli aspetti dell’anarchismo, che in ultima analisi sono ciò che motiva in larga misura la nostra affinità con i suoi postulati e la sua proposta, potrebbero rivelarsi contraddittori rispetto alla negatività
essenziale dell’anarchismo? Potrebbe essere che l’istituzione di principi, la definizione di scopi, l’elaborazione di modelli di società, la costituzione di un’identità specifica, la formazione di una cultura propria, con i suoi simboli, la sua memoria, le sue figure emblematiche, ecc. mettesse in discussione il suo carattere indominante, facendo sì che quando il sogno anarchico si impegna in una lotta, esso faccia saltare la piena autonomia di coloro che lo hanno intrapreso?



Per giungere a una conclusione incerta
Sembra abbastanza chiaro che la negatività anarchica, da un lato, e l’inebriante sogno anarchico, dall’altro, non rappresentano semplicemente aspetti diversi della stessa entità. Non si tratta di elementi distinti, bensì di elementi complementari, anzi di aspetti chiaramente antagonisti. In realtà, la negatività e il sogno anarchico sono semplicemente incompatibili. In altre parole, il sogno anarchico si oppone proprio a ciò che la negatività anarchica persegue e le rende impossibile raggiungere i suoi obiettivi di preservazione dell’autonomia delle lotte e dei collettivi protagonisti. All’inserirsi nelle lotte con le sue valide e preziose prerogative, è chiaro che l’anarchismo inietta in esse principi sviluppati al di fuori di esse. In breve, il sogno anarchico sfida la natura indominante dell’anarchismo, portandolo a contraddire i suoi stessi principi antidirigisti e il suo impegno radicale per l’autonomia. La negatività anarchica, da parte sua, marginalizza completamente e praticamente elimina tutto ciò che rende l’anarchismo attraente e ricco, considerando che il sogno anarchico è ben lungi dall’essere indominante, ed è, per così dire, insufficientemente anarchico. Sembra quindi che l’unica cosa possibile sia riconoscere la natura intrinsecamente dilemmatica dell’anarchismo e constatare che al suo interno coesistono due entità chiaramente antagoniste e innegabilmente contraddittorie. Tuttavia, ciò che è contraddittorio non deve essere screditato e respinto per principio, poiché la logica aristotelica non si basa su alcun mandato imperativo e assoluto. Oltre all’esistenza di altri tipi di logica (e ce ne sono…), è anche importante tenere presente che certe realtà possono essere allo stesso tempo antagoniste e simbiotiche (potere e libertà illustrano perfettamente questa figura). Forse la ricchezza dell’anarchismo sta proprio nel saper mantenere la tensione costante tra le sue due dimensioni, supponendo che sia proprio la contraddizione che ne deriva a preservarlo dal cadere nella placida immobilità delle cose non problematiche o che si presentano come tali. L’anarchismo è ciò che vive e si muove nel



punto preciso in cui si genera la tensione tra queste due dimensioni irrimediabilmente opposte, ma intimamente intrecciate, del desiderio di vivere collettivamente liberi e, al contempo, del desiderio di vivere radicalmente indominanti. È proprio l’incapacità di mantenere viva questa tensione che porta buona parte dell’anarchismo a sottovalutare l’importanza della negatività che lo caratterizza e a privilegiare quello che qui ho chiamato il sogno anarchico. Tuttavia, si scopre che concentrarsi sul sogno anarchico porta a una certa frustrazione di fronte all’evidenza
che la sua realizzazione può avvenire solo, e solo parzialmente, in spazi relativamente piccoli e in numero limitato. Questa frustrazione, che non necessariamente porta a rifugiarsi nell’inazione, a volte porta alla ricerca di capri espiatori invece che a un’analisi serena delle ragioni di questa stagnazione e a una certa autocritica di fronte ai propri difetti. Nella misura in cui il poststrutturalismo, concettualizzato, tra gli altri, da Michel Foucault, Gilles Deleuze o Jacques Derrida (da non confondere né con la progenie americana della teoria francese, né con il vuoto del postmoder-
nismo) ha messo in difficoltà alcuni postulati che l’anarchismo ha ereditato dall’Illuminismo, come, tra molti altri, e per citare solo due esempi, la fede nelle grandi narrazioni o la fiducia nel progresso, è stato abbastanza facile fare del poststrutturalismo e dei suoi pensatori il capro espiatorio responsabile di questa stagnazione e dell’indebolimento del vigore della lotta di classe e della frammentazione dei fronti di lotta. La cosa preoccupante


Traduzione di Valeria Giacomoni

è che questa attenzione alla ricerca di capri espiatori ci impedisce di vedere che i drastici cambiamenti vissuti dal capitalismo e dalle società da esso plasmate rendono inefficaci alcuni modelli di confronto con il sistema a causa della loro natura obsoleta e causano la stagnazione di coloro che vi si aggrappano. Analizzare attentamente questi cambiamenti è la prima condizione per inventare e articolare nuove forme di lotta che smantellino il sistema costituito e aprano la strada verso un altro stile di vita, più vicino al sogno anarchico.
Pubblicato su «Redes Libertarias» n.2 (2024), Madrid, pp. 5-9 https://redeslibertarias.com/2025/03/11/sobre-la-negatividad -y-positividad-del-anarquismo-hoy/




La rivoluzione spagnola del 1936 si caratterizza per essere un movimento di massa, che non consegna alla storia grandi pensatori o teorici, bensì l’azione collettiva di una parte della popolazione dopo trent’anni di diffusione culturale e crescita del sindacato anarchico della CNT. Nella memoria collettiva, per una volta, rimangono gli eventi (le collettivizzazioni, l’entrata degli anarchici nel governo, ecc.) e non tanto i personaggi, tranne qualche militante di spicco. Tra questi troviamo Federica Montseny, che potremmo definire come esponente di un anarchismo culturale ma rivoluzionario, concetto molto caro a questa rivista.
La Montseny, capace con la sua personalità e le sue scelte di affermarsi in un contesto prevalentemente maschile di compagni rivoluzionari, si dedica soprattutto a scardinare stereotipi e pregiudizi. I suoi meriti stanno quindi nella diffusione di nuovi modelli di relazione, tema fondamentale all’interno di un pensiero che si propone di cambiare il mondo. Federica con la sua vita dimostra a tante donne dell’epoca che «è possibile» avere la stessa considerazione di un uomo, e si prodiga per diffondere pratiche di emancipazione, dalla famiglia (tramite l’educazione) dal matrimonio (predicando l’amor libre, in quanto libera unione consapevole al di fuori del-

109


le istituzioni), dalla maternità (come scelta consapevole). Grande oratrice, la sua voce è una delle più importanti dell’anarchismo spagnolo negli anni della rivoluzione, ed è una voce di donna.
Figlia di una maestra laica, Teresa Mané e dell’anarchico Joan Montseny, fondatori di vari progetti culturali tra i quali La Revista Blanca (1898-1905), periodico che contava illustri collaborazioni nazionali e internazionali, del calibro di Eliseé Reclus e Lev Tolstoj. I suoi genitori furono coinvolti nel processo di Montjuic del 1898 a Barcellona, forte repressione contro il movimento anarchico dopo una serie di attentati, che fece conoscere al mondo quella che venne poi chiamata la «Seconda Inquisizione spagnola» e che portò poi alla fucilazione di Francisco Ferrer nel 1909. Vari degli autori che scrissero libri di testo per la Escuela Moderna erano collaboratori de La Revista Blanca. L’ambiente in cui nasce e cresce Federica fu quindi quello della Generación del 98, di intellettuali orientati verso un anarchismo culturale: con i genitori esuli a Madrid frequentò i caffè letterari dell’epoca e i circoli operai.
Il secondo periodo del La Revista Blanca (1923-36) iniziò invece sotto la dittatura di Primo de Rivera, in un periodo sanguinoso di scontri armati per il movimento operaio spagnolo in cui il Montseny si propone di imbracciare di nuovo le armi della cultura. Il titolo «neutro» della rivista (sottotitolata «Sociologia, scienza e arte») ne permette la pubblicazione e anzi, proprio cercando un mezzo per arrivare alla popolazione vista la sospensione di tante libertà, dal 1924 vengono pubblicati come supplemento dei brevi romanzi, la collezione de La Novela Ideal, che propongono storie di quotidianità ma con un’etica liberatoria, laica e basata su ideali libertari. È soprattutto la figura femminile e il suo ruolo a cambiare, e questi romanzi contribuiscono a sostenere l’immaginario collettivo verso l’emancipazione della donna. I primi romanzi pubblicati sono proprio di Federica, che inizia a collaborare anche con altre riviste confederali e ad occupare un posto di rilievo nel movimento, nonostante il suo essere donna. Queste pubblicazioni, considerate non di grande qualità letteraria, proprio per la loro semplicità ave-







vano il merito di trasmettere temi sociali e anticlericali ad un’immensa platea (con una tiratura tra le 10 mila e le 50 mila copie).
Federica, nella CNT dal 1923, entra anche nella FAI, organizzazione nata in clandestinità nel 1927 per dare alla CNT maggiore slancio operativo e si schiera con Durruti e García Oliver contro i “riformisti”, Pestaña e Seguí, nella doppia anima dell’anarchismo spagnolo. Soprannominata «la mujer que habla», compie lunghi tour di propaganda in tutta la Spagna, grazie alla sua presa sulla popolazione, soprattutto sulla parte femminile. Dal 1935 succede al padre nella direzione de La Revista Blanca e nel maggio 1936 le viene incaricata una missione di propaganda su educazione, emancipazione e lotta antifascista.
Dopo il golpe e i primi mesi di strenua lotta e riorganizzazione confederale, quando la CNT a novembre 1936 accetta di entrare nel governo, tra i quattro ministri troviamo Federica Montseny alla Sanità (che insieme a García Oliver alla Giustizia rappresentava la parte più rivoluzionaria della CNT). Senza entrare nel merito a posteriori delle scelte della CNT, i discorsi che Federica pronuncia in quei mesi concitati spiegano in dettaglio la coerenza e l’obiettivo delle loro azioni, conscia della difficoltà di poter comprendere dall’esterno la contraddizione della presenza di anarchici nel governo.
Come prima ministra donna in Spagna, si circonda di donne medico e cerca di migliorare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione, introducendo temi rivoluzionari come l’aborto e i «liberatorios de prostitución» che puntavano ad offrire alle ragazze un’occasione per l’emancipazione. Ma mentre nel governo si cercava un’unità antifascista, i fatti di Maggio 1937 a Barcellona portarono alla fine della breve estate dell’anarchia.
In esilio in Francia dal 1939, continuò il suo attivismo politico mantenendo incarichi nella CNT in esilio. Le viene criticata un’estrazione piccolo borghese e la scelta in esilio di allinearsi con il marito su un immobilismo politico, ma in questo profilo si intende



valorizzare il suo contributo alla causa della rivoluzione del 1936 come portatrice di un nuovo immaginario, grazie alle sue doti di oratrice e propagandista. Iconico rimane anche il suo discorso nel 1977 a Barcellona, in una gremita plaza de Espanya, quando la CNT sperava di riprendersi dopo quarant’anni di dittatura.
Bibliografia
Scritti di Federica Montseny
Mis primeros cuarenta años, Plaza y Janés, 1987.
Horas trágicas, La novela roja, Madrid, 1922.
El hijo de Clara, La Revista Blanca, Madrid, 1927.
La indomable, La Revista Blanca, Madrid, 1928.
Qué es el anarquismo, Biblioteca de divulgación politica, Editorial La Gaya Ciencia, Barcelona, 1976.
El éxodo. Pasión y muerte de españoles en el exilio, Edicions Galba, Barcelona, 1977.
Scritti su Federica Montseny
Cosmacini G., Federica Montseny. Una anarchica al governo della Salute, Editoriale Le Lettere, 2021.
Tavera S., Federica Montseny. La indomable, Temas de hoy, Madrid, 2005
Bookchin M., Los anarquistas espanoles. Los años heroicos 1868-1936, Numa Ediciones, 2001.
ERA 80, Els anarquistes, educadors del poble. La Revista Blanca (1898- 1905), Curial Edicions, 1977.
Gurucharri S., Federica Montseny. Luces y sombras, en Polémica 14/3/2013.
Aisa Pampols M., Federica Montseny: una intelectual de la FAI, febrero 2024.


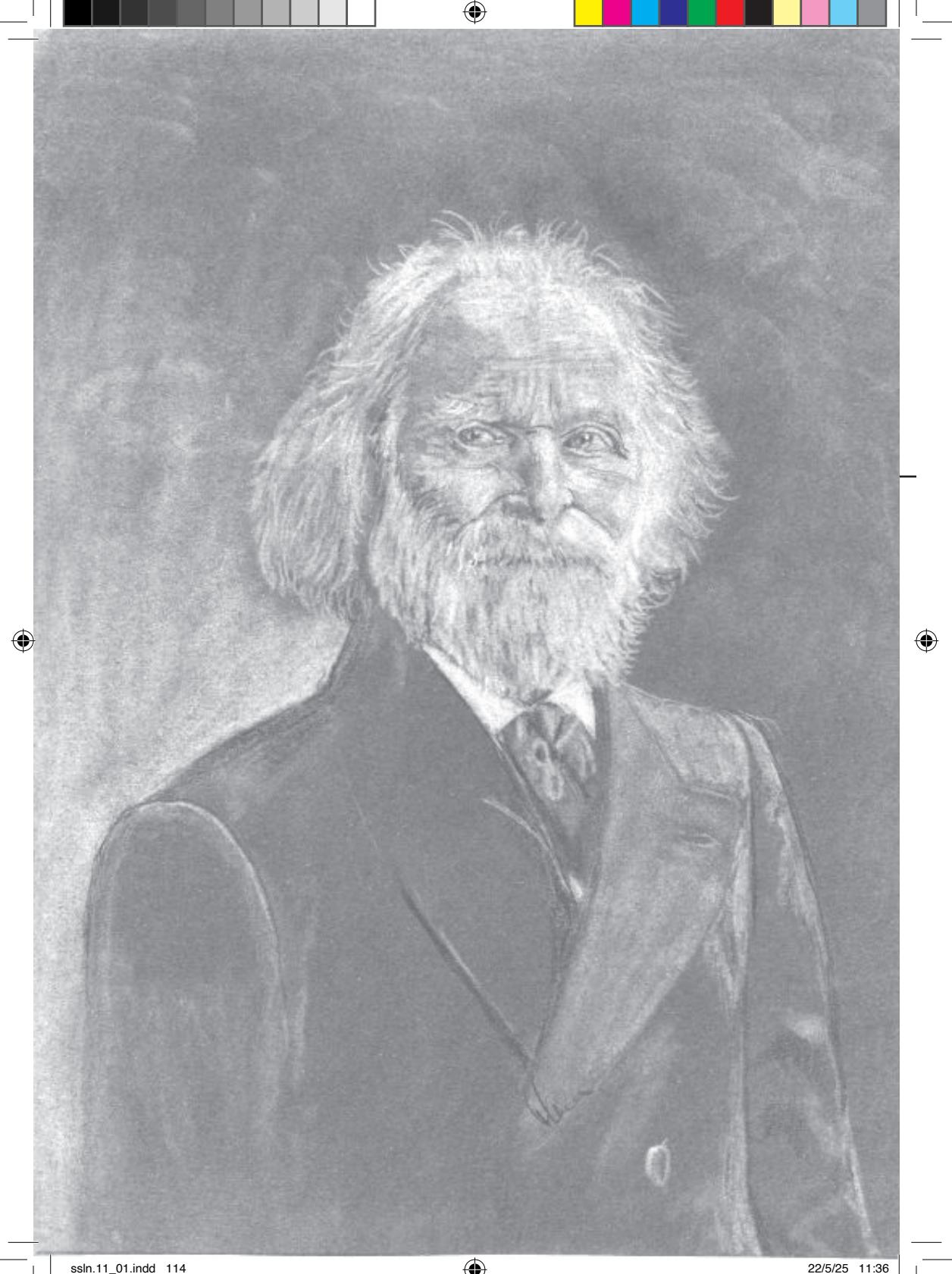

La straordinaria forza dei pensatori e delle pensatrici dell’anarchismo classico risiede nel fatto che, per quanto riguarda il nucleo centrale della loro elaborazione teorica, risultano contemporanei di tutte le età, in virtù dell’universalità e dell’integralità del messaggio di emancipazione sociale che promana dai loro scritti. Tra di loro, una particolare menzione merita il contributo di Élisée Reclus, che è stato in specie grande anticipatore del tempo presente, di alcune domande e inquietudini tra le più rilevanti che attraversano e scuotono la travagliata epoca che stiamo vivendo.
Qual è il posto dell’umanità in quella che un tempo era identificata come la «grande catena dell’essere», nella traiettoria dell’evoluzione naturale e nella storia della Terra e di tutte le forme di vita che la popolano? Quale relazione sussiste tra la scienza e le dottrine dell’emancipazione sociale, in primis l’anarchismo? Quale rapporto intercorre tra la lotta generale contro lo Stato e il capitale, contro il dominio politico ed economico, e lotte particolari, come quelle contro il patriarcato e il razzismo? Che valore assumono le esperienze libertarie cooperative di vita e di lavoro all’interno di una società strutturata su valori opposti?


115
Reclus non solo ha saputo interrogare il suo tempo con quesiti che risultano in molti casi attuali, ma ha anche elaborato risposte profonde che tutt’oggi costituiscono un riferimento imprescindibile per un pensiero libertario che si prefigge di essere critico e costruttivo. Eminente studioso, Reclus va annoverato tra i fondatori della corrente della geografia sociale. Va rilevato che due dei principali teorici dell’anarchismo classico, Kropotkin (1842-1921) e Reclus, geografo, naturalista e storico il primo, geografo con inclinazione per la storia e l’etnologia il secondo, furono studiosi le cui teorie scientifiche si intersecano profondamente con la loro concezione politica e sociale.
Nato in una famiglia protestante nella Francia sud-occidentale, Reclus rivelò ben presto uno spirito critico e ribelle, avvicinandosi successivamente al socialismo sansimoniano e fourierista. Sul piano scientifico, decisiva fu l’influenza di Carl Ritter (1779-1859), i cui corsi ebbe modo di seguire all’Università di Berlino.
Il colpo di Stato del 1851 di Luigi Bonaparte lo indusse ad abbandonare la Francia, insieme al fratello Élie (1827-1904), futuro antropologo e anarchico, come sarà anarchico e appassionato di geografia anche il figlio di questi, Paul (1858-1941). Iniziò allora, per Reclus, un lungo periodo di viaggi, che lo portò nelle Americhe. Qui, in Colombia, cercò, senza successo, di realizzare una comune agricola ispirata ai principi del socialismo.
Gli anni Sessanta risultarono ancor più decisivi nella biografia intellettuale di Reclus: nel 1869 diede alla luce la ponderosa La Terre e il divulgativo, ma geniale, Histoire d’un ruisseau, opere che incontrarono un largo successo. Ad esse seguirono, negli anni successivi, altri scritti, che consolidarono la fama di Reclus come geografo dotato di una sterminata cultura enciclopedica, capace di uno sguardo universale e in possesso di una notevole forza comunicativa: la Nouvelle géographie universelle,



scritta con la collaborazione di un nutrito gruppo di geografi e studiosi di orientamento anarchico e pubblicata, in 19 volumi, tra 1876 e il 1894; Histoire d’une montagne (1880) e L’Homme et la Terre, opera in sei volumi pubblicata postuma tra il 1905 e il 1908.
Su un piano politico, negli anni Sessanta Reclus si unì alla corrente libertaria del movimento operaio e socialista, divenendone un esponente di primo piano. Strinse amicizia con Bakunin (1814-1876) – di cui pronuncerà l’elogio funebre –, entrò nella Prima Internazionale, partecipò alla gloriosa esperienza della Comune di Parigi (1871) e alla costituzione del movimento anarchico. L’esilio svizzero che seguì alla sconfitta della Comune lo spinse a intrecciare legami profondi con gli internazionalisti anarchici della Federazione del Giura e gli permise soprattutto di entrare in relazione con Kropotkin, pensatore con cui ebbe un grande sodalizio scientifico, politico e umano, concretizzatosi nella collaborazione all’edizione di diverse opere e incentrato intorno alla valorizzazione del principio etico e scientifico del mutuo appoggio, alla rilevanza attribuita agli elementi di libertà e cooperazione emersi nella storia e alla formulazione della dottrina del comunismo anarchico.
Il pensiero di Reclus, sviluppato in migliaia di pagine di scritti scientifici e divulgativi, geografici e politici, e contraddistinto dalla volontà di dar conto di una storia universale del genere umano nel tempo, nel suo complesso intreccio con l’ambiente geofisico, capace di metterne in rilievo gli elementi di unità, come quelli di diversità, presenta forti tratti di originalità, alcuni dei quali si intendono qui segnalare, sinteticamente, per punti.
Il primo aspetto attiene al rapporto tra uomo e natura. Precursore delle moderne dottrine ecologiste e in particolare della corrente ecologico-sociale sviluppata da Murray Bookchin (1921-2006), Reclus, da umanista libertario, ritiene



che l’umanità debba riconoscere a se stessa il ruolo di agente morale nei confronti del mondo naturale, da cui promana e di cui fa organicamente parte: «l’uomo è la natura che ha preso coscienza di se stessa», come recita la famosa formula con cui si apre L’homme et la Terre. Come ha osservato John Clark, per Reclus l’umanità deve giungere alla consapevolezza di rappresentare l’autocoscienza della Terra e deve perciò completare il processo storico di sviluppo di questa coscienza, con tutte le implicazioni etiche e politiche che ciò comporta: la costruzione di un mondo umano giusto e libero, nella storia e per la natura. La prospettiva di Reclus si distanzia in tal modo sia dalle correnti di pensiero che concepiscono l’umanità come un unicum nella storia della natura, sì da veicolare l’immagine di un essere umano superiore e completamente avulso rispetto a un mondo naturale ridotto a terra di conquista e saccheggio; sia da quelle teorie anti-umanistiche che profetizzano una sorta di bio-uguaglianza tra tutti gli esseri, non cogliendo la specificità dell’essere umano e i tratti che lo contraddistinguono, sul piano qualitativo e quantitativo, all’interno del mondo naturale di cui è parte: la libertà, la capacità di volere e di operare delle scelte consapevoli, sulla base di un presupposto etico e razionale. Entrambi questi approcci convergono nel deresponsabilizzare l’umanità nei confronti della natura. In particolare, il secondo ingenera la seguente riflessione critica: se l’uomo non si distingue qualitativamente dagli altri esseri che popolano il pianeta, perché, a differenza di questi, dovrebbe essere ritenuto responsabile delle sue scelte e in particolare di quelle che impattano negativamente sul mondo naturale?
La consapevolezza proto-ecologista sviluppata da Reclus nei suoi scritti è davvero prefiguratrice degli sviluppi recenti del pensiero ecologista: egli arriva a individuare nella «brutale violenza con cui molte nazioni hanno trattato la Terra nutrice» una delle cause del declino delle civiltà nel corso della storia



e già negli anni Sessanta del XIX secolo comincia a denunciare i pericoli connessi alla rottura dell’equilibrio ecosistemico a causa della depredazione del territorio naturale, per esempio attraverso la distruzione delle foreste: «Gli sviluppi dell’umanità si legano nella maniera più intima alla natura circostante, un’armonia segreta si stabilisce tra la terra e i popoli ch’essa nutre e quando le società imprudenti si permettono di metter mano su ciò che fa la bellezza del loro dominio, finiscono sempre per pentirsene». La sua concezione razionale e umanista non lo spinge tuttavia verso una visione antiscientifica e anti-tecnologica. Pur preconizzando gli sviluppi burocratici e tecnocratici della società moderna, Reclus è persuaso che la scienza e la tecnologia possano effettivamente essere poste al servizio dell’uomo e della natura. La concezione reclusiana della specificità della storia umana, unita alla convinzione che l’umanità debba porsi in una dimensione di convivenza cooperante col mondo naturale, è esemplificata dal ruolo e dal valore attribuito alla città nella storia della civiltà. «Dove le città crescono, l’umanità progredisce, dove diminuiscono, la civiltà stessa è in pericolo». Tuttavia, appare chiaro a Reclus che l’età contemporanea si contraddistingue per una «crescita mostruosa delle città», per un assorbimento dell’elemento rurale e naturale da parte di quello urbano: «Nel guardare le nostre città, che si espandono giorno per giorno e quasi ora per ora (…) si avverte una specie di brivido, come in presenza dei sintomi di una malattia sociale».
Altro punto significativo della dottrina filosofico-politica di Reclus è la sua concezione della storia umana, legata all’idea di progresso e di civilizzazione, che appare sorretta da una attitudine spirituale ragionevolmente ottimista ma non fideistica, distante sia dalle visioni nichiliste e catastrofiste, quanto dalle teorie ingenuamente o acriticamente apologetiche delle sorti magnifiche e progressive.



In tal senso, l’evoluzione e la rivoluzione gli appaiono come «due fatti» appartenenti a «uno stesso ordine, differenti solo per l’ampiezza del movimento (…). L’evoluzione precede la rivoluzione e questa precede una nuova evoluzione, generatrice di rivoluzioni future». La storia umana presenta sempre una natura intimamente contraddittoria, in conseguenza della complessità dei fenomeni sociali e fisici che ne caratterizzano le differenti manifestazioni. Se, per quanto riguarda le età passate, Reclus ritiene che lo sviluppo storico non sia avanzato sincronicamente verso un progresso indefinito, a causa della diversità della storia dei popoli e degli ambienti fisici nei quali si sono trovati ad interagire, per quanto riguarda l’età moderna e contemporanea esso tende verso una unificazione del genere umano e quindi verso la sincronizzazione dei tempi storici dei popoli e delle nazioni, elemento che favorisce il perseguimento del processo di emancipazione universale dell’umanità.
L’approccio dialettico e anti-manicheo porta Reclus a sottolineare, di molti fenomeni storici, la dimensione contraddittoria e antinomica: «Non esiste un avvenimento che non presenti due aspetti». Così, evoluzioni e rivoluzioni non sono necessariamente un progresso, giacché possono portare distruzione, declino e involuzione: la Rivoluzione francese, ad esempio, può essere ritenuta un avanzamento storico nella lotta per l’emancipazione dell’uomo, ma va anche considerato che ha prodotto il consolidamento dello Stato moderno. È sempre l’approccio dialettico a permettere a Reclus di predire l’involuzione autoritaria del socialismo, a individuare nei liberatori del presente gli oppressori del futuro.
Un ulteriore aspetto qualificante del pensiero di Reclus attiene alla valorizzazione del mutuo appoggio nella storia, che emerge politicamente in riferimento al comunalismo e su un piano economico-sociale con riguardo alle esperienze di proprietà comune delle terre. Sotto il primo profilo, Reclus è portato, come Kropotkin, ad esaltare la polis greca e il



comune medievale come esempi di pratica dei principi della democrazia diretta e partecipativa e del federalismo. Reclus osserva che «lo spirito associativo non è scomparso nei comuni, nonostante l’ostilità dei ricchi e dello Stato, che hanno tutto l’interesse a disfare questi nuclei di resistenza alla propria brama di potere e che tentano di ridurre la società a un insieme di individui isolati». Sotto il secondo profilo, egli si sforza di mettere in rilievo l’importanza dell’«antica proprietà comunitaria», delle consuetudini fondate sulla cooperazione e sull’utilizzo responsabile e in comune dei beni. La pratica della libertà, infatti, influisce «chiaramente sul carattere morale degli individui che sviluppano considerevolmente lo spirito di solidarietà, di gentilezza reciproca e di cordiale affabilità». Pur critico del movimento cooperativo sorto all’interno del socialismo, Reclus ritiene che esso abbia rivitalizzato l’idea della comunanza dei beni che era stato un fattore qualificante delle società precapitalistiche e reputa che debba essere ricavato «un grande insegnamento dalle numerose cooperative che sono sorte ovunque e si sono unite tra loro formando organismi sempre più vasti (…). La pratica scientifica del mutuo appoggio si diffonde e diventa facile; non rimane che darle il suo vero significato e la sua etica».
Infine, un aspetto rimarchevole del pensiero reclusiano risiede nell’accento posto sul legame tra la lotta generale contro il dominio politico ed economico, rappresentato dallo Stato e dal capitale, e le lotte particolari, che mirano a processi di liberazione specifici. Sotto questo profilo, nelle opere di Reclus si può rinvenire un attacco deciso alla concezione tradizionale e patriarcale della famiglia, di matrice aristotelica, quale sede del potere del marito sulla moglie, del padrone sullo schiavo e dei genitori sui figli. Abbracciando le istanze del nascente femminismo, Reclus si dichiara contrario a ogni forma di dominazione del maschio sulla femmina, a favore dell’abolizione di ogni forma di schiavitù e discriminazione fondata su basi razziali



e propenso alla valorizzazione dei diritti e delle necessità dei bambini all’interno di un percorso pedagogico incentrato sulla libertà e sul rispetto.
Dal pensiero di Reclus ricaviamo che il dominio dell’uomo sulla natura è connesso al dominio dell’uomo sull’uomo, e che il primo non può essere eliminato, senza procedere contemporaneamente con l’abolizione del secondo. L’età contemporanea ha visto certo l’affermazione degli Stati e del capitalismo, ma è stata anche teatro della crescita di consapevolezza della «libertà della persona umana». La speranza nella realizzazione dell’anarchia, intesa come la più alta espressione dell’ordine, si fonda sul fatto che essa non solo è un supremo ideale morale da perseguire, ma anche risponde a una necessità di riorganizzazione della società su basi egualitarie, capace finalmente di armonizzare natura e società: «per divenire veramente bella, la “madre benefica” attende che i suoi figli si siano abbracciati da fratelli e abbiano infine concluso la grande federazione degli uomini liberi».



Bibliografia
Scritti di Reclus
Anarchy, Geography, Modernity. Selected writings, a cura di J. Clark e C. Martin, PM Press, Oakland, 2013.
Les grands textes, a cura di C. Brun, Flammarion, Paris, 2014.
L’Homme et la Terre. Histoire contemporaine, Fayard, Paris, 1990.
L’Homme. Geografia sociale, a cura di P.L. Errani, Franco Angeli, Milano, 1984. Natura e società. Scritti di geografia sovversiva, a cura di J. Clark, elèuthera, Milano, 2022.
Storia di un ruscello, a cura di M. Schmidt Friedberg e F. Codello, elèuthera, Milano, 2020.
Storia di una montagna, Tatarà, Verbania, 2018.
Scritti su Reclus
G. Berti, Il pensiero anarchico. Dal Settecento al Novecento, Lacaita, Manduria-Bari-Roma,1998.
F. Codello, La condizione umana nel pensiero libertario, elèuthera, Milano, 2017.
F. Ferretti, Il mondo senza la mappa. Élisée Reclus e i geografi anarchici, Zero in Condotta, Milano, 2007.
F. Ferretti, Élisée Reclus: pour une géographie nouvelle, Éd. du CTHS, Paris, 2014.
J. Cornuault, Élisée Reclus. Étonnant Géographe, editions FANLAC, Montignac, 1999.
P. Pelletier, Géographie et Anarchie. Reclus, Kropotkine, Metchnikoff, Les Éditions du Monde Libertaire, Paris, 2013.
H. Sarrazin, Élisée Reclus. Ou la Passion du monde, Éditions du Sexstant, Paris, 2004.
M. Schmidt di Friedberg (a cura di), Élisée Reclus. Natura ed educazione, Atti del Convegno Internazionale, Bruno Mondadori, Milano, 2007.



Élisée Reclus
La federazione dei liberi
Come il singolo uomo, anche la società presa nel suo insieme può essere paragonata all’acqua che scorre. In ogni istante un corpo umano, che rappresenta una minuscola frazione dell’umanità, viene meno e si dissolve, mentre in un altro punto del globo un bambino esce dall’immensità delle cose, apre gli occhi alla luce e diventa un essere pensante. Come in una pianura tutti i granelli di sabbia e tutti i globuli di argilla sono stati trascinati dal fiume e depositati sulle sue rive, così tutta la polvere che ricopre il globo è fluita insieme al sangue dal cuore alle arterie dei nostri antenati. Di età in età, le generazioni si sono susseguite modificandosi poco a poco: i barbari dal volto animalesco, in lotta con le belve per la supremazia, sono stati sostituiti da esseri più intelligenti, a cui lo studio e l’esperienza della natura hanno insegnato l’arte di allevare gli animali e di coltivare la terra. Poi, di progresso in progresso, gli uomini sono arrivati a fondare le città, a trasformare le materie prime, a scambiare i prodotti, a mettersi in relazione da una parte all’altra del mondo; si sono civilizzati, ossia il loro genere si è nobilitato, il cranio si è fatto più ampio, il cervello più esteso, e i fatti si sono raggruppati nella loro mente in un contesto sempre più vasto. Ogni generazione che perisce è seguita da una generazione diversa, che a sua volta dà origine ad altre moltitudini. I popoli si mescolano ai popoli, come i ruscelli ai ruscelli e i fiumi ai fiumi; prima o poi formeranno una sola nazione, come tutte le acque di un unico bacino finiscono per fondersi in un solo fiume. L’epoca in cui tutte le correnti umane si congiungeranno in un punto non è ancora venuta: razze e popolazioni diverse, sempre attaccate alla gleba natale, non si sono ancora riconosciute come sorelle. Ma si avvicinano sempre più; ogni giorno si amano di più e insieme incominciano a guardare verso un ideale comune di giustizia e di libertà. I popoli, fattisi maturi, impareranno sicuramente ad associarsi in una federazione di liberi: l’umanità, finora divisa in correnti distinte, diventerà uno stesso fiume, e noi tutti, riuniti in una sola corrente, scenderemo insieme verso il grande mare in cui tutte le vite vanno a perdersi e a rinnovarsi.
Da Élisée Reclus, Storia di un ruscello, a cura di M. Schmidt di Friedberg e F. Codello, elèuthera, Milano 2020, pp. 230-31.



Radici pubblicate
Maria Luisa Berneri n° 2 (A. Soto)
Murray Bookchin n° 1 (S. Varengo)
Martin Buber n° 3 (F. Biagini)
Albert Camus n° 7 (A. Soto)
Stig Dagerman n° 10 (F. Ferrari)
Dorothy Day n° 10 (F. Codello)
Luce Fabbri n° 6 (L. Pezzica)
Emma Goldman n° 9 (F. Ermacora)
Marie Goldsmith n° 7 (F. Codello)
Pëtr Kropotkin n° 1 (F.C.)
Gustav Landauer n° 4 (G. Ragona)
Ursula Le Guin n° 8 (E. Lista)
Errico Malatesta n° 8 (D. Turcato)
George Orwell n° 9 (A. Binelli)
Carlo Rosselli n° 5 (N. Del Corno)
Lev Tolstoj (F. Codello)
Colin Ward n° 2 (F.C.)
Simone Weil n° 5 (F. Lazzarin)
Clara Wichmann n° 4 (E. Zarro)
Mary Wollstonecraft n° 3 (F. Berti)



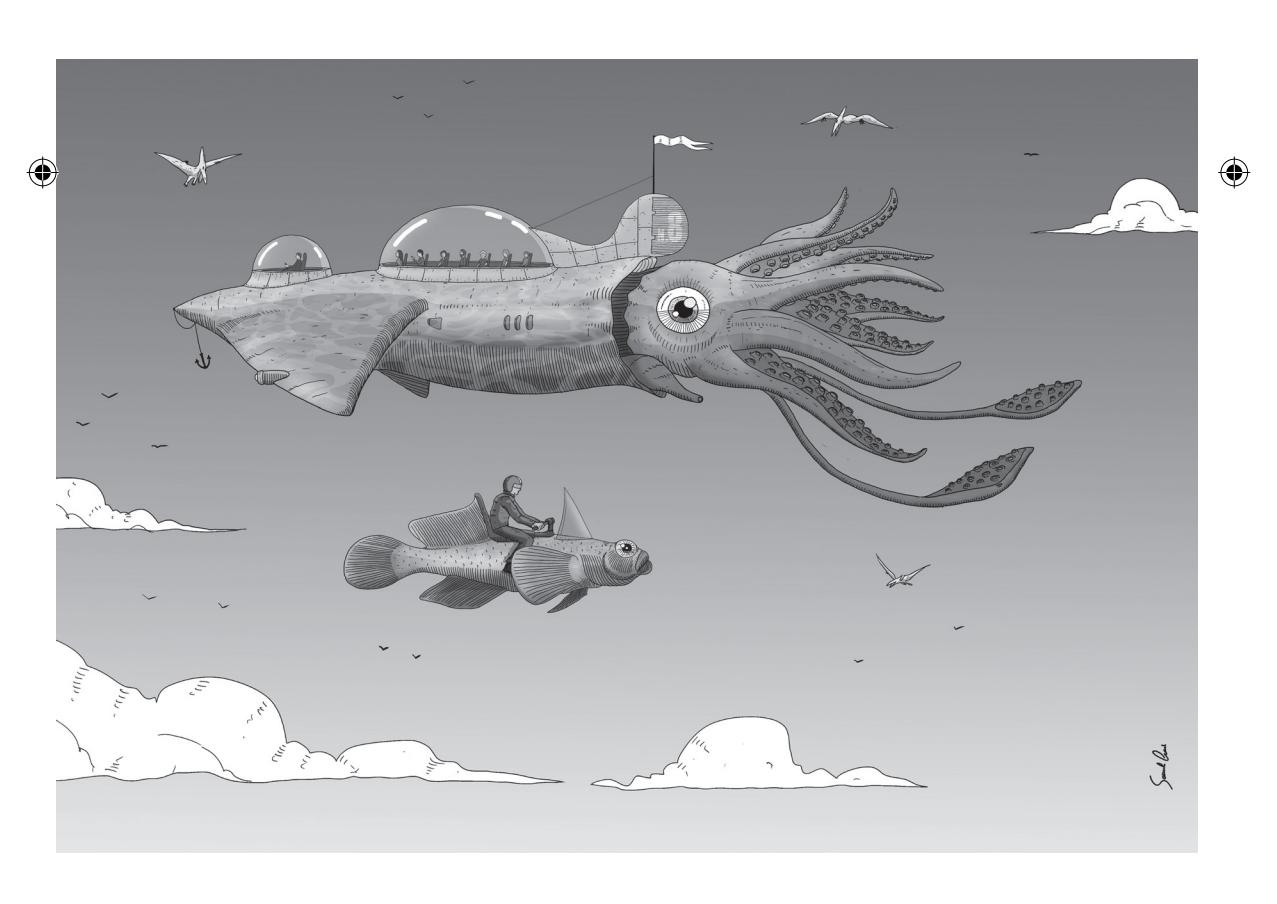
MUSICA
F.S.
Arcivescovo dell’anarchia? Il Bob Dylan «cattivo»
Archibishop of anarchy. Questa definizione, affibbiatagli da un giornalista nel 1965, impensierì Bob Dylan, che sul momento reagì con una frase divenuta celebre, usata come titolo per un bootleg (registrazione pirata) e per un album dei Chumbawamba: Give the anarchist a cigarette, «date una sigaretta all’anarchico». Come rivelò in un’intervista con Ed Bradley, quasi quarant’anni dopo, quella formulazione giornalistica l’aveva inquietato: «passi tutto», aveva rivelato all’intervistatore, «ma a essere chiamato arcivescovo dell’anarchia uno si preoccupa». Nel 1965, dopo la «svolta elettrica», con Like a Rolling Stone come hit del momento, Dylan era al culmine del suo successo e della sua notorietà. Lì si conclude il recente film biografico di James Mangold, A complete unknown. Da «completo sconosciuto», il ragazzo trasandato, fan di Woody Guthrie, che tutti chiamavano «Bobby», era diventato, in capo a pochi anni, una specie di leggenda vivente, icona del nuovo folk-rock e della controcultura degli anni Sessanta. Questo sbalzo notevole, dall’essere uno «scappato di casa» del Midwest a diventare una star internazionale, ebbe un forte impatto su un Bob Dylan ancora ventiquattrenne. Una scena del film di Mangold descrive questa situazione piuttosto paradossale, per un ragazzo che fino a tre-quattro anni prima aveva cantato per



pochi dollari a sera nelle bettole della scena folk newyorkese: ora, data la notorietà, non poteva più permettersi di entrare in quei locali, ai quali era ancora affezionato, senza generare un parapiglia. Un altro suo celebre detto di quel periodo «accetto il caos, sperando che il caos accetti me», gli era diventato reale. In questa difficile posizione, Dylan decise di stringersi intorno una piccola accolita di amici e affezionati e di muoversi protetto da questo gruppo, che visto dall’esterno poteva assomigliare a una specie di «gang», con lui a capo. Dada king lo avrebbe chiamato Joan Baez, il «re dada», attorniato da una piccola corte anticonformista e antisistema. Fu dunque in quello scenario che gli arrivò l’etichetta che comprensibilmente lo metteva in allarme: erano anni quelli, poco dopo l’omicidio di Kennedy e in piena guerra del Vietnam, durante i quali il controllo della società americana da parte della C.I.A. era molto forte.
Quella definizione corrispondeva a una effettiva simpatia di Dylan per le idee anarchiche? Non ci sono elementi concreti per pensarlo. Dylan si è sempre tenuto, per tutta la sua vita, lontano dalla politica. Vero è che aveva partecipato alle battaglie per i diritti civili e che Woody Guthrie era il suo idolo. Ma anche Woody, pur essendo vicino al IWW e apertamente antifascista, non aveva mai espresso una posizione politica definita. A Sacco e Vanzetti, certo, Woody Guthrie aveva dedicato un intero album di ballate e canzoni. Oltre a Woody, la formazione culturale e politica di Dylan aveva ricevuto una importante influenza dalla sua fidanzata dei primi anni Sessanta, Suze Rotolo (che nel film di Mangold viene chiamata Sylvie, interpretata da Elle Fanning). Suze era figlia di italoamericani di idee comuniste e gli aveva fatto conoscere Bertolt Brecht e forse anche Arthur Rimbaud. Nelle canzoni di Dylan saranno molti i riferimenti a Brecht. Con Rimbaud ci sarà quasi una identificazione poetica. Ma niente fa pensare a riferimenti specifici al movimento anarchico. A livello spontaneo e creativo, se vogliamo, sì. Una canzone come Subterranean Homesick Blues – quella che apre l’album del 1965 Bringing It All back Home e che fu usata per un celebre videoclip



– ha una sua scaturigine decisamente «anarchica». Da un verso di quella canzone You don’t need a weatherman to know which way the wind blows («non serve un meteorologo per sapere da dove soffia il vento»), i Weathermen (o Weather Underground), gruppo rivoluzionario situazionista, presero il nome. La canzone Maggie’s Farm, nello stesso album, è chiaramente una metafora di rivolta al sistema capitalistico. La battaglia contro il conformismo è un tema ricorrente nelle canzoni di Dylan ma è difficile individuare un chiaro riferimento di critica antiautoritaria, a parte lo spirito dadaista che anima Subterranean Homesick Blues con il suo Don’t follow leaders, watch the parkin’ meters («non seguire capi, stai all’occhio coi parchimetri»). In To Ramona, del 1964, si coglie la ricerca di rompere gli schemi, ma in forma velata, poetica. Lo spirito di rivolta c’è in When the Ship Comes In (1963) ma è celato in un alone quasi metafisico. Masters of War (1962) è forse la più potente canzone contro la guerra che sia mai stata scritta, ma nella sesta strofa è il perdono di Gesù che i padroni della guerra rischiano di perdere. I riferimenti biblici sono
molto presenti nelle canzoni di Dylan ed è piuttosto evidente che un sentimento di fede si sia sempre intrecciato alla sua creazione artistica.
Per tornare alla pseudo gang del 1965 e al Dylan «cattivo», va ricordato il significativo episodio della «spedizione punitiva» a Barry McGuire. L’autore di Eve of Destruction – una canzone che ebbe molto successo – aveva
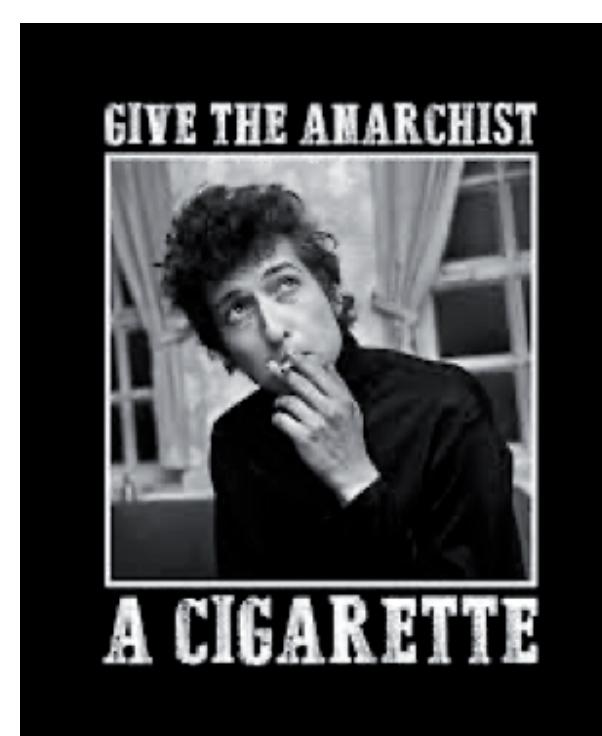



approfittato del fatto che nelle canzoni di Dylan non vi fossero riferimenti espliciti alla guerra in Vietnam, per confezionare una hit nello stile musicale di Dylan (stile creato in quello stesso anno), imitando il modo di cantare di Dylan. Qualcuno della «cricca» di Dylan punì McGuire mettendogli, a sua insaputa, LSD nella birra.
Insomma, la dicitura «arcivescovo dell’anarchia» è divertente e anche un po’ geniale, nel suo paradosso: ironizza su un personaggio che, in tutta la sua vita, ha cercato di sottrarsi a tutte le definizioni e tutti i cliché… per poi accomodarsi, ultraottantenne, nella confortevole resa cinematografica della sua gioventù nel film di Mangold, che ai vecchi fan rischia di apparire un po’ «premasticata», conformata allo spirito del tempo.



BOAB BOLOGNA ANARCHIST BOOKFAIR 5-6-7 SETTEMBRE 2025 PARCO DEL FONDO COMINI BOLOGNA

Negli ultimi anni, a livello internazionale, gli incontri dedicati all’editoria anarchica e libertaria si sono moltiplicati, confermandosi come momento fondamentale di condivisione e convivialità, in una continua riaffermazione dell’autogestione e del confronto faccia-a-faccia. Orfan* della Vetrina dell’editoria anarchica e libertaria di Firenze, che per quasi vent’anni ci ha permesso di incontrarci un anno sì o uno no, e spint* dalla voglia di rimetterci in gioco, abbiamo deciso di dare corso a quelle che per un po’ sono state solo idee scambiate davanti a un bicchiere, o alla fine di una iniziativa, e provare a organizzare un incontro dove di nuovo potremo vederci, parlare, discutere, mangiare, bere e ballare insieme. Dove fare comunità insomma, in un momento in cui ce n’è tanto bisogno. Alcun* di noi si conoscono da molto tempo, altr* è la prima volta che collaborano assieme, ci sarà da rimboccarsi le maniche questo è certo, ma la speranza è che questo sia solo il primo di una lunga serie di incontri.
Per farla breve, è con grande entusiasmo, tanta voglia di conoscere nuove persone e rivedere vecchie facce, che vi invitiamo alla Bologna Anarchist Bookfair – BOAB, il 5-6-7 settembre 2025, a partire da una serata di accoglienza venerdì al Circolo anarchico Berneri e poi sabato e domenica presso il parco del Fondo Comini (via Fioravanti 68). Oltre ai banchetti di libri, riviste, autoproduzioni e materiale informativo, sono previsti dibattiti e momenti di confronto con un’attenzione particolare alle forme e alle pratiche dell’anarchismo contemporaneo, ma anche musica, spettacoli, laboratori, giochi e spazi per bambin*, cibo e vino, secondo un’abitudine che ci è cara: quella dell’autogestione, unendo l’approfondimento e la riflessione alla socialità, l’impegno e gli accordi pratici al piacere della convivialità.
Biblioteca Elio Xerri (Circolo anarchico Berneri), Centro studi libertari G. Pinelli, edizioni Malamente, con il supporto di ReBal, Rete delle biblioteche anarchiche e libertarie.
Info e contatti:
Web: boab.zone / Email: info@boab.zone 18/02/2025




Il cinema carcerario è un genere che si è sviluppato sostanzialmente intorno a due filoni di movimento: uno centripeto, focalizzato al racconto delle condizioni di vita dentro il carcere, l’altro centrifugo, centrato sull’idea della fuga o dell’abbattimento delle barriere. In entrambi i casi, la narrazione cinematografica si è occupata quasi esclusivamente del mondo maschile, un mondo criminale e violento che mette necessariamente ai margini una possibile narrazione al femminile. Anche in materia di carcere quella delle donne è una storia minore, che non vale la pena raccontare. Ci è sembrato quindi importante, per il nostro percorso di visioni, partire proprio dall’analisi di questa lacuna di genere, piuttosto frequente in un’industria cinematografica che ancora vede le registe rappresentate per meno del dieci per cento rispetto ai registi.
La storia del carcere femminile nel nostro Paese nasce con gli istituti correttivi religiosi, dove donne che avevano commesso reati venivano rinchiuse insieme a quelle che, allontanandosi dai parametri di madre, moglie e casalinga erano considerate peccatrici o comunque «diverse». La correzione, più che la punizione, veniva affidata alle suore, un modello che è rimasto invariato


fino al 1975 quando, con la riforma del Codice Penitenziario, sono state aperte delle sezioni femminili all’interno delle carceri, introdotte nuove figure professionali, anch’esse femminili, e le suore sono state man mano allontanate.
Il sistema di moralizzazione delle donne, tuttavia, non è stata una peculiarità nostrana. Ce lo mostra in maniera brutale il regista scozzese Peter Mullan nel film Magdalene, Leone d’Oro per il miglior film alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2002. Ambientata nel 1964, la pellicola narra la vicenda di tre ragazze rinchiuse in una «Magdalene». Così venivano chiamati gli istituti cattolici sorti nel Regno Unito e in Irlanda nel diciannovesimo secolo, e poi diffusi anche negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, dove venivano recluse, per espiare le loro colpe, le donne considerate indegne di vivere nella collettività, e quindi meritevoli di subire un duro trattamento a causa della loro condotta di vita sregolata. Si tratta di donne rifiutate dalle famiglie perché colpevoli di aspettare un figlio al di fuori del matrimonio, di aver abbandonato il tetto coniugale, o ritenute pericolose perché troppo avvenenti, o troppo intelligenti: in pratica tutte coloro che venivano considerate deviate dalla società cristiana perbenista dell’epoca, e che pertanto andavano corrette. Dentro le mura del convento/carcere si nascondevano in realtà delle vere e proprie lavanderie industriali (in Irlanda venivano chiamate Magdalene Laundries) dove le donne lavoravano ore e ore con le mani nude nell’acqua bollente, fornendo manodopera gratuita che portava ingenti e illeciti guadagni ai conventi. Se violavano le regole del silenzio o facevano amicizia tra loro, venivano punite e picchiate, e alcune di loro erano addirittura condotte in manicomio senza alcuna spiegazione, come succede a una delle protagoniste del film che, ritenuta instabile a seguito delle molestie ricevute da un prete, viene rinchiusa arbitrariamente dalle suore in un ospedale psichiatrico, dove morirà dopo qualche anno. Alle residenze-prigioni delle «Magdalene», rimaste aperte fino al 1996, ci riportano anche altri



due film, entrambi tratti da fatti realmente accaduti. Philomena (2013) del regista inglese Stephen Frears. Coniugando tragedia e commedia, il film narra le vicende di Philomena che, rinchiusa dalla famiglia in una «Magdalene» perché rimasta incinta adolescente, è alla disperata ricerca del figlio partorito nel convento-carcere. Piccole cose come queste (2024) del regista belga Tim Mielants, riporta invece lo sguardo di un uomo che, scoprendo alcuni segreti su un convento del villaggio irlandese in cui vive, si confronta con il proprio passato traumatico. Il film non documenta la vicenda delle Magdalene Houses, ma si interroga su una questione morale: molti irlandesi erano infatti al corrente di ciò che succedeva all’interno dei conventi, ma decisero di far finta di non sapere. Bill, il protagonista del film, sceglie di fare la differenza disobbedendo a quel codice del silenzio, che troppo spesso accompagna il male.
L’annuale rapporto di Antigone sulle carceri italiane evidenzia che, a fine 2023, le donne detenute erano il 4,3% della popolazione carceraria totale. La percentuale raddoppia se consideriamo le persone che hanno commesso reati considerate socialmente pericolose, che per questo vengono recluse nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) che sono state aperte dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. In questo caso la percentuale delle donne in carcere arriva all'11%, un dato che meriterebbe un approfondimento e sul quale ci lasciamo interrogare dalla visione di Ragazze interrotte, di James Mangold (1999). Il film, ambientato alla vigilia degli anni ‘70, parte dal racconto di Susanna, una ragazza diagnosticata borderline in seguito a quelli che vengono definiti «comportamenti promiscui», associati a un apparente tentativo di suicidio. Un atto autolesionistico che probabilmente cerca di nascondere l’impossibilità di esprimere le proprie emozioni in una società pronta a puntare il dito, a giudicare e a punire quelle che considera deviazioni dalla norma tacciandole come follia.



La patologizzazione e la stigmatizzazione delle persone pericolose sono due facce della stessa medaglia: entrambe legittimano il potere di punire la loro devianza dalla normalità socialmente acquisita. Se si accetta l’idea che sia possibile trasformare una persona privandola della libertà, allora la repressione diventa una forma di correzione. In particolare, se la norma/normalità è di pertinenza maschile, la devianza femminile dalla stessa si colora giocoforza di patologia, e per le donne la punizione/rieducazione ha storicamente avuto l’obiettivo correzionale di piegarle al ruolo sessuale tradizionale. Una narrazione che perdura anche ai giorni nostri.
Le detenute in Italia si trovano, nella stragrande maggioranza, in sezioni ricavate all’interno di istituti disegnati per gli uomini, in contesti che, per quanto apparentemente meno coercitivi, non sono attraversati da un pensiero che tenga conto delle differenze di genere. In maniera non dissimile a quanto avviene fuori del carcere, la donna che viene privata della libertà diventa una categoria residua, e ciò è quanto ritroviamo anche in ambito cinematografico, dove le pellicole che parlano della carcerazione femminile sono residuali rispetto alla narrazione filmografica sul carcere, confermando un dominio maschile nella dimensione pubblica del discorso. La specificità della condizione femminile in carcere sembra venire affrontata soprattutto in relazione alla condizione di maternità: sono donne, sono madri, aderenti quindi al ruolo biologico loro assegnatole.
Di questo tratta 107 madri (2021), un docufilm che il regista slovacco Peter Kerekes ha presentato al 78o Festival del Cinema di Venezia e che non è mai stato distribuito, né al cinema né nelle piattaforme di streaming. Il film, girato in presa diretta in un carcere femminile, racconta la storia di Lesya che, macchiatasi di un delitto passionale e per questo condannata a scontare sette anni in una delle strutture correzionali femminili di Odessa, ha appena dato alla luce il suo primo figlio e si ritrova a entrare in un reparto popolato di sole donne. Sono detenute, infermiere



e guardie, donne di tutte le età, mogli e vedove, figlie, sorelle, donne incinte e donne con bambini. Un film femminile, più che carcerario, con cui il regista ci restituisce una visione molto tradizionale di quello che sembra essere la sola cosa che conta per una donna. Tuttavia le centosette madri trovano in quella maternità temporanea, ovvero prima che il bambino venga loro sottratto, la possibilità di dare un senso alla propria esistenza, e ciò le avvantaggia rispetto a quelle detenute che si ritrovano sole, senza una famiglia a cui pensare e in cui pensarsi una volta uscite da quella prigionia.
Anche Malqueridas (2023) della regista cilena Tana Gilbert è un documentario, presentato anch’esso al Festival del Cinema di Venezia che, pur vincendo il Gran Premio della Settimana della Critica, non è mai uscito nelle sale cinematografiche in Italia, e non ha neppure trovato una distribuzione nelle piattaforme di streaming. Realizzato attraverso una serie di filmini raccolti con vecchi cellulari tenuti clandestinamente dalle carcerate stesse, affronta la condizione carceraria delle donne filtrandola attraverso il tema della maternità. Siamo in Cile, le malqueridas del titolo sono le «malvolute», donne recluse che scontano lunghe pene lontane dai loro affetti. I figli e le figlie crescono lontano da loro, ma rimangono sempre nei loro cuori. In prigione trovano l’affetto delle altre detenute che condividono la loro stessa esperienza e il sostegno reciproco tra queste donne diventa una forma di resistenza e di emancipazione.
In tema di carcerazione, ciò che sembra continuare a mancare è una tutela delle soggettività femminili al plurale, nelle diverse dimensioni della vita in cui le donne si esprimono e continueranno a esprimersi, nonostante e dopo il carcere. Al tema del reinserimento nella società è dedicato il film La seconda vita (2024) che il regista Vito Palmieri ha presentato al Bif&st 2024 (Bari International Film Festival). Anna è una giovane donna che tenta di ricostruire la propria esistenza dopo anni di carcere. La sua ricerca di un nuovo posto nella società corre lungo



due fili: uno positivo rappresentato dall’incontro con Antonio, l’unico che potrebbe realmente «ripararla» offrendole una occasione per reinventarsi, l’altro negativo delineato dalla condanna morale, che Anna non riesce a scrollarsi di dosso, perpetuata dal chiacchiericcio giudicante della gente del paese. Girato a Peccioli, piccolo comune toscano, il film in prima battuta mette in luce l’apparente bontà e intimità tra gli abitanti del luogo, ma subito dopo denuncia il falso buonismo e il pregiudizio presenti proprio in una comunità ristretta. Il problema del dopo-carcere è cruciale per chiunque, perché presuppone il dover rimontare la china col fardello di un’impronta pesante, ma anche qui la donna subisce una stigmatizzazione maggiore rispetto all’uomo, quasi avesse mancato di rispondere al ruolo di moglie e madre che la società le assegna, al di là del reato commesso. A ciò si deve anche che la donna, spesso detenuta per microcriminalità di strada, rompa il legame con la propria famiglia di provenienza ben più frequentemente di quanto non accada per gli uomini – colpevoli solo di aver infranto, in alcuni casi con onore, il penale – rendendo ancora più in salita il percorso di reinserimento.
Se il fine della pena è quello di reintegrare le persone nella società, la loro vita affettiva dovrebbe essere il più possibile simile alla vita fuori del carcere, mantenendo e tutelando le relazioni con quell’esterno al quale, alla fine della detenzione, faranno ritorno. Il diritto all’affettività e alla sessualità per una persona detenuta sono fondamentali quanto il diritto alla salute. Su questo fronte il nostro Paese è terribilmente indietro: è datata solo febbraio 2024 la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di affettività in carcere. Qualcosa sembra pertanto muoversi nel garantire momenti di intimità all’interno degli spazi detentivi affinché le persone recluse possano esercitare il loro diritto alla sessualità non solo al di fuori del carcere, durante le uscite in permesso. Oltretutto, poiché i permessi sono connessi alla premialità, anche la sessualità, nei fatti è stata fin qui trattata alla stregua di un premio, a



cui, tra l’altro non possono accedere le persone in custodia cautelare. Al tema dell’affettività tra le sbarre ci riporta Fiore (2016) di Claudio Giovannesi. Daphne, minorenne, viene arrestata per aver tentato di rubare un telefonino nella stazione in cui dormiva. Nel carcere minorile dove viene rinchiusa si innamora di Josh, un altro giovane rapinatore. Essendo impossibile per ragazzi e ragazze incontrarsi in questo contesto, la relazione tra i due viene vissuta solo attraverso gli sguardi, le brevi conversazioni attraverso le sbarre e le lettere clandestine. La mancanza di libertà è mancanza di amore. Mediante la figura della protagonista, il regista mostra il ventaglio di emozioni che attraversano un’adolescente reclusa: l’orgoglio di chi lotta, nonostante tutto, per preservare la propria dignità, l’amore per un suo coetaneo, la speranza di una fuga finale e, soprattutto, la rabbia di chi è relegata ai margini della società, con una madre di cui nulla si sa e un padre appena uscito di galera, quasi a voler significare che il carcere è ereditario.
Il numero limitato di presenze femminili fa sì che, nella gestione degli istituti penitenziari le risorse economiche, il personale e le attività proposte vengano convogliate sulla parte maschile, numericamente più ponderante. Il mondo del cinema si è allineato perfettamente a questa tendenza: i film che affrontano il tema della carcerazione femminile sono quantitativamente pochi e troppo spesso non trovano canali di distribuzione, né nelle sale cinematografiche, né sulle piattaforme di streaming. Sono film invisibili, come alcuni di quelli che vi abbiamo proposto in questo percorso di (non) visioni, con cui abbiamo comunque voluto dare visibilità a coloro che sono condannate a essere le marginali dei marginali del sistema carcerario.



Inquadra il QR-code per vedere spezzoni e trailer dei film citati:


Magdalene Philomena

Piccole cose come queste

Ragazze interrotte

107 Madri

Malqueridas

La seconda vita Fiore


