Numero Completo 10

INDICE
| Editoriale | 3 | ||
|---|---|---|---|
| ESPERIENZE | CEMEA: una pratica di educazione attiva Traficantes de sueños Il libro come mezzo di trasformazione individuale e collettiva |
A. Soto Valeria Giacomoni |
11 25 |
| Tentativi genuini di resistenza contadina | Marco e Michela (collettivo Erbe Matte) |
35 | |
| TI N |
La ribellione dei quattro elementi. Fuoco, acqua, terra e aria contro l’Antropocene |
Marco Antonioli |
47 |
| APPROFON E M DI |
Anarchia è amore Da Chávez a Maduro: 25 anni di dittatura in Venezuela. |
Carne Ross Andrés Rodriguez |
53 57 |
| SAZIONE CONVER |
La lunga lotta per la libertà continua Conversazione con Matthew Wilson |
a cura della Redazione |
67 |
| INTERNA ZIONALE |
Parliamo di democrazia. Democrazia reale | Cora Roelofs |
77 |
| RADICI | Stig Dagerman Dorothy Day |
Fulvio Ferrari Francesco Codello |
93 97 |
| DI VISIONE RSI PERCO |
Tempi postmoderni | Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri |
105 |
| MUSICA | Tra silenzi e spari. Suoni e percorsi della canzone politica italiana |
Felice Liperi |
113 |





Editoriale
Mentre chiudiamo il n° 10 di Semi sotto la neve, un devastante incendio sta finendo di bruciare vaste zone di Los Angeles. Un’area immensa, grande quanto San Francisco, è andata letteralmente in fumo in pochi giorni, trasformando un ambiente boschivo, coltivato o abitato in un terreno nero, fumante, morto. Nella civiltà di Internet e di Instagram, di Space X, delle auto volanti e dei treni che viaggiano a 600 km all’ora, l’uomo si ritrova sempre più impotente di fronte ai cataclismi naturali, più incapace di spegnere i roghi o di fronteggiare le alluvioni rispetto a 100 anni fa, quando la maggior parte degli esseri umani si muoveva ancora a piedi o a cavallo. L’enorme, indubbio balzo tecnologico della società post-industriale non ha ancora finito di trasmettere a troppi un insano senso di superiorità sull’elemento naturale, una tracotante sensazione di poter dominare, controllare e determinare l’evoluzione della nostra casa comune e delle migliaia di specie viventi che la popolano. Quanto gli eventi stiano andando in una direzione addirittura contraria ce lo spiega, nell’articolo per questi motivi simbolo di questo numero, il nostro redattore Marco Antonioli: la terra, l’aria, l’acqua e il fuoco, quasi assumendo le sembianze di moderni cavalieri dell’Apocalisse, si ribellano sempre più a un modello di crescita e sviluppo che deve essere profondamente rivisto, pena la distruzione del pianeta, la sua trasformazione in un ambiente inadatto alla vita.


Perché questa ribellione possa davvero determinare un radicale cambiamento di indirizzo, è necessario che alla rivolta della natura faccia seguito quella delle donne e degli uomini dotati di una coscienza civile.
Basta guerre, basta ingiustizia, basta illibertà!
Come scrivevamo nello scorso numero, non solo il pianeta brucia, arso da incendi prodotti da incuria umana e riscaldamento globale; l’umanità arde a causa di guerre troppo lunghe e devastanti, come quelle che affliggono ucraini e russi, israeliani e palestinesi. E molti altri popoli e zone del pianeta non godono di una salute troppo migliore.
Non è solo l’inaccettabile sofferenza delle società civili, delle vittime innocenti a suscitare tormento e destare indignazione. È che la guerra, soprattutto se prolungata, lascia in chi sopravvive ferite profonde, rabbia e rancore che faticano a stemperarsi e che sono spesso l’anticamera e l’incubatrice di nuovi conflitti. La guerra è la massima espressione della violenza dell’uomo sull’uomo, dell’istinto o della volontà di dominazione e di sopraffazione. La guerra trasforma la società, modifica i rapporti sociali, legittima la gerarchia, fa emergere alla lunga le pulsioni più negative. Rende peggiori i vincitori e i vinti. La guerra non è solo nemica della pace, è nemica della libertà.
E il ritorno alla pace non è una garanzia sufficiente.
Nelle ultime settimane si è forse conclusa, in Siria, una guerra civile e internazionale durata quasi 15 anni, che ha provocato un numero di vittime forse superiori al mezzo milione. Il principale responsabile, Bashar al-Assad, è fuggito impunito in Russia, mentre il potere è stato preso da una eterogenea coalizione di forze, con a capo un ex (?) jihadista, al-Jolani. Quanto potrà durare la pace così faticosamente raggiunta?




La vera pace non può che crescere all’ombra della libertà e della giustizia sociale. Ecco perché le guerre ricominciano sempre, spesso negli stessi posti dove erano cessate poco tempo prima. Ecco perché il pacifismo, senza l’antimilitarismo e il socialismo autogestionario, è un rimedio poco efficace per contrastare le derive belliciste del mondo contemporaneo. Occorre accrescere il tasso di cooperazione libera nella società, perché solo questo è garanzia profonda di pace e di rispetto degli uomini tra di loro e verso la Madre Terra. Come scriveva Kropotkin più di cento anni fa, non vi è che un «istinto che si è lentamente sviluppato tra gli animali e fra gli uomini nel corso di un’evoluzione estremamente lunga, che ha insegnato», o dovrebbe insegnare, «tanto a gli animali quanto agli uomini la forza che possono acquisire dalla pratica del mutuo appoggio e dell’aiuto reciproco, e le gioie che possono trovare nella vita sociale».
Questa – lo ripeteremo allo sfinimento – è la mission della nostra rivista. Lo è perché sappiamo – l’esperienza continua ce lo insegna, nel male e nel bene – che è l’unico futuro possibile, per l’uomo e per la natura.
Partiamo dai piccoli esempi, dalle piccole esperienze, per generare un cambiamento macro-sociale.
Ed ecco il numero! Le opere di Giulietta Gheller che lo attraversano raccontano del rapporto sostanziale tra uomo e natura e le due performance Ostrakon e Requiem, in cui l’artista sacrifica le proprie sculture distruggendole, riflettono sul tema dell’irreversibilità della nostra condizione richiamandoci a una responsabilità di fronte al presente.
Nelle esperienze: A. Soto illustra la storia e l’attività della federazione italiana dei Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educa-




zione Attiva, un’organizzazione internazionale basata sui principi dell’educazione partecipativa, sviluppatasi in Italia a partire dagli anni Cinquanta grazie all’impulso di Margherita Fasolo e al successivo impegno di Lamberto Borghi. Si tratta di una struttura che compie una doppia attività, di formazione e di gestione di momenti educativi e che si propone di contribuire all’emancipazione delle persone lungo l’intero arco della vita, applicando un principio di educazione permanente e non-coercitiva, in modo da assicurare una formazione civile di qualità.
Valeria Giacomoni interroga l’esperienza spagnola dei Traficantes de sueños, progetto editoriale e politico che colloca al centro della sua pratica il valore comunitario del libro. La cooperativa, situata a Madrid, è insieme casa editrice, libreria che si occupa della distribuzione e centro sociale, dato che nei suoi locali si offrono corsi, dibattiti, proiezioni e riunioni. Traficantes è certo conosciuta per aver creato un modello di produzione sostenibile grazie al download gratuito dei testi, ma ha elaborato una proposta molto più audace, il sogno di trasformare i testi in strumenti collettivi di pensiero, in modo che la pratica della lettura sia in grado di creare una plusvalenza di relazioni sociali.
Infine, il collettivo delle Erbe matte presenta la propria esperienza, ormai decennale, di agricoltura biologica e di pratica contadina fondata sui principi del mutuo appoggio, della condivisione e della partecipazione. Nato nel bolognese, per poi diffondersi a livello nazionale, Genuino Clandestino è un movimento formato da contadini e contadine, simpatizzanti e coproduttori, persone che scelgono concretamente di solidarizzare con chi trova nella terra la sua forza e potenzialità produttiva e sociale, il cui nucleo portante è l’assemblea autogestita di contadini e simpatizzanti.
Negli approfondimenti. Marco Antonioli, come anticipato, prende spunto dalle disastrose alluvioni autunnali che hanno deva-




stato Valencia e alcune regioni italiane per riflettere sulla crisi sistemica dovuta al riscaldamento globale. La ribellione della natura mostra che è l’intero sistema a essere in crisi, e solo un cambiamento altrettanto sistemico potrà darci una speranza di futuro. Non è più tempo di mezze misure o di compromessi: il nostro rapporto con il pianeta va modificato radicalmente e per farlo è necessario adottare un nuovo paradigma culturale nel rapporto tra uomo e natura, prima ancora che un nuovo modello di sviluppo economico e sociale.
Carne Ross, già diplomatico di primo piano per il governo britannico, è divenuto da diversi anni un apostolo della diplomazia non-governativa e un sostenitore delle idee libertarie. Nell’articolo qui proposto riflette sulla sua visione esplicitamente anarchica, mettendo in luce il fatto che l’anarchismo non è solo una filosofia politica che si propone di trasformare in senso socialista e autogestionario la società, ma anche una visione spirituale, che chiama l’uomo a compiere una rivoluzione interiore. La pratica esistenziale dell’anarchismo implica l’adozione di relazioni non gerarchiche, egualitarie, ponendo i bisogni dell’altro allo stesso livello dei propri.
Andrés Rodriguez riflette sul fallimento della «rivoluzione bolivariana», il socialismo nazionalista-populista venezuelano, ripercorrendo la parabola politica di Hugo Chavez e poi di Nicolas Maduro Moro, autocrati che hanno represso nel sangue e affogato nei brogli elettorali il desiderio di libertà e democrazia di una parte considerevole del popolo venezuelano. L’articolo è stato scritto a fine 2024 e i suoi contenuti rimangono validi anche se nel gennaio 2025 si sono verificati importanti eventi politici: Edmundo
González ha intrapreso un tour internazionale per cercare sostegno di fronte alla crisi interna del paese; Maria Corina Machado è stataarrestata in una controversa operazione che ha suscitato una fortecondanna internazionale; Nicolás Maduro si è consolidato come presidente, rafforzando la sua posizione. Il vero socialismo




non può che nascere e crescere nella libertà e nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui, delle minoranze, dei gruppi sociali. L’articolo di Cora Roelofs prosegue la riflessione su cosa debba intendersi per vera ed effettiva democrazia. Prendendo le mosse dalle aporie della democrazia statunitense, fondata su una forma esasperata di patriottismo e su una pratica elettoralistica utile a coprire una struttura sociale fortemente gerarchizzata, l’autrice si interroga sul significato profondo della democrazia odierna: un agire politico che richiede alcune precondizioni, come una distribuzione egualitaria delle ricchezze e delle risorse, e che implica una pratica partecipativa e diretta, fondata sulla valutazione, il feedback, il monitoraggio e la riflessione critica.
La Conversazione è dedicata a un confronto con Matthew Wilson, autore del recente, importante volume Discorsi sull’autogoverno, edito da elèuthera. Wilson focalizza la sua riflessione sul rapporto tra anarchismo e trasformazione sociale. Gli anarchici hanno sempre insistito sul fatto di essere contrari al compromesso, rifiutando di annacquare le loro critiche radicali al capitalismo e allo Stato. Wilson rileva come tale rifiuto diventi a volte politicamente dannoso: il punto non è quello di rifiutare in punta di principio il compromesso, ma capire il grado di compromessi politicamente accettabili in un dato contesto storico-politico.
Nelle Radici. Francesco Codello presenta il profilo di Dorothy Day, straordinaria donna capace come pochi di coniugare il pensiero libertario e l’azione incessante a favore degli oppressi. Pacifista radicale, simpatizzante dell’IWW, influenzata da pensatori come Tolstoj e Kropotkin, Day ha coniugato lo spiritualismo cattolico con l’attivismo anarchico, sostenendo la causa dei poveri e degli sfruttati e creando una rete di solidarietà concreta che ha sostenuto migliaia di diseredati. Fulvio Ferrari ricostruisce la figura




di Stig Dagerman, autore ancor oggi letto, tradotto, discusso in tutto il mondo. Narratore, giornalista, militante anarchico, Dagerman ha mantenuto per tutta la sua breve vita uno sguardo lucido e critico sulla società, sull’arte e su sé stesso, mettendo a nudo nodi che, irrisolti, conservano tutta la loro urgenza e la loro complessità. Dagerman fu una curiosa figura di anarchico disincantato e militante, che fino alla fine ha continuato a collaborare con i giornali del movimento e a partecipare alle manifestazioni di piazza. Nella Musica Felice Liperi conduce il lettore in un viaggio tra suoni e percorsi della canzone politica italiana. Dopo aver evocato il ruolo dei canti politici in Italia, dall’età sveva alle lotte operaie di inizio Novecento, l’autore si concentra sulla canzone politica italiana contemporanea. Da Francesco Guccini ad autori come Brunori sas e Vasco Brondi, Liperi narra la lunga stagione dei cantautori impegnati e dei gruppi arrabbiati, che continua tutt’oggi nonostante la crisi dei movimenti e il riflusso nel privato.
Infine, una nuova rubrica, Percorsi di visione di Mariangela Mombelli ed Enrico Ruggeri, dedicata al cinema. Il primo articolo, che analizza il rapporto tra il cinema e il lavoro, prende le mosse da una citazione di Camillo Berneri per evidenziare come, fin dai suoi esordi, il cinema non abbia mai smesso di raccontare il lavoro come principio fondante della società. L’analisi di molte opere cinematografiche degli ultimi anni evidenzia quanto il lavoro sia rimasto una pena senza neppure l’aspettativa di un finale consolatorio.
La parola ai lettori! Continuate a scriverci, a farci avere il vostro sostegno, le vostre idee, le vostre critiche. La rivista ha bisogno di farsi conoscere, di essere discussa, di nuovi lettori e abbonati. Siamo una piccola voce, ma abbiamo tanta voglia di dire la nostra e di farci ascoltare! Tutto questo, sarà possibile solo grazie al vostro aiuto e al vostro impegno.





CEMEA: una pratica di educazione attiva
C’è sempre la speranza che i ragazzi possano esportare qualcuna delle loro fantasie nella nostra troppo stabile società. Colin Ward, Trasmissione dell’anarchismo, «Volontà», a. XVI, febbraio 1963.
La federazione italiana dei CEMEA (Centri di Esercitazione ai Metodi dell’Educazione Attiva) è costituita da una ventina di gruppi, fra centri e gruppi locali, che si basa sui principi dell’educazione attiva. Essa ha l’obiettivo di contribuire all’emancipazione delle persone lungo l’arco della vita, assicurando una formazione civile di qualità, con l’esplicito proposito di promuovere una cittadinanza democratica, nella convinzione che la trasformazione di pratiche educative permetta l’emergere di nuove relazioni tra gli individui e favorisca il consolidamento della società civile. Attraverso la dialettica individuo/gruppo, contribuisce alla costruzione di legami sociali cooperativi e allo sviluppo dell’autonomia critica e consapevole. La concezione umanistica occupa un luogo centrale nell’educazione attiva, approccio che valorizza la libertà di iniziativa, di crea-


zione, di espressione, assegnando a questi elementi particolare importanza nella sfera emotiva della personalità degli individui.
I CEMEA compiono una doppia attività, di formazione e di gestione di momenti educativi. Si occupano cioè di formare il personale impegnato in diversi ambiti dell’attività educativa: centri estivi, soggiorni di vacanza, scambi internazionali, comunità alloggio, scuole, aziende sanitarie locali, case delle arti e del gioco, attività di ludobus e teatro di strada, organizzando corsi di formazione, residenziali e non, per varie categorie di educatori, insegnanti, operatori sociali, animatori, genitori, volontari del servizio civile nazionale e del servizio volontario europeo.
Allo stesso tempo gestiscono diverse tipologie di servizi educativi: nidi, scuole dell’infanzia, centri giovanili, case di vacanza, comunità alloggio per minori, comunità mamma-bambino, animazione nei centri anziani.
I CEMEA nascono in Francia, fondati nel 1936 da Giséle de Failly (1905-1989), e in Italia sono attivi fino dagli anni Cinquanta a Milano, Firenze e Roma. Tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta infatti si sviluppa in Italia il movimento dell’educazione attiva, attraverso iniziative da parte di gruppi e associazioni di pedagogisti e insegnanti. Il primo nucleo italiano dei CEMEA viene fondato a Firenze tra il 1950 e il 1951 da Margherita Fasolo, allieva e assistente di Ernesto Codignola, di ritorno da un periodo di ricerca in Francia, dove i CEMEA erano radicati e diffusi (De Maria 2012).




A Firenze testimonia Marcello Trentanove, altro protagonista di questa sperimentazione insieme a Fasolo e Codignola, allora giovane maestro elementare vicino agli ambienti azionisti e anarchici; «c’era un clima favorevole, grazie alla presenza di Codignola che insegnava Magistero, e grazie soprattutto al fatto che nel capoluogo toscano c’era stata una Resistenza notevole con uomini di prim’ordine dal punto di vista politico, culturale e pedagogico. C’era una commistione interessantissima tra politica ed educazione. Una volta vinto il fascismo, il discorso sul rinnovamento della società era affidato all’educazione. C’era grande fiducia in questo senso». Non a caso nel 1949 fu pubblicato dalla casa editrice La Nuova Italia di Ernesto Codignola Democrazia ed educazione di Dewey. Un testo che ha fatto epoca per tutti coloro che guardavano alla pedagogia laica. I movimenti di rinnovamento della scuola attivi nel dopoguerra (anni Cinquanta in particolare) erano legati anche da ideali di carattere politico (De Maria 2015).
Nel 1953 nasce l’Associazione nazionale dei CEMEA sotto la presidenza proprio di Codignola, che si trasforma nel 1971 in Federazione Italiana dei CEMEA (FITCEMEA), sotto quella di Lamberto Borghi (1907-2000), educatore libertario che ha dato un apporto fondamentale al rinnovamento della pedagogia e alla preparazione dei giovani insegnanti italiani. Egli si può considerare il «padre nobile» della pedagogia libertaria italiana, che definisce come costituita da un approccio non costrittivo o, come più spesso lo si è denominato, «non coercitivo», riferito sia al sistema di apprendimento e d’insegnamento sia all’intero corpo sociale (Borghi 2023).
La Federazione italiana dei CEMEA fa parte di una più vasta rete internazionale, la Federazione internazionale dei centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva (FICEMEA), che raggruppa associazioni presenti in altre parti d’Europa, in America latina e nei Caraibi, in Africa, in India, in Libano ecc. per un totale di trenta-quaranta gruppi.




Rispetto e considerazione sono alla base della pedagogia
Ogni essere umano, senza distinzione di sesso, età, origine, convinzioni, cultura, situazione sociale ha diritto al nostro rispetto e alla nostra considerazione.
Art. 1 del testo I Principi che guidano la nostra azione, Giselle De Failly, Congresso di Caen, 1957.
I CEMEA si basano su alcuni principi di fondo a partire dal rispetto delle particolarità e delle specificità delle persone, che va di pari passo con la fiducia nel fatto che ogni individuo abbia la possibilità e il desiderio di migliorarsi. Ogni azione educativa
richiede un contesto accogliente: questo significa porre attenzione agli altri, ascoltare e rispondere in modo attivo, essendo capaci di leggere le richieste attraverso le reazioni o le non reazioni delle persone e provando a essere incisivi senza forzare, e significa anche cura dei contesti di vita e di esperienza. A tal fine gli attivisti dei CEMEA predispongono ambienti, materiali e situazioni che concretizzano tale metodo: ne è un esempio lo stage, un periodo di forma-
zione nel quale una équipe di formatori si prende cura di un gruppo di partecipanti e instaura con loro una relazione di rispetto, di attenzione, di apprendimento significativo.
Negli stage si sviluppa la crescita delle persone grazie a un’atmosfera e a una condizione di fiducia dove vigono atteggiamenti nonviolenti, non competitivi, dove non si giudica e si chiede a ognuno di prendere coscienza di ciò che è senza sentimenti di colpa o di paura. L’équipe dei docenti, utilizzando un continuo lavoro di gruppo, svolge una funzione di organizzazione e di mediazione, esercitando un’autorevolezza senza autorità, offrendo attività e proposte di vario tipo.




Raccontiamo l’esperienza di 12 giorni vissuta da circa 150 ragazzi e ragazze tra i 6 e i 13 anni al CEMEA a Oriolo Romano, tra Roma e Viterbo, nell’estate del 2024. I ragazzi sono divisi in gruppo di circa 15 aderenti a seconda dell’età. La giornata solitamente si svolge così: ognuno si sveglia quando vuole all’interno dell’arco orario 7.30-9.00, fa colazione, da solo o in gruppo, prendendo da solo quel che serve. La mattina ci sono giochi di movimento all’aria aperta, o si svolge un’escursione che a volte prende anche il pomeriggio, o ci si prepara per la festa per genitori, amici, parenti che si svolge solitamente a metà della vacanza: prepararsi vuol dire imparare balli e canti provenienti da diversi contesti culturali e geografici, creare giochi (che poi nella giornata di festa verranno fatti da tutti, genitori compresi) e manufatti in legno e in altri materiali. Giochi auto-costruiti e particolari che, dicono i ragazzi, «si fanno solo al CEMEA» e piacciono proprio a tutti: «saltacavallo», freccette, minigolf, la pesca, «gira la ruota», «la pallina nel castello», la costruzione di una mongolfiera di cartapesta, che il giorno della festa si è alzata in cielo, sparendo nel blu e riempiendo di emozione tutti i partecipanti. Le escursioni si svolgono in mezzo alla natura, a scoprire le sorgenti di acqua sulfurea e le piante che circondano il casale in campagna che è la residenza del CEMEA Lazio, i noccioleti e la faggeta, ma anche al lago di Bracciano, o a scoprire le tracce del passato, come nel caso della gita a una vecchia mola abbandonata.
Tutte queste attività si fanno anche il pomeriggio, ma dalle 16 in poi: prima c’è il pranzo e dopo pranzo i giochi da tavolo e le chiacchiere. Ecco, il parlare tra ragazzi, è insieme al fare ciò che più piace: lo si fa spesso, anche andandosi a rifugiare nel noccioleto. In realtà qui stiamo ricostruendo una giornata tipo ma i giorni non sono mai uguali e le attività non sono proprio così fisse o inquadrate come sembra da questo scritto. Si fanno anche laboratori di pittura, di lavorazione della creta, si costruiscono dei mobile con elementi naturali, foglie, legno, corda, c’è il laboratorio di crepes e così via.




Pranzi e cene funzionano così: un gruppo da 15 viene diviso in tre e a turno, un gruppo apparecchia, uno sparecchia e l’altro non fa nulla e a rotazione i gruppi si alternano, pasto dopo pasto. La sera dopocena c’è la veglia, un gioco che si fa tutti insieme, ogni gruppo di circa 15 persone, in cerchio. Poi ci si lava i denti, ci si mette il pigiama, si legge un libro tutti insieme in una tenda e si va a dormire in tende separate per i maschi e per le femmine. Nell’esperienza quotidiana dei ragazzi, così come in quella di un solo giorno che hanno fatto gli adulti in occasione della festa, i principi alla base dell’educazione attiva sono praticati «naturalmente» e si percepisce un’atmosfera nuova, genuina, profonda e rilassata. Quel che raccontano i ragazzi che hanno vissuto l’esperienza del CEMEA è che qui è facile stringere amicizia, ci sono persone molto aperte, che portano anche chi è più chiuso ad aprirsi. C’è sempre modo di chiacchierare e di stringere amicizia, nelle camminate, nel dopo pranzo, andando al noccioleto ecc. I genitori si possono sentire per telefono dalle 19 alle 19:30, che è anche l’unico momento in cui i ragazzi hanno a disposizione uno smartphone.
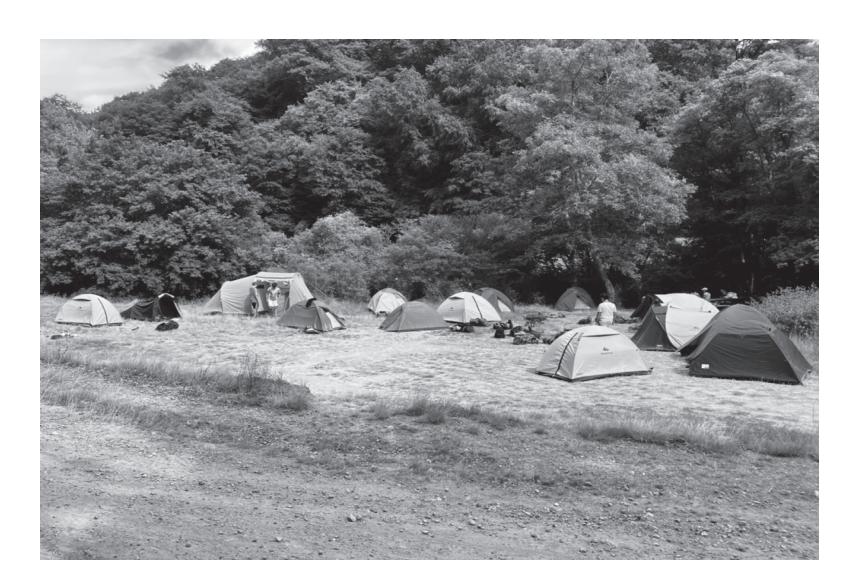




I ragazzi e le ragazze escono da queste esperienze cambiati, cresciuti, maturati. Così dicono: «esci da lì che sei un’altra persona», anche perché in queste esperienze molto belle e formative si fanno amicizie importanti, che rimangono nel tempo, sottolineano.
L’apprendimento si basa sul fare, nel senso che è l‘ESPERIENZA a fare sì che un concetto venga interiorizzato
Ciò che caratterizza queste esperienze educative è anche l’assenza di giudizio: agli occhi dei ragazzi gli adulti, cioè gli educatori, chiamati solitamente «monitori», sono simpatici, bravi, non severi ma «giusti», perché – e sono ancora le parole di alcuni partecipanti – «ci lasciano liberi». Devo dire, mi si passi un piccolo inciso personale, che una delle soddisfazioni più grandi del mio lavoro da insegnante, è stata quando alcune studentesse, finiti tre anni di lavoro insieme e uscite dal liceo, mi hanno detto che avevano apprezzato il mio insegnamento «perché non le giudicavo». Questa cosa mi stupì moltissimo, e c’è una simile meraviglia nei partecipanti al CEMEA, un disorientamento iniziale dato da tale assenza di giudizio, che poi li affascina, libera la loro voglia di fare, di riflettere, di immaginare. Le risposte, individuali o di gruppo, alle proposte degli educatori, sono ascoltate, valutate e contribuiscono alla nascita di nuove proposte. Ecco che l’educazione si sviluppa concretamente attraverso le persone che vivono in prima persona quella esperienza.
L’apprendimento si basa sul fare, nel senso che è l’esperienza a fare sì che un concetto venga interiorizzato. Le attività manuali, espressive, ludiche, non verbali sono centrali nelle attività dei CEMEA, che collegano così teoria e pratica, il riflettere e l’agire, gli aspetti verbali e non verbali, coinvolgendo la persona nella sua interezza e complessità. John Dewey sosteneva che tra tutte le incertezze ci fosse un punto fermo: il «nesso organico fra educazione ed esperienza personale» e precisava: «esperienza ed educazione non si equivalgono […] Tutto dipende dalla qualità dell’esperienza». Molla per un impegno non superficiale da




parte dei ragazzi e delle ragazze è la motivazione, che porta a compiere un’azione non solo per il proprio interesse, ma anche per condividere con gli altri scoperte, entusiasmi, sconfitte. Essa a volte è cosciente, a volte è sommersa, negata dai ruoli e dalle consuetudini e valorizzarla è la chiave per affrontare anche le situazioni più difficili.
Le attività proposte dai CE-MEA coinvolgono la persona nella sua complessità, tenendo presente i vari mondi che si muovono in ogni essere umano: quello affettivo, logico, dell’immaginazione, degli ideali, la dimensione cognitiva, affettiva ed esistenziale. L’educazione attiva ritiene che non sia separabile il pensiero dall’affettività ed entrambi questi aspetti vengono fatti interagire: si pensa, si fa, ci si emoziona. Lo si fa in uno spazio adeguato e in un tempo tranquillo, libero dalla frettolosità e dall’ansia che caratterizzano la nostra vita sociale. I CEMEA sostengono così che un tempo libero
e «liberato» dia l’opportunità ai cittadini e alla società di riappropriarsi in modo attivo e consapevole della gestione della propria crescita personale, fuori da schemi e condizionamenti caratteristici dell’economia di mercato. Promuovono così il diritto alle vacanze per tutti, anche grazie a tariffe che si vogliono mantenere popolari (non oltre i 30 euro al giorno), e sostengono l’importanza di strutturare percorsi formativi non professionalizzanti che permettano ai giovani di impegnarsi in maniera volontaria per attuare questo diritto.





Le attività sono diversificate a seconda dell’età: nel caso del CE-MEA del Lazio inizialmente, ovvero fino ai sei anni, sono previsti attività di uno o due giorni, poi si arriva a un paio di settimane estive presso il centro CEMEA, in abitazione o in tenda, quindi dai 13 anni in su cominciano a effettuare vacanze in tenda, cioè in campi auto-costruiti, in posti lontani dalle residenze CEMEA. Una modalità consueta in tutte queste occasioni di formazione e di vacanza è il lavoro in équipe, basato sul confronto continuo, che consiste anche nel mettere in comune le proprie debolezze, pensando che una debolezza condivisa rappresenti la massima risposta educativa a quella specifica situazione, a quella realtà, a quelle precise persone con le quali si sta lavorando. I CEMEA non utilizzano sistemi forti né univoci, o sistemi che mirano più al risultato che al processo, più al prodotto che alle persone e anzi ritengono che l’incertezza dei risultati sia importante perché porta a rileggere insieme ciò che è avvenuto dopo ogni proposta. Nei campi d’azione proposti dal CEMEA il gruppo ristretto, quello allargato, l’agire nel sociale, sono tre aspetti di uno stesso problema: nel senso che non ci dovrebbe essere contraddizione




tra piccolo e grande, particolare e generale. I CEMEA sono un movimento locale e internazionale insieme, un movimento educativo specifico ma non settoriale. Il personale è sociale, l’educativo è politico. Dagli stage, dove la relazione interpersonale avviene in una comunità relativamente piccola, fino alle iniziative più diradate nel tempo o meno intense, l’attenzione dei CEMEA è sempre rivolta a creare condizioni che permettano lo scambio, il dialogo, la comunicazione aperte. Le iniziative di formazione, l’organizzazione di situazioni di vacanza, la realizzazione di corsi professionali, i progetti internazionali, i convegni, fanno tutti parte dello stesso progetto educativo e coniugano la formazione personale a quella sociale più allargata.
Educazione come cambiamento
L’educazione non [è] già l’organo della «riproduzione» dell’esistente, come essa è stata ed è ancora in larga misura praticata dalle istituzioni e dagli Stati, bensì l’agenzia privilegiata del cambiamento e della trasformazione.
Lamberto Borghi, Educare alla libertà, 1992, p. 3.
L’azione dei CEMEA è aconfessionale e apartitica, ma non neutrale né apolitica, in quanto mira alla crescita continua dell’essere umano, alla libertà di pensiero, al senso di responsabilità, al rifiuto di ogni dogmatismo; fa vivere in prima persona a chi partecipa alle attività atteggiamenti di rispetto e di comprensione verso se stessi e gli altri, fa crescere la stima di sé, dà fiducia, rassicura e consolida, alleggerisce la paura verso l’altro, verso il diverso. Una proposta-tramite, che può permettere a ognuno di sperimentare il percorso della propria formazione e della propria emancipazione. I CEMEA si impegnano per la piena e sostanziale applicazione dei principi che fondano la laicità: la libertà di coscienza, la separazione tra interessi delle Chiese e dello Stato, il libero esercizio dei culti e dell’ateismo, il rispetto dei diritti umani e delle diversità culturali.




L’educazione è qui intesa come impegno sociale, al fine di costruire una società giusta, solidale, egualitaria. Ciò vuol dire che i CEMEA partecipano attivamente alla trasformazione della società e alla costruzione di alternative, inscrivendo la propria azione nelle correnti di pensiero ispirate all’internazionalismo e alla nonviolenza, nella tradizione libertaria e democratica. Si oppongono a quelle scelte politiche che aggravano le disegua-
glianze e distruggono il vivere e i beni comuni, nella convinzione che l’educazione, la cultura, la salute e il sociale siano beni collettivi che devono essere tenuti fuori dalle logiche della commercializzazione e della privatizzazione.
I CEMEA sono parte di un sistema di reti locali ispirate a pratiche cooperative e alternative in campo sociale ed educativo e inseriscono la propria azione nella prospettiva di un servizio pubblico locale, ter-

ritoriale, nazionale e internazionale. Con la loro azione laica e democratica, creano spazi di saperi e servizi che hanno come riferimento valori dell’economia sociale e solidale, affermando, internamente ed esternamente, il primato della persona sul profitto. Agiscono per un’educazione al rispetto, alla tolleranza, alla diversità, per l’acquisizione dello spirito critico e per lo sviluppo del vivere comune in una prospettiva di pace.
Nel fare questo contrastano ogni modello di società fondato sul profitto, il consumo, il dominio dell’economico che minaccia i diritti fondamentali degli esseri umani, della natura e delle sue risorse. Promuovono stili di vita sostenibili, forme attive di decrescita, di riduzione dei consumi e dei bisogni, di riutilizzo delle risorse che assicurino un approccio globale alle realtà complesse




del mondo, che siano sociali, culturali, economiche e ambientali. Considerano l’educazione ambientale e il consumo consapevole un fattore indispensabile per rafforzare il legame tra rispetto dell’individuo, difesa dell’ambiente e qualità della vita quotidiana per tutti.
Per i CEMEA l’educazione è globale ed essi credono nel ruolo centrale della scuola laica e pubblica, luogo della riuscita, del successo formativo per tutti e dell’apprendimento dei valori dell’eguaglianza e della cooperazione, e rivendicano l’importanza del lavoro comune tra insegnanti, genitori, attori educativi del territorio, movimenti associativi pedagogici, mondo della cooperazione sociale. I CEMEA promuovono la diffusione di pratiche pedagogiche centrate sull’allievo inserito in una comunità d’apprendimento, che favoriscano percorsi personalizzati, nel quadro della scolarità obbligatoria e in continuità con i principi dell’Educazione Attiva, come testimoniano anche alcune esperienze private di qualità, ad esempio la Scuola Fasolo a Firenze, il CEIS a Rimini. Sostengono la necessità di migliorare e promuovere la formazione iniziale e permanente degli insegnanti e, con il proprio patrimonio di esperienze, competenze teoriche e pratiche, rivendicano la partecipazione a questi processi formativi sviluppando l’integrazione tra educazione formale e non formale.
I CEMEA sono convinti della necessità di un’educazione artistica e culturale che non miri a «consumare meglio», ma piuttosto a fornire le chiavi della comprensione delle espressioni artistiche e culturali, come anche gli strumenti per agire in maniera creativa e consapevole nel proprio ambiente. Non intendono l’educazione, o la cultura, come qualcosa di specializzato o settorializzato, ma sostengono l’idea di individualità integrata, ritengono che ogni aspetto della persona sia importante, non negando la specializzazione tecnica o culturale, ma arricchendola delle molte sfumature che sono dentro ogni persona, rivalutando la qualità del vivere individuale e associato. Sostengono da sempre che l’educazione attraversa ogni momento della vita. «L’educazione è




in ogni momento, ogni momento di vita deve essere considerato con la stessa attenzione», affermava Gisèle de Failly, un concetto che ritroviamo in Colin Ward e nella sua definizione di educazione «incidentale» (Ward 2018). Se famiglia e scuola sono sempre stati considerati i luoghi per eccellenza dell’educazione, Ward esplora invece luoghi accidentali: strade urbane, prati, boschi, bagni scolastici, negozi e botteghe artigiane sono tipi diversi di ambiente dove il bambino è inserito e che possono offrire opportunità educative insperate. La formazione non deve essere confinata nelle aule scolastiche ma essere diffusa. Ne consegue che la consapevolezza di essere agenti di educazione riguarda tutti ed emerge in ogni contesto. Riguarda l’essere genitori, insegnanti, chi fa il medico, l’assistente sociale, l’infermiere o l’impiegato. Chiunque, adulto o bambino che sia, abbia un rapporto di potere, dipendenza, autorità, diritto nei confronti di altri si trova in condizione di esplicare azioni educative.




Bibliografia
Borghi L., La città e la scuola, a cura di Goffredo Fofi, eleuthera, Milano, 2023.
Codello F., La buona educazione. Esperienze libertarie e teorie anarchiche in Europa da Godwin a Neill, Franco Angeli, Milano, 2005.
De Maria C., Lavoro di comunità e ricostruzione civile in Italia. Margherita Zoebeli e il Centro educativo italo-svizzero di Rimini, Viella, Roma, 2015.
De Maria C., Intervento sociale e azione educativa. Margherita Zoebeli nell’Italia del secondo dopoguerra. Atti del convegno tenutosi al Centro educativo italo-svizzero, Rimini, 7 maggio 2011, Clueb, Bologna, 2012.
Denti R., Conversazioni con Marcello Bernardi, elèuthera, Milano, 1991.
Gervasio G., Un operaio semplice. Storia di un sindacalista rivoluzionario anarchico (1886-1914), ZIC, Milano, 2011 (cap. 14: L’educazione dei giovani).
Landi G. (a cura di), Dossier Lamberto Borghi. Per una pedagogia libera, laica libertaria, in «A Rivista anarchica» n. 419, ottobre 2017.
Ward C., L’educazione incidentale, a cura di F. Codello, elèuthera, Milano, 2018.


ESPERIENZE
Traficantes de sueños Il libro come mezzo di trasformazione individuale e collettiva
Valeria Giacomoni
Il progetto politico Traficantes de Sueños colloca al centro della sua pratica editoriale il valore comunitario del libro. Questa peculiare cooperativa, situata a Madrid, è una casa editrice ma anche una libreria, si occupa della distribuzione e funziona da centro sociale dato che nei suoi locali si offrono corsi, dibattiti, proiezioni e riunioni. Traficantes è conosciuta per aver creato un modello di produzione sostenibile in cui il download gratuito dei testi si affianca alla vendita di libri stampati. La loro proposta comunque è molto più ambiziosa. In questo progetto i testi sono strumenti collettivi di pensiero e la pratica della lettura sembra essere capace di creare una plusvalenza di relazioni sociali. Nel modo in cui organizza il proprio lavoro, forma lettori, costituisce le sue collezioni, distribuisce i suoi testi e finanzia un’imprenditorialità critica, Traficantes sembra intendere il libro come un luogo di incontro che potenzia diversi dibattiti, posizioni e pratiche all’interno dei movimenti politici. Le linee strategiche presenti nei suoi libri sono l’economia politica, la cultura libera, il femminismo, la geografia critica, la critica della produzione culturale e altre ancora.
Questo è il modo in cui si definiscono sul loro sito web: Traficantes de sueños è un progetto di produzione e comunicazione politica con sede a Madrid, che aspira ad apportare contenuti e




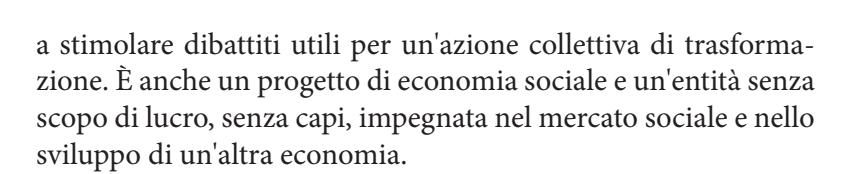
Evoluzione del progetto
Proviamo a seguire il processo di crescita dalla nascita della piccola libreria nel 1995 in una posizione emblematica, vicino alla piazza Tirso de Molina, uno dei punti più significativi a Madrid per l’attivismo politico, culturale e sociale dato che accoglie tutte le domeniche un mercatino di libri a tema sociale/politico. I movimenti sociali degli anni Novanta lavoravano sui temi dell’ecologismo, del femminismo, dell’occupazione di spazi e di centri sociali, dell’antimilitarismo. In questo magma così variegato diverse persone si organizzarono per creare uno spazio stabile dove mettere a disposizione di tutti questi collettivi materiali per la riflessione, la formazione e la discussione per poter avanzare in qualche modo tutti insieme. La necessità di una certa stabilità rispondeva al problema della precarietà di tante piccole biblioteche/librerie che nascevano nei numerosi spazi occupati nella Spagna degli anni Novanta, che però rimanevano progetti temporanei senza la possibilità di crescere.
La scelta del libro appunto portò ad interrogarsi in fretta sulla sostenibilità del progetto, che dagli inizi si sentiva parte di una rete più grande inserita nei movimenti sociali. Il primo passo è stato passare da libreria a libreria associativa.
Il concetto di base della libreria associativa è avere dei soci che si impegnano a supportare il progetto con un apporto mensile in
cambio di una serie di sconti, una specie di finanziamento collettivo. Fondamentale quindi è stato trovare persone che considerassero necessario ed interessante sostenere un progetto come questo, anticipando piccole quote; questo ha permesso nel tempo di creare una
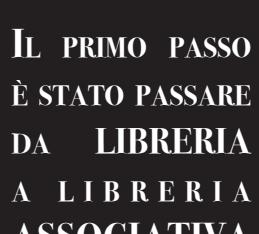


serie di relazioni tra diverse persone e collettivi che sono diventate una vera e propria rete. Questo generarsi di incontri e di possibilità di progetti è un motore molto più forte del semplice contributo economico.
Negli anni Traficantes è cresciuta, diventando da libreria associativa a casa editrice, occupandosi poi anche della distribuzione; dagli anni 2000 il progetto è cresciuto con la proposta grafica, e infine con lo spazio di autoformazione e produzione Nociones Comunes. La sede della libreria è quindi uno spazio collettivo, aperto alla città, in un luogo centrale e significativo di Madrid, che accoglie numerose presentazioni, proiezioni, riunioni, laboratori e dibattiti. Il legame di Traficantes con i movimenti sociali non è variato, e, per questo motivo, cambia insieme a loro: in questa evoluzione continua, quando cambiano le domande, cambiano anche le risposte e le alternative che si propongono. È un processo vivo: la casa editrice funziona meglio quando è capace di ascoltare ciò che succede nei movimenti sociali e questa connessione le dà una maggiore probabilità di presentare testi che rispondano all’interesse della gente. Così la casa editrice rinforza il movimento e questo a sua volta rinforza la casa editrice. È una relazione di dialogo in una spirale costante, potremmo dire in un circolo virtuoso.





Organizzazione interna
Traficantes è un’associazione culturale che funziona come un collettivo, ovvero in maniera assemblearia e orizzontale. Attualmente sono 14 i componenti dello staff con responsabilità, più una serie di collaboratori. Ogni area si organizza attraverso la propria assemblea, e ha quindi autonomia sia economica che per la presa di decisioni quotidiane, cosa che permette che i processi siano abbastanza agili. Inoltre, c’è un coordinamento settimanale di tutto lo staff per prendere le decisioni più a medio e lungo termine e per definire le linee sulle quali lavorare e investire. Questa cadenza di incontri viene combinata con una o due riunioni annuali nelle quali si fa un bilancio del lavoro e degli obiettivi ed una proiezione per i mesi successivi.
Traficantes è iniziato come un progetto di attivismo politico e culturale per cui non c’era ricompensa economica per le persone che vi dedicavano del tempo, ma a poco a poco si è trasformato in un progetto di autoimpiego. Il cambiamento è avvenuto a mano a mano che il progetto cresceva, dato che di pari passo aumentava il tempo e il grado di professionalità richiesto. C’è stato quindi un processo di specializzazione e formazione nelle funzioni di libraio ed editore. Da un certo momento il collettivo ha deciso che era necessario uno stipendio per il lavoro svolto, che fosse dignitoso e con contratto regolare. In altri progetti politici il rifiuto dello Stato passa anche da un rifiuto delle sue strutture di protezione collettiva; nel caso di TDS, invece, si considera che sia stato lo Stato ad appropriarsi delle formule di cura collettiva che aveva creato il movimento operaio. Tutte le aree di TDS sono produttive e ogni lavoratore riceve lo stipendio dalla sua area. Esistono dei meccanismi di solidarietà interna, e tutti gli stipendi sono uguali.
Per quanto riguarda gli stipendi e la lotta contro la precarietà comunque il collettivo ha scelto la propria posizione con una riflessione interna, tenendo conto che in un progetto precario, con pochi soldi, si tende a non pagare per le cose di cui si ha bisogno, e si finisce per contribuire a generare precarietà (per esempio



28


se inviti un gruppo a suonare al centro sociale, meglio se non si fanno pagare). Per rompere questo circolo vizioso invece l’idea è di pagare in forma giusta tutti i servizi intorno al progetto; coscienti che si tratta di circolazione di soldi tra poveri e che contemporaneamente è da portare avanti una lotta parallela per una più equa divisione della ricchezza e per altri diritti collettivi, ma senza dubbio il pagamento dei servizi offerti sostiene un’economia solidale che permette a tanti di andare avanti.
Economia sociale/ Impresa politica
Questi termini sembrerebbero antagonistici: può un’azienda/ impresa essere qualcosa di politico? È possibile che l’economia sia qualcosa di sociale? Le imprese sono effettivamente qualcosa di molto politico; sembra che possa esistere solo un tipo di azienda: quella capitalista che conosciamo, il cui unico obiettivo è ottenere benefici senza tenere in conto il pianeta e gli esseri che ci vivono.
Ma tante persone si possono unire e mettere in moto processi produttivi, che generano posti di lavoro, beni e servizi, a partire da principi etici. Questa è la base dell’economia sociale, che conta in tutto lo stato spagnolo, e in tutto il mondo, migliaia di cooperative, associazioni e aziende che producono secondo un altro modello economico. L’obiettivo non è accumulare benefici, bensì generare beni e servizi attraverso strutture produttive giuste, dove ciò che conta sono l’uguaglianza nel lavoro, l’uguaglianza di genere e il rispetto per il pianeta.
Traficantes è un progetto di economia sociale e un’azienda politica. È un’associazione senza scopo di lucro dove comandano i lavoratori. Uno spazio produttivo dove si tiene molto in conto ciò che può essere politicamente utile a movimenti e collettivi che aspirano alla trasformazione dello stato attuale delle cose; TDS può apportare qualcosa perché è immerso nel tessuto vivo della città. Come molti altri progetti di economia sociale quindi sopravvive grazie alla comunità che sceglie di appoggiarlo perché lo considera una risorsa preziosa per tutte/i.




Cultura libera
Una delle peculiarità del progetto è lo scommettere su una cultura libera. I movimenti per la cultura libera aspirano alla libera diffusione della conoscenza e delle espressioni artistiche della società. Comprendendo che questi saperi sono il risultato della collaborazione sociale, considerano che vincolarli mediante le leggi della proprietà intellettuale danneggia lo sviluppo della società e di ognuno dei suoi membri.
Per questo motivo, i testi della casa editrice TDS vengono pubblicati con la licenza Creative Commons, che permette di copiare liberamente e distribuire senza scopo di lucro. Inoltre, nello stesso momento in cui i libri di TDS vengono pubblicati e sono in vendita, viene contemporaneamente caricato il pdf sul loro sito, per download gratuito, a disposizione delle persone che vogliano replicare quei contenuti. Questa scelta è stata una scommessa, un’intuizione; nessuno poteva assicurare che avrebbe funzionato, ma si è dimostrata sostenibile
nel tempo. Con la loro esperienza hanno dimostrato che anche mettendo a disposizione il download gratuito, si continuano a vendere libri fisici.
Il ragionamento di base ruotava intorno al fatto che l’importante per un libro è sapere che esista, solo in questo modo c’è poi la possibilità che venga letto e acquistato. Quindi più gira l’informazione o anche il testo intero, più viene conosciuto e comprato. Per una




casa editrice piccola e di pensiero critico, al giorno d’oggi internet apre una finestra di visibilità che permette, anche senza disporre di una grande macchina promozionale, di entrare in un mercato molto concentrato nelle mani delle grandi case editrici, che si accaparrano la maggior parte del mercato.
Ma, inutile negarlo, libero non vuol dire gratis, e i progetti di cultura libera hanno quindi bisogno della co-responsabilità della comunità, ovvero che chi crede nella libera diffusione della cultura, li sostenga in molteplici forme.
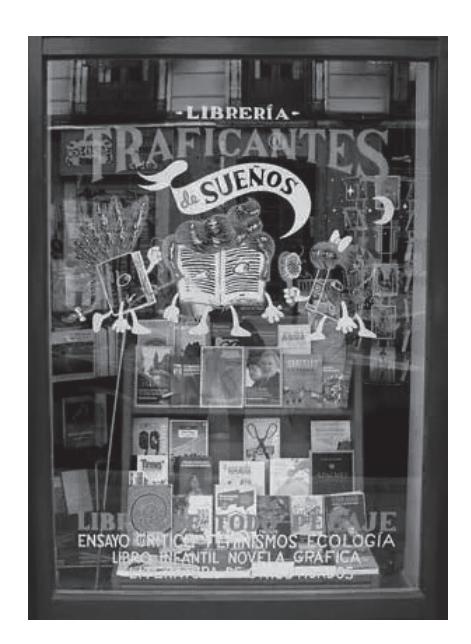
Fare rete
Traficantes partecipa alla Fundación de los Comunes, iniziativa condivisa con l’Ateneu Candela di Terrassa, in Catalogna, e la Casa Invisible di Malaga. Grazie a questa federazione hanno attivato il progetto Nociones Comunes a livello statale e incoraggiano la produzione di analisi e ricerche, come con l’Osservatorio Metropolitano di Madrid e di Barcellona o Azofra a Saragozza. Formano parte della rete anche altri progetti-libreria come Katatrak di Pamplona, La Pantera Rosa di Saragozza, Synusia a Terrassa e La Fuga a Siviglia.
L’obiettivo della rete è generare un nuovo modello istituzionale, che superi il vuoto o la limitata capacità di risposta delle istitu-




zioni tradizionali alla situazione critica che stiamo attraversando, a livello economico, sociale e politico. La proposta è quindi sostenere il pensiero e l’azione critica con la costituzione di un polo trasversale di produzione critica che metta in circolazione nuovi paradigmi di interpretazione della realtà e nuove proposte di trasformazione nelle nostre pratiche di vita.
https://fundaciondeloscomunes.net/
Anche queste connessioni con diversi collettivi in vari punti della penisola arricchiscono il bagaglio culturale del progetto, permettono confronto continuo e aiutano a tenere il polso delle inquietudini, energie e necessità che si manifestano nel tessuto sociale.
La rete di librerie è fondamentale. Prima di costituire la Fundación il sostegno era pratico in una rete di vendita solidale, dove poter integrare tutto il circuito del libro dalla capacità di incidenza, alla diffusione, alla visibilità. Ogni casa editrice offriva uno spazio privilegiato nella sua libreria alle pubblicazioni delle altre, che venivano sempre raccomandate anche perché prodotto di un dibattito collettivo. La collaborazione poi si è ampliata condividendo strumenti come l’architettura della pagina web e la sua programmazione, e all’inizio con formazione ai librai e la possibilità di avere libri in deposito. Quando una libreria è nuova e c’è un margine di incertezza sul futuro, nessuno vuole lasciare libri in deposito, in questo modo invece si mette in pratica il mutuo appoggio e si cerca di intercedere con altre librerie perché facciano lo stesso. Questo certamente aiuta nell’impresa iniziale di aprire una nuova libreria. Inoltre, condividendo gli stessi dibattiti politici il coordinamento si è ampliato alla Fundación per proporre presentazioni di libri o corsi di Nociones comunes. C’è un processo di sinergia tra i diversi progetti che passa attraverso una lotta comune.




Formazione e attività proposte
Per quanto riguarda la preparazione, in Traficantes quasi nessuno ha compiuto studi legati all’editoria o alla distribuzione, la maggior parte dei componenti del gruppo hanno studiato storia, lettere, architettura, design ma soprattutto tutti/e si considerano attivisti/e e quindi i contenuti dei libri vengono dalla loro formazione e dalla loro militanza.
«Essere immersi nei movimenti politici del nostro tempo è ciò che ci fa scommettere su determinate linee. Essere nelle lotte, nelle strade é ciò che ci permette di individuare quali campi sono potenzialmente utili per cambiare le cose o per il pensiero critico trasformativo».
La forza di questo collettivo pare proprio questa immersione in un contesto politicizzato e la plasticità del progetto, capace di adattarsi alle diverse necessità aprendo nuove linee di azione, sempre in evoluzione.
L’idea di offrire servizi di grafica e design nasce dal fatto di avere già sviluppato queste competenze con la casa editrice e quindi dal mettere a disposizione di terzi le proprie capacità, rispondendo così a una necessità delle reti di attivismo e del contesto politico in cui si muovono.
C’è poi fin dall’inizio un’attenzione verso proposte culturali gratuite e accessibili a tutti/e e allo stesso tempo un interesse perché il lavoro, le competenze e il tempo investito dalle varie persone venga valorizzato. L’idea di proporre dei cicli di incontri parte quindi da questa necessità di approfondire delle singole presentazioni o dibattiti che non offrivano continuità o possibilità di arricchire il discorso. Nociones comunes nasce nel 2010 e propone corsi in otto o dieci sessioni, dove uno o più invitati apportano il loro punto di vista su un argomento, con l’obiettivo di creare una riflessione comune. Le sessioni vengono registrate e messe a disposizione su internet con Creative Commons in modo che questi contenuti non siano solo per le persone che possono




partecipare fisicamente agli incontri. Si è creato perciò un archivio di memoria e discussione accessibile su internet. Ció concorda totalmente con gli obiettivi del progetto.
Le attività organizzate da TDS sono circa 250-300 all’anno, praticamente tutti i giorni, e la maggior parte sono gratuite. I corsi organizzati con Nociones Comunes invece generalmente sono a pagamento. È previsto tuttavia che ci siano diverse tariffe, per tutte le tasche. Le tariffe basiche sono Precaria, Standard e Sostenitore ma in ogni caso nessuno rimane escluso per questioni economiche. In conclusione, possiamo dire che la plasticità e la connessione con i movimenti sociali in cui è immerso siano le caratteristiche principali di questo progetto. Con una grande capacità di cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie anche nell’ambito della produzione editoriale, e il coraggio di saper scommettere su intuizioni controcorrente.

Links
Entrevista a Beatriz García de Traficantes de sueños (Maldita Cultura) | Valor de cambio
https://elasombrario.publico.es/traficantes-de-suenos-luchar-con-libros


34


Nascita e sviluppo
Non ci ricordiamo la data, forse era il febbraio del 2015, ma ricordiamo il luogo: Magazzini Prensili, spazio autogestito nel feltrino da alcuni giovani con progettualità artistiche artigianali. Soprattutto ricordiamo chi: alcuni contadini, qualche volto visto in svariati incontri, festival, altri non conosciuti. Tutti presenti in una stanza a discutere del senso del nostro lavoro, delle progettualità mutualistiche che possono intercorrere tra le varie realtà agricole, del valore politico delle nostre azioni, delle difficoltà di arrivare a fine mese quando ci si prende la responsabilità di lavorare in agricoltura.
Nasce così, informalmente, il primo gruppo Genuino Clandestino. Nasce come snodo tra le realtà di Belluno, Treviso e Venezia poi, con il passare del tempo, vedrà partecipi soprattutto le realtà contadine della Marca Trevigiana. Ironicamente il gruppo, unico in Italia, viene accolto con il sorriso dai compagni di «Campi aperti» quando verranno a conoscerlo e si chiamerà «Genuino clandestino Treviso Belluno Venezia». Il collettivo promotore non avrà per anni un nome. Solo negli ultimi tempi il gruppo si è dato il nome di «Erbe matte».




L’inizio non sarà facile, passeranno diversi mesi e qualche riunione, poche all’inizio. I contadini sono troppo impegnati nei campi per ritrovarsi. Poi, piano piano, anche se con fatica, riusciremo a confrontarci con il manifesto nazionale di Genuino Clandestino, discutendone ogni punto ed elaborando regole autonome.
Dopo qualche mese, la situazione si sblocca in coincidenza dell’assemblea nazionale che si terrà presso il bocciodromo autogestito di Vicenza. Ogni anno si tengono due assemblee nazionali itineranti che scandiscono il ritmo del movimento nazionale: ci si confronta e ci si dà collettivamente le coordinate, le parole d’ordine, i contenuti condivisi su cui lavorare.

Il movimento Genuino Clandestino è nato nel bolognese, per poi diffondersi su tutto il territorio nazionale, cercando di dare delle risposte concrete a tutti quei compagni e compagne che hanno scelto di imbracciare zappa e rastrello per iniziare a seminare una relazione nuova con la terra. È un movimento formato da contadini e contadine, simpatizzanti e coproduttori, persone che scelgono concretamente di solidarizzare con chi trova nella terra la sua forza e potenzialità produttiva e sociale.
Nella ricerca di dare forza e concretezza alla realtà locale che si stava creando, il primo scoglio che si è presentato è stato individuare il luogo dove poter realizzare le progettualità che divenivano via via sempre più chiare e condivise. L’incontro a Vicenza con alcuni militanti del centro sociale Django di Treviso darà ulteriore spinta positiva al progetto.



Per diversi anni nella terza domenica del mese, appuntamento che poi diverrà consuetudine, si tiene un mercatino di vendita dei nostri prodotti e in tale occasione si dialoga con la gente del posto. Raccontiamo la biodiversità dei nostri campi, le nostre idee, il nostro manifesto, distribuendo volantini, illustrando corsi e iniziative varie. Il mercoledì diventa il giorno della consegna delle verdure e del pane presso la bottega gestita dal G.A.S. La Piave.
La relazione, per noi «sacra», con i clienti o coproduttori, è avviata grazie a questi continui interscambi. Individualmente ognuno ha il suo percorso, ma qui si privilegia il lavorare insieme. In questo piccolo mondo alcune realtà troveranno terreno per far germogliare la propria esperienza, in tranquillità, senza burocrazia. Non è facile fare agroecologia all’interno del modello di sviluppo attuale, competitivo e unilateralmente razionale, composto da esperienze economiche strutturate, volte unicamente al profitto. Il nostro territorio è un intreccio di capannoni, vigneti, strade e cave. I campi ecologicamente resistenti appaiono solo raramente. Sicuramente la relazione e la costruzione di contenuti condivisi, che si traduca in pratiche reali, è l’unica speranza che abbiamo per dare e darci una risposta al nonsense dell’asfalto padano.
I contenuti maturati dal gruppo sono affini a quelli del Genuino Clandestino nazionale. Ci si insedia nelle zone agricole che ancora sopravvivono. Scegliere di liberare la terra dalla chimica e dal dilagare dell’industria è una vera e propria battaglia campale, che si combatte palmo a palmo. Diviene sempre più necessario aumentare il territorio liberato dalle sementi delle multinazionali, dai prodotti deleteri per le falde acquifere, dai veleni mortali per la fauna selvatica, ma è sempre più difficile. I semi commerciali ibridi totalizzano l’agricoltura tradizionale rendendo quella ecologica sempre più complessa da praticare con piante non adatte a essere coltivate con tecniche naturali.




Fare biodiversità
Fare biodiversità significa portare avanti linee genetiche tradizionali che arricchiscono la nostra quotidianità di sapori, colori, profumi, nutrimenti che sfuggono dalla ricerca ingegneristica delle multinazionali. L’industrializzazione del prodotto, la programmabilità della sua pezzatura ai fini commerciali, la maturazione standardizzata per facilitarne la raccolta e la distribuzione, omologano la varietà delle specie coltivate. Questo comporta come corollario la perdita della capacità del contadino di salvare il seme e si rende così l’agricoltura totalmente dipendente dalla ricerca delle multinazionali che, attraverso il meccanismo dei brevetti, rendono costoso il patrimonio comune della vita e fuori dal controllo da parte degli agricoltori. Ecco che il grano antico Verna di Giovanni, il mais bianco perla di Daniel, il cavolo riccio di Michela ridanno i sapori e la genuinità di un’alimentazione capace di nutrire.
Per fare resistenza in campagna c’è bisogno non solo di contadini che facciano funzionare economicamente le loro aziende, le loro comuni, i loro eco-villaggi, ma anche di tutta una rete

sociale che li appoggi e ne condivida le scelte. Questo si traduce nella pratica in mercati della terra, gruppi di acquisto solidale, gruppi di acquisto solidale della terra, collettivi di supporto all’agricoltura contadina. C’è tutto un lavoro da fare per la selezione e conservazione delle sementi tradizionali, che per riuscire, ha bisogno della partecipazione di tante realtà. Per non ricadere nel seme brevettato bisogna iniziare un lavoro importante che non può essere fatto se non con un lavoro condiviso.




Un’altra battaglia importante per il Genuino Clandestino è quella di riuscire a diminuire il tempo dedicato alle sempre più onerose incombenze burocratiche, liberando risorse da dedicare in modo più proficuo alla cura della terra e dei suoi prodotti. È intollerabile dedicare il 20-30% del tempo alla burocrazia. Si dà spazio anche a realtà che nell’economia classica sarebbero considerate marginali, ma che invece con passione ancor più viva si prendono cura di un territorio. Essere delle realtà più agili e strutturate, meno soffocate da regole e adempimenti burocratici è un punto di forza. Nostra scelta è far sì che il proprio agire non abbia sempre solo il fine economico, ma che si possa creare un equilibrio sempre nuovo fra la propria sopravvivenza e la cura delle reti di vita in cui si è immersi quando si lavora in campagna.
Una delle cose importanti per i contadini che lavorano in accordo con la natura è la necessità di comunicare efficacemente il proprio modo di produrre, per farne comprendere la genuinità. È importante per noi quindi non delegare a un ente certificatore esterno che burocraticamente garantisca la qualità del prodotto. In questo orizzonte nasce il vero nucleo di Genuino Clandestino: l’assemblea autogestita dei contadini e simpatizzanti. Insieme si costruiscono le regole e i percorsi. Si crea un sistema di certificazione partecipata.
Perché pagare un ente di certificazione terzo, convenzionato con lo Stato, per poter dimostrare al consumatore l’ecologicità del proprio prodotto quando siamo noi in prima persona, con il nostro lavoro e le nostre scelte a garantire la bontà e autenticità di quanto viene offerto? Le visite nelle aziende sono aperte a quanti vogliono partecipare sia per curiosità sia per affinità con le nostre idee e condivisione dei progetti del movimento. Molto importante è la partecipazione di un nucleo di produttori del genuino con dimestichezza nell’agire agricolo. Se la visita si svolge in un’azienda orticola sarà presente almeno un ortolano del gruppo che accompagnerà e fornirà tutte le spiegazioni al riguardo oppure se si vuole visitare un’apicoltura sarà presente un produttore di miele consentendo in tal modo a ognuno di




approfondire e valutare le criticità specifiche di ogni settore. È importante la condivisione di pratiche e di conoscenze. Si cerca quindi di valorizzare le esperienze di quanti visitano le nostre coltivazioni, promuovendo l’ascolto e il dialogo per metterne in luce peculiarità e soluzioni. È capitato spesso che durante le visite venissero osservate delle criticità legate alle tecniche di produzione, a quel punto si cerca, attraverso la condivisione, di individuare strategie che aiutino a migliorare il nostro agire ecologicamente. Insieme viene individuato il percorso da intra-
La VISITA è un’occasione di confronto che spesso dà luogo a successivi incontri per la costruzione di percorsi comuni prendere e i miglioramenti da apportare. Durante la visita alle aziende produttori e consumatori inoltre conoscono e confrontano le tecniche produttive, condividono prospettive, competenze e difficoltà, apprezzano l’importanza degli incontri che danno luogo a scambi di esperienze nella condivisione spontanea di cibo e risate. La visita è un’occasione di confronto che spesso dà luogo a successivi incontri per la costruzione di percorsi comuni.
Dietro i volti un po’ «fricchettoni» un po’ sornioni di chi ha deciso di mettere mano alla vanga e all’erpice rotante del trattore, ci sono ore di interminabili discussioni e negoziazioni per giungere a decisioni che permettano al gruppo di prendere delle posizioni, di operare delle scelte, di avere maggiore chiarezza nelle posizioni politiche e nelle analisi critiche nei riguardi di un sistema che sta alimentando sempre più il decadimento culturale e il disastro ambientale.



Dalla teoria alla pratica
Siamo vegani? Come resistere alla nuova ondata di OGM camuffati in salsa green? Siamo antifascisti? Cosa significa esserlo oggigiorno nelle nostre campagne di fronte al dilagare del totalitarismo tecnologico? Queste e altre domande elettrizzano di volta in volta le riunioni. Vengono abbracciate prospettive precise nel modo in cui le riunioni si svolgono per cercare di rappresentare tutti i contenuti che animano il gruppo. Le decisioni devono essere condivise e non imposte con la forza dalla maggioranza o dal carisma individuale. Ricerca dell’unanimità, dell’inclusione, per cercare di anticipare una società non impositiva.
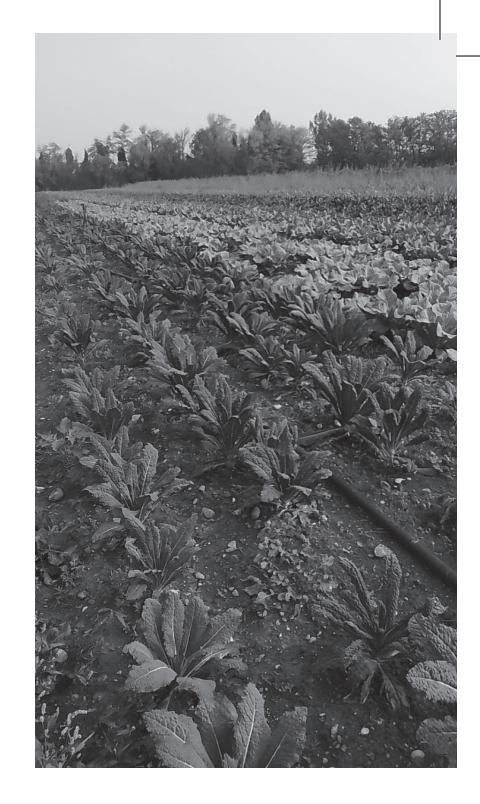
Il dominio sulle campagne rispecchia la società industriale attuale: il potere delle macchine dilaga sui terreni a discapito degli alberi, dei paesaggi e delle reti di vita. Terreni, declivi, boschetti, prati incolti, alberi morti funzionali alla vita, nidi, passaggi ecologici, vengono distrutti a ritmo incessante. Creare delle basi sociali, reti di condivisione di progettualità comuni, reti di mutuo aiuto, rendono possibile il delinearsi di nuove realtà e il rafforzamento di quelle esistenti.
I principi comuni si traducono nel quotidiano, nel lavoro dei campi, nella raccolta del cibo che nutre le persone, nel trovare alternative al diserbo chimico e ai nutrimenti di sintesi, ai pesticidi pericolosi per l’uomo e per la rete della vita, fatta di animali e microrganismi che rendono vivo e forte il suolo. Quindi via l’aratro e i macchinari pesanti che sterilizzano il terreno per dare spazio alle aiuole permanenti, alle piante autoctone, alle siepi naturali e al selvatico che congiunge i nostri campi ai residui di





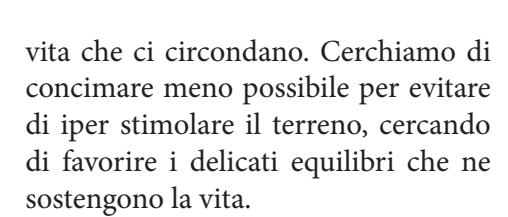
Non somministriamo, per la concimazione, prodotti di sintesi che inibiscono la crescita autonoma delle piante, preservando così anche le falde
acquifere evitando il percolamento di reflui azotati. Circondati da autostrade, superstrade, monoculture come il mais e la soia, finalizzate unicamente al ciclo della carne, che si alternano a immense estensioni di vigneti di prosecco, noi invece tentiamo disperatamente di collegare le nostre esperienze per sostanziare un altro mondo che sia vitale, naturale, umano.
Abbiamo provato a creare, con le nostre poche forze, una comunità con degli impegni, delle linee guida che si traducessero in una politica diversa in una relazione altra con la natura anche con la natura rappresentata dai nostri corpi. In risposta all’attuale politica sanitaria autoritaria abbiamo elaborato un manifesto, declinato localmente, in sintonia con le nostre sensibilità. Diffidiamo dei prodotti di sintesi anche di quelli che vengono inoculati nei nostri corpi pensando che il problema non sia tutto in un organismo da combattere ma nel sistema che lo produce, non lo previene, non lo cura.
Abbiamo trasposto il nostro atteggiamento verso la terra al nostro corpo considerandolo un terreno che, se messo in buone condizioni, dà buoni frutti in grado anche di auto-guarirsi. Sarà la nostra aspra critica verso il Green pass a segnare il punto di rottura con il Django e la fine della collaborazione come gruppo «Erbe matte».
Nel manifesto locale abbiamo integrato l’antifascismo e l’antisessismo, il nostro antiautoritarismo che allarga e integra lo spazio delle libertà e della differenza a tutti gli ambiti dell’esistente. Scopriremo poi, nell’assemblea nazionale tenuta a Mondeggi, cascina occupata dai genuini nei dintorni di Firenze, che la nostra sensibilità è condivisa da tanti contadini del movimento. Non è




un caso che chi sacrifica la propria esistenza per trovare un’alternativa ai prodotti della chimica e che resiste attivamente alle manipolazioni genetiche si insubordini di fronte alla calata dall’alto della sanità tecnoindustriale. Le poche righe che segnalano il nostro manifesto parlano della diffidenza verso un mondo a dimensione di macchina dove ogni frammento di vita diventa monetizzabile e manipolabile. Mondo dove la possibilità stessa della manipolazione diventa automaticamente la possibilità della sua attuazione. Torrenti, animali, cespugli, ife, disegnano il limite entro cui possono maturare le nostre esistenze.
La nostra critica costruttiva e creativa alle macchine vuole significare la resilienza alla programmabilità, all’incasellamento, alla schematizzazione, al disegno forzato che vorrebbe inserirsi nel nostro esistente: capezzagne, incolti, erbe matte, sostanziano l’alternativa agli asfalti rettilinei. I trattori servono, ma non da 200 quintali che danneggiano il terreno compattandolo per poi rendere necessaria la chimica per la sopravvivenza delle piante. L’agricoltura oggi è figlia del lavoro frazionato, non di una società organica. Una manciata di agricoltori specializzati nutre la gran parte della popolazione, ma questo necessita di macchinari, chimica e ipermercati. Per evitare grandi infrastrutture logistiche distributive dobbiamo rilocalizzare le produzioni, rendere le comunità capaci di autonomia, alimentare e creare un consumo di prossimità.
Difficoltà e resilienza
Nonostante la distanza tra le varie esperienze agricole e le difficoltà che si incontrano in questo periodo storico, ambientale e sociale, che hanno minato alcune progettualità o impedito ad alcune iniziative di decollare, l’esperienza è continuata fino ad oggi spostandosi nelle terre del vittoriese (area di Vittorio Veneto). Difficile proseguire la propria attività quando, dopo anni, scopri che il tuo lavoro vale economicamente molto meno del poco che guadagna un dipendente ventenne alla prima esperienza lavorativa da McDonald’s. Diventa inoltre sempre più




difficile riuscire a includere tutti i costi reali di produzione nella creazione del prezzo dei prodotti agricoli, e riuscire a proporre un paniere genuino alla portata di tutti. Ma questo è quanto. La grandine flagella le colture, il sole arde sempre di più, le piogge si concentrano in alcune stagioni rendendo fragili gli ecosistemi, impedendo alle micorrize di proliferare, diminuendo le rese. Ancora un po’ e scopriremo che non è solo faticoso fare i contadini ma che sopravvivere è difficile. Ecco perché un movimento come Genuino diventa necessario, se ben armato degli argomenti giusti per una critica intelligente della realtà.
Ma al di là dei pensieri corretti devono seguire le azioni conformi. Quando siamo stati flagellati nei campi da una tromba d’aria ghiacciata, dopo la quale sono sopravvissute solo delle piccole patate ben nascoste sottoterra, abbiamo visto colleghi venuti a darci una mano, vivaisti venuti a regalarci le piantine da trapiantare, amici e gruppi di persone volontarie che ci hanno aiutato a riavviare il lavoro e clienti che ci consegnavano una busta per cercare di andare avanti. Non solo a noi è toccata questa sorte. A rotazione più o meno ogni anno tocca a tutti, rendendo la prospettiva sempre più inquietante.
Proporzionalmente la solidarietà diventa sempre più presente. Ormai porsi in maniera critica verso la società di massa delle grandi opere, dei grandi capitali, delle grandi istituzioni implica sempre più un’analisi accurata delle contraddizioni dell’esistente, in una progettualità concreta che comincia da percorsi di trasformazione del reale che possono diventare «la propaganda con i fatti» dei nostri tempi.
È importante trovare subito un’alternativa alla passività spettacolare di una società che potremmo definire «socio virtuale». Bisogna comprendere dove stanno le contraddizioni altrimenti non si colgono più. Siamo sprofondati in una sorta di ragnatela consumistica, affetti da sindrome di adattamento. Consideriamo i capannoni e gli ipermercati i nostri angoli affettivi. Quanto sembrano belli anche i filari di viti e questi orti ben curati senza un filo d’erba, questi tappeti inglesi e questi campi di mais della Pioneer così ben disposti.




Come gruppo abbiamo compiuto deboli tentativi di essere presenti nelle lotte al di fuori dei perimetri dei nostri orti ma non riscontrando grande partecipazione. La battaglia contro la Superstrada Pedemontana Veneta era una buona occasione per unire la lotta ambientale alle lotte agricole, denunciando la complicità dello Stato con imprese private impegnate nella devastazione ambientale e nello sperpero di soldi pubblici. Purtroppo, nonostante un collettivo energico, denso e armato di giuste critiche, l’appello è rimasto inascoltato e non è nato alcun movimento importante. Questa, a nostro avviso è però la strada giusta per cercare di realizzare una reale trasformazione, reimpossessarsi delle terre impedendo la logica del capitale che valorizza sé stesso asfaltando, speculando, lottizzando producendo surplus. È la nostra sfida in questo periodo storico: stare dalla parte della natura, partigiani del vivente, solidali con le piante, con gli animali e con tutte quelle persone che dedicano la propria vita per cercare di produrre il nutrimento senza intaccare il delicato sistema naturale.



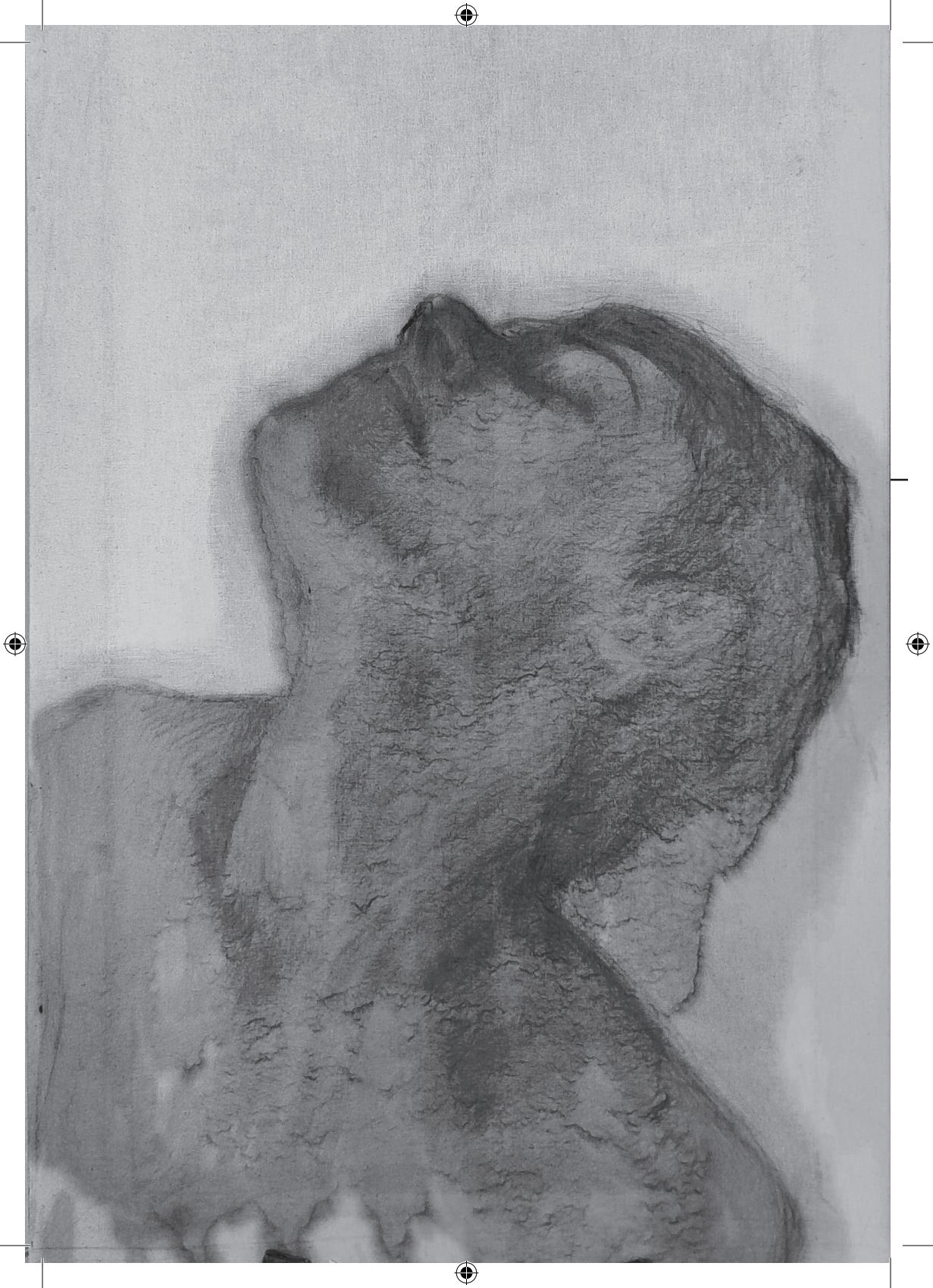
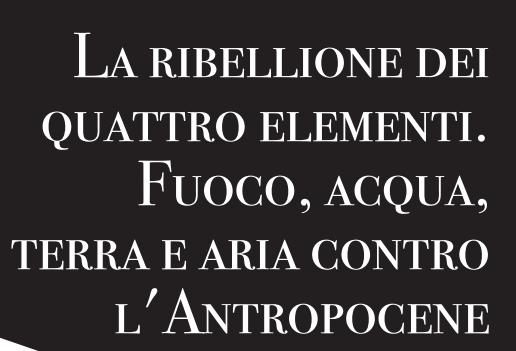
Marco Antonioli
Scriviamo queste righe a una settimana dalla disastrosa alluvione della Dana a Valencia che ha causato oltre duecento vittime, e a un paio di settimane di distanza dall’ennesima alluvione che ha colpito Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Calabria e Sicilia a ottobre 2024. Avremmo potute scriverle a settembre dello stesso anno o a maggio dell’anno precedente. Il punto di partenza sarebbe stato lo stesso: non stiamo attraversando crisi sporadiche con picchi emergenziali, siamo all’interno di una crisi sistemica. Non è cambiamento climatico – perché il clima è sempre cambiato – ma è riscaldamento globale. Tutti i fenomeni estremi a cui stiamo assistendo sono frutto diretto o indiretto di una temperatura media sulla Terra che sta crescendo sempre di più. Già a novembre Copernicus ha annunciato che il 2024 è stato l’anno più caldo della storia. Il primo ad avere una temperatura media superiore a 1,5°C rispetto al periodo pre-industriale. Quel limite che negli Accordi di Parigi del 2015 ci si era detto di non superare. Non è cambiamento climatico, è crisi climatica. Il riscaldamento globale ha scatenato la «ribellione dei quattro elementi». Il fuoco sta assumendo una forza distruttrice e una capacità di rigenerarsi senza precedenti, l’acqua sta trovando



nuovi modi per evadere da dove è stata costretta dalla spinta costruttrice dell’uomo e sta scomparendo dai luoghi più caldi, la terra sempre più edificata sta franando per riprendersi i propri spazi e l’aria è diventata sempre più irrespirabile.
Come il fuoco sta cambiando e sta incrementando la propria forza distruttrice a causa delle condizioni climatiche, è già stato affrontato dal giornalista canadese John Vaillant nel recente volume L’età del fuoco. Una storia vera da un mondo sempre più caldo (Iperborea, 2024), dove racconta il più grande incendio mai avvenuto. Era il 3 maggio 2016 e a Fort McMurray, Alberta, Canada faceva molto caldo e il tasso di umidità era fra i più bassi mai registrati; è bastata una scintilla per scatenare un incendio incontrollabile. Ciò che ha contribuito al diffondersi delle fiamme è stato anche il luogo in cui è scoppiato. Fort McMurray è una città nata sull’estrazione del bitume. Attività che nasce dal fuoco e che non si può fermare neanche col fuoco alle porte. È la rappresentazione plastica di quello che l’autore chiama Petrocene, l’era geologica dominata dalla corsa dell’Homo flagrans, dirompente quanto un’eruzione vulcanica, all’energia-a-tutti-i-costi.
Per raccontare come l’acqua sta tornando a fluire e a uscire dagli spazi in cui è stata costretta, per avere idea della forza distruttrice dell’elemento da sempre associato alla vita, bisogna guardare alle due alluvioni che hanno colpito l’Emilia-Romagna in primavera 2023 e autunno 2024 e ancor di più all’alluvione di Valencia di fine 2024. Tutti i principali enti di ricerca che si occupano di gestione del territorio, dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) al CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), sono concordi nel dire che l’evento è stato accentuato dalla non adeguata gestione del territorio a livello regionale, e in particolar modo da non essere intervenuti sulle problematicità del dissesto idrogeologico e sulla legislazione sul consumo di suolo. L’Emilia-Romagna è la terza regione d’Italia per consumo di suolo con circa 658 ettari cementificati in un solo anno e l'80% di questa superficie riguarda aree a pericolosità idraulica.




Questa situazione si è evidenziata ancora di più nella città di Bologna a ottobre 2024. È passato tristemente alle cronache il torrente Ravone che taglia da sud a nord alcune zone prospicenti al centro città. Fino al 1932 aveva un corso completamente scoperto che la furia costruttivista dell’epoca ha deciso di tombare a seguito di un «furioso uragano» che aveva allagato numerose case. Questa scelta, che all’epoca sembrava la soluzione migliore, ha fatto da «pentola a pressione» che non è riuscita a contenere le acque.
È invece ancora presto per analizzare i dati precisi relativi alla Dana (Depresion aislada en niveles altos, «depressione isolata ad alta quota») che ha colpito Valencia. C’è un’unica certezza: ciò che genera questi fenomeni è una massa di area fredda che si scontra con le temperature troppe elevate del suolo e del mare; quando è scoppiata la Dana le temperature delle acque del Mediterraneo erano di 5-6 gradi superiori rispetto alla media. Con il riscaldamento globale in atto ci sono ragioni per temere che le precipitazioni saranno più rare, ma molto più intense, proprio perché dipendenti da temperature più alte. Quindi l’acqua continuerà a ribellarsi in primavera e in autunno e il fuoco approfitterà delle temperature più elevate nei mesi estivi.
La ribellione dell’acqua porta con sé anche la ribellione della terra. Strettamente collegati ai fenomeni alluvionali troviamo anche i fenomeni franosi che interessano da anni ampie fasce dell’Appennino dalla Liguria alla Calabria. Secondo l’ISPRA, dal 2016 al 2023 sono stati più di 620.000 gli eventi franosi che interessano il 94% dei comuni del territorio italiano. Nel 2023 nelle sole province orientali dell’Emilia e della Romagna i fenomeni franosi sono stati 80.000. Sintomo di una terra che si ribella alla



La ribellione dei quattro elementi
continua speculazione e incuria dei terreni; come scriveva già nel 2015 la geografa Paola Bonora in Fermiamo il consumo di suolo. Il territorio tra speculazione, incuria e degrado (Il Mulino, 2015) il consumo di suolo è un prodotto della finanziarizzazione immobiliare e della rendita, di una pianificazione territoriale debole e compromessa, di ambiguità legislativa, e in più di speculazione, corruzione, opere inutili.
Altro fenomeno che testimonia la ribellione di terra e acqua è l’aridificazione. È più corretto parlare di aridificazione che di siccità perché come sottolineava nel 2020 il giornalista austriaco Bob Berwyn di Inside Climate News «la siccità implica il ritorno dell’acqua». Mentre ormai in molte zone siccitose l’acqua è scomparsa. L’aridificazione è la porta di accesso alla desertificazione. In Italia la regione più colpita da questo fenomeno è la Sicilia che a febbraio 2024 aveva già dichiarato lo stato di emergenza per siccità, ampliatosi in estate quanto la popolazione della provincia di Agrigento è stata costretta a razionare il proprio consumo di acqua fino al 45%. Con impatti inimmaginabili sulla vita delle persone.
L’ultimo elemento che si ribella, meno evidente perché invisibile, è l’aria. Gli Accordi di Parigi, firmati nel 2015 da 194 paesi che miravano a limitare il riscaldamento globale al di sotto di 2°C e a proseguire gli sforzi per circoscriverlo a 1,5°C al fine di evitare le conseguenze catastrofiche, sono stati prontamente disattesi. Secondo i dati di Copernicus, osservatorio climatico dell’Unione Europea, la temperatura media globale nel periodo marzo 2023-febbraio 2024 è stata costantemente superiore agli 1,5°C che avevamo promesso di non superare. Febbraio è stato a livello mondiale più caldo di 1,77°C rispetto alla media del periodo 1991-2020. Se possibile in Italia la situazione è stata an-
cora peggiore: +2,19°C. Pochi mesi dopo abbiamo vissuto una delle estati più calde della storia, seguita da due alluvioni, a dimostrazione degli stretti legami fra i quattro elementi.



Prima di trarre le nostre conclusioni è necessario ricordare storicamente da dove deriva la teoria dei quattro elementi. È stato Empedocle, filosofo greco del V secolo a.C., a teorizzare che le forme della materia si basano su quattro elementi e che tutti gli oggetti materiali sono composti dalla combinazione di essi. La mutazione degli oggetti materiali avverrebbe attraverso la riorganizzazione degli elementi.
Come abbiamo visto, nell’Antropocene stiamo vivendo un periodo di forte squilibrio sistemico dei quattro elementi naturali causato dalle attività umane conseguenti alla rivoluzione industriale.
È ormai acclarato che il riscaldamento globale è causato dalle attività umane che determinano il rilascio nell’atmosfera di gas serra. Alcune delle attività umane che contribuiscono a incrementare le temperature sono la deforestazione indiscriminata, l’allevamento intensivo e l’uso di combustibili fossili.
La ribellione dei quattro elementi non è altro che la manifestazione più evidente di come la natura stia reagendo all’era dell’Antropocene. Il fuoco divora territori sempre più vasti, nutrendosi del calore di un’atmosfera sempre più calda. L’acqua infrange gli argini artificiali che abbiamo costruito, riappropriandosi degli spazi che le abbiamo sottratto. La terra frana sotto il peso della nostra incontrollata urbanizzazione. L’aria, invisibile ma onnipresente, continua a scaldarsi oltre ogni previsione e oltre ogni soglia di sicurezza che la politica si era imposta.
La ribellione degli elementi mostra che è l’intero sistema a essere in crisi, e solo un cambiamento altrettanto sistemico potrà darci una speranza di futuro. Non è più tempo di mezze misure o di compromessi: o cambiamo radicalmente il nostro rapporto con il pianeta, o sarà il pianeta stesso a imporci questo cambiamento, con conseguenze che possiamo solo iniziare a immaginare.
Come abbiamo visto fuoco, acqua, terra e aria trovano modi e percorsi per mutare, sopravvivere e rigenerarsi. Non è in discussione la vita del pianeta, come si modificherà la vita degli esseri viventi in un pianeta sempre più caldo. Le scelte scelle-




rate dell’essere umano hanno generato questa situazione. Se in passato abbiamo imparato a padroneggiare (o quasi) i quattro elementi, è giunto il momento di imparare a padroneggiare noi stessi. Abbiamo due strade che si possono intersecare: mitigazione e adattamento. Nel primo caso significa fare di tutto per ridurre l’emissione di gas serra nell’atmosfera, nel secondo significa anticipare gli effetti avversi del riscaldamento globale, mettendo in campo azioni che prevengano o diminuiscano i danni. La mitigazione è lontana da venire, perché dipende in maniera diretta dalle scelte di pubbliche amministrazioni sempre più reazionare e negazioniste e di corporation globali il cui obiettivo continua a essere la massimizzazione dei profitti. L’adattamento è invece qualcosa che può essere messo in campo anche e soprattutto da comunità locali orizzontali che individuino i rischi e anticipino i possibili effetti, prendendosi cura dei propri territori. È il momento di agire. Ora.



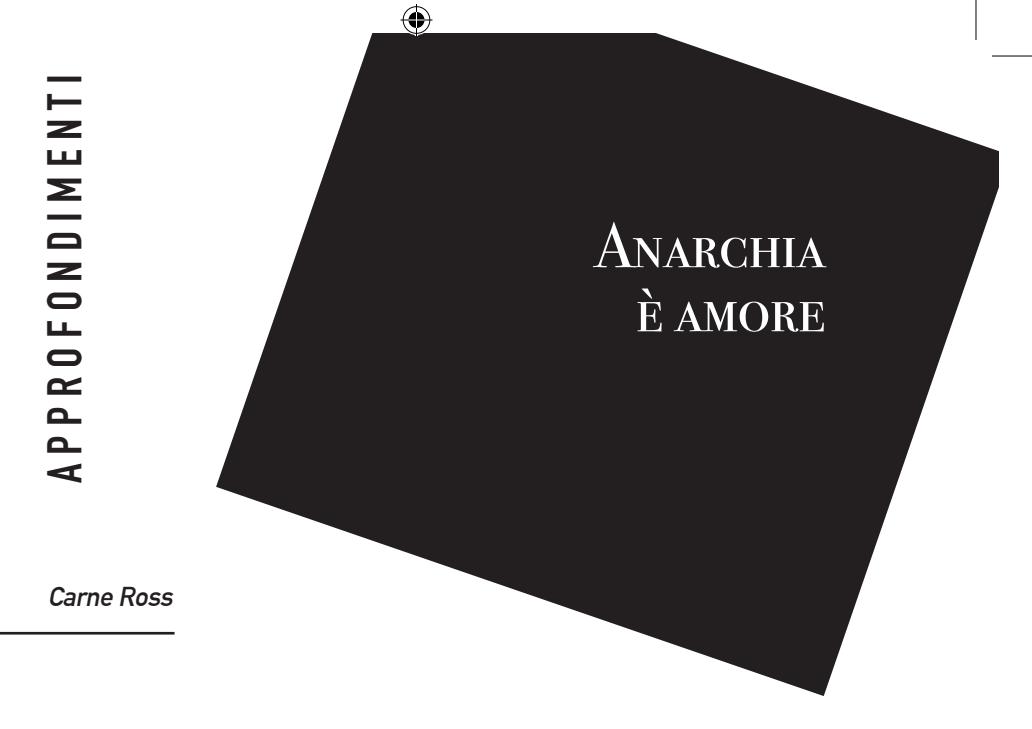
Pensavo che l’anarchismo fosse «solo» una filosofia politica. Mi sbagliavo. È molto, molto più di questo.
Con filosofia politica intendo un modo di pensare riguardo a politiche, istituzioni e modalità di presa delle decisioni. Come le persone arbitrano gli affari tra loro, teorie di governo – o di autogoverno – o l’abolizione di ogni gerarchia. Mi piaceva riassumere l’anarchismo in poche frasi come: «L’anarchismo consiste nel fatto che nessuno ha potere su nessun altro».
Non mi sbagliavo. Infatti l’anarchismo riguarda anche tutte queste cose. È una filosofia politica. Riguarda come le persone prendono le decisioni insieme e gestiscono i propri affari collettivamente. Ma pensavo che fosse filosofia in toto, che non ci fosse niente di più. Era un modo di pensare separato dalle nostre realtà interiori. Pensavo che fosse una filosofia esteriore, che riguarda soprattutto il modo in cui ci comportiamo gli uni verso gli altri.
Queste idee vi porteranno lontano nell’analisi dell’attuale situazione politica ed economica e nell’elaborazione di come riformarla e sostituirla. Al posto di un sistema di governo top-down, abbiamo bisogno di un sistema in cui le decisioni siano prese dalla massa, includendo tutti coloro che sono interessati.




Al posto di un sistema economico controllato da pochi con enormi ricchezze, abbiamo bisogno di un sistema in cui le quote di ricchezza e di capacità di azione siano uguali e in cui tutti abbiano voce in capitolo negli affari economici che li riguardano, sia sul posto di lavoro sia nella società in generale. L’individuo e la società sono il cuore di questa idea. Gli individui devono essere liberi di agire come credono, ma prendendo sempre in considerazione i bisogni degli altri – una negoziazione equa e solidale (questa non è la forma più puramente libertaria dell’anarchismo, ovviamente, ma piuttosto un libertarismo socialista).

Ma chi sono questi individui e come pensano? Gli anarchici sono scettici nei confronti della religione formale, considerandola come un’altra forma di controllo sociale, in cui l’iniziativa viene negata all’individuo a favore di una rigida ortodossia imposta gerarchicamente, il più delle volte da uomini. L’affermazione dell’esistenza di dio è vista come un velo usato per nascondere molti torti e ingiustizie umane, scusato come un balsamo e una spiegazione universale. L’anarchismo rifiuta la religione: né dei, né padroni.
Per questo motivo, ero scettico nei confronti di coloro che a volte si definivano anarchici spirituali. Che cos’è lo spiritualismo se non un altro tipo di religione che ci induce in errore rispetto alla nostra realtà terrena? Vedevo ciò che si può vagamente chiamare spiritualismo come narcisistico ed egoistico, con la sua attenzione all’anima individuale e ai suoi bisogni ed espressioni. Alcuni di coloro che ho visto parlare di spiritualismo si sono ritirati dal campo di battaglia della società cadendo nelle droghe e in altre forme di rifugio, sia fisico che mentale. La battaglia è nelle nostre città e nelle nostre strade, qui e ora, argomentavo con veemenza.




Ma quegli stessi «spiritualisti» sostenevano che non si poteva rivoluzionare l’intera società senza rivoluzionare il modo in cui gli individui pensano al suo interno. Non ci si può aspettare che la società adotti pratiche di uguaglianza, rispetto e inclusione se noi stessi non ci trasformiamo dal razionalismo e dal pensiero analitico che vede tutto come struttura o transazione. Anche l’interiore ha bisogno di essere riformato. Non esiste rivoluzione di un aspetto, senza la rivoluzione dell’altro.
Inizio a pensare che potrebbero avere ragione.
Al centro di tutto l’anarchismo c’è come trattiamo le altre persone. L’anarchismo esige che questo trattamento sia sempre rispettoso ed egualitario: nessuno può costringere un altro, sia con mezzi palesi sia subdoli. La mia idea di anarchismo richiede di trattare le persone come esse desiderano, non come noi desideriamo (che è, comunque, un esplicito rifiuto della cosiddetta «regola aurea», secondo la quale dovremmo trattare gli altri come vorremmo essere trattati. Invece dobbiamo attenerci a cosa dicono di volere, non a cosa noi pensiamo che essi vogliano). Dobbiamo rinunciare a tutte le nozioni di dominio, di influenza e di far fare agli altri ciò che vogliamo. Dobbiamo rinunciare a tutto il potere.
Tempo fa lavoravo nel governo. Ero entusiasta del potere, convinto di lavorare in mezzo a un’élite dei pochi che comprendevano i bisogni della società – nel mio caso, della politica estera e della diplomazia – meglio di quanto la società comprendesse se stessa. Questo ha nutrito il mio ego e ha strutturato la mia vita intorno alla carriera e allo status. È stato un percorso difficile abbandonare questi pilastri del mio senso di valore e di me stesso. Se non ho il potere, cosa sono? Se non posso dire agli altri cosa fare, che valore hanno le mie idee e i miei desi-
deri? Se sono solo io, cosa sono?
Ho capito che ho bisogno di credere in qualcosa. Non sono sicuro di come definirlo. Ma sospetto che i miei amici spiritualisti lo chiamerebbero così: bisogno spirituale. È la convinzione che



esistano valori e significati esterni a noi, ma che animano e ispirano le nostre realtà interiori. Le religioni possono chiamare questa cosa dio, espresso attraverso la litania. Ma la mia litania è l’anarchismo e non sono disposto a chiamare dio questo spirito guida. È più terreno, è più umano.
Lo identifico osservando il cuore della pratica anarchica: l’interazione con gli altri. Come trattiamo le altre persone. Nell’anarchismo, quell’interazione deve essere guidata da considerazione e cura, dal mettere i bisogni dell’altro allo stesso livello dei nostri. O almeno: nella sua iterazione più estrema, è la cancellazione di sé. Lao Tzu parla di questo nel Dao te ching. Avere potere rinunciando a ogni potere. È arrivato a questa conclusione migliaia di anni fa. Un’armonia fra come vediamo e trattiamo gli altri e come trattiamo noi stessi. C’è una parola per questa pratica: è amore. Senza quest’anima «spirituale», l’anarchismo fatica ad avere senso. Se giudicata nei termini dell’attuale cultura capitalistica, non è necessariamente una pratica più efficiente e produttiva: non produce necessariamente più beni o fa fare più soldi. Ciò che realizza ha un valore infinito: la bellezza di esseri umani che vivono insieme l’un l’altro con amore, rispetto ed eguaglianza. Sono cose astratte e ineffabili che non possono essere misurate in euro, sterline o dollari. In effetti, queste cose vanno al di là di tutti i termini stessi – ed è per questo che è difficile anche esprimerle a parole. Siamo su un piano superiore a tutto questo. E se volete chiamarlo piano «spirituale», mi sta bene. Ciò che accade nello spirito o nell’anima conta, perché conta anche per la realtà esterna. Ciò che crediamo in noi stessi è intrinseco al modo in cui ci confrontiamo con il mondo. L’uno non funziona senza l’altro.
Carne Ross è un ex-diplomatico britannico, autore del libro The Leaderless Revolution: How ordinary people will take power and change politics in the 21st century (2012) e protagonista del film Accidental Anarchist (2017).
Tratto da: The Anarchist Library Traduzione di Marco Antonioli



Da Chávez a Maduro: 25 anni di dittatura in Venezuela. La lunga lotta per la libertà continua
Andrés Rodriguez
Il sogno di una maggiore libertà per il Venezuela sembra finalmente a portata di mano. Grazie soprattutto alla mobilitazione popolare fatta di manifestazioni spesso duramente represse che ha da sempre contrastato il chavismo, il 28 luglio 2024 il candidato dell’opposizione Edmundo González Urrutia ha ottenuto 7.303.480 voti, contro i 3.316.146 di Nicolas Maduro Moros. Ma quella stessa notte, il CNE (Consiglio Elettorale Nazionale) ha ribaltato ancora la realtà: 5.326.104 voti per González Urrutia, 6.408.844 per Maduro.
Per capire come siamo arrivati fin qui, dobbiamo tornare all’origine di tutto. Il 4 febbraio 1992, il Venezuela assisteva al tentativo di colpo di stato del tenente colonnello Hugo Chávez e del suo MBR-200. Il paese era in ginocchio: la crisi economica mordeva, il pacchetto di politiche neoliberiste (Paquetazo) imposte dal presidente Pérez aveva generato una recessione profonda e il malcontento popolare era esploso nel Caracazo del 1989, una serie di proteste di massa represse dal governo. Il golpe fallì, ma quel fallimento segnò l’inizio di tutto. Prima di essere arrestato, Chávez pronunciò in TV due parole che divennero il simbolo della sua rivoluzione: «per ora». Dopo due anni di carcere, nel 1994, la grazia del presidente Caldera gli aprì la strada verso il potere.




Nel 1998, Chávez vinceva le elezioni presidenziali. L’anno successivo, con un referendum popolare, faceva nascere una nuova Costituzione che cambiava il volto del paese: rielezione immediata del presidente, mandato esteso a 6 anni, nuove istituzioni e un nuovo nome, «Repubblica Bolivariana del Venezuela». Era l’inizio della cosiddetta «Rivoluzione Bolivariana».
Ma l'11 aprile 2002, il Venezuela tornò sull’orlo del baratro. Una massiccia manifestazione dell’opposizione verso Palazzo Miraflores si trasformò in tragedia: gli scontri con i chavisti causarono morti e caos. Alti ufficiali militari ritirarono il loro sostegno a Chávez, che venne arrestato. Pedro Carmona, presidente della Federazione delle Camere e delle Associazioni di Commercio e di Produzione del Venezuela (Fedecámaras), si autoproclamò presidente, ma il suo governo durò appena 48 ore. Il 13 aprile, Chávez tornava al potere. Questo episodio ha contribuito a rafforzare la figura di Chávez e la sua narrazione di fronte a una «guerra» contro élite e potenze straniere.
La storia continuava, e con essa la lotta tra chi combatteva per la libertà e chi voleva il potere assoluto.
Dopo il fallito golpe, l’opposizione cercò altre vie. Nel dicembre 2002, lanciò uno sciopero nazionale che paralizzò anche PDV-SA, il colosso petrolifero statale. Il paese si fermò, mancava tutto, persino il carburante. Ma Chávez non cedette. A febbraio 2003, lo sciopero finì nel nulla, e PDVSA venne epurata da chi aveva osato sfidare il regime.
L’opposizione non si arrese. Sfruttando la Costituzione del 1999, raccolse milioni di firme per un referendum che destituisse il presidente. Il 15 agosto 2004, il «No» vinse con il 58% contro il 41% del «Sì». Gli osservatori internazionali confermarono il risultato, ma quel referendum ebbe un prezzo terribile: nacque la «Lista Tascón».
Il deputato chavista Luis Tascón pubblicò online i nomi di chi aveva firmato contro Chávez. Fu l’inizio di una caccia alle streghe: licenziamenti nel settore pubblico, discriminazioni, servizi negati. Non bastò: una seconda lista, la «Lista Maisanta», colpì




anche i familiari dei firmatari. Il Venezuela sprofondava sempre più nella paura.
Nel 2007 Chávez propose un referendum per 69 riforme costituzionali, tra cui la rielezione a tempo indeterminato del presidente e un maggiore controllo statale sull’economia. Il 2 dicembre, per la prima volta, perse: 51% contro 49%. «Una vittoria di merda», la definì, ma dovette accettarla. Questa vittoria parziale dimostró che anche sotto una dittatura c’erano limiti alla volontà della popolazione di accettare cambiamenti così profondi nella struttura dello stato. Purtroppo questo nuovo vento non durò molto: nel 2009 Chávez ottenne comunque l’eliminazione dei limiti alla rielezione.
Per comprendere il livello di autoritarismo e di personalismo imposto da Chávez durante la sua presidenza non possiamo non citare, oltre all’aumento dei poteri dati al presidente, l’annullamento dell’indipendenza del potere giudiziario, le discriminazioni verso l’opposizione e i media critici nei suoi confronti e la notevole restrizione della libertà di espressione e di associazione nel paese. Come ricorda Human Rights Watch in un rapporto del 2013, sotto la presidenza Chávez il Venezuela è uscito dalla Convenzione Americana per i Diritti Umani e ha rifiutato l’ingresso nel paese di osservatori esterni, screditando anche le organizzazioni non-governative venezuelane che lavoravano per la tutela di questi diritti. Inoltre all’interno dell’Assemblea generale dell’ONU, il Venezuela ha costantemente votato contro le risoluzioni che condannavano pratiche abusive perpetrate in Corea del Nord, Iran e Siria. Non pago di ciò Chávez ha espresso esplicita solidarietà a leader fanatici ed estremisti come il siriano Bashar Al-Assad, il libico Mu’ammar Gheddafi e l’iraniano Mahmoud Ahmadinejad, conferendo a ciascuno di questi soggetti «l’Ordine del Liberatore», la più alta onorificenza ufficiale del Venezuela.
Nel giugno 2011, Chávez si ammalò di cancro. Nonostante le cure a Cuba e la vittoria alle elezioni del 2012 contro Henrique Capriles, la malattia avanzava inesorabile. Nello stesso anno, nel




suo ultimo discorso pubblico, designò Nicolás Maduro come successore. Il 5 marzo 2013, Maduro annunciava la morte di Chávez.
Una parte del Venezuela pianse il suo leader per sette giorni. Le folle si accalcarono all’Accademia militare di Caracas per l’ultimo saluto. Ma mentre i chavisti piangevano, i loro oppositori tiravano un sospiro di sollievo. La morte di Chávez non segnò però la fine del regime, ma l’inizio di una nuova, più buia stagione.
Nel 2013, Maduro vinse le elezioni presidenziali contro Capriles con soli 225.000 voti di differenza. L’opposizione gridò alla frode e chiese il riconteggio totale. Il CNE concesse una verifica parziale, ma non cambiò nulla. Le proteste esplosero, ci furono morti e feriti, ma Maduro prestò giuramento. Il Venezuela entrava in una nuova era di instabilità e repressione. È importante parlare di queste elezioni e dei loro risultati perché hanno approfondito la polarizzazione in Venezuela, aumentando la sfiducia nelle istituzioni elettorali e segnando l’inizio di un periodo di
crescente instabilità politica ed economica.
Facendo un balzo in avanti di alcuni anni, Il 2017 segnò un punto di non ritorno. Il Venezuela era in ginocchio: iperinflazione galoppante, scaffali vuoti nei supermercati, ospedali senza medicine. A marzo, il TSJ, la Corte Suprema controllata dal regime, tentò di esautorare l’Assemblea Nazionale, l’ultimo baluardo dell’opposizione. Fu un colpo di stato mascherato da sentenza.
La gente scese in piazza. Da aprile a luglio, il Venezuela bruciò: oltre 120 morti, migliaia di feriti e migliaia di arresti. La rispo-




sta di Maduro? Convocò un’Assemblea Nazionale Costituente per riscrivere la Costituzione. Le elezioni del 30 luglio furono una farsa: l’opposizione le boicottò, l’affluenza fu bassissima, ma poco importava. La nuova Assemblea, fedele al regime, prese il potere.
Intanto il paese era sempre più al collasso. L’iperinflazione divorava i risparmi, la gente frugava nei cassonetti per mangiare, la produzione di petrolio crollava. Iniziò l’esodo: più di 7,7 milioni di venezuelani fuggirono, la più grande crisi di rifugiati della storia dell’America Latina. OAS e Unione Europea condannarono, imposero sanzioni, ma il regime resisteva.
Il 2019 portò una nuova speranza per un futuro di libertà. Il 5 gennaio, Juan Guaidó venne eletto presidente dell’Assemblea Nazionale. Il 23 gennaio, durante una manifestazione a Caracas, si proclamò presidente ad interim del Venezuela. Stati Uniti, Unione Europea e gran parte dell’America Latina lo riconobbero. Ma Maduro, sostenuto dall’esercito, non mollava.
Il Venezuela si ritrovò così con due presidenti: Guaidó, appoggiato dall’opposizione e dalla comunità internazionale, e Maduro, che controllava l’apparato statale e militare. Nel corso dello stesso anno Guaidó tentò una rivolta militare che fallì e a cui seguirono – come la storia del Venezuela ci ha insegnato – nuovi arresti e nuove repressioni.
I tentativi di dialogo si susseguirono, ma furono tutti inutili. La crisi politica alimentava quella umanitaria, e viceversa, in un circolo vizioso che sembrava non avere fine. Il Venezuela sprofondava sempre più nell’isolamento diplomatico, mentre il suo popolo continuava a fuggire in cerca di un futuro migliore.
Nel 2024, la situazione resta drammatica. L’iperinflazione continua e il calo della produzione petrolifera hanno mantenuto il paese in una situazione economica disperata. Gli ospedali sono al collasso, la povertà estrema dilaga, la gente continua a fuggire. Le proteste non si fermano e, con esse, la repressione.
La crisi umanitaria resta un enorme problema. La carenza di cibo, medicine e beni di prima necessità continua a colpire la




popolazione. Il sistema sanitario è in condizioni critiche e la povertà estrema è diffusa. La migrazione dei venezuelani continua a essere una delle maggiori crisi umanitarie nella regione. Milioni di persone continuano a fuggire dal Paese a causa della crisi economica e dell’instabilità politica.
Le proteste antigovernative restano diffuse e spesso subiscono una pesante repressione da parte delle forze di sicurezza. Le segnalazioni di violazioni dei diritti umani e di repressione politica continuano a essere motivo di preoccupazione per le organizzazioni internazionali.
Il Venezuela continua a far fronte alle sanzioni internazionali, imposte principalmente dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, che hanno influenzato l’economia e le relazioni diplomatiche del paese. Il governo di Maduro ha mantenuto rapporti con alcuni alleati internazionali, tra cui Russia e Cina, che hanno offerto sostegno economico e politico.
Il 28 luglio 2024 si sono svolte le ultime elezioni per eleggere il presidente per i prossimi sei anni. Le elezioni presidenziali non sono state né libere né regolari, si sono svolte in un contesto in cui il governo Maduro continua a controllare tutti i poteri dello Stato e a reprimere l’opposizione politica.
Queste elezioni sono state precedute dall’Accordo delle Barbados sulle garanzie elettorali firmato tra il governo e l’opposizione nel 2023. Dalla sua firma, l’Accordo è stato ripetutamente violato dal governo. Con queste elezioni Maduro ha cercato di legittimarsi a livello internazionale per uscire dalle sanzioni economiche. Le ONG e i partiti politici venezuelani hanno denunciato l’uso di disinformazione, minacce di morte e attacchi fisici da parte dei simpatizzanti del chavismo e dell’Esercito di Liberazione Nazionale, contro i candidati dell’opposizione.
La giornata elettorale si è svolta con apparente normalità, ad eccezione di un attacco motorizzato a Maturín. Dopo la chiusura delle votazioni, l’opposizione ha denunciato che in diversi seggi elettorali lo spoglio dei voti era stato bloccato e i testimoni erano stati costretti ad allontanarsi. Nel suo primo bollettino, il CNE



62


ha dichiarato vincitore Nicolás Maduro, con oltre sei milioni di voti, mentre Edmundo González Urrutia ne ha ricevuti poco più di cinque milioni. La comunicazione dei risultati è arrivata in ritardo, giustificato con un «hackeraggio» del sistema. Nonostante la presunta irreversibilità dei risultati annunciati, c’è stato uno scarto di oltre due milioni di voti che non sono stati assegnati a nessun candidato e che sarebbero sufficienti per cambiare il risultato delle elezioni.
L’opposizione ha rifiutato queste cifre, dichiarando che Edmundo González Urrutia aveva vinto con oltre 7 milioni di voti. Diversi paesi hanno rifiutato i risultati, segnalato irregolarità e chiesto la pubblicazione dei verbali dello scrutinio.
Media indipendenti come El Espectador e Infobae hanno sottolineato che la dichiarazione ufficiale dei risultati del CNE del 29 luglio, in cui Maduro ha ricevuto il 51,2% dei voti con un margine di errore dello 0,0001% e González e altri hanno ricevuto il 42,2% dei voti con lo stesso margine, è statisticamente improbabile ed è un indicatore di frode elettorale.
Dopo le elezioni, il CNE ha rinviato e successivamente sospeso tre audit postelettorali critici, compreso uno del sistema di comunicazione che avrebbe dovuto confermare l’«hackeraggio». Tra gli osservatori internazionali, il Gruppo di esperti elettorali delle Nazioni Unite ha dichiarato che le elezioni non soddisfacevano le misure di integrità e trasparenza e il Carter Center ha concluso che le elezioni non potevano essere considerate democratiche.
Dal 29 luglio le piazze si sono riempite di nuovo. Prima in modo spontaneo e poi in modo organizzato. Le persone protestano contro i brogli e contro l’ennesimo furto della loro democrazia. Ya ganamos y vamos a cobrar, porque la lucha es hasta el final è lo slogan che risuona nelle piazze di chi continua a opporsi. Da venezuelano che ha vissuto sempre sotto la dittatura mi sento orgoglioso, perché finalmente si intravede una via d’uscita dalla dittatura. Ma non bisogna abbassare la guardia e continuare la lotta per la libertà. Fino alla fine.


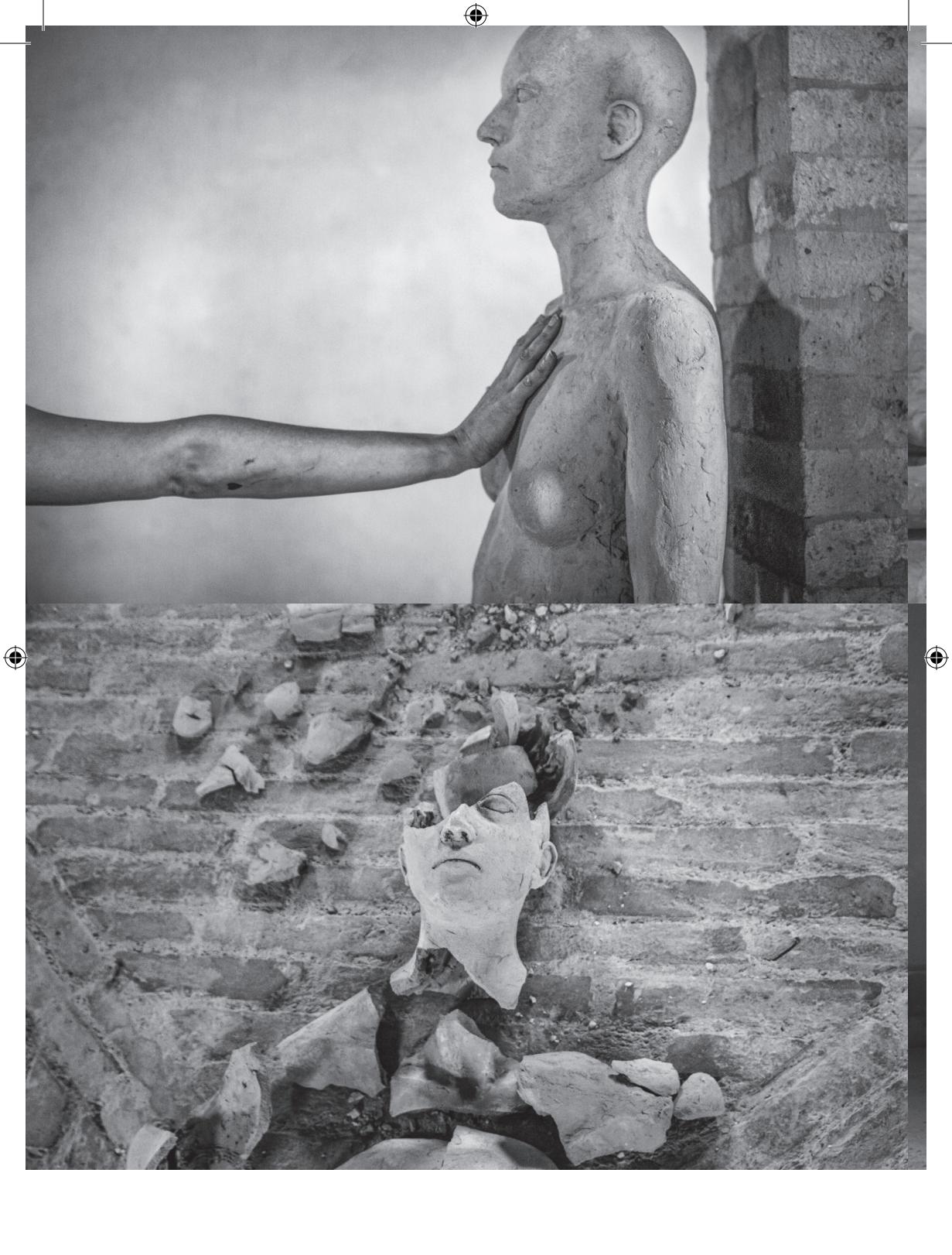
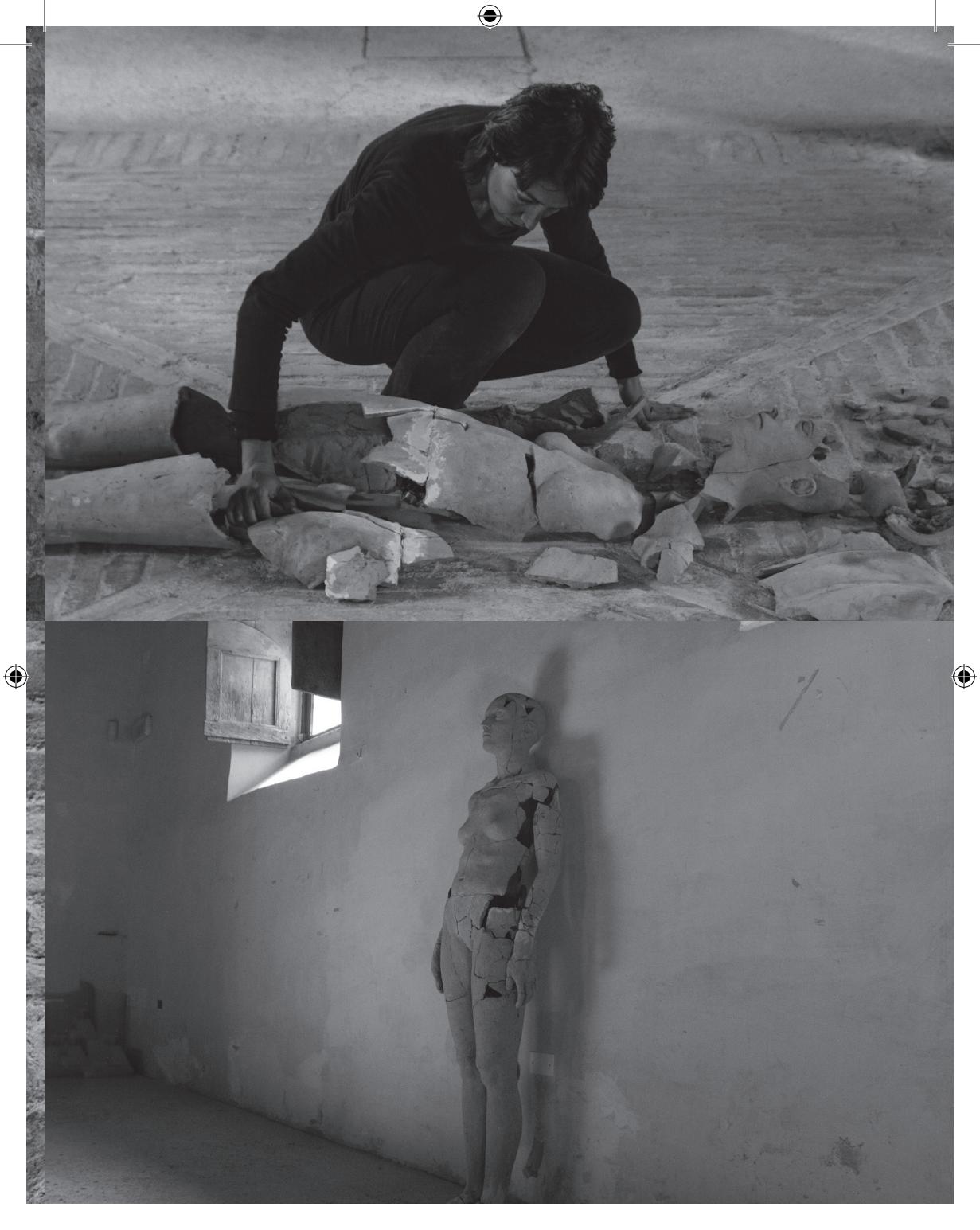
Ostrakon la seconda vita. Azione irreversibile su una scultura, performance di Giulietta Gheller e Alice Toccaceli, scultura di Giulietta Gheller, 2023.
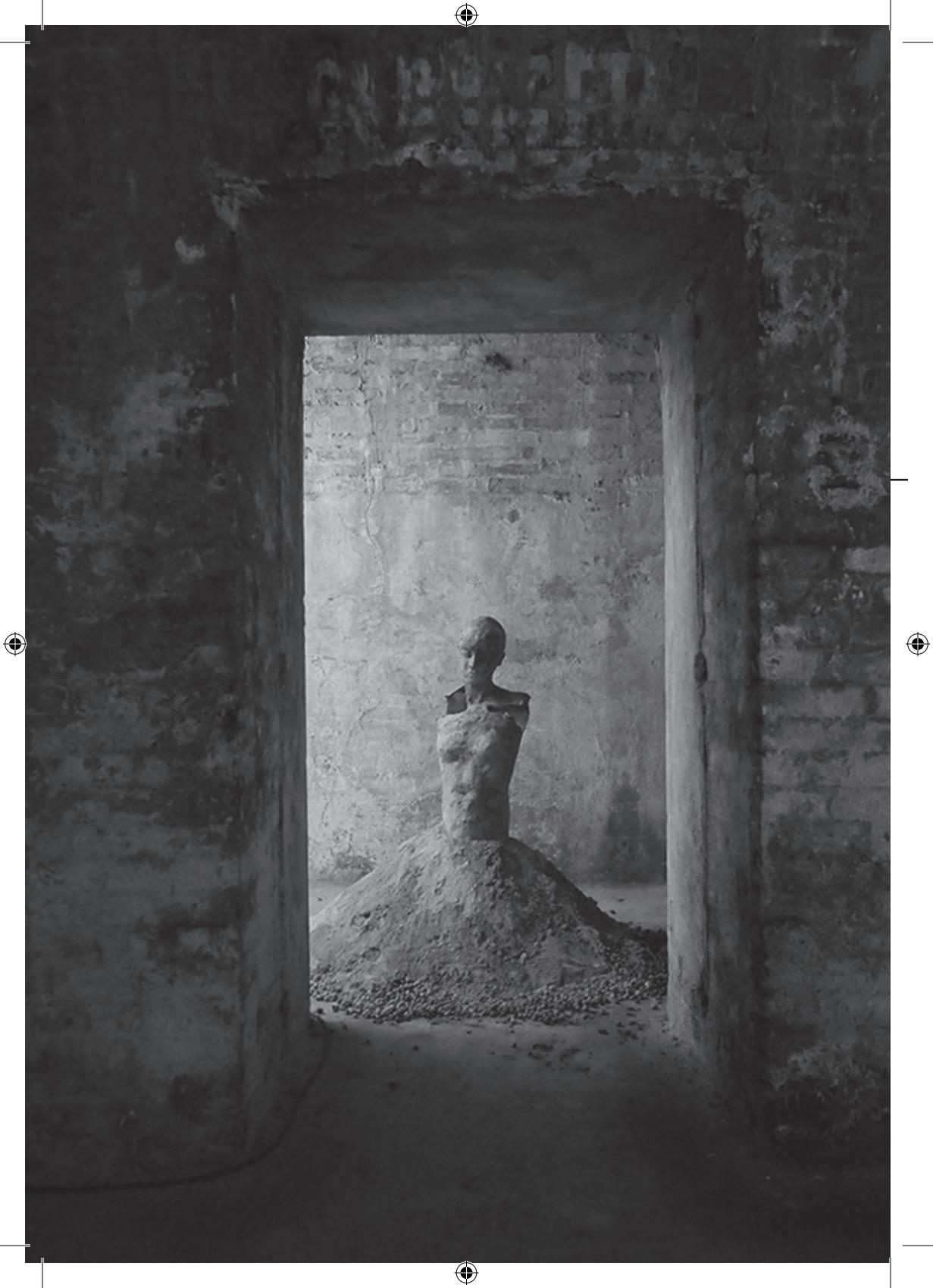

Il libro di Matthew Wilson Discorso sull’autogoverno (elèuthera 2022) rappresenta un importante punto di partenza per un approfondimento necessario rispetto alle aporie del pensiero anarchico tradizionale, superato dall’evoluzione delle società contemporanee.
In esso vengono poste diverse questioni a nostro avviso non più rinviabili, se non si vuole accettare l’idea che l’anarchismo, invece che porsi «nella storia, ma contro la storia» finisca per scivolare decisamente «fuori dalla storia».
Lo sforzo che stiamo facendo infatti è quello di interrogarci in modo sempre più pressante circa la possibilità di pensare un anarchismo propositivo che superi, nel suo articolato pensiero, una concezione esclusivamente negativa. Lo facciamo da un lato recuperando quelle parti del pensiero classico che hanno posto le basi per una evoluzione del pensiero anarchico in questo senso (Kropotkin, Landauer, Berneri, Goodman, Ward, ecc.), dall’altro proseguendo quel profondo rinnovamento pensato e praticato negli ultimi decenni da una parte del movimento anarchico italiano (Bertolo, Berti, Ambrosoli, Lanza, Di Leo e altri). Questa conversazione con Matthew Wilson vuole spingerci, per quanto possibile, a non restare solo fermi alla pur necessaria


valutazione delle contraddizioni e dei problemi che il pensiero anarchico presenta, ma anche a individuare possibili tracce di soluzioni e proposte.
Non è, a nostro giudizio, sufficiente, anche se indispensabile, cogliere le problematiche che sono presenti ed emergono dal confronto tra pensiero e azione qui e ora, ma è fondamentale provare ad andare oltre con idee propositive e, per dirla con Colin Ward, «rispettabili».
Partendo dalla tua affermazione «non abbiamo tutte le risposte e abbiamo sbagliato molte cose» e considerando necessario implementare il pensiero anarchico con altri approcci di ispirazione sociale libertaria, soprattutto con le voci critiche che hanno «individuato debolezze nel nostro movimento che non siamo stati capaci di vedere», puoi fare esempi concreti di come idee e pratiche antiautoritarie possono trasformare in senso positivo il pensiero e l’azione libertaria?
La politica è un processo costante di negoziazione e compromesso. Gli anarchici hanno sempre insistito sul fatto di essere contrari al compromesso, rifiutando di annacquare le loro critiche radicali al capitalismo e allo Stato. A volte questo rifiuto è positivo e gradito, altre volte diventa politicamente dannoso. Una delle sfide più grandi per ogni progetto politico è capire quando, dove e – soprattutto – come scendere a compromessi. La paura degli anarchici è che i nostri ideali vengano tirati nella direzione sbagliata, ma dobbiamo essere più coraggiosi e iniziare a pensare che forse possiamo ribaltare la narrazione e così portare più persone verso i nostri ideali.
Per rispondere in maniera più diretta alla tua domanda penso che potremmo impegnarci molto di più negli spazi progressisti, anche se non sono la nostra espressione politica ideale. Questo potrebbe funzionare nei consigli locali, nelle scuole e nelle università, nei sindacati e anche più ampiamente nella società civile; potremmo essere sorpresi e scoprire che possiamo cambiare alcuni elementi di quegli spazi – per esempio il loro processo




decisionale – ma è anche un modo per promuovere le nostre idee in cerchie più vaste.
Le due ragioni principali che individui riguardo al motivo per cui l’anarchismo non è riuscito ad affrontare le problematicità insite nel discorso anarchico sono: 1) la convinzione che l’anarchismo abbia già dimostrato di essere praticabile (riferendosi a storie del passato più o meno remoto e a contesti epocali molto specifici) e 2) il rifiuto sempre ostentato di assumere modelli teorici di riferimento.
Puoi specificare meglio cosa intendi e, soprattutto, come è possibile tenere insieme un orizzonte teorico con delle pratiche qui e ora che siano credibili nel mondo contemporaneo?
Chiunque simpatizzi per il pensiero anarchico crede che l’umanità possa organizzarsi in modo diverso, che possiamo essere guidati dalla cooperazione piuttosto che dalla competizione, dall’uguaglianza e dall’emancipazione piuttosto che dalla divisione e dalla gerarchia.
Ma cosa significhi ciò per un pianeta di sette miliardi di persone, che affronta molteplici crisi, con dietro di sé secoli di storia di lotta di classe e una cultura profondamente plasmata da una politica regressiva, è lontano dall’essere chiaro. Naturalmente, non sarebbe chiaro nemmeno se sviluppassimo una posizione teorica esplicita, perché la realtà non corrisponderà mai perfettamente alle nostre visioni teoriche. Ma mi sembra chiaro che ci sono alcune domande enormi e fondamentali alle quali dovremmo almeno cercare di offrire delle risposte. Possiamo farlo indicando pratiche esistenti; possiamo pensare a come affrontare i comportamenti antisociali guardando ai casi di giustizia comunitaria, o a come organizzare l’economia indicando le assemblee popolari, e così via; ma non possiamo permetterci di ignorare la richiesta molto ragionevole di dare alla gente un’idea di ciò che vorremmo vedere realizzato, né possiamo puntare a contesti sociali radicalmente diversi, come la guerra civile spagnola, prima di internet e prima della globalizzazione, e dire: guarda, ha




funzionato qui, quindi funzionerà ovunque.
È fondamentale pensare molto di più a questo periodo di transizione: come ci muoviamo dal punto in cui ci troviamo all’interno del capitalismo di Stato?
Questo fornisce l’orizzonte, i prossimi passi che dobbiamo compiere, ma per molti anarchici (e altri radicali) questo appare troppo riformista perché pensano in termini di “tutto o niente”. Ma la storia non è mai stata “tutto o niente” e non dovremmo pensare in questo modo nemmeno al futuro.
Affronti con lucidità e chiarezza il tema della libertà, dell’uguaglianza, della diversità rilevandone sia la portata universalistica, sia le difficoltà di tradurre questi orizzonti concettuali in pratiche coerenti. Da sempre questi temi hanno attraversato le varie riflessioni anarchiche, ma non siamo mai giunti fino in fondo a declinarne la loro attuazione concreta se non restando in consolanti affermazioni di principio. La nostra convinzione è che ciascuna di queste idee-forti non possa mai essere assunta in modo assoluto, ma vada confrontata e arricchita dalle altre in una sorta di continuo e precario equilibrio continuamente modificabile e aggiornabile. Qual è la tua proposta in merito?
Fai due considerazioni molto importanti – forse le più importanti – quando pensiamo a valori come libertà e uguaglianza; innanzitutto che queste non debbano mai essere intese in termini assoluti e, in secondo luogo, che sono sempre relazionali. C’è sempre quel “prezioso equilibrio” di cui parli. La sfida è accettarle senza sentirsi in colpa per aver fatto concessioni terribili o per essere scesi a compromessi. Infine, mentre parole come “libertà” sono incredibilmente potenti a livello culturale, sono quasi ridondanti quando si tratta di pensare a una vita sociale complessa. Basta guardare quante persone con visioni politiche molto diverse dicono di supportare l’idea di libertà per rendersene conto. Davvero, dobbiamo parlare di questioni specifiche – libertà da cosa e libertà di fare cosa?



70


Sostieni che l’idea della prefigurazione, cioè l’anarchia in azione in un più ampio ambiente non anarchico, può assumere un ruolo importante nel portare avanti il progetto anarchico se sarà in grado di rispondere apertamente alle critiche sollevate. Allo stesso tempo sottolinei la sostanziale fallacia delle tesi secondo cui questi esperimenti prefigurativi dimostrino la fattibilità di società interamente anarchiche. Inoltre valorizzi le due dimensioni, individuale e sociale, della prefigurazione stessa.
Come mettere insieme queste osservazioni che possono apparire contradditorie soprattutto nelle cose concrete del vivere da anarchici in un mondo autoritario?
Questa domanda ci porta indietro al modo di pensare “tutto o niente” e alla cultura collegata di vedere l’esistenza di un’organizzazione anarchica come prova della fattibilità di una società anarchica. Prefigurazione per me vuol dire fare ciò che puoi in qualsiasi condizione ti trovi ad affrontare; qual è il modo giusto di agire adesso? Molti progressisti ignorano il concetto di prefigurazione perché pensano che non prenda in considerazione i vincoli strutturali del nostro sistema, mentre altri sembrano credere che agire in maniera prefigurativa significhi in qualche modo lavorare al di fuori di quei vincoli. Secondo me agire in maniera prefigurativa vuol dire lavorare secondo gli ideali che vorremmo vedere in tutta la società, ma con la consapevolezza di essere limitati in ciò che facciamo. La nozione semplicistica della compatibilità mezzi-fini è davvero inutile. Ciò che dovremmo dire è: la struttura del sistema rende questa compatibilità mezzi-fini quasi sempre impossibile, quindi la nostra prassi politica dovrebbe essere una conversazione continua e aperta su come, dove e quando fare del nostro meglio. Il momento in cui diciamo “no compromessi” e iniziamo a pensare in questa maniera assolutista, non è il momento in cui diventiamo puri, anzi è il momento in cui diventiamo ipocriti e deludenti, perché possiamo davvero solamente evitare quei compromessi nella sicurezza del nostro pensiero dogmatico.




Scrivi: «Quando si tratta di imparare a lavorare, vivere e giocare in una comunità orizzontale, passare dalla teoria alla pratica non è una semplice questione di scelta individuale. Le nostre abitudini e le norme cui sottostiamo, che attualmente sono espressione di un mondo competitivo e gerarchico, vanno consapevolmente smontate e sostituite con nuovi valori. Questi progetti diventano allora un terreno fertile per il pensiero e le pratiche strategiche e tattiche capaci di opporsi all’oggettivazione quotidiana cui il capitalismo ci riduce e quindi costituiscono i germi di nuovi tipi di comunità».
“Qui e ora” e non la “attesa del futuro” è la postura che suggerisci: che ne facciamo dell’idea della rivoluzione?
Penso che l’idea di rivoluzione sia generalmente poco utile, soprattutto quando implica un passaggio drammatico e improvviso da un sistema a un altro. Non mi sembra che i cambiamenti sociali avvengano molto spesso con questi grandi cambiamenti sismici e, quando accadono, tendono ad andare drammaticamente male. Poiché tendenzialmente siamo abituati a un modo di pensiero binario, crediamo che l’unica alternativa alla rivoluzione siano le riforme, soprattutto riforme che fondamentalmente non cambieranno mai il sistema. Mi piacciono i numerosi modi di pensare che vanno oltre ciò – sia che si tratti di idee di costruzione di una contro-egemonia, sia che si tratti di idee riformiste non-riformiste, sia che si tratti di idee di persone come Olin Wright e del suo punto di vista sulla trasformazione; in definitiva, possiamo cambiare radicalmente il mondo in modo frammentario, per così dire, passo dopo passo. Di certo anche questo approccio presenta delle sfide, come progressi positivi sempre vulnerabili a essere distrutti o cooptati; ma non vedo alcun altro modo.
Quando sostieni che esiste comunque uno spazio considerevole in cui possiamo orientarci verso una vita più coerente, ti riferisci al pensiero di Landauer che pone la questione con forza, affermando il suo rifiuto di dividere le persone in padroni dello Stato e servitori dello Stato.




La possibilità dell’anarchia, secondo te, dipende dalla convinzione che le persone possono sempre cambiare il loro comportamento. Per cambiare noi stessi e le nostre condizioni sociali, dobbiamo fare ricorso alla libertà limitata di cui disponiamo. Non spetta a nessun altro, se non a noi stessi, e dobbiamo anche creare quanta più libertà e unità possibili. Come coniugare la dimensione individuale del cambiamento con la prospettiva sociale della mutazione più globale?
Un’ottima domanda, ma potremmo iniziare a rifiutare l’idea che sia necessario combinare attivamente queste dimensioni e iniziare a capire fino a che punto sono sempre inestricabilmente legate fra di loro. Ma poi, naturalmente, abbiamo bisogno di modi per teorizzare questa connessione e per parlarne e pensarla in termini di nostro attivismo. È un argomento troppo vasto per poterlo affrontare in questa sede, ma credo che il punto di partenza sia la comprensione del fatto che ciò che facciamo “individualmente” è anche intrinsecamente sociale. Penso che riguardo a questo abbiamo fatto numerosi passi indietro, la seconda ondata femminista e i movimenti per i diritti civili degli anni ‘60 e ‘70 sembravano capirlo molto meglio rispetto a noi oggi; adesso è diventato un po’ un cliché, ma l’idea che “il personale è politico” era parte fondamentale del senso comune radicale. Dobbiamo riportalo in superficie. Ovviamente è lì – sottotraccia – in tutti i tipi di controcultura, ma c’è anche molta resistenza da parte di persone che ritengono che gli individui e le loro azioni siano ininfluenti – o non importanti – rispetto al sistema. Mi piacerebbe vedere molte più persone che si alterassero di fronte a questi comportamenti e difendessero l’importanza del cambiamento politico individuale.
Riconoscere i limiti delle decisioni prese attraverso il consenso significa capire che l’anarchismo è qualcosa di più di un semplice processo decisionale. Sarà inevitabile adottare forme diverse di decisione in un contesto libertario, quindi dobbiamo essere consapevoli che è la pratica che ci indirizzerà concretamente verso una soluzione o l’altra, senza considerare qualche scelta come universale e assoluta.




Qui allora entra in gioco l’etica anarchica cioè quel di più e oltre che caratterizza l’approccio anarchico alla convivenza sociale. Entriamo un po’ di più nel dettaglio di questo problema.
La riflessione sull’etica anarchica inizia quando riconosciamo che nessuna politica anarchica produrrà un mondo senza conflitti. Ci saranno sempre decisioni etiche da prendere e, senza un dio o senza la convinzione che la razionalità possa fornire tutte le risposte, rimaniamo solo con noi stessi. Non aderisco a una particolare teoria etica, come l’utilitarismo, la deontologia o altro. Penso che il pensiero critico, l’apertura mentale e l’onestà siano probabilmente i modi migliori per affrontare questa questione – fare ciò che possiamo per considerare una situazione, per considerare i vari argomenti e per provare a trovare la soluzione migliore possibile. Naturalmente, crederemo sempre di pensare in modo critico e onesto, anche quando non lo facciamo, ma sono dell’idea che sia bene evidenziare quelle qualità che si collegano al modo in cui ci impegniamo nelle questioni etiche, piuttosto che nel pensare ai valori che dovrebbero guidarci. I valori non ci guidano davvero, perché sono sempre legati a presupposti precedenti su ogni genere di cose, quindi dobbiamo iniziare a disfare il maggior numero possibile di questi presupposti.
Traduzione di Marco Antonioli










Parliamo di democrazia. Democrazia reale
Cora Roelofs
La democrazia rappresentativa riproduce sistemi di potere oppressivi. La democrazia può assumere molte forme, ma per lottare per essa dobbiamo prima sapere di cosa stiamo parlando.
Il governo del popolo è il popolo. È lì che si trova il potere: nel popolo. E i leader del popolo non sono tutti al governo. Sono ovunque.
Winona LaDuke, White Earth Ojibwe
Negli Stati Uniti ci viene insegnato da bambini che viviamo in una democrazia e che questa democrazia ci assicura la libertà. Poi ci viene detto di alzarci in piedi, mettere la mano sul cuore e giurare fedeltà alla bandiera. In quarta elementare ho scoperto cosa succede quando non lo fai. Mi fu ordinato di andare in corridoio e mi venne chiesto dall’insegnante: perché non dicevo il giuramento? Ho tremato e sono rimasta in silenzio di fronte alla rabbia del mio insegnante. Quando chiesi consiglio a mia madre attivista, lei mi suggerì che sarebbe stato più facile cambiare silenziosamente alcune parole – «giustizia e libertà per alcuni» – invece che affrontare le sanzioni per aver disobbedito al mio insegnante.


Questa è stata una prima lezione su ciò che la vera democrazia americana rappresenta: una combinazione tossica di rituali patriottici forzati; aspirazioni degne ma mai raggiunte; un compromesso dei nostri ideali sotto la pressione del potere; cinismo; delusione; e, infine, debolezza, rozzezza o non partecipazione.
Per la maggior parte di noi, la democrazia è poco più che un voto periodico per far sì che qualcun altro prenda decisioni al posto nostro. In questa democrazia rappresentativa, ci viene detto che il nostro più grande dovere patriottico è quello di votare. Che si vinca o si perda, ci si aspetta che accettiamo che gli eletti e gli altri funzionari governativi facciano del loro meglio per rappresentarci. Ma vediamo sempre che rappresentano solo i loro interessi, quelli delle aziende e quelli di persone che sono ancora più ricche di loro. L’enorme disuguaglianza prodotta dall’accumulo privato di ricchezza del sistema capitalista viene
riprodotta attraverso questa cosiddetta democrazia. La nostra soluzione, ci viene detto, è quella di eleggere candidati migliori e/o di marciare in proteste autorizzate per attirare la loro attenzione. Ci viene anche detto di partecipare a varie audizioni sponsorizzate dal governo e a riunioni comunitarie in stile Parks and Rec (sitcom americana di satira politica NdT), dove le persone possono esprimere la loro rabbia e proporre idee - solo come valvola di sfogo.
Il popolo non ha un vero potere decisionale. Alla fine, gli eletti e i loro consiglieri tecnocratici sono gli unici ritenuti capaci di decisioni giuste e sagge e sono considerati eroici per aver «fatto la cosa giusta». Anche i referendum – noti anche come «quesiti elettorali» – ci permettono solo di esprimere le nostre preferenze politiche, senza portare a nessun cambiamento fondamentale. È



tempo di parlare di democrazia, non solo nel nostro Paese, ma anche nelle nostre organizzazioni, nelle nostre comunità e persino nelle nostre famiglie. Possiamo parlare della superficialità o della corruzione della democrazia negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Ma dovremmo anche parlare di come costruire il nuovo nel guscio del vecchio. Come possiamo costruire processi democratici significativi ed equi che creino effettivamente libertà per tutti?
Parliamo di democrazia come mezzo per raggiungere la libertà dalla gerarchia e dall’oppressione.
Parliamo di democrazia come processo per superare la violenza, la distruzione dell’ambiente e tutti i problemi che ci affliggono. Parliamo di democrazia come «fine» che non finisce mai – un processo sempre incompleto, ma che assicura un’ampia e profonda discussione per prendere buone decisioni.
Cos’è la democrazia? Niente su di noi, senza di noi.
(Slogan del Disability Right Movement)
La democrazia non può essere un luogo dove chiunque ha voce, ma nessuno ha responsabilità.
Astra Taylor
In tournée con il suo recente film, What is Democracy? l’attivista di Occupy Wall Street Astra Taylor ha spiegato perché ha scelto di non intitolare il film come il popolare canto di Occupy «This is what democracy looks like» («Questo è l’aspetto della democrazia»). Ha scelto la domanda, invece della risposta, perché non esiste una formula o un criterio definitivo per definire qualcosa «democrazia». La democrazia può assomigliare a una protesta di strada in cui chiunque guida un coro. Può sembrare un’assemblea sindacale che vota per lo sciopero. Può sembrare un lungo discorso di un anziano che spiega i valori fondanti della comunità. Può trattarsi di




una «assemblea delle assemblee» in cui i delegati locali si riuniscono per stabilire le principali strategie di movimento. In un certo senso, lo sappiamo quando la vediamo e lo sappiamo quando la sentiamo. Soprattutto, sappiamo quando non è giusta e possiamo fare qualcosa.
Democrazia significa letteralmente governo del popolo, ma chi è il popolo e come governa deve essere determinato dal popolo stesso. Nonostante la risonanza di questa idea, la storia non ha molto da raccontare sui governi chiamati democrazie. Secondo i nostri standard di emancipazione popolare, la mag-

gior parte delle democrazie presenta difetti evidenti, come l’esclusione della maggior parte delle persone dal «governo del popolo». Questi difetti sono insiti nelle regole, nelle costituzioni e nei processi di queste democrazie. Il sistema di democrazia inaugurato dagli antichi greci consentiva solo ai cittadini maschi – non schiavi – di deliberare sui problemi della città. Negli Stati Uniti, dopo una violenta rivoluzione per stabilire un sistema di autogoverno, i padri fondatori furono
ispirati a mantenere il vincolo di partecipazione ateniese del «cittadino maschio libero». Tuttavia, hanno ignorato l’antico processo greco di selezione casuale a sorte, istituendo invece un sistema repubblicano di elezione delle élite per prendere decisioni a nome della popolazione. Secondo David Graeber in The Democracy Project, questo sistema fu esplicitamente progettato per sopprimere i sentimenti rivoluzionari popolari sulla democrazia, in particolare per ridurre l’influenza della Confederazione Haudenosaunee – nota anche come Confederazione Irochese – e dei pirati marinari in visita che gestivano le loro comunità attraverso processi altamente partecipativi e inclusivi.


Si potrebbe obiettare che la democrazia si è evoluta nel tempo diventando più democratica grazie alla rappresentanza delle donne e di altre categorie precedentemente escluse. Popolazioni indigene, immigrati naturalizzati e neri sono stati eletti a tutti i livelli di governo. Tuttavia, risulta che i non ricchi – il 98% – sono ancora quasi del tutto esclusi dal processo decisionale, a parte per la scelta dei ricchi che decideranno per loro.
In Europa, i sistemi parlamentari hanno permesso la rappresentanza di partiti politici di sinistra che promettono un rifiuto radicale del neoliberismo, interventi sul cambiamento climatico e persino la fine del patriarcato. Molti di noi sono stati entusiasti quando una coalizione di questi partiti ha preso il potere in Grecia nel 2015. Tuttavia, chi contava che Syriza in Grecia o Podemos in Spagna fossero in grado – o disposti – a contrastare le pressioni delle élite finanziarie globali è rimasto deluso.
Questa distanza tra l’obiettivo e la realtà della democrazia è ciò che agli occhi di molti ha de
terminato il fallimento. In generale, gli esempi storici di formulazioni statali della democrazia sembrano limitare la partecipazione di alcuni o addirittura della maggior parte della popolazione – per presunte ragioni tecniche o di merito – a favore del mantenimento del potere da parte dei potenti. Yanis Varoufakis ama raccontare la storia di una manifestante greca durante la rivolta del 2011 che fu bloccata mentre cercava di entrare nelle sale del governo. La guardia la fermò per chiederle: «Chi pensi di essere?, al che lei rispose: Chi devo essere?».




Come possiamo rendere reale la democrazia?
L’istituzionalizzazione di una democrazia radicale, in cui tutti abbiano voce in capitolo, è quindi essenziale per creare un cambiamento duraturo. Solo la democrazia reale ha il potenziale per sfidare contemporaneamente le ingiustizie del nostro tempo e assemblare i mattoni di una società liberata.
The Symbiosis Research Collective
Potremmo iniziare a rispondere a questa domanda su cosa sia veramente la democrazia ponendoci alcune domande preliminari: Perché desideriamo la democrazia? Quali sono le qualità che fanno della democrazia la forma di governo ideale? Quali valori sono intrinseci alla nostra visione di democrazia? In che modo l’impegno per la democrazia può influenzare il nostro comportamento quotidiano? Per molti di noi, l’opportunità di discutere di tali questioni è allo stesso tempo scomoda e liberatoria, una sensazione che potremmo definire «democratica». Non otterremo risposte cercandole nella Costituzione o con qualsiasi altro processo che non sia la discussione tra di noi. Ecco quindi alcuni temi o «elementi democratici» da inserire nel dibattito:
- Autogoverno/autonomia: come può la partecipazione essere più del diritto di essere ascoltati? Come può essere un modo effettivo per influenzare le decisioni relative alla propria vita e agli affari comuni?
- Appartenenza e comunità: chi può pretendere di partecipare all’autogoverno e in quali momenti del processo? Quali sono i comportamenti che fanno sì che le persone vengano cacciate?
- Voce, libertà individuale e creatività: come possono gli individui essere liberi di esprimere il proprio sé unico mentre lavorano con gli altri per creare nuove possibilità?
- Ben-essere collettivo: come gli interessi individuali vengono bilanciati e controllati da ciò che è bene per la comunità?




- Forza nella diversità: come appiattire le tradizionali gerarchie di potere per garantire decisioni migliori, più umane e una partecipazione inclusiva?
- Deliberazione, discorso e discussione: come facilitiamo conversazioni produttive e rispettose?
- Accordo/decisioni: attraverso quale processo vengono prese e registrate le decisioni? Quando e come possono essere riviste?
- Educazione e saggezza: come possono i nuovi membri imparare da coloro che li hanno preceduti e diventare partecipanti sofisticati?
- Dissenso: cosa succede quando non c’è un accordo universale? Quali diritti hanno gli individui? Quali sono le limitazioni a questi diritti?
- Giustizia: quali sono gli standard per il comportamento nei confronti degli altri? Come si possono riparare i torti e come si rinforzano le regole?
Ognuno di questi aspetti dovrebbe essere preso in considerazione quando abbiamo, o cogliamo, l’opportunità di costituire una democrazia. Le risposte a queste domande dovrebbero tradursi in una documentazione fatta di norme e aspettative – ciò che alcuni potrebbero chiamare regole, statuti, primi principi, accordi comunitari, costituzioni o contratti so
ciali. Se tutti parlano contemporaneamente o dicono sempre le stesse cose o cose irrilevanti, si può ancora considerare una democrazia, ma non sarà né piacevole né efficace. Una struttura ben pensata e confrontata può prevenire la «tirannia della mancanza di struttura», il riemergere di schemi gerarchici e la confisca di riunioni e organizzazioni da parte di chi non è in grado di mettere da parte il proprio «io» per dare una possibilità al «noi».



La democrazia è notoriamente instabile. Quando scende il caos, la voce forte conquista il potere perché siamo tutti stufi e ci disgreghiamo invece di unirci. Oppure semplicemente non ci presentiamo.
Nelle nostre organizzazioni, spesso riproduciamo la gerarchia e il dominio, l’omologazione, la corruzione e la cooptazione. Spesso tralasciamo informazioni quando dovremmo essere trasparenti, ci mettiamo sulla difensiva invece di riflettere e tolleriamo gli abusi perché ci sembrano troppo difficili da affrontare. Nel
tentativo di fare le cose per bene, a volte cementiamo processi che scoraggiano ed esauriscono i partecipanti e non riconosciamo la necessità di cambiare, crescere, riposare e divertirci. Dobbiamo riconoscere che siamo esseri umani con tendenze comportamentali, con norme culturali e atteggiamenti socializzati, con ferite e guarigioni diverse. Queste influenze possono essere esaminate e considerate sia come punti di forza che come potenziali sfide mentre tentiamo di costruire la fiducia e di realizzare un cambiamento positivo verso una società libe-
ratoria. Le pratiche generose volte a riconciliare le differenze e a smascherare il sottile dominio possono essere sviluppate attraverso un impegno esplicito di responsabilità da parte dei membri della comunità democratica. Senza giustizia non possiamo pretendere di andare avanti.
I forum democratici sostenibili dipendono dall’organizzazione, dalla gestione del tempo e dalle regole. Importante anche capire come far rispettare le regole senza le consuete modalità coerci-




tive. Le aspirazioni liberatorie sono spesso più facili da accettare – come la parità di tempo tra uomini e donne per parlare – che da realizzare.
Dobbiamo accettare che la costruzione della democrazia è un processo e che la valutazione, il feedback, il monitoraggio e la riflessione sono inevitabili. Questi processi sono essenziali, così come l’attenzione esplicita all’educazione politica o paideia – il processo di formazione e di evoluzione dei partecipanti per approfondire l’intelligenza e l’impegno democratico. Sessioni di orientamento, gruppi di studio e colloqui in cui l’obiettivo è
semplicemente imparare e riflettere dovrebbero essere integrati nelle nostre nuove pratiche democratiche.
Dovremmo anche riconoscere che ci sono delle precondizioni per la democrazia. Ci sono condizioni fisiche, sociali ed economiche che abilitano la partecipazione di tutti. Le condizioni fisiche comprendono l’accessibilità degli spazi per le persone con disabilità, l’assistenza ai bambini e l’interpretazione della lingua. Le condizioni sociali includono la riduzione dei comportamenti che scoraggiano la partecipazione delle persone storicamente marginalizzate, comprese
le donne, le persone gender non-conforming e le persone prive di credenziali accademiche. Ciò può essere fatto sviluppando protocolli e processi che mirano esplicitamente a eliminare il razzismo, il sessismo, l’elitarismo e così via, come i caucus di affinità, la forte facilitazione, le quote di partecipazione e la «chiamata in causa» costruttiva per incoraggiare la riflessione, la responsabilità e la trasformazione.




Possiamo anche incoraggiare la leadership nelle nostre organizzazioni orizzontali di persone che sono state storicamente emarginate, richiedendo esplicitamente queste voci e fornendo opportunità di praticare abilità come la facilitazione e la gestione. Chiedersi «cosa dobbiamo fare affinché tutti, indipendentemente dalle risorse finanziarie, dallo status, dagli orari di lavoro e dalle responsabilità familiari, possano partecipare?», aiuta ad affrontare la forte esclusione dei non ricchi dalla partecipazione a tutti i processi democratici, compresi i nostri. Per esempio, assemblee infinite sono una barriera alla partecipazione di chi è già esausto. Rispondere a queste domande sulla condizione economica ci aiuta a capire che il lavoro non è equamente suddiviso e che coloro che preparano il caffè e puliscono devono poter partecipare da pari a pari ai nostri processi democratici e devono anche potersi riposare.
Affrontare la corazza della vecchia «democrazia»
Diventiamo potenza solo attraverso l’organizzazione. Contro i tentativi della modernità capitalista di infiltrarsi nelle cellule più profonde della vita individuale e sociale per snaturarne il tessuto, dobbiamo organizzarci contro il sistema con valori democratico-comunitari. In questo senso, la democrazia è la libera forma di vita della società. Poiché la socialità è legata alla libertà, la libertà può essere vissuta solo nelle sfere della democrazia. La democrazia radicale fa crescere le sfere di libertà della società. Ci impedisce di essere soppressi e annientati dai sistemi statalisti che ci occupano, ci alienano, ci colonizzano e ci distruggono. Inoltre, ci aiuta a diventare persone in grado di parlare, discutere, decidere e agire per conto proprio. La democrazia radicale fa emergere la forza di volontà umana. Abilita le persone a essere se stesse. Queste persone possono contribuire in maniera significativa alle loro società. Nella misura in cui una persona di questo tipo partecipa alla società con le proprie diverse caratteristiche, creerà diversità e aumenterà la libertà di quella società e di se stessa.
Komun



Gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone.
Audre Lorde
Molte persone – a destra, a sinistra e al centro – credono che il modo di trasformare la nostra società sia che più persone possibili votino e lavorino per eleggere buoni candidati. Sperano che le brave persone elette siano in grado di attuare nuove politiche che non riflettano solo gli interessi dei ricchi e dei potenti. Esiste certamente una tradizione di candidati che promettono di farlo, ma il bilancio non è positivo. Anzi, tendiamo a essere delusi dai compromessi da loro raggiunti. Molti pensavano che negli Stati Uniti, la combinazione di un uomo nero apparentemente progressista come presidente e del Partito Democratico al Congresso avrebbe portato a un’inversione di tendenza negli impatti crescenti del neoliberismo – austerità, disuguaglianza e dominio di tutte le decisioni importanti prese sulla base delle volontà del mercato. Ma non solo non l’hanno fermato, l’hanno anche intensificato. Le banche hanno vinto e le persone hanno perso.
Molti continuano a contare su candidati eletti, speranzosi che siano anti-establishment, per capire come vincere e trasformare le cose dall’interno. Tuttavia, anche se fosse possibile che diversi progressisti vincessero le elezioni, noi, il popolo, vorremmo comunque avere voce in capitolo su come risolvere i problemi del nostro modo di vivere sul pianeta. Per citare il titolo del libro di Marina Sitrin e Dario Azzellini: «Non ci possono rappresentare». Dovremmo renderci conto che, anche se queste persone sono per lo più benintenzionate, oltre che simpatiche, attraenti e intelligenti, semplicemente non possono risolvere i problemi complessi che tutti noi dobbiamo affrontare. Abbiamo bisogno di più idee, più risorse, più potere e più persone che partecipino direttamente ai processi democratici dedicati a riparare gli errori del passato e a creare le condizioni per la sopravvivenza dell’uomo e delle altre specie.




Mentre i candidati progressisti e populisti aumentano le aspettative, possiamo lavorare per un sistema di governo diverso e migliore, in cui più persone abbiano voce in capitolo. È il momento di liberare la nostra immaginazione e di impegnarci per democratizzare dal basso le nostre vite. È il momento di proporre, discutere e decidere le nostre regole. Questo processo è l’organizzazione del doppio potere: costruire strutture democratiche che delegittimino le istituzioni e i rituali democratici d’élite, dimostrando cos’è la vera democrazia. Queste assemblee e gruppi di lavoro democratici alternativi possono costruire e riattribuire il potere prendendo decisioni e trovando risorse per affrontare i nostri bisogni critici come la casa, il cibo, l’istruzione, l’accesso alla terra, la sicurezza e la cultura.
Tuttavia, a meno che lo Stato non crolli sotto le sue stesse contraddizioni, le nostre strutture democratiche rimarranno all’ombra delle istituzioni statali legittime. Le istituzioni dello Stato non possono essere ignorate, ma devono essere affrontate e sollecitate a rispondere, ove possibile. Così, ci troveremo impegnati nella grande controversia sulla quantità di sforzi da mettere nelle «richieste» da fare ai governi rispetto a capire come fare da soli. Ci troviamo di fronte alla questione strategica di sapere quando scappare, quando nasconderci e quando combattere. Questa tensione continuerà ad esistere e deve essere studiata.
In quali circostanze le nostre richieste saranno riconosciute e faranno sì che i governi rispondano? Quando sono destinate a essere inutili, estenuanti e cooptate? Quando è probabile che ci troveremo di fronte a repressioni e punizioni, inflitte con violenza, in risposta alla contestazione dei governanti? Quando possiamo sostenere con successo le nostre alternative e quando dobbiamo cercare di ottenere alcune delle risorse monopolizzate dallo Stato? Possiamo contemporaneamente avanzare richieste alle udienze e nei corridoi ai funzionari eletti, mantenendo energia sufficiente per le nostre assemblee democratiche? Ci possono essere circostanze particolari in cui sosteniamo le iniziative politiche dei politici progressisti, responsabilizzandoli per le loro promesse?



Forse possiamo considerare l’idea di «stand» rispetto alle richieste. Uno «stand» è sia una posizione sia un luogo. Prendiamo uno «stand» per dire ciò che vogliamo e ciò in cui crediamo, ma è anche un luogo dove possiamo prendere una limonata e chiacchierare del tempo, del baseball, dei bambini e della politica. È un luogo pubblico, ma sicuro, di convivialità, di soddisfazione dei bisogni, di scambio di informazioni, di espressione di opinioni, di generazione di idee e di elaborazione di progetti. Gli «stand» non hanno un inizio, una metà e una fine, purché la limonata non finisca. Abbiamo i limoni, facciamo la limonata. E cos’è la limonata dei nostri movimenti per la democrazia, se non il nostro impegno per la liberazione e la nostra etica della cura?
Tratto da: The Anarchist Library Traduzione di Marco Antonioli






Requiem per un sudario vuoto. Azione irreversibile su una scultura, performance e scultura di Giulietta Gheller, 2020.
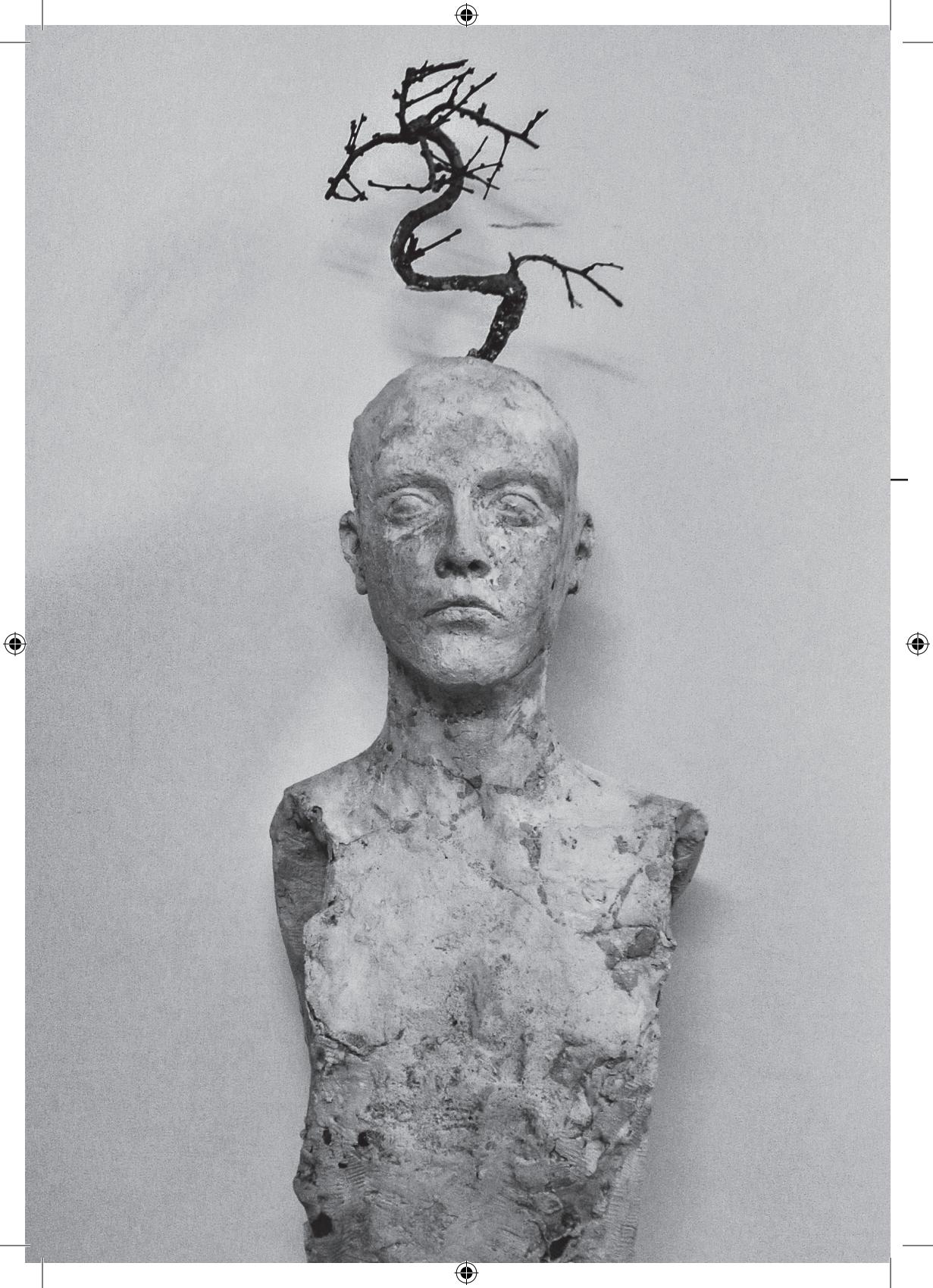
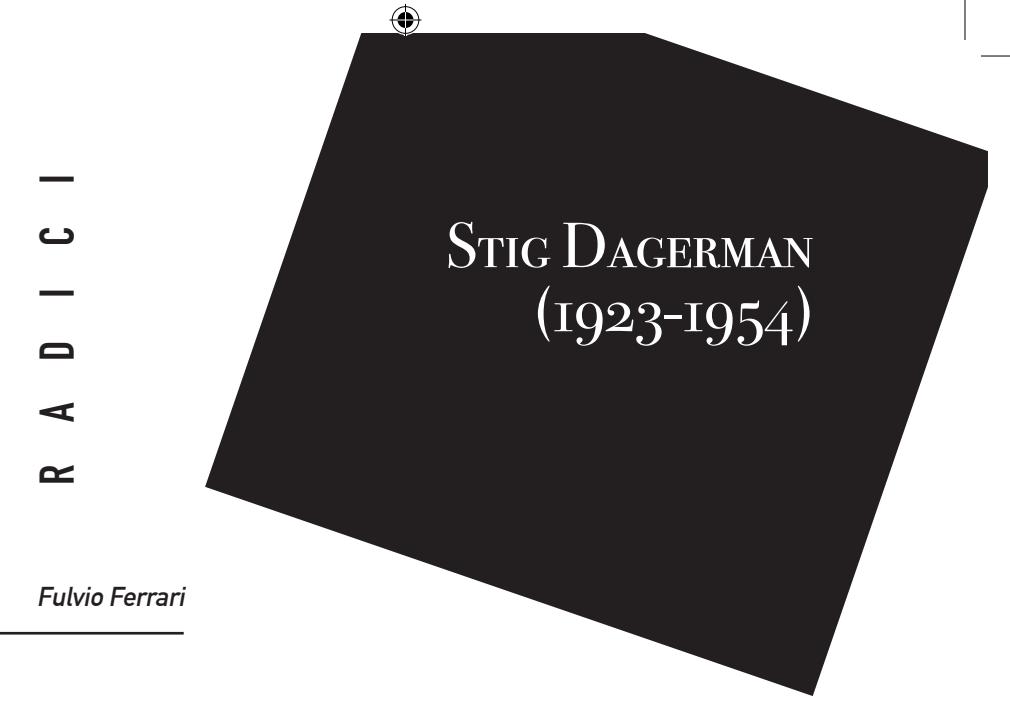
C’è un motivo, anzi, ci sono molti motivi se Stig Dagerman è ancora oggi, a settant’anni dalla sua morte, un autore letto, tradotto, discusso in tutto il mondo (una scelta di suoi testi è stata pubblicata l’anno scorso in lingua araba). Narratore, giornalista, militante anarchico, Dagerman ha mantenuto per tutta la sua breve vita uno sguardo lucido e critico sulla società, sull’arte e su sé stesso, mettendo a nudo nodi che, irrisolti, conservano tutta la loro urgenza e la loro complessità. Nato nel 1923, anarchico Dagerman lo è stato fin dall’adolescenza, quando ha cominciato a frequentare insieme al padre operaio il circolo anarco-sindacalista di Stoccolma, e la sua abilità nella scrittura ha fatto sì che entrasse ben presto a far parte della redazione del giornale dei giovani anarchici Storm («Tempesta») e che, poco più tardi, cominciasse una collaborazione con il quotidiano del movimento, Arbetaren («Il lavoratore»), durata fino alla morte.
La svolta nella sua vita di scrittore è arrivata nel 1945 con la pubblicazione del suo primo romanzo, Il serpente: poco più che ventenne, Dagerman si trova al centro della scena letteraria svedese, acclamato come portavoce di una nuova generazione. Il successo, però, non gli ispira nessun facile ottimismo: in un breve saggio di quello stesso 1945, intitolato Lo scrittore e la coscienza, Dagerman


affronta tutta la contraddittorietà del suo ruolo sociale. In quanto artista, lo scrittore è moralmente tenuto a cercare la verità e la verità non si lascia indagare con un linguaggio «facile», banalizzante. D’altro canto lo scrittore, pur nella sua libertà, non può esimersi dallo schierarsi nella lotta sociale: «perché nessuno è tanto ’libero’ da potersi esimere dal prendere posizione nella lotta degli sfruttati contro gli sfruttatori». Da queste convinzioni nasce il paradosso di una letteratura che si dà come scopo la liberazione di una classe sociale che non è in grado di leggerla. Dagerman non dà risposte facili, la sua risposta è che bisogna accettare di muoversi nel «bosco dei paradossi».
Anche il suo anarchismo, del resto, è inteso in un senso originale. Sia chiaro, Dagerman non è un anarchico da salotto, la sua adesione al movimento è militante e fino alla fine continua a collaborare con i giornali libertari e a partecipare alle manifestazioni di piazza. Il suo anarchismo, però, è un anarchismo disincantato, privo di qualsiasi colorazione di messianesimo sociale. Già nel romanzo Il serpente, il personaggio Scriver, evidente proiezione letteraria dell’autore, dà voce al suo pessimismo esistenziale: «Io aspiro alla giustizia sociale, cioè, a un sistema in cui non ci sia più la tratta degli schiavi, in cui sia considerata una cosa contro natura che si debba essere riconoscenti a un datore di lavoro, a una banca o a una lotteria perché ti garantiscono il diritto di vivere. […] Per l’armonia, invece, non chiedo assolutamente nessuno spazio, in quel sistema. La serena felicità, purtroppo, ha dimostrato una certa tendenza a degenerare in rutti e indigestioni».
Nel saggio Il mio punto di vista sull’anarchismo, del 1946, da un lato afferma che l’esperienza catalana ha storicamente dimostrato la possibilità di realizzare una società coerente con gli ideali anarchici, ma dall’altro lato riconosce la sconfitta internazionale del movimento e la necessità di un lungo lavoro culturale prima di poter porre di nuovo la questione della costruzione di una società libertaria: «In quanto anarchico (e in quanto pessimista, nella misura in cui è consapevole che il suo contributo potrà forse avere solo un significato simbolico), lo scrittore può intanto attribuirsi in buona









coscienza il modesto ruolo del lombrico nel terriccio della cultura che altrimenti si disseccherebbe nell’aridità delle convenzioni. Essere il politico dell’impossibile in un mondo dove sono troppi i politici del possibile è, nonostante tutto, un ruolo che personalmente mi può soddisfare come essere sociale, come individuo e come autore del Serpente».
La consapevolezza del paradosso e della sconfitta non induce Dagerman alla passività, anzi: negli anni tra il 1945 e il 1949 scrive i suoi capolavori, sempre sperimentando nuovi stili e nuove tecniche, attento soprattutto alla lezione di Kafka e di Faulkner, oltre che dei grandi autori svedesi del Novecento. Continua anche la sua attività militante, scrivendo poesie satiriche per l’Arbetaren e impegnandosi nella lotta contro il franchismo e il dispotismo stalinista. L’acutezza del suo sguardo gli permette poi di individuare una linea di tendenza che porta dalla società del bisogno a una società dell’angoscia e dell’impotenza.
Forse proprio l’angoscia, una lunga crisi creativa e l’ansia di prestazione sono la chiave per capire le ragioni del suo suicidio, nel novembre del 1954. Un suicidio che nulla toglie all’attualità del suo pensiero e all’urgenza delle questioni che ha posto nella sua opera.
Bibliografia:
Dagerman S., Il serpente, Iperborea, Milano, 2021.
- La politica dell’impossibile, Iperborea, Milano, 2016.
- Autunno tedesco, Iperborea, Milano, 2018.
- Bambino bruciato, Iperborea, Milano, 1994.
- Il nostro bisogno di consolazione, Iperborea, Milano, 1991.
Fontana G., Letteratura senza aggettivi, «Rivista anarchica», 50, 440, febbraio 2020.
Riva A., Il tormento di Stig Dagerman, il politico dell’impossibile, «Domani», 26 febbraio 2021.
Rossetti I., Stig Dagerman. Il cuore intelligente, FVE, Milano, 2021.


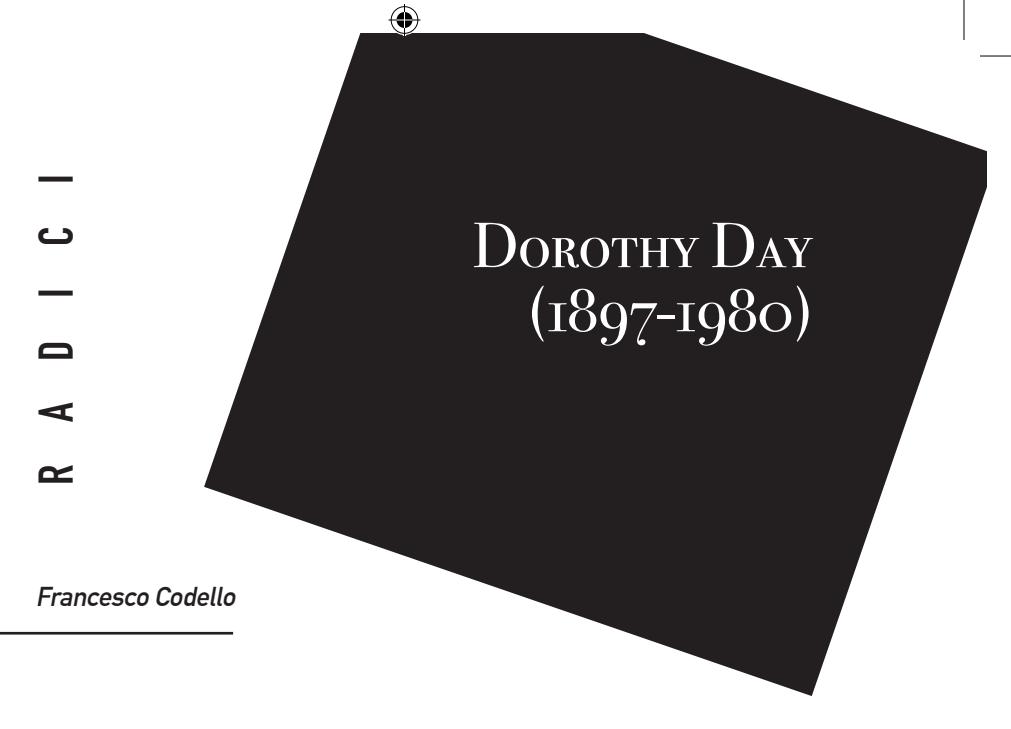
Presentare un breve profilo di Dorothy Day significa soprattutto parlare della sua vita. Questa straordinaria donna, infatti, non ha mai voluto separare il suo pensiero dalla sua vita, che in lei diventa testimonianza continua e indelebile di valori professati ma, soprattutto, vissuti quotidianamente.
Nasce l'8 novembre del 1897 a Brooklin (New York), in una famiglia dalle forti tradizioni protestanti e patriottiche, padre giornalista sportivo e madre casalinga. Per esigenze di lavoro del padre si trasferisce a San Francisco e poi a Chicago. Nel 1914, all’età di 17 anni, all’inizio della prima guerra mondiale, vince una borsa di studio all’Università dell’Illinois per studiare Lettere. Si dichiara atea e si rende indipendente dalla famiglia. Matura l’adesione al movimento socialista. Due anni dopo abbandona l’Università e si trasferisce a New York cominciando il suo lavoro di giornalista nei giornali di sinistra «The Liberator», «The Masses» e «The Call» diventando una attivista a tutto tondo nel movimento sindacale e socialista. Nel 1917 finisce per la prima volta in prigione (decine saranno le carcerazioni successive) per una protesta a favore del diritto di voto alle donne, ma sarà liberata dopo una decina di giorni grazie a uno sciopero della fame di gruppo. Scoppia la Rivoluzione russa e l’anno seguente finisce



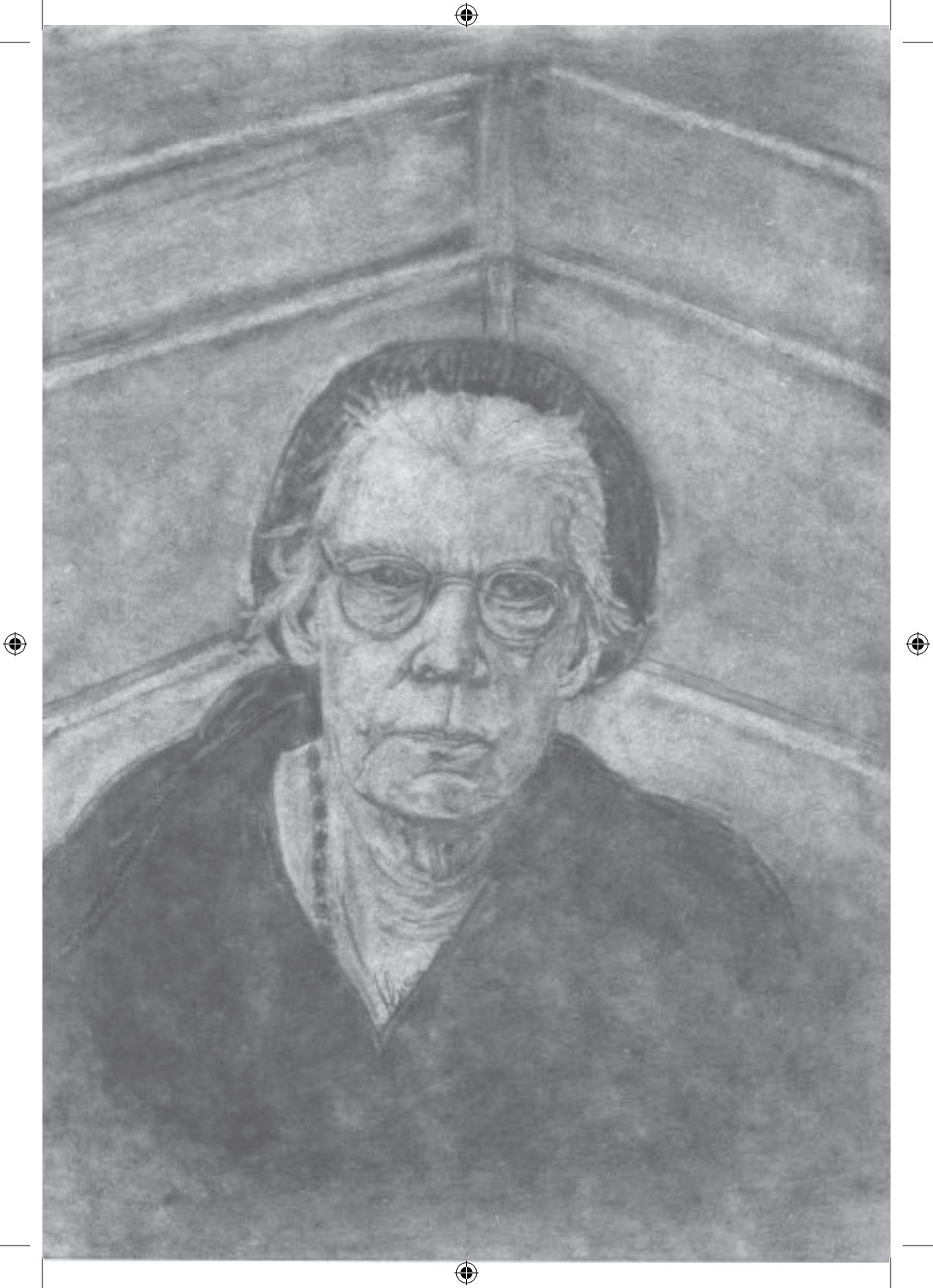

la prima guerra mondiale e Day segue corsi di infermiera nell’ospedale Kings County di Brooklyn. Si sposa nel 1918, resta incinta ma abortisce per evitare di separarsi dal compagno, peró poi divorzia l’anno seguente. Da una relazione successiva nasce sua figlia Tamar nel 1926. A partire da quest’anno inizia il processo della sua conversione al cattolicesimo, che sfocia nella richiesta del battesimo per sé e per la figlia. Nel 1933 incontra Peter Maurin (1881-1949) col quale inizierà una collaborazione intensa e dal quale sarà influenzata culturalmente e spiritualmente abbracciando la filosofia personalistica di Mounier e Maritain. Nel 1922, all’età di 25 anni, scrive il romanzo autobiografico The Eleventh Virgin dal quale sarà tratto un film di successo e lei riceverà cinquemila dollari coi quali acquisterà una piccola casetta sulla spiaggia di Staten Island. Nel 1933 con Maurin condivide le simpatie per l’IWW (sindacato rivoluzionario libertario) e fonda il periodico «The Catholic Worker» organo dell’omonimo movimento sociale (The Catholic Worker Movement) creato da questa coppia di radicali libertari americani.
Il giornale ha evidenti affinità anarchiche ma è di esplicito orientamento cristiano, si schiera in difesa dei diseredati e dei poveri. Sia lei, sia Maurin scrivono appassionatamente a favore dei diritti delle donne, della necessità che l’amore sia libero dallo sfruttamento e dall’oppressione dell’urgenza del controllo delle nascite. In pieno clima guerrafondaio degli anni ‘30, si impegna tenacemente per sostenere una nuova collocazione neutrale e pacifista che sposi le pratiche attive della nonviolenza, l’amore operoso, la lotta all’economia di sfruttamento capitalistico e al sentimento nazionalistico. Day e Maurin fondano numerose case di accoglienza in diverse città statunitensi per garantire ospitalità concreta agli impoveriti dalle crisi del sistema economico e sociale e per dare speranze di rinascita ai diseredati. Queste «case di ospitalità» rappresentano lo sforzo maggiore del movimento e un esempio concreto di pratiche solidali e mutualistiche, in grado di contrastare la miseria e la sofferenza che gli ultimi patiscono a causa di un sistema sociale autoritario e corrotto dalle logiche


del denaro. Queste case si diffondono a decine anche in Canada e in Gran Bretagna dando a Dorothy Day una visibilità e una notorietà internazionale.
Da sempre contro la guerra, Dorothy Day indice con i militanti del movimento numerose manifestazioni antimilitariste, molte delle quali terminano con il fermo poliziesco di decine di persone. Nel 1955, dopo essere stata arrestata, divide la cella con Judith Malina, attrice del Living Theatre anch’ella presente alla manifestazione incriminata. Secondo la testimonianza di Judit Malina, Dorothy era anarchica a tutto tondo, anche se quest’anarchismo era di fatto e per definizione coniugato con un cattolicesimo profondo e integrale: «Dorothy si rifiutava di fare distinzioni fra i poveri, gli ubriaconi, i miserabili, i disoccupati che arrivavano per un piatto di minestra e la gente che la minestra la cucinava […]. Ho visto Dorothy incontrare queste persone senza speranza in un modo così incredibile, semplice e diretto, che mi ha fatto imparare moltissimo della vita, del sistema delle classi, dei nostri obblighi gli uni verso gli altri, e di me stessa». Malina testimonia inoltre come Dorothy mostrasse alle detenute un modo diverso di rapportarsi col potere dell’autorità: mostrando resistenza ma senza un atteggiamento di odio […]. Conosceva assai bene i principi di base dell’anarchismo classico». Infatti Day aveva letto molto Tolstoj e apprezzato il suo cristianesimo libertario, aveva studiato e commentato testi come Il mutuo appoggio e Campi, fabbriche, officine di Kropotkin, ma conosceva anche Bakunin ed Emma Goldman e molti altri militanti anarchici. Scrive nella sua autobiografia a questo proposito: «Io ero in bilico tra socialismo, sindacalismo (IWW) e anarchia. Quando leggevo Tolstoj ero anarchica, Ferrer con le sue scuole, Kropotkin con le sue comuni agricole, l’IWW con la sua solidarietà e i suoi sindacati mi attiravano ugualmente […] Il socialismo era troppo dottrinario; non capivo Marx».
Nonostante ciò ha sempre rifiutato l’etichetta di anarchica, preferendo essere definita cristiana, cattolica e «personalista».
Benché la sua devozione alla Chiesa cattolica fosse forte, non ha




mai voluto imporre la sua fede agli altri, né mai sono mancate le critiche alla stessa istituzione ecclesiastica. Dopo la vittoria di Francisco Franco nella guerra civile spagnola, suscitando sdegno negli ambienti cattolici americani, si schiera, in opposizione alla posizione ufficiale della gerarchia cattolica, apertamente contro la dittatura franchista; altra polemica la avrà con il cardinale Francis Spellman, che voleva imporle la sostituzione della testata del suo giornale, cosa che lei sempre. Coerente con i suoi valori e testimoniando con la vita la sua devozione agli ultimi, attraverserà da protagonista critica i movimenti di contestazione della fine degli anni Sessanta e non cesserà mai di garantire il suo impegno per la causa dell’emancipazione umana.
Ha speso la sua vita sostenendo sempre in modo concreto la causa dei poveri e degli sfruttati girando in lungo e in largo gli Stati Uniti, l’Europa, e molti altri paesi (Russia compresa). Le case che hanno accolto migliaia di diseredati sono state tutte fondate e sostenute dalla militanza degli attivisti, finanziate esclusivamente con donazioni e sottoscrizioni, la sua intera vita è stata vissuta all’insegna della sobrietà senza concedersi nessun lusso né agio particolare. Il suo impegno è sempre stato caratterizzato da un approccio radicalmente non violento e pacifista e si è accompagnato con continue azioni antimilitariste e internazionaliste.
Dwight Macdonald nel numero del 4/10/1952 del «New Yorker» così descrive la figura complessa di Dorothy: «Comunica una forza morale composta di apertura, sincerità, serietà e umorismo […] Il suo temperamento unisce sentimento mistico e praticità in un modo non comune nel mondo di tutti i giorni […] Miss Day combina le funzioni di direttrice – l’allegra allegria, la capacità di far emergere i timidi, l’abile intrattenimento degli indisciplinati e persino la raccolta fondi – con quelle di una madre affettuosa e vigile». Soffre per l’uccisione dei coniugi Rosemberg, come aveva patito la morte sulla sedia elettrica di Sacco e Vanzetti. Per difendere i neri dalle violenze razziste subisce un attentato in occasione della sua visita alla colonia comunitaria cristiana chiamata «Koinonia» ad Americus in Georgia. Si bat-




te contro gli ordigni nucleari e gli intenti bellicistici da parte di ogni tipo di regime politico. Assieme al movimento dei Catholic Worker partecipa alle proteste contro tutte le guerre: il conflitto cino-giapponese, la guerra d’Etiopia, in Spagna, la seconda guerra mondiale, quella in Corea, in Algeria e in Vietnam. Scrive continuamente nel giornale di ciò che vede e vive: le lotte per la giustizia sociale, le comuni agricole fondate dal movimento, gli esperimenti e le pratiche di vita evangelica, la difesa dei diritti civili, la non violenza attiva e il rinnovamento della Chiesa. Ovunque ci sia bisogno della sua presenza fisica e morale lei c’è. A Roma nei giorni del Concilio indetto da papa Giovanni digiuna e prega confidando in particolare nella condanna di ogni guerra e violenza. Amore, solidarietà, comunità: tre parole chiave per capire fino in fondo la portata del messaggio di Dorothy Day e a chi le chiede dei suoi piani futuri ripete, come un mantra, la sintesi estrema del suo pensiero che ispira la sua militanza: «Continuare a lavorare per una società dove sia più facile essere buoni». Nonostante sia diventata un personaggio pubblico frequentemente citata nei grandi organi di informazione conserva sempre la sua vocazione di povertà e di semplicità. Queste caratteristiche straordinarie possono ben sopportare le contraddizioni che talvolta Day ha espresso rispetto alla sessualità, all’adesione alla Chiesa come istituzione, ecc. Va ricordato che i suoi interlocutori privilegiati all’interno del cattolicesimo saranno dissidenti come il pensatore gandhiano Lanza del Vasto, Hélder Camara, fratello Roger di Taizé, madre Teresa di Calcutta, solo per citare i principali. In Italia sarà con Danilo Dolci, Ignazio Silone e sua moglie Darina, in prima fila nella lotta contro la mafia e l’oppressione della disuguaglianza sociale ed economica. Solidarizzerà con il dissenso sovietico e collaborerà anche con Joan Baez in un simposio antimilitarista e pacifista. L’ultimo arresto lo subisce all’età di 75 anni e lo considera un periodo di «riposo» dalle frenetiche attività militanti. L’ultimo intervento pubblico è del 1976: per lei diventa l’ennesima occasione di schierarsi contro la bomba atomica proprio nell’anniversario della bomba di Hiro-



shima e di riaffermare il suo pacifismo e il suo antimilitarismo. Nel suo conclusivo scritto pubblico esalta la bellezza della natura, l’amore di Dio, la necessità di perdonare, l’augurio al mondo di più misericordia e più felicità: «Abbiamo bisogno di rispetto per la terra. Tutto viene da lei».
Dorothy Day, morta a New York il 29 novembre del 1980, è stata sepolta nel Resurrection Cemetery di Staten Island, a pochi isolati da dove si trovava il suo cottage vicino al mare. Per suo volere la Chiesa sarà una chiesa dei poveri e non la cattedrale. Fino alla fine fedele al vecchio slogan mutuato dall’IWW: «Costruire il nuovo dentro la struttura del vecchio». Agire ora, qui, concretamente per edificare fin da subito il mondo nel quale desidereremmo vivere.

Bibliografia suggerita per approfondire
Day D., Una lunga solitudine. Autobiografia, Jaca Book, Milano, 2002.
Forest J., Dorothy Day. Una biografia, Jaca Book, Milano, 2011.
Forcades T., Per amore della giustizia. Dorothy Day e Simone Weil, Castelvecchi, Roma, 2021.
Galeotti G., «Siamo una rivoluzione». Vita di Dorothy Day, Jaca Book, Milano, 2021.
Miller W. D., Dorothy Day e il Catholic Worker Movement, Jaca Book, Milano, 1981.
Moreel B., I compagni Catholic Workers, in: «A-Rivista anarchica», 36, 322, Milano, dicembre 2006-gennaio 2007.
Valenti C., Conversazioni con Judith Malina, Elèuthera, Milano, 1995.





Quale attività più universale del lavoro? Quale problema più vasto e più ricco di interferenze con tutti gli altri problemi di quello del lavoro? Leggi economiche, leggi fisiologiche, leggi psichiche: quasi tutta la società e quasi tutto l’uomo sono in gioco in quest’attività, che ancor oggi è una pena, ma che domani diventerà la suprema delle dignità umane (C. Berneri, Il lavoro attraente, 1934).
Se da un lato il cinema stimola riflessioni sulle dinamiche culturali e politiche che determinano i cambiamenti sociali, dall’altro – nel corso della sua storia novecentesca – è stato ed è ancora oggi uno strumento potente in grado di modellare opinioni, valori e comportamenti. Da qui l’importanza di questa nuova rubrica, che nasce con lo scopo di proporre «percorsi di visione» su tematiche e aspetti di una società sempre più complessa e in continua trasformazione e che intende suggerire la visione di film che possano aiutare e stimolare la riflessione su tali tematiche. La prima analisi che proponiamo riguarda il lavoro come principio fondante della società che, mutato nelle sue forme e nel suo significato, sembra non rappresentare più, per molte persone, un elemento centrale e identitario della propria vita.


Il mondo del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici, ha sempre ispirato pellicole, fin dagli esordi del cinematografo. Il primo film, quello che convenzionalmente indica la nascita del cinema, venne proiettato a Parigi dai fratelli Lumière il 28 dicembre 1895, e si intitolava proprio L’Uscita dalle Officine Lumière a Lione. Il film, della durata di cinquanta secondi, mostrava semplicemente gli operai che uscivano dalla fabbrica – ora diventata un museo a Lione – attraverso immagini fotografiche dei fratelli Lumière. Il cinema, già all’esordio, rifletteva su se stesso, o meglio sui suoi mezzi di produzione, e se a questo aggiungiamo che per assistere alla proiezione lo spettatore, per la prima volta, doveva pagare un biglietto da un franco, è straordinario notare come il cinema – considerata la settima arte – nasca proprio come fonte di profitto e «industria» cinematografica, e la proiezione dell’uscita degli operai dalle fabbriche sembrava fatta apposta per rappresentarla.
Nel corso del Novecento la macchina da presa è entrata sempre più nella realtà del lavoro, assumendo i toni della commedia, della denuncia, della riflessione drammatica affrontata anche, a volte, con taglio comico, ma sempre riflettendo la vita delle persone, spinte a immedesimarsi nella narrazione. Questo è stato lo scopo principale del cinema di un regista politico impegnato nella rivoluzione d’Ottobre come Sergej Ėjzenštejn, che sperimentò il cosiddetto «montaggio intellettuale» proprio con il suo primo film incentrato sul mondo del lavoro, Sciopero (1925).
È attorno agli anni Trenta, però, che escono al cinema due film particolarmente significativi, Metropolis (Fritz Lang, 1927) e Tempi moderni (Charlie Chaplin, 1936), che di fatto segnano l’ingresso del tema del lavoro nel mondo del cinema. Visionario e fortemente drammatico il primo, denuncia tragicomica il secondo, rappresentano due facce della stessa medaglia: la fabbrica ford-taylorista dominata dal robot, che sia quello fantascientifico di Metropolis o l’uomo-macchina di Tempi moderni. In entrambe le pellicole i lavoratori vengono trattati come automi, costretti a ritmi di lavoro esasperati, senza garanzie e diritti, fino alla totale alienazione.




Un filo rosso che, in tema di lavoro, corre lungo tutto il Novecento, ma che qui non intendiamo dipanare e nemmeno riavvolgere con una narrazione. La nostra «scelta di campo» guarda al presente, al contemporaneo, o meglio ancora al post-moderno. Facciamo quindi un salto temporale dai Tempi moderni ai «Tempi post-moderni», per un viaggio che, pur non avendo la pretesa di essere esaustivo e nemmeno fedelmente cronologico, vuole riflettere sul cinema che negli ultimi vent’anni ha messo il tema del lavoro e le sue contraddizioni al centro della propria produzione.
Confrontandosi con il nostro tempo e la nostra società, La legge del mercato (Stéphane Brizé, 2015) mette in scena il rapporto tra l’individuo e il mondo del lavoro, senza alcuna manipolazione cinematografica ma raccontando gli effetti del disagio sulla vita del protagonista Thierry, interpretato da uno straordinario Vincent Lindon. Disoccupato da 20 anni, con 51 anni sulle spalle e 500 euro al mese di sussidio, Thierry cerca di resistere per cavarsela in un contesto sociale che solo apparentemente sembra disposto a sostenere chi è davvero in difficoltà. Spinto dal desiderio di far proseguire gli studi al figlio disabile e dalla necessità di sanare un debito con la banca, Thierry sceglie fin da subito di non condividere la propria lotta con i compagni di lavoro, accettando un impiego sottopagato e lontano dalle proprie competenze specifiche. Diventa sorvegliante di un supermercato dove i piccoli furti, sintomo di una crisi economica sempre più dilagante, sono all’ordine del giorno e pongono Thierry davanti al dilemma morale di denunciare i colleghi autori dei taccheggi. Inseguendo la logica del profitto, la legge del mercato relega i lavoratori ai margini, privandoli non solo della libertà economica ma anche etica. Il protagonista viene continuamente «pedinato» dalla macchina da presa, che si sofferma sul suo vivere quotidiano con lunghi piani sequenza, quasi a chiedere a chi guarda di «sospendere l’incredulità» e osservare la realtà per quella che è. Un cinema quasi documentaristico, cinéma vérité, come dicono i francesi. La legge del mercato è il primo capitolo di una trilogia che il regista Stéphane Brizé dedica al mondo del lavoro, cui seguono In guerra (2018) e Un altro mondo




(2022), collocandosi a pieno titolo in quel cinema sociale e militante di cui i fratelli Dardenne, autori del nostro prossimo suggerimento di visione, sono tra i maggiori interpreti.
Due giorni, una notte (Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2014) è la storia del drammatico weekend di Sandra, interpretata da Marion Cotillard, operaia e madre di famiglia sotto minaccia di licenziamento, costretta a bussare alle porte dei colleghi per convincerli a rinunciare al bonus aziendale e mantenere così il suo posto di lavoro. La vicenda, che si svolge in un’anonima periferia belga, avrebbe potuto essere ambientata ovunque: è il racconto di una guerra tra poveri in un mercato del lavoro sempre più selvaggio e disumano, dove troppo spesso salvare se stessi vuol dire colpire l’altro. La macchina da presa si incolla alla protagonista e non l’abbandona mai, per due giorni e una notte la segue nella sua via crucis al confine, oggi sempre più labile, tra la difesa di un diritto e l’elemosina. Il cinema dei Dardenne si caratterizza, generalmente, per il crudo realismo della narrazione e questo film non fa eccezione: la trasformazione e l’evoluzione dei personaggi, e delle situazioni in cui sono inseriti, verso il lieto fine – ben distante dal buonismo di stampo hollywoodiano – risultano necessarie per suggerirci che in questa guerra tutti-contro-tutti la lotta solitaria non dà sbocchi e che, per salvare se stessi, occorre guardarsi l’un l’altro e generare solidarietà.
Nello spazio di tempo di una settimana, invece, corre la vita di un’altra donna, Julie (Laure Calamy), protagonista di Full Time - Al cento per cento (Eric Gravel, 2022). Julie corre, letteralmente. Non si ferma mai, schizza da una parte all’altra di Parigi per tenere insieme la sua vita. Corre a prendere il treno ogni mattina per andare al lavoro come capo cameriera in un hotel di lusso, corre a prendere la metro e recuperare i figli dalla vicina, corre a fare la spesa, corre a cercare un impiego più remunerativo. Corre, fino a quando uno sciopero nazionale dei mezzi di trasporto fa saltare il gioco di incastri su cui si basa la sua quotidianità e la porta a perdere il posto di lavoro. Costretta a fermarsi, Julie trasforma il momento di crisi in un’occasione per ripartire da sé. Visto fuori dal




contesto, il film ha la stessa tensione di un thriller con una donna braccata e in fuga. A inseguire la protagonista, però, non ci sono spie o terroristi bensì il quotidiano in un dramma sociale comune alle molte Julie ricattabili e costrette a lavori precari e sottopagati. Full time - Al Cento per Cento è una radiografia del nostro tempo che sottomette e annienta bisogni e sentimenti nel nome di un essere umano disumanizzato, divenuto ingranaggio del sistema. Come lo è Ricky, il protagonista di Sorry We Missed You (Ken Loach, 2019) che, disoccupato e senza diplomi né qualifiche professionali, accetta al volo un lavoro come autista indipendente per una ditta di consegne a domicilio. Per acquistare il furgone, convince la moglie a vendere l’unica auto di famiglia e inizia la sua corsa a ritmi indiavolati scanditi da tempi e da scadenze dettate da uno scanner digitale. Diventare imprenditori di se stessi non implica diminuire i tempi di lavoro, ma aumentare i rischi e i problemi che finiscono per compromettere la solida unità familiare di Ricky. Bersaglio della denuncia di Ken Loach, che non ha mai fatto segreto delle sue idee manifestandole in un concreto impegno politico e nella militanza culturale, è la gig economy, il regime di libero mercato in cui i lavoratori assumono le stesse mansioni di un lavoratore dipendente, ma anche i rischi e le responsabilità di un libero professionista. Situazione diffusa tra i fattorini di Deliveroo, i corrieri indipendenti di Amazon e molte altre realtà, il gig working declina la mobilità sociale a vantaggio delle corporazioni invece che dei lavoratori di cui il protagonista del film è la perfetta esemplificazione.
Anche Issa, il giovane protagonista senegalese del film Anywhere Anytime di Milad Tangshir (2024) – alla sua prima prova come regista – è alle prese con la propria sopravvivenza nel mondo drogato della gig economy. Il film scandisce il ritmo della povertà: alla continua ricerca di un’occupazione, Issa acquista a fatica una bici usata per poter lavorare «a chiamata» come rider per le consegne a domicilio. Le cose per lui si complicano quando, durante una consegna, la bicicletta gli viene rubata. Inizia quindi un inseguimento – un pedinamento quasi zavattiniano – alla disperata ricerca della




bici sottratta, che in una condizione di estrema vulnerabilità può fare la differenza tra salvarsi e non farcela. La bicicletta rappresenta, per Issa, l’unica possibilità che ha di poter lavorare, e qui il riferimento al capolavoro del 1948 di Vittorio De Sica Ladri di biciclette diventa oltremodo evidente, anche se non è mai scontato, poiché la sensibilità del regista riesce ad attualizzare la storia e a renderla se possibile ancora più cruda. Un neorealismo postmoderno che non intende concedere nulla a niente e a nessuno, tantomeno a un finale falsamente consolatorio. Anywhere Anytime, la scritta sullo zaino giallo del protagonista rider, diventa la metafora dell’ipocrisia della società sul mondo del lavoro sommerso e clandestino.
Infine, ci piace suggerire la visione di due pellicole italiane, tra le poche a dare ancora voce alla rabbia operaia: Palazzina Laf (Michele Riondino, 2023) che racconta il mobbing nel reparto lager dell’Ilva di Taranto, e La fabbrica dei tedeschi (Mimmo Calopresti, 2008) che racconta la tragedia della Thyssen-Kupp Acciai Speciali di Terni, dove sette operai persero la vita.
Il lavoro, così come si desume da questo nostro primo percorso di visioni cinematografiche, non sembra essere diventato «la suprema delle attività umane», come auspicato da Camillo Berneri. Piuttosto, è rimasto «una pena», e senza neppure l’aspettativa di un finale consolatorio. Tra tutti i diritti umani, quelli di chi lavora sono tra i più violati al mondo a partire da quello a riunirsi in sindacati e a negoziare collettivamente, senza il quale è difficile immaginare che si possano proteggere il diritto a un salario minimo adeguato, alla salute e alla sicurezza sul lavoro o a ragionevoli orari di lavoro. La dialettica tra capitale e lavoro non è mai stata, almeno potenzialmente, paritaria e mai lo sarà, ed è innegabile che esista un chiaro legame tra il rispetto dei diritti dei lavoratori e la forza di qualsiasi democrazia. Mala tempora currunt.




Inquadra il QR-code per vedere spezzoni e trailer dei film citati:

Anywhere anytime

Due giorni, una notte

Full time - Al cento per cento

L’uscita dalle officine Lumière a Lione

La fabbrica dei tedeschi

La legge del mercato

Metropolis

Palazzina LAF

Sciopero

Sorry We Missed You

Tempi moderni






MUSICA
Tra silenzi e spari. Suoni e percorsi della canzone politica italiana
Felice Liperi
Com’è noto la canzone è uno degli strumenti di comunicazione più efficaci per arrivare all’intimità delle persone perché tocca in modo diretto i sentimenti profondi dell’animo umano, è quindi perfettamente comprensibile che sia stata usata anche per scopi politici e di mobilitazione. Fin dall’epoca sveva. Basta pensare al celebre Canto delle lavandaie del Vomero lanciato a Napoli per protestare contro la promessa non mantenuta dal regnante aragonese di distribuire ai contadini «fazzoletti» di terra. Sullo stesso argomento nel secolo XVIII in Sardegna Francesco Mannu firma Su patriotu sardu a sos feudatarios, inno di rivolta dei contadini contro la gestione del territorio isolano da parte dei baroni delegati dai piemontesi. Anche durante il Risorgimento l’uso della canzone politica si rafforza con i canti giacobini e garibaldini che incitano il popolo a rovesciare i governi tirannici della penisola, fra questi Andremo a Roma con dei bastoni, Camicia rossa, Inno a Garibaldi, e quindi quelli anarchici: Figli dell’officina, Amore ribelle e il celebre Inno della rivolta con il testo rilanciato dal movimento studentesco negli anni sessanta: insorgeremo! / per le vittime tutte invendicate / là nel fragor dell’epico rimbombo / compenseremo sulle barricate / piombo con piombo / e noi cadremo in un fulgor di gloria / schiudendo all’avvenir novel-


la via / dal sangue spunterà la nuova storia / dell’anarchia.
Poi, naturalmente, si sono affermati i canti più strettamente legati all’emergere del movimento operaio e contadino e delle organizzazioni politiche e sindacali. Non solo di sinistra (Bandiera rossa, Inno dei lavoratori) ma anche di destra, soprattutto negli anni dell’avvento del fascismo (Balilla, Giovinezza, Faccetta nera) che comprese l’importanza della canzone per conquistare consenso. Nel secondo dopoguerra del novecento due gruppi politico-culturali come Cantacronache e Il nuovo Canzoniere Italiano hanno recuperato alcuni canti della tradizione popolare per trasformarli in strumenti di battaglia politica accompagnandoli con titoli inediti d’autore (Per i morti di Reggio Emilia e Contessa con il celebre passaggio Compagni dai campi e dalle officine / prendete la falce e portate il martello / scendete giù in piazza e picchiate con quello / scendete giù in piazza e affossate il sistema) funzionali alle battaglie delle classi operaie e studentesche. Ma il ruolo, forse più importante, di queste organizzazioni è stato quello di aver rilanciato con la stagione del folk revival un repertorio politico già esistente di cui fa parte la ripresa della famosa Bella ciao rimasta viva nell’intero secondo dopoguerra anche grazie a continue rielaborazioni del testo. Su ispirazione di questo repertorio ha preso corpo il lavoro di Francesco Guccini che da scrittore e cantautore è riuscito a dare forma a canzoni come La locomotiva, Primavera di Praga, Dio è morto, Noi non ci saremo, Auschwitz, Canzone per Silvia, Piazza Alimonda, Canzone per il Che, e persino L’avvelenata, dove la denuncia si è fatta letteraria ma non meno efficace e coinvolgente. Senza dimenticare che dopo l’addio ai concerti ha inciso due album dedicati proprio alla canzone sociale e politica in cui figuravano Morti di Reggio Emilia e Addio a Lugano.
In seguito la trasmissione fra canzone popolare e rock viene sostenuta da tre formazioni come Stormy Six, Area e Canzoniere del Lazio. I primi sono il gruppo che a partire dalla fine degli anni Sessanta costruisce un nuovo repertorio di chiaro stampo politico basandosi sulla passione per il rock e il folk, ed è curioso




vedere e forse non casuale, che «L’Unità», il primo album del gruppo del 1972, proponga una rilettura antiretorica del Risorgimento italiano. Negli anni seguenti gli Stormy Six sono stati al centro di un lavoro che offriva un repertorio narrativo alla stagione dell’impegno politico degli anni settanta con brani come Stalingrado, dedicato all’eroica resistenza sovietica all’invasore nazista nel 1942: Fame e macerie sotto i mortai / come l’acciaio resiste la città / strade di Stalingrado, di sangue siete lastricate / ride una donna di granito su mille barricate / sulla sua strada gelata la croce uncinata lo sa / d’ora in poi troverà Stalingrado in ogni città / e poi con l’album Macchina maccheronica (1980) premiato come miglior progetto musicale per l’organizzazione Rock in Opposition una sorta di Cantacronache europea. Il Canzoniere del Lazio è stata invece la formazione che ha riletto il repertorio popolare, soprattutto dell’area laziale, in chiave politica e di battaglia oltre che per recuperarne la memoria. Fra i titoli più rappresentativi Vivo tra le pecore e li cani, il canto garibaldino O Roma Roma e Su, comunisti della capitale, così introdotto: Su, comunisti della capitale / è giunto alfine il dì della riscossa / quando alzeremo sopra al Quirinale/ bandiera rossa. Profondamente politico, però orientato verso una prospettiva sperimentale, è invece il lavoro degli Area che esordiscono nel 1973 con Arbeit macht frei, un progetto dove confluiscono suoni etnici, denuncia e il canto incontenibile di Demetrio Stratos al servizio della causa palestinese in Luglio, agosto, settembre (nero): Giocare col mondo facendolo a pezzi / bambini che il sole ha ridotto già a vecchi / non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all’omertà / forse così sapremo quello che vuol dire affogare nel sangue tutta l’umanità / gente scolorata quasi tutta eguale / la mia rabbia legge sopra i quotidiani / leggi nella storia tutto il mio dolore / vedi la mia gente che non vuol morire / quando guardi il mondo senza aver problemi / cerca nelle cose l’essenzialità / non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all’umanità (Cramps records, 1973)
La morte di Stratos nel 1979 e la crisi della stagione dell’impegno politico cancellano le tracce di un modello canoro e musicale




dal messaggio politico esplicito che riprende in forme totalmente diverse – qualcuno azzarda post-moderne e surreali – o attraverso la poesia. Come nel caso del «punk filosovietico» degli emiliani CCCP, che non trova più riferimento nel folk italiano né statunitense ma nel suono dark di Berlino, dove infatti esordisce il gruppo nel 1982. Un punto di rottura col passato, che però trasforma i CCCP in un riferimento ideale e stilistico per molti gruppi, che arriveranno negli anni Novanta e Duemila, soprattutto nel modo di rappresentare la vita di provincia, l’ideologia e l’appiattimento provocato dal consumismo, in titoli come Militanz. A Ja Ljublju SSSR (rilettura dell’inno sovietico), Manifesto e Spara Jurij con il celebre adagio: Spara Jurij spara Jurij spara! / spera Jurij spera / spera Jurij spera / spera Jurij spera Jurij spera! / felicitazioni / felicitazioni / felicitazioni / spara, spara, spara, spara! / spara, spara, spara, spara! SPARA!, che si propone come ironica rilettura del bellicismo sovietico veramente impressionante oggi alla luce dell’aggressione dell’Ucraina.
1° giugno 1980, Bologna Piazza Maggiore, il concerto dei Clash… non si trattava del solito rito, della messa, del sabba, dell’ascolto assorto e silenzioso che precede l’approvazione e il Grande Applauso… no … con Joe Strummer veniva proclamato lo Stato d’Agitazione permanente! Con lui era tornato il fantasma di Woody Guthrie, che si sporgeva dal vagone del carro merci e ti diceva: «forza, corri figliolo, corri aggrappati alla mia mano, salta su» … Strummer chiamava alla Rivoluzione quella vera, quella che inizia dentro di te e poi divampa… Così il 1° giugno del 1980 io e mio fratello Sandro ci arruolammo volontari dell’esercito del punk rock dei Clash agli ordini di Joe lo Strimpellatore (In Quel giorno Dio era malato. Sulle strade dei Gang, storie e canzoni di Marino Severini con Alberto Sebastiani, Milieu edizioni, 2024).
In effetti così è cominciata l’avventura dei Gang, gruppo di Filottrano nelle Marche, nel rock politico, album dopo album – Barricada Rumble Beat, Le radici e le ali, Storie d’Italia, Fuori dal controllo, Sangue e cenere – concerto dopo concerto, fino a quando il pubblico ha cercato altri messaggi musicali nel racconto poetico come accaduto nelle canzoni di Tra silenzi e spari, l’album più recente. Curioso che dalle stesse zone d’origine dei




CCCP, Reggio Emilia non è Modena, ma non ne è lontana, sia emerso nei primi anni Novanta il combat folk dei Modena City Ramblers che si sostanzia in una rilettura del folk rock che mette insieme la ballata popolare italiana – vedi le riletture di Bella ciao e Contessa – a quella irlandese, scozzese e al liscio, persino. Questo progetto ha avuto il merito di offrire nuova popolarità alla canzone politica più tradizionale tornata in grande auge fra il pubblico giovanile proprio mentre stava esplodendo in Italia un nuovo impegno in musica grazie al lavoro nei centri sociali di sinistra e anarchici. Praticamente ogni città vede emergere uno spazio di mobilitazione radicale che trova riferimento proprio nei centri sociali occupati e in una musica derivata dall’antagonismo caraibico del reggae e dell’hip hop. Le posse, i gruppi nel gergo rap, lanciano nel 1990 la nuova musica, prima di tutto con il lavoro dei romani Onda Rossa Posse, poi Assalti Frontali, che rileggono l’impegno in musica raccontando con il rap la rabbia delle periferie e il sostegno al pacifismo ad esempio contro la guerra in Iraq con il brano Bagdad 1.9.9.1. : Orribile notte / la bandiera a stelle e strisce è in volo / ha i colori della morte / nella notte senza luna il suo rumore / senza più nessuna esitazione / per colpire e non vedere / nient’altro che se stessa / scoperta nel deserto / la bandiera della guerra su Baghdad 1.9.9.1.
Sullo stesso percorso si sono mossi anche i napoletani 99 Posse, mischiando reggae e rap con la protesta politica che nel 1994 porta all’album Canta Napoli antifascista a cui partecipano molti gruppi attivi nella scena dell’impegno radicale: Bisca (G7), Daniele Sepe (MCMXVIV perché i vivi non ricordano), i citati 99 Posse (S’adda appiccià), E Zezi (G 7 Zimbre e capretti), Maurizio Capone (Parole amare). Negli stessi anni nell’area salentina i Sud Sound System usano un mix fra reggae e pizzica per denunciare le conseguenze dello sfruttamento economico del Meridione. É invece torinese Francesco Di Gesù alias Frankie hi nrg, uno dei maggiori talenti della nuova scena musicale hip hop. Grazie alla capacità di usare in modo estremamente creativo e politico la lingua italiana su un tappeto di ritmi rap lancia canzoni come




Combatto la tua idea, Disconnetti il potere, Potere alla parola e la famosa Fight da faida: É la vigilia di una rivoluzione alla voce del Padrino, ma don Vito Corleone oggi è molto più vicino: sta seduto in Parlamento. É il momento di sferrare un’offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva, oggi uniti più di prima, alle cosche, fosche attitudini losche mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche, basta una busta nella tasca giusta in quest’Italia così laida… you gotta FIGHT DA FAIDA!!!
Ma la canzone, d’autore, sia tradizionale che quella emersa dall’hip hop, si è imposta per la qualità delle sue melodie e il modo originale con cui ha raccontato, e denunciato questioni e problemi sociali mai trattati dalla musica leggera utilizzando però forme diverse dalla canzone politica classica. Per questo, se non si possono considerare cantautori politici in senso classico Bindi, Paoli, Donaggio, sicuramente Sergio Endrigo, Luigi Tenco, De André, Gaber, Jannacci, Edoardo Bennato sono stati fin dagli esordi autori attenti a tematiche sociali e persino chiaramente politiche. Vedi ad esempio album come Tutti morimmo a stento e Storia di un impiegato, di De André con brani come Canzone del maggio: E se credete ora che tutto sia come prima / perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina / convinti di allontanare la paura di cambiare / verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte / per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti / per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti.
O ancora le canzoni del Teatro Canzone di Gaber, quelle sociali di Jannacci e Bennato con l’ironia utilizzata per attaccare l’opportunismo dei politici italiani di Salviamo il salvabile: È giusto che ognuno si prenda una fetta / chiudiamo tutte le scuole di lotta / io me la vedo brutta ma / Salviamo il salvabile, mmh Salviamo il salvabile, yeah, di Bennato, ed Ricordi, 1974)
Trasformato così il modo di realizzare una canzone impegnata, anche musicisti considerati lontani da un approccio esplicitamente politico, come Vasco Rossi, Ligabue, Jovanotti, Litfiba, Daniele Silvestri, Battiato, spesso con le loro parole sono stati capaci di descrivere sentimenti e passioni delle generazioni che




crescevano negli anni Novanta. Vedi per tutti la straziante denuncia di Franco Battiato in Povera Patria del 1991: Povera patria / schiacciata dagli abusi del potere / di gente infame, che non sa cos’è il pudore / si credono potenti e gli va bene / quello che fanno e tutto gli appartiene / tra i governanti / quanti perfetti e inutili buffoni / questo paese devastato dal dolore / ma non vi danno un po’ di dispiacere / quei corpi in terra senza più calore? (dall’album Come un cammello in una grondaia, EMI, 1991).
Su questi sentimenti si è aperta la strada a gruppi come Afterhours e Marlene Kuntz, Baustelle particolarmente attenti a proporre un messaggio sensibile ai drammi esistenziali e politici dell’Italia del nuovo millennio, come mostra il testo di … la tempesta è in arrivo degli Afterhours: La tempesta è in arrivo / riesci a sentirlo?/ quel che credevi raccolto / arriva un vento a strapparlo / non puoi più decidere come sarai / quale pazzo aspetta tanta oscurità / per riconoscere se stesso?/ la tempesta è in arrivo nessun compromesso (dall’album Padania, Germi 2012).
Sulla stessa strada su cui si è mosso Jovanotti, ma con una lettura più ironica e dissacrante, anche Caparezza con molti brani fra cui Fuori dal tunnel, Legalize the premier, Prisoner 709, Confusianesimo e La fitta sassaiola dell’ingiuria, Fonda la tua gloria sull’ingiuria / lavati i denti col seltz come Furia Smile, siamo in aria, canta vittoria / ma io ti sputerò come un seme d’anguria / c’è penuria di muri adibiti alla memoria, pura vanagloria (di Branduardi e Salvemini, dall’album ?! del 2000).
Capa è stato uno dei performer «più politici» fra novecento e duemila, seguito da una nuova ondata di rapper meno politicizzati ma trasgressivi nello stile e sensibili alle tematiche sociali, vedi i casi di Piotta, Ghali, Rancore, che si affiancano alle testimonianze di cantautori particolarmente sensibili come Brunori sas, Vasco Brondi e di gruppi quali Offlaga disco pax (Socialismo tascabile, Robespierre) e Lo Stato Sociale (Turisti della democrazia, L’Italia peggiore, La rivoluzione non passerà in tv, Combat Pop) a conferma del fatto che da tempo è radicalmente cambiata la forma della canzone politica passando da un’epoca in cui la sua denuncia o la spinta verso la lotta erano veementi e diret-




te probabilmente perché facevano riferimento a un movimento che marciava parallelamente a loro. Da tempo non è più così, il movimento non c’è più o s’è frammentato, anche se negli artisti non si è persa la passione per l’impegno e i valori del progresso e del cambiamento. Basta dare ascolto ai brani di grandi protagonisti della canzone d’autore del recente passato come Francesco De Gregori, Luca Carboni, Dario Brunori per ritrovare quella passione, solo che magari utilizzano la metafora, l’allegoria, l’ironia o i ritornelli parossistici del rap, e meno lo slogan, per denunciare e incitare al cambiamento. Ecco perché in conclusione, lo spirito ironico che anima Che benessere?!, canzone de Lo Stato Sociale, è forse la migliore sintesi per rappresentare lo stile con cui oggi la canzone d’autore propone la sua denuncia politica e…. non si arrende:
Wikipedia ha detto che i gelati sono buoni non sono cattivi come quelli che ci rubano il lavoro ma l’azienda si deve salvare meglio delocalizzare rubiamo a casa loro dove rubare è legale
(nell’album Stupido sexy futuro, Garrincha dischi, 2023)


