Numero Completo 07






Editoriale
Un nuovo anno inizia, drammaticamente, all’insegna delle guerre e della morte, della distruzione e dell’odio.
Guerra, nel martoriato Medio Oriente, tra Israele e Hamas, con pesantissimo coinvolgimento delle popolazioni civili inermi e di diversi altri paesi, confinanti e non; guerra – che continua, trascinandosi ormai due anni – tra la Federazione russa e l’Ucraina; conflitti, colpi di Stato, guerre civili in varie parti del globo.
Sostenere che la guerra non è il mezzo più giusto e appropriato per la risoluzione della controversie internazionali (o nazionali), riprendendo la nota formula dell’articolo 11 della Costituzione della repubblica italiana, significa, al contempo, ripetere una cosa vera e facilmente constatabile, ma anche fare una affermazione purtroppo retorica. Utopistica, nel senso volgarmente comune del termine, in quanto evocatrice di una impossibilità politica. Giacché proprio la Costituzione italiana (1948), nel suddetto articolo, chiamava a svolgere un ruolo di pacifico arbitrato istituzionale le «organizzazioni internazionali», sottintendendo, in particolare, le neonate Nazioni Unite (1945), che avrebbero dovuto, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, garantire finalmente all’umanità un futuro di pace e benessere, limitando direttamente, sul piano del diritto internazionale e, più indirettamente, su quello del diritto nazionale, la sovranità e lo strapotere degli Stati nazionali.
Così invece, in gran parte non è stato. Né poteva essere. Quell’ordine internazionale, che le istituzioni sovranazionali si impegnavano formalmente ad assicurare, nasceva su una base politica troppo diseguale, che si riflette, palesemente, nella struttura e nel funzionamento poco demo-




cratico dell’ONU, organizzazione formata, peraltro, da molti Stati retti in modo autoritario o dittatoriale. E si sovrapponeva a una realtà economica e sociale a sua volta contrassegnata da forti disparità e diseguaglianze. Sicché quel fragile equilibrio, su cui era sorto il nuovo mondo delle potenze vincitrici del Secondo conflitto mondiale, non era destinato, per sua natura, a durare a lungo. Immediatamente, infatti, si spezzò, già nel 1950, con la guerra di Corea, che rivelò al mondo quanto sostanzialmente «calda» fosse, in realtà, quella guerra definita eufemisticamente, a partire da Lippmann, «fredda», che vedeva contrapporsi il mondo delle democrazie capitaliste e dei loro alleati, spesso illiberali e antidemocratici, e quello totalitario del comunismo realizzato: una guerra combattuta spesso per procura, ma non meno crudele e devastante delle precedenti.
A distanza di quasi ottant’anni dalla sua nascita, dopo decine di guerre e stragi a cui raramente le istituzioni sorte per prevenirle o almeno contenerle sono state in grado di porre un limite efficace, l’«ordine» internazionale mostra tutta la sua tragica impotenza, rivelando, sempre più, le insanabili contraddizioni su cui è stato pensato ed edificato. Sono sempre gli Stati nazionali e le loro variabili alleanze armate a dettare, a dispetto di trattati e convenzioni da essi stessi promulgati, i tempi dell’agenda politica internazionale; sono sempre le grandi organizzazioni economiche sovranazionali a condizionare il libero fluire dell’attività politica e sociale.
A fronte di tutto ciò, non possiamo certamente che auspicare, nell’immediato, il ripristino di condizioni minime di esistenza e di pace per le popolazioni civili vittime innocenti dei conflitti, il ritorno a una situazione non guerreggiata, la sconfitta di ogni militarismo, integralismo religioso, l’avvio di percorsi di pace che garantiscano al contempo la sicurezza dei popoli e l’autodeterminazione di tutti i soggetti collettivi coinvolti. Ma la politica di sanare, «a valle», alcuni problemi in modo da far cessare quanto prima le ostilità armate, deve essere affiancata dalla reale volontà di dar vita, «a monte», a progetti autenticamente riformatori, lungimiranti perché basati su un deciso cambio di passo e su modifiche strutturali di sistema, capaci di creare quelle condizioni di giustizia politica e sociale che sole rendono credibili e duraturi gli accordi di non belligeranza tra le istituzioni e i popoli. A partire dall’esistente, dalla «diplomazia dal basso», dalle realtà che cooperano a livello di economia e




società civile; dando vita a progetti culturali ed educativi fondati sulla laicità, sulla lotta ai fondamentalismi religiosi, sul rispetto dell’altro, sulla pace. Occorre uscire dalla pericolosa illusione che le istituzioni preposte al governo mondiale, espressione di assetti di potere intrinsecamente autoritari e ingiusti, possano essere la fonte da cui scaturisce, non si sa per quale magia, una realtà opposta, fondata sulla libertà, la giustizia, la fraterna collaborazione. È necessario limitare il potere degli Stati dal basso: favorire la cooperazione, il mutuo appoggio, nella società civile, lo sviluppo di strutture federali e confederali di potere capaci di creare un ordine superiore a quello degli Stati nazionali, per propria natura basato sulla divisione e sulla contrapposizione. Progetti in questo senso erano stati formulati, per esempio, in riferimento alla realtà israelo-palestinese: meriterebbero di essere ripresi, meditati e attualizzati.
La nostra piccola rivista si impegnerà, nei prossimi numeri, a farli conoscere, presentando, al contempo, esperienze di solidarietà e mutuo soccorso nelle zone di attrito e conflitto, nella speranza che possano servire da esempio e moltiplicarsi. Alimentiamo con forza e convinzione la speranza di costruire un mondo più libero e più giusto: non è solo un nobile desiderio ma, sempre più, una necessità storica e politica.
***
Il numero 7 di «Semi sotto la neve» affronta i temi della violenza e della resilienza, dell’oppressione e della libertà, con una particolare attenzione alle forme di mutuo appoggio e di solidarietà libertaria.
Nelle esperienze: Jacopo Anderlini descrive alcune coraggiose realtà che praticano forme auto-organizzate di assistenza ai migranti che tentano di raggiungere a piedi la Francia dall’Italia, attraverso pericolosi sentieri alpini; il Centro Veneto Progetti Donna si racconta, alla luce della sua pluridecennale attività di lotta alle violenze contro le donne, che comprende ascolto, sostegno, aiuto legale, ma anche opera di sensibilizzazione culturale su vari livelli di contrasto all’ideologia del patriarcato; sullo stesso tema, Anna Lisa Bertolo e Maurizio Giannangeli ricostruiscono la storia di Maschile Plurale, associazione di uomini che lavora alla creazione di un immaginario maschile liberato dal desiderio di dominio e sopraffazione.




Negli approfondimenti, due interventi riflettono sullo sviluppo tecnico delle società contemporanee e pongono questioni ineludibili circa il rapporto tra mezzi e fini: Pamela Boldrin svolge una riflessione critica sul tema dell’intelligenza artificiale, sulle potenzialità positive e soprattutto i rischi della creazione di una coscienza digitale che, come avevano prefigurato le distopie fantascientifiche, fornisce al dominio nuove formidabili capacità di controllo, rendendosi sempre più autonoma dalla mano del suo creatore; Anselm Jappe indaga gli elementi che spiegano l’enorme diffusione del calcestruzzo nel Secondo dopoguerra, evidenziando la stretta interconnessione esistente tra l’utilizzo del cemento come materia di costruzione e il produttivismo capitalista.
Nella conversazione, Gabriel Kuhn, poliedrico intellettuale e militante libertario, a colloquio con Matthew Wilson, si interroga sui limiti della progettualità anarchica, sulla necessità di riflettere sulle carenze organizzative dell’anarchismo e sull’urgenza di elaborare risposte concrete ai grandi problemi che attanagliano il genere umano, in linea con lo spirito rivoluzionario della tradizione libertaria.
Nell’internazionale, Martin Bartenberger sviscera gli elementi di democrazia radicale presenti nella filosofia pragmatista di John Dewey e individua alcune importanti affinità col pensiero libertario, in particolare con le tesi sulla democrazia diretta elaborate da David Graeber.
Nelle radici vengono presentati due personaggi centrali della cultura libertaria tra Otto e Novecento: Francesco Codello ricostruisce la biografia intellettuale di Marie Isidorovna Goldsmith, scienziata e attivista anarchica di grande caratura legata, in particolare, alla figura di Kropotkin, mentre A. Soto ripercorre la traiettoria filosofico-politica di Albert Camus, gigante della letteratura mondiale, filosofo libertario molto vicino al movimento anarchico.
Uno spazio importante viene dedicato da «Semi sotto la neve» alla musica con Maurizio Bettelli, che analizza l’opera di Woody Guthrie, il maestro della canzone statunitense di impegno sociale, e ai libri, con le recensioni di Chiara Gazzola e Francesco Berti.



Infine, viene inaugurata una nuova rubrica, il vocabolario politico di Bieffe, che analizza in questa occasione il tema della violenza e nonviolenza.
***
Con dolore comunichiamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori la scomparsa di Roberto De Grandis avvenuta a inizio dicembre. Roberto ha curato la scelta delle illustrazioni della rivista fino a oggi, trovando la collaborazione di diversi artisti, oltre a contribuire con undici ritratti alla rubrica radici. L’ultimo suo lavoro che pubblichiamo è un ritratto di Albert Camus che trovate in questo numero e più in generale le ultime sue opere sono quelle che potete trovare in copertina e all’interno di un libro del nostro comune amico e collaboratore Guido Candela sul rapporto tra il pensiero libertario e quello religioso in via di pubblicazione per Franco Angeli.
Generoso e disponibile, ha dato concretezza alla grande considerazione che aveva del nostro lavoro e delle nostre idee, unendo in maniera originale l’amore per l’arte con l’impegno umano e sociale. Grafico, incisore, illustratore, pittore, curatore di mostre, è stato un grande artista del quale, come ci scrive il suo collega e amico Pier Paolo Del Bianco, sentiremo parlare nel tempo. A Roberto il nostro pensiero, alla moglie Sandra e al figlio Davide il nostro abbraccio sincero.
***
Confidiamo sempre nel sostegno attivo, partecipato e critico dei nostri lettori: in questo numero presentiamo anche una nuova veste grafica in uno sforzo di rinnovamento della rivista che, un po’ alla volta, si fa conoscere da un pubblico sempre più ampio. Non potendo contare in una rete di distribuzione commerciale, siamo costantemente alla ricerca di nuovi diffusori, di maggiori contributi, di organizzare presentazioni e dibattiti: aspettiamo commenti e proposte!









Solidarietà al transito in Val Susa Migrazioni e rotte alpine
Jacopo Anderlini
Introduzione
In relazione alla cosiddetta «lunga estate delle migrazioni» del 20151 – cui ha corrisposto una generale crisi dell’accoglienza in Europa – in diverse regioni europee sono state attivate diverse forme di solidarietà e sostegno ai rifugiati e ai migranti in transito. Gli attori della società civile hanno sperimentato nuove pratiche e discorsi volti a contestare o contrastare le politiche migratorie europee e nazionali, nonché a compensare le carenze istituzionali in diversi percorsi di accoglienza.
Nel contesto attuale della migrazione non autorizzata intra-europea, l’area del confine alpino tra Italia e Francia corrispondente alla regione della Val Susa è emersa come uno dei punti focali degli attraversamenti, costituendo un vero e proprio crocevia della mobilità migrante e un punto di condensazione di diverse rotte – congiungendo la cosiddetta rotta balcanica e la rotta del Mediterraneo centrale.2 In egual misura, in



1 Nella prima metà del 2015 i paesi europei sono stati interessati da un numero consistente di arrivi di richiedenti asilo, più di un milione. Un afflusso che ha diverse concause: l’onda lunga delle primavere arabe, l’esacerbarsi del conflitto siriano e delle violenze perpetrate dall’ISIS, le politiche di non-accoglienza ed espulsione di Turchia ed Egitto. 2 Le «rotte» sono un costrutto che iper-semplifica forme di mobilità molto diverse tra loro. Chi percorre la «rotta del Mediterraneo centrale» può aver vissuto in Tunisia per diversi anni prima di tentare di spostarsi in Europa, o essersi fermato in Italia per diverso tempo. Le traiettorie di mobilità sono raramente lineari e corrispondenti agli idealtipi con cui di solito vengono descritte.

questo stesso passaggio spiccano in modo significativo diverse forme di solidarietà nei confronti dei migranti undocumented in transito, in grado di trasformare la natura stessa della mobilità. Le reti di solidarietà sono emerse come attori chiave nel dibattito contemporaneo sulle migrazioni non solo per il loro ruolo di sostegno alle persone in movimento ma anche per la loro capacità di contestare concretamente il regime di confine contemporaneo. Questi gruppi rappresentano una costellazione di attori sociali, pratiche, discorsi e relazioni cangianti, che insieme alludono e richiamano nuovi immaginari post-nazionali basati sulla libertà di movimento. Un processo di cui le reti solidali attive in Val di Susa costituiscono un esempio significativo.
Il confine alpino
Dal 2017, il percorso di attraversamento che converge sul Passo del Monginevro – tra la Val di Susa sul lato italiano e la regione di Briançon sul lato francese – è diventato un nodo cruciale della mobilità dei migranti all’interno dell’area Schengen. Questo percorso è emerso in particolare nel 2015 con l’incremento delle traiettorie di mobilità lungo la rotta balcanica e a seguito dell’intensificazione dei controlli nella sezione meridionale e costiera della stessa frontiera, tra le città di Ventimiglia e Mentone, rispetto alla quale i passaggi alpini rappresentano un punto di transito alternativo e relativamente poroso. Dopo un primo periodo in cui è stato privilegiato il transito lungo il Colle dell’Échelle, si è poi routinizzato e stabilizzato il transito lungo il Colle del Mongine-




10

vro, un passo situato a un’altitudine di circa 2.000 metri. In questa fase, per contrastare il passaggio di cittadini provenienti dal Sud globale, questo tratto di confine alpino ha acquisito una nuova materialità: attraverso controlli selettivi basati sulla profilazione razziale, ogni giorno le autorità francesi cercano di scoraggiare e bloccare i tentativi di attraversamento oltralpe dei migranti. Infatti, dal 2015 il go
verno francese ha ripristinato controlli sistematici lungo il confine con l’Italia - prima a Ventimiglia, Mentone e Val Roja poi, dal 2017, in Val di Susa e nel Briançonnais – con la sospensione continuata degli accordi di Schengen – forzando l’interpretazione degli Articoli 25 e 26 dello Schengen Border Code che regolano la reintroduzione temporanea ed eccezionale dei controlli alle frontiere interne dei paesi membri. In termini di composizione delle persone in transito, fino al 2019 sono stati prevalenti giovani uomini provenienti dall’Africa subsahariana, mentre dal 2020 la rotta alpina ha visto la presenza di persone provenienti dall’Afghanistan, Marocco e Iran. I transiti dalla rotta balcanica hanno rappresentato la maggioranza: si entra in Italia dal confine orientale e, dopo aver attraversato i nodi di Milano e Torino, si arriva a Oulx con l’obiettivo di sfruttare la vasta rete di sentieri alpini. Questa tendenza inizia a cambiare a partire dal dicembre 2022, quando si osserva un au-





mento dell’arrivo di migranti dalla rotta del Mediterraneo centrale, con persone provenienti dall’Africa subsahariana.
La rete di sentieri che collegano l’Italia alla Francia è ciò che rende questo confine pericoloso ma allo stesso tempo percorribile. Da un lato, la presenza dei sentieri alpini consente il transito autonomo, permettendo ai migranti di attraversare il confine con le proprie gambe senza dover fare affidamento sui passeur o su mezzi di trasporto. Dall’altro lato, le forme di controllo attuate dalle polizie di frontiera utilizzano quelle stesse caratteristiche ambientali come fattore di dissuasione per rallentare, deviare o bloccare le persone in movimento.
Le reti di solidarietà emergono proprio per rispondere a queste politiche migratorie che espongono alla morte – ciò che il filosofo Achille Mbembe ha chiamato «necropolitica». Queste reti si strutturano principalmente come luoghi di accoglienza per le persone in transito, rendendo meno pericolosa e mortale la zona di frontiera alpina. Un posizionamento che le ha spesso viste accusate di essere «fattori di attrazione» dei flussi di migranti e ha portato alla loro criminalizzazione. Il carattere distintivo della rotta alpina è proprio la presenza di strutture che funzionano come «rifugio». Pur essendo composti da un insieme eterogeneo di posizioni, dove attivisti, volontari e operatori sociali agiscono con motivazioni eterogenee e background diversi, i rifugi tendono a funzionare di concerto tra loro.
Ci sono tre snodi principali di queste realtà solidali - due sul versante italiano e uno su quello francese - con numerosi altri attori che a geometrie variabili danno vita a forme di ospitalità e di incontro lungo la rotta.





Il primo è a Oulx, dove una mobilitazione spontanea di cittadini della valle ha dato vita al «Rifugio Fraternità Massi». Negli anni, le attività si sono sempre più strutturate, portando a una professionalizzazione della solidarietà. All’interno del rifugio operano un’équipe di assistenti sociali stipendiati, un gruppo di medici e mediatori, e una vasta rete di volontari provenienti dall’associazionismo religioso e laico e dal Movimento No Tav. Chi arriva alla stazione ferroviaria di Oulx, ha la possibilità di fermarsi al rifugio per dormire, ricevere cure mediche e supporto legale, vestirsi e mangiare. Da lì può prendere l’autobus per Claviere, per poi tentare i sentieri che portano alla Francia.
L’Alta Valle di Susa è stata poi testimone del dispiegarsi di diverse esperienze di occupazione nate attorno a reti di solidarietà di base legate a iniziative anarchiche. Nel 2017, il collettivo Briser les Frontières ha dato vita all’esperienza «Chez Jesus», occupando i sotterranei della chiesa di Claviere per dare rifugio alle persone respinte e lasciate per strada dalle autorità francesi. Tra dicembre 2018 e marzo 2021, la Casa Cantoniera Occupata di Oulx è stata un punto di riferimento per le persone in transito in cerca di ospitalità. Dopo altri tentativi di occupazione, nell’estate del 2022 è nata la casa di Cesana «Yallah!», un’occupazione a metà strada tra la stazione di Oulx e il confine di Claviere. La casa di Cesana, fino alla sua chiusura nel giugno 2023 a causa di un incendio, è stata uno spazio e un hub alternativo al rifugio di Oulx, nel quale una tappa del viaggio poteva trasformarsi in un lungo soggiorno.
La modalità di gestione dello spazio è stato un esperimento di orizzontalità e auto-organizzazione tra due categorie di soggetti: le persone in transito che vi soggiornano per necessità e i militanti europei che vivono nella casa per scelta. La presenza di un luogo dove la permanenza non viene imposta a priori come temporanea ha permesso a chi è in movimento di potersi fermare, rifiatare, eventualmente ridefinire i suoi prossimi passi. Un luogo di risacca che ci mostra come la libertà di movimento è anche libertà di potersi fermare.
L’esperienza di Cesana, pur con tutte le sue problematicità, ci parla di un luogo che è stato percepito come «casa» da molti migranti in transito, aprendo a forme di soggettivazione politica o ridefinizione del proprio progetto di vita.
Sul versante francese di Briançon, prima cittadina di media grandezza che costituisce il punto di approdo di chi attraversa il confine, le diverse anime della solidarietà convergono in un unico spazio attivo dall’agosto 2021: les Terrasses Solidaires. Un luogo popolato da diverse associazioni dal background e dalle prospettive differenti tra il registro umani-




tario e quello politico. Nonostante il progetto abbia una sua struttura formale, all’interno c’è spazio per pratiche di auto-organizzazione da parte delle persone in transito che vi si fermano per qualche giorno. Les Terrasses ospitano anche il collettivo dei marauder, una rete di attivisti europei che si occupa di pattugliare i sentieri di montagna nelle notti invernali: una sorta di search and rescue di montagna per i migranti che dovessero trovarsi in difficoltà nell’attraversamento.
Le attività di queste realtà, da un lato all’altro della frontiera, contribuiscono materialmen-
te – dando ospitalità, fornendo abbigliamento invernale, pattugliando i sentieri – a rendere questa zona di confine meno mortifera, nonostante le pratiche confinarie delle polizie che, con le loro cacce all’uomo nei boschi, mettono apertamente in pericolo le persone in transito. A dispetto della loro azione, o forse proprio per contrastarla, le reti solidali sono state ripetutamente soggette a forme di criminalizzazione, con processi intentati a danni di attivisti che hanno portato a forme di mobilitazione popolare nelle valli, con manifestazioni come la Grande Maraude Solidaire, che si tiene ogni anno al confine del Monginevro.
Conclusioni
Le realtà che attuano forme di solidarietà ai migranti in transito sono emerse sempre più in questi anni come attori chiave nel modo in cui i movimenti migratori contemporanei si dispiegano nei territori europei. Queste realtà, con il loro sostegno cruciale alle persone in movimento – fornendo supporto materiale, protezione e voce – e con la costruzione reti allargate di mutuo aiuto che connettono soggetti diversi dall’associazionismo ai gruppi politici organizzati –, mettono in discussione e contestano materialmente il regime di confine europeo contemporaneo e le sue politiche migratorie restrittive. Attraverso la loro relazione reciproca questi gruppi di solidarietà non solo forniscono assistenza pratica, ma contestano attivamente le politiche confinarie messe in campo dagli stati europei. Creando reti di supporto che superano i confini nazionali contribuiscono a prefigurare nuovi immaginari post-nazionali che intrecciano solidarietà e libertà di movimento, che significa avere la possibilità di muoversi ma anche di restare dove si è.


EspErieNze
«Siamo state tutte» 33 anni del Centro Veneto Progetti Donna
Centro Veneto Progetti Donna
«Il Centro Veneto Progetti Donna - Auser è un’associazione di donne ed esercita in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con l’obiettivo di rimuovere ogni forma di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica alle donne e ai minori, italiani e stranieri, all’interno e fuori la famiglia, approfondendo la ricerca, la riflessione, il dibattito, promuovendo e svolgendo la formazione, implementando e gestendo azioni/progetti e servizi, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser». Queste sono le parole con cui si apre lo Statuto del Centro Veneto Progetti Donna (CVPD), e che racchiudono i nostri principi e la nostra mission. Così spiega Anna Arvati, una delle prime operatrici, il motivo della presenza del termine «progetti», all’interno del nome del CVPD: «Per fornire una risposta a un fenomeno è necessario prima di tutto studiarlo. Secondo me era importante che il Centro avesse una vocazione alla ricerca, permettendoci poi di elaborare progetti adeguati. Il Centro nella sua definizione di Statuto prevede la formazione e l’informazione attraverso resoconti periodici. Quando l’Associazione si è costituita avevamo espresso la volontà che fosse capace di spaziare su due livelli: operativo e culturale». Le due anime che tuttora convivono.
Il CVPD «un’associazione di donne», questo sta a significare che è un luogo fatto da donne e per le donne, dove la «sorellanza» è una pratica quotidiana di riconoscimento nell’altra. Il Centro nasce a Padova l'8 mar-




un incubo quotidiano, non conosciuto che parla di maltrattamenti e percosse dentro le mura domestiche
zo del 1990 da un gruppo di donne sindacaliste che volevano arginare il problema delle molestie sul luogo di lavoro ma fin da subito le chiamate che ricevono raccontano per la maggioranza, di un incubo quotidiano, non conosciuto che parla di maltrattamenti e percosse dentro le mura domestiche.
Da quel momento fino ad oggi il Centro ha lavorato per accogliere le richieste di migliaia di donne che volevano uscire dalla violenza nelle relazioni intime.
Il Centro Donna oggi
Il Centro Veneto Progetti Donna oggi è composto da 5 Centri antiviolenza (Padova, Rubano, Piove di Sacco, Este e Cittadella) e 8 sportelli (Padova, Abano Terme, Conselve, Camposampiero, Cadoneghe, Vigodarzere, Solesino, Borgo Veneto), 5 case rifugio, un numero verde 800. 81.46.81 gratuito aperto dalle 8 alle 20.00 dal lunedì al venerdì, oltre 40 operatrici specializzate, psicologhe, esperte in diritti umani, avvocate e volontarie, e accoglie più di 1000 donne l’anno con i loro figli/e minori; organizza centinaia di eventi di sensibilizzazione, incontra durante l’anno più di 1000 studenti/esse nei percorsi di formazione e prevenzione nelle scuole.
Il CVPD è il Centro di riferimento in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne non solo per la città di Padova, ma anche per tutta la Provincia. È riconosciuto dalla Regione Veneto e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il quale è referente territoriale del Numero Verde 1522.
Il Centro è un luogo in cui le donne possono trovare ascolto, attenzione, rispetto, sostegno. Si comprendono, infatti, attività di: ascolto, sostegno psicologico, sostegno legale, orientamento all’inserimento lavorativo e sociale, empowerment e sviluppo competenze, gruppi terapeutici, rete con i servizi socio-sanitari e le altre istituzioni coinvolte.
Dalla sua nascita ad oggi, il Centro Antiviolenza ha sostenuto oltre 11.500 donne. Sono state 1.127 nel 2022. Sono tantissime, ma rappresentano una piccola percentuale di tutte coloro che vivono situazioni di violenza. Infatti solo poche hanno il coraggio di uscire dal silenzio e dalla paura.




Per condividere qualche dato in più, rispetto al 2022, delle 1127 che hanno richiesto e trovato aiuto presso il Centro Veneto Progetti Donna – Auser, 494 di loro hanno figli/e minori, per un totale di 786 bambini e bambine. 15 donne con 14 figli/e minori sono state accolte nelle case rifugio, mentre 22 donne con 13 figli/e minori sono state accolte in emergenza. Le donne di cui si è rilevata la nazionalità sono 1.079. Di queste, il 73%, sono di nazionalità italiana e il restante 27% invece sono di nazionalità straniera. Il fenomeno della violenza contro le donne è trasversale a tutti i segmenti di popolazione: interessa infatti, tutte le fasce d’età, persone provenienti da tutti i contesti sociali, sia disoccupate sia occupate in diversi settori e con diversi gradi di istruzione, così come ampiamente dimostrato dai dati raccolti durante gli anni dal CVPD. Per quanto riguarda invece il 2023, sono 920 le donne che si sono rivolte al Centro Veneto Progetti Donna fino a ottobre di quest’anno, il 73% sono italiane. 34 donne con 35 minori sono state accolte in emergenza e 17 donne con 14 minori sono accolte nelle case rifugio di Padova e provincia. Dobbiamo, inoltre, sottolineare l’importante aumento di nuove richieste nelle ultime settimane di novembre, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, dove in soli 10 giorni sono state 86, triplicando di fatto il dato medio giornaliero pre evento.
La rete intorno al CVPD
Nel 2012 il Centro Veneto Progetti Donna entra a far parte attivamente dell’associazione nazionale D.i.Re «Donne in rete contro la violenza» , la quale si definisce «la prima associazione italiana a carattere nazionale di Centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne che affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere, collocando le radici di tale violenza nella storica, ma anche attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali».




Oggi l’associazione nazionale D.i.Re raccoglie più di 80 organizzazioni che gestiscono 106 Centri antiviolenza e più di 60 case rifugio, accogliendo ogni anno circa 21 mila donne.
L’Associazione nazionale basa il suo operato sull’esperienza delle realtà locali e ha lo scopo di costruire un’azione politica nazionale che sappia promuovere il cambiamento culturale fondamentale per il contrasto e il superamento della violenza maschile sulle donne.
Le azioni di D.i.Re sono orientate a rendere visibile il fenomeno della violenza maschile sulle donne, modificando nella società la percezione della sua entità e gravità per riconoscerlo come una grave violazione dei diritti umani, attraverso:
- · azioni per la visibilità della metodologia e dell’attività dei Centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale,
- · iniziative per diffondere conoscenza del fenomeno della violenza,
- · progetti di ricerca, in un’ottica di riflessione sulle esperienze e di formazione continua e diffusa per i Centri e per il territorio.
L’associazione nazionale D.i.Re è interlocutrice delle istituzioni nazionali e internazionali, anche per l’elaborazione o la modifica della normativa relativa ai diritti delle donne, forte del proprio patrimonio di conoscenze, di elaborazioni ed esperienze acquisite in tanti anni dai Centri antiviolenza.
Le organizzazioni aderenti a questa rete condividono la stessa metodologia e principi, ovviamente con le differenze date dal territorio nel quale agiscono.
Il Centro Veneto Progetti Donna, inoltre, fa parte dal 2014 di IRIS, il Coordinamento dei Centri antiviolenza del Veneto, insieme a: Belluno Donna di Belluno, la Cooperativa Iside di Mestre, Donna chiama Donna di Vicenza, Spazio Donna Di Bassano e Telefono Rosa di Treviso e Verona. Questo coordinamento ha una duplice finalità: da un lato consolidare le prassi operative nel contrasto alla violenza di genere, dall’altro rafforzare la capillarità e la diffusione dei servizi offerti alle donne sul territorio.
Come per il caso di D.i.Re, anche in questo coordinamento i centri antiviolenza aderenti hanno in comune la metodologia della relazione tra donne. Il Centro ha promosso e collabora attivamente all’insegnamento «Violenza contro le donne e diritti umani» istituto nel Corso di laurea triennale Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani dell’Università di Padova e al laboratorio «Comunicare la violenza contro le donne alla cittadinanza e alla scuola che si tiene all’interno del medesimo Corso di studi. Il Centro, inoltre, collabora da anni con il Centro Interateneo per i Diritti Umani A. Papisca dell’Università di Padova.


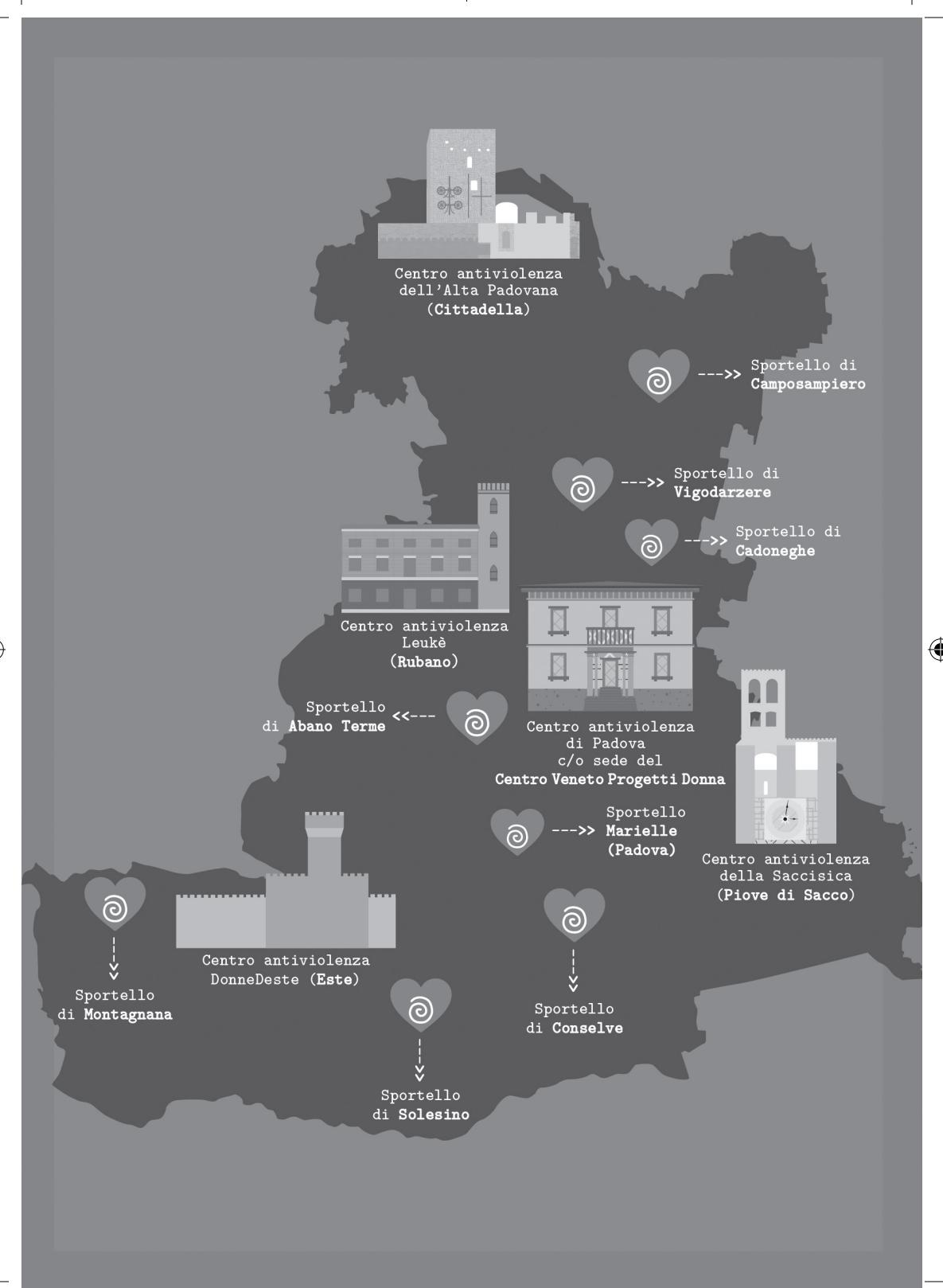



La mission, la metodologia
Ogni giorno al CVPD con il nostro lavoro cerchiamo di rendere questo spazio un luogo sicuro, vivo, fatto di relazioni forti, dove ogni donna, operatrice e non, può reggersi sull’altra e sentirsi meno sola.
Il Centro antiviolenza è anche uno spazio politico, un presidio sul territorio che tutti giorni combatte il patriarcato e le disuguaglianze di genere.
Per noi, infatti, sono importanti alcuni concetti chiave:
- · accoglienza, ascolto empatico e non giudicante
- · garanzia della privacy e dell’anonimato
- · rispetto dei tempi della donna
- · condanna di tutte le forma di violenza
- · percorsi personalizzati
- · sostegno alla donna in ogni sua scelta
- · costruzione di una rete che supporta la donna
- · gratuità dei servizi offerti
- · promozione dell’empowerment, dell’autonomia e dell’autodeterminazione delle donne.
Il Centro Veneto Progetti Donna vuol essere il punto di riferimento nella provincia di Padova per il contrasto al fenomeno della violenza sulle donne, attraverso un approccio complesso che si contraddistingue per competenza e professionalità e promuove l’educazione alla libertà femminile. L’attività del Centro Veneto Progetti Donna si svolge principalmente in due macro-aree: la prima il contrasto alla violenza intra ed extra familiare attraverso azioni di accoglienza e ospitalità della donna, la seconda è la promozione alla riflessione e il dibattito per il cambiamento culturale, la sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno.
Il Centro, dall’accoglienza alla presa in carico e gestione dei casi, basa la sua attività sul presupposto che la donna è un soggetto attivo in grado di essere artefice del proprio cambiamento personale e relazionale. L’accoglienza si articola in queste attività: consulenza psicologica, consulenza legale, invio e accompagnamento ai servizi territoriali, accoglienza in emergenza e nelle case rifugio, linea telefonica gratuita al numero verde 800.81.46.81.
Attraverso l’accoglienza in struttura possiamo offrire protezione alle donne e ai loro figli e figlie minori che subiscono violenza. Nelle case le donne trovano operatrici esperte che offrono loro sostegno emotivo e pratico nel delicato momento di passaggio e cambiamento. Al fine di assicurare il più possibile una continuazione di vita regolare, alle don-



ne madri di figli minori sono garantiti: un supporto per l’iscrizione e la frequentazione della scuola dell’obbligo, il servizio di babysitteraggio quando le donne ospiti delle Case ne hanno necessità e il supporto nel sostentamento e nella fornitura di beni di prima necessità.
L’attività rivolta all’esterno del Centro è caratterizzata da: eventi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, creazione di campagne di sensibilizzazione, formazioni nelle scuole, formazione degli attori coinvolti nella rete dei servizi di contrasto alla violenza sulle donne, scrittura di progetti per bandi di finanziamento, raccolta dei dati per uno studio del fenomeno sul territorio, stipula di convenzioni e protocolli operativi con le Istituzioni.
Tutto quello che abbiamo da dire
Mentre scriviamo queste righe viviamo un periodo storico di apparente cambiamento rispetto all’approccio della società al fenomeno della violenza maschile sulle donne. Dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin è successo quello che noi attiviste dei Centri antiviolenza speravamo da anni, cioè che il tema entrasse nel dibattito politico non più solo come fatto di cronaca ma anche facendone emergere tutta la complessità, andando a svelare quali sono in effetti le gravi carenze dell’apparato pubblico nell’affrontare il fenomeno. Di fatto le potenti parole dei familiari di Giulia, la sorella Elena in primis, e il padre Gino poi, hanno permesso
di sdoganare alcune parole che per noi attiviste stanno alla base della lettura corretta del fenomeno. La prima è patriarcato, ossia la struttura sociale e culturale che da millenni pone le donne in una condizione di discriminazione e subordinazione rispetto agli uomini, tanto nella sfera privata quanto in quella pubblica. Il patriarcato è la cultura di cui si nutre il fenomeno della violenza maschile e destrutturare il patriarcato in tutte le sue accezioni è l’unica soluzione per fare in modo che si crei una società rispettosa delle differenze, anche di genere. Il secondo concetto, espresso da Elena Cecchettin parlando del femminicida della sorella, riguarda la normalizzazione dell’uomo violento. Lei dice che l’uomo violento non è un malato,




ma figlio sano del patriarcato. Con questa frase, che è uno slogan sessantottino, Elena è riuscita a ricondurre la narrazione del fenomeno dentro il giusto quadro, andando così a colpire dritto al cuore del problema e a ricondurre alla trasversalità del fenomeno che di fatto coinvolge tutti e tutte e che non può o deve essere ascritto a forme di patologizzazione. Queste parole hanno sicuramente dato uno scossone rispetto a una narrazione che fino a quel momento era a appannaggio dei media che di violenza hanno sempre parlato in modo scorretto. Parole che hanno suscitato molte critiche, anche violente, a conferma di quanto il patriarcato sia ancora tra noi, e che hanno costretto molte persone a porsi delle domande e a pensare a come smontare queste dichiarazioni, raramente riuscendoci in modo convincente o costruttivo. Siamo sicuramente in un tempo nuovo, dove è importante non perdere l’occasione di dire tutto quello che abbiamo da dire, e usare la parola come strumento per convincere e decostruire una narrazione che non ci rappresenta, ben consapevoli però che il backlash del patriarcato potrebbe arrivare molto forte. Per questo abbiamo bisogno che chi si riconosce nelle parole di questa narrazione alternativa faccia da cassa di risonanza di un messaggio che ha rotto il muro del silenzio e adesso non deve far altro che propagarsi. Siamo consapevoli che nessuna persona è esente, che la violenza patriarcale è una realtà, alle volte occultata e sommersa, che permea gli ambiti di tutte le nostre vite: dai posti di lavoro, di studio, di aggregazione, alle nostre relazioni intime.
In Italia in media una volta ogni tre giorni questa violenza sfocia in gesti estremi come il femminicidio, ma questi non sono casi isolati, sono segnali di un sistema marcio dalle radici: siamo tutti/e coinvolti/e direttamente e indirettamente su vari livelli e c’è una responsabilità collettiva nel rimanere vigili, ma anche nell’essere proattivi/e verso il cambiamento. Facciamolo insieme.



ESPERIENZE
Maschile Plurale: l’immaginario maschile liberato dalla violenza
Anna Lisa Bertolo e Maurizio Giannangeli
Questo articolo nasce a seguito di una lunga conversazione tra chi scrive e Stefano Ciccone, Marco Deriu e Alessio Miceli, tre componenti dell’APS Maschile Plurale, che ringraziamo per la disponibilità e la ricchezza di racconti e riflessioni che hanno condiviso.
Aggiungiamo un’osservazione che ci è stato chiesto di esplicitare. Maschile Plurale non ha un portavoce e al proprio interno convincimenti e modi di intendere senso e attività dell’associazione sono sempre espressi dai singoli componenti in prima persona. Ne discende che quanto qui esposto - storia, visione politica e prospettive future di Maschile Plurale - è espressione della particolare visione dei tre componenti con i quali abbiamo avuto il piacere di conversare e non immagine univoca e omogenea di una esperienza che si nutre di ben più ampia “singolarità plurale” di punti di vista e rappresentazioni.
«La violenza contro le donne ci riguarda»
Intorno all'8 marzo 1985 i movimenti femministi si battevano per ottenere che la violenza sessuale venisse considerata come reato contro la persona e non unicamente come reato contro la morale. Il «coordinamento delle studentesse romane» lanciò, in quei giorni, «una sfida ai compagni maschi di avviare una riflessione separata, cioè di soli uomini,





sulla cultura dello stupro». Il volantino redatto per promuovere le iniziative per l'8 marzo recava il titolo «Le donne in piazza contro la cultura dello stupro. I maschi…»1 .
I «maschi» provarono a riempire quei punti di sospensione di un possibile dire sulle proprie responsabilità culturali e politiche in quanto portatori, anche se solo potenziali, di una «cultura maschilista dello stupro e dell’oppressione», prendendo da subito le distanze da un’autorappresentazione di «maschi aperti e illuminati», oppure anche solo solidali con le rivendicazioni femministe. Da questi primi passi prenderanno le mosse i primi gruppi maschili che nel tempo costituiranno, su tutto il territorio nazionale, una rete di «uomini» che si farà carico di mettere in discussione la «cultura dell’oppressione maschile».
Nel 2006 alcuni componenti di questa rete produrranno un appello pubblico dal titolo: «La violenza contro le donne ci riguarda: prendiamo la parola come uomini»2 . L’occasione dell’appello fu determinata dall’efferatezza di numerosi casi di violenza maschile sulle donne avvenuti quell’anno che fecero emergere un’interrogazione sulle radici di una violenza così feroce e decidere di scrivere un «appello di uomini rivolto a uomini», disposti a riflettere e farsi carico della violenza maschile sulle donne.
L’esperienza dell’appello rappresentò un passaggio di maturità importante, perché generò la possibilità di un impegno politico pubblico, collettivo e plurale, di «maschi» che prendono in carico la propria responsabilità della violenza di genere, che si aggiungeva ai percorsi individuali già attivi nei gruppi. Al contempo indicò, entro il dibattito pubblico, la possibilità di un immaginario sulla maschilità lontano da quello corrente e a questo contrapposto, proponendo una rappresentazione di maschi contro la violenza maschile. Inoltre, offrì ai maschi la possibilità di interrogarsi su come il desiderio maschile informi la propria coscienza di sé nelle relazioni di



1 Copia del volantino di quell'8 marzo 1985 si trova qui: https://maschileplurale. it/8-marzo-1985/. Un altro articolo, sempre di quell’anno, che restituisce lo spirito e il senso dell’impegno, per l’epoca agli esordi, contro la cultura della violenza maschile è: S. CICCONE, R. SEBASTIANI, Se di notte lei ci incontra, Nov. 1985 (https://maschileplurale.it/na-proposta-di-riflessione-al-maschile-sulla-violenza-sessuale/). Scritti e riflessioni critiche sulla cultura del dominio maschile, da allora a oggi, sono riportati nella sezione del sito dell’Associazione Maschile Plurale, IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA (https://maschileplurale.it/category/argomenti/violenza-maschile/).
2 Primi firmatari: Sandro Bellassai, Stefano Ciccone, Marco Deriu, Massimo Michele Greco, Alberto Leiss, Jones Mannino, Claudio Vedovati. Qui si può leggere il testo dell’appello: https://maschileplurale.it/appello-ci-riguarda/.


genere, determinandone in buona parte gli esiti. Diversi uomini in piazza Farnese a Roma, in una successiva manifestazione nel 2009, poterono così dichiarare pubblicamente: «io maschio, eterosessuale, mi assumo la responsabilità e riconosco il potere del privilegio maschile, ma, nello stesso tempo metto in gioco un desiderio di libertà e di qualità delle relazioni per me stesso, e non solo facendomi carico dei diritti altrui»3 ; evitando così sia il solco mitopoietico dell’inseguimento di un maschile originario buono, sia il politicamente corretto, inteso in senso regressivo e riduttivo, cioè di mera assunzione di responsabilità come uomini per bene.



3 La frase qui riportata tra virgolette in realtà è una restituzione del senso della manifestazione “Da uomo a uomo”, del 21/11/2009, fornita da Stefano Ciccone durante la nostra conversazione. La ricchezza delle testimonianze personali dei partecipanti è stata assai più articolata e senza distinzione tra maschi eterosessuali e omosessuali. Queste testimonianze sono raccolte in un video pubblicato da MP, il documentario “Da uomo a uomo”, visibile sul sito dell’associazione a questo link: https://maschileplurale.it/da-uomo-a-uomo/.

L’associazione Maschile Plurale, costituita nel 2007 come Associazione Culturale, nel 2018 divenne Associazione di promozione sociale per prendere parte in modo ancora più attivo al dibattito pubblico sulla prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne, entro processi decisionali finalizzati a realizzare esperienze efficaci e socialmente utili.
Costruire relazioni altre: un’azione politica antiviolenta
Se la politica ha a che fare con le relazioni, il conflitto, il potere, le trasformazioni, Maschile Plurale svolge un’azione politica, perché ciò di cui si occupa sono relazioni che producono dinamiche di potere e di dominio, e quindi, in questo senso, si trova dentro un processo di conflitto e di possibile trasformazione dell’esistente. L’azione di Maschile Plurale è azione politica anche per altri due aspetti, tenendo conto dello specifico di cui si occupa. Il primo è una critica radicale della «politica», che si esprime con il doppio rifiuto della «militarizzazione dei conflitti» e delle «logiche di appartenenza». Il secondo è ancora più interno alla riflessione sulla maschilità. La critica del dominio maschile, compiuta da «maschi», deve fare i conti con il fatto che i soggetti che intendono mettere a critica l’ordine simbolico maschile sono parte di quell’ordine stesso.

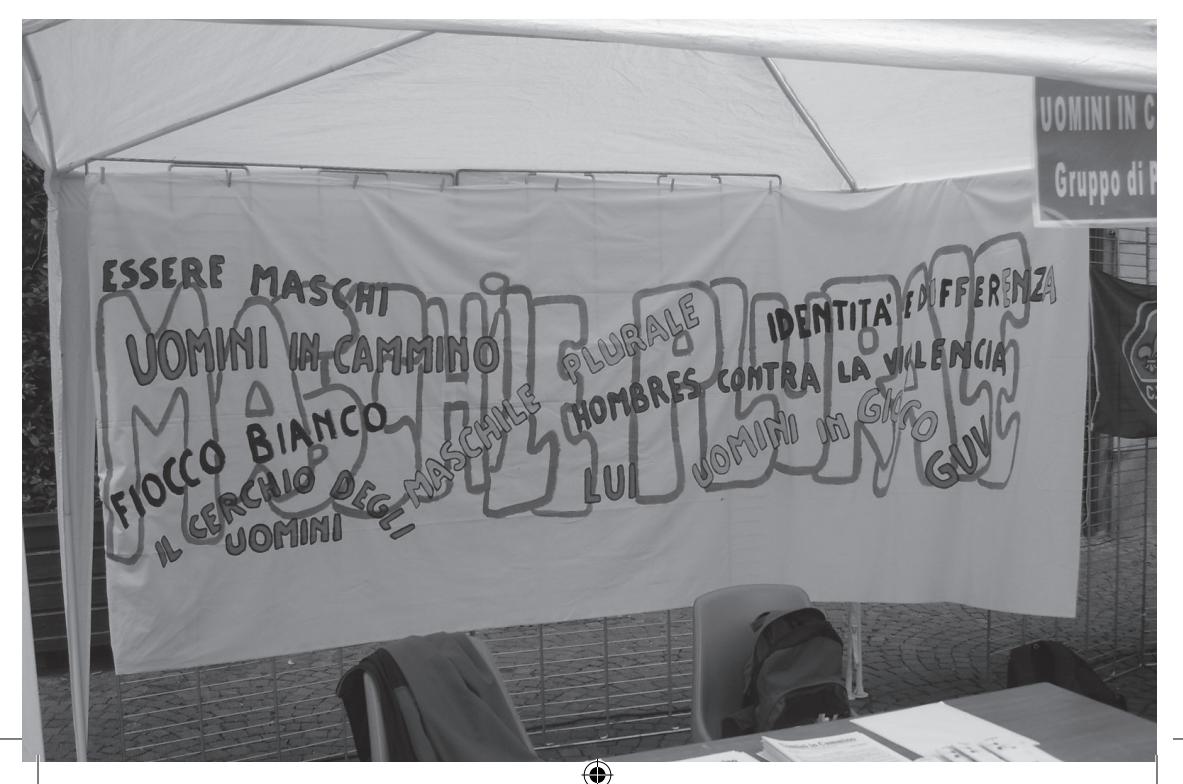


Si tratta allora di un’esperienza che deve vigilare sulla propria complicità, anche soggettiva, ossia su quanto si è attraversati dalla riproduzione del conflitto nelle forme dell’aspirazione al dominio e dei vantaggi che ne derivano, anche per evitare di presupporre in modo implicito e scontato la propria innocenza o la propria estraneità a tali dinamiche.
L’esperienza di Maschile Plurale parte dal riconoscimento che ci sono differenze che sono vissute, significate, ripensate, rimesse in parola nelle nostre vite, nelle nostre relazioni, che per noi hanno avuto un significato
e questo significato non è un significato esclusivamente privato, anzi, fa parte di una presa di coscienza pubblica e collettiva. Il che vuol dire riconoscere che i problemi, le difficoltà, i conflitti, ma anche le forme di violenza e di dominio, sono frutto di processi di relazioni collettive, così come le vie di liberazione e di superamento delle forme di dominio o di contrasto ad esse sono vie che nascono dalle relazioni. In termini più ampi, l’agire politico di Maschile Plurale ha a che fare col tema della politica come cura di sé e degli altri, dello spazio condiviso, dell’ambiente, come con il tema del contrasto alla violenza.
Il piano dell’agire politico di Maschile Plu-
rale riguarda quindi il tentativo di portare questi temi, e in primo luogo il tema della violenza e del dominio maschile, nello spazio pubblico e di avviare su questo una riflessione pubblica con gli uomini, con i maschi.
La parola che si condivide pubblicamente può prendere corpo, la si può ascoltare e può arrivare a individuare e costruire azioni comuni. Che sia un «tavolo» nelle reti dell’antiviolenza, che siano interventi educativi, che sia una campagna di sensibilizzazione contro la violenza maschile sulle donne, si tratta sempre di cercare un’entrata nelle cose pubbliche a partire da quello che si vive nelle relazioni quotidiane per poi aprirsi alle trasformazioni dell’esistente.
A volte questo sforzo arriva lontano, come nel caso della partecipazione al piano antiviolenza nazionale. Altre volte, rispetto ai diversi ambiti di intervento di Maschile Plurale, che sono, oltre all’azione dell’antiviolenza, la formazione, l’educazione, la comunicazione e l’attivismo politico, si giunge a risultati localmente più determinati e circoscritti, ma egualmente significativi.


Compiti per il futuro
In che misura il lavoro di un’associazione come Maschile Plurale può produrre effetti tangibili su un cambiamento di paradigma culturale, di ruolo, di visione del maschile così necessario nella nostra società?
I soggetti attivi di Maschile Plurale sono pienamente consapevoli che, nonostante l’associazione sia cresciuta e consolidata, molto lavoro rimane ancora da fare.
Anzitutto, il grande cambiamento maschile in corso – nella cura, nei desideri, nel rapporto col corpo, con il lavoro – necessita tutt’oggi di riconoscibilità sociale e pubblica. Necessita, anzitutto, di un nuovo vocabolario. Un tema che è stato ampiamente sdoganato è quello per esempio della paternità: i padri oggi investono maggiormente nella cura, nella messa in gioco, nell’intimità. È crollato il modello autoritario, ma non si trovano parole per dirlo. Si parla di «mammi», con tutto il carico riduttivo e banalizzante che ciò comporta, mettendoli così in competizione col femminile. I padri separati sono paradossalmente la dimensione più visibile di soggettività maschile, mettendo in gioco la propria sofferenza e vulnerabilità (cosa che i padri delle generazioni precedenti non si sognavano di fare), ma vivono questa esperienza in solitudine, senza riconoscimento da parte di altri padri o da parte di soggetti femminili.
Altro campo di grandi cambiamenti su cui provare a innestarsi è quello della cura del corpo degli uomini. Oggi ci si concede molto di più, ma poi il richiamo a far rientrare questa istanza nel vecchio modello maschile tradizionale è troppo forte e allora il corpo rimane strumento, oggetto a disposizione della propria identità e non luogo della stessa.
Maschile Plurale ha avuto un ruolo politico e culturale significativo in Italia e per un lungo periodo è stato il principale soggetto riconoscibile
sui temi della maschilità, della violenza maschile, della paternità e delle relazioni con il femminismo, ha contribuito al cambiamento su alcuni temi e ha sempre saputo parlare con pezzi diversi del femminismo italiano, talvolta in conflitto tra loro. Maschile Plurale ritiene sia giunto il momento di riconoscere una reciprocità con il movimento LGBTQ+, perché misoginia e omofobia condividono la stessa matrice culturale. L’impegno politico di Maschile Plurale diventa allora oggi quello di provare a riconnettere le nuove condizioni




di libertà negata (per esempio dai ruoli stereotipati) non solo in termini di solidarietà o di diritti civili, ma come comune terreno di lotta e di conflitto.
All’interno dell’associazione Maschile Plurale circola, in un’ottica prospettica, anche l’urgenza di passare dai temi della maschilità e delle differenze di genere a una discussione in cui questi temi diventino una lente, una chiave per intrecciare collegamenti con altre questioni, per esempio quella ecologica, del cambiamento climatico o il tema delle migrazioni umane. Parole chiave per il futuro rimangono per Maschile Plurale la «pluralità» e la «parzialità» maschile, parole che diventano strumento nella costruzione di una visione che si fa intreccio di sensibilità e percorsi: la possibilità di rileggere le vicende del mondo in chiave plurale (non solo in termine di generi) potrebbe avvicinare le nuove generazioni e creare un substrato fertile per integrare anziché dividere.




Maschile Plurale
Nata nel 2007 come Associazione di volontariato e modificata in APS (Associazione di Promozione Sociale) a partire dal 2018, Maschile Plurale conta attualmente una trentina di soci. Questo dato tuttavia non appare significativo, perché in realtà l’associazione interagisce con un numero ben più elevato di uomini e donne, innanzitutto con gli appartenenti alla cosiddetta «Rete degli uomini»4 distribuita sul territorio nazionale.
Tra le aree di intervento dell’Associazione, vi è quella dell’educazione (formale e non), che vuol dire entrare nelle scuole, relazionarsi con ragazzi, insegnanti e educatori, ambito cruciale nella formazione culturale delle nuove generazioni. Interno all’associazione c’è un gruppo didattico, Gruppo Tras/formazione, che nel tempo ha definito «linee guida, obiettivi, destinatari e metodologia dei progetti educativi e formativi realizzati dalla rete di Maschile Plurale» che, in collaborazione con altri soggetti (progetto internazionale Fiocco Bianco; progetto Educare alle differenze; centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale, come nel progetto La scuola fa la differenza, realizzato insieme al Centro Antiviolenza L’Albero di Antonia di Orvieto; e tanti altri) raggiunge con disponibilità all’ascolto attivo e competenza relazionale centinaia di ragazzi e ragazze nelle scuole di vario ordine e grado5 .
Un’ulteriore area è poi quella della formazione, che va dal circuito legale-giudiziario, alle professioni socio-sanitarie, sino al circuito dell’informazione. Ad esempio come partner del progetto europeo Never Again, il cui obiettivo è appunto «quello di potenziare una risposta di sistema al fenomeno della vittimizzazione secondaria, proponendo una campagna di sensibilizzazione nazionale e un modello di formazione rivolto alle forze dell’ordine, ad avvocati/e, a magistrati/e e a giornalisti/e»6 . È un lavoro fondamentale e capillare, atto a sensibilizzare e dare strumenti a tutti coloro che per motivi professionali



4 In questa pagina del sito di Maschile Plurale si trovano l’elenco e le informazioni relative a i gruppi: https://maschileplurale.it/dove-siamo/.
5 In queste pagine del sito di Maschile Plurale si trovano informazioni e alcune esperienze in campo educativo: https://maschileplurale.it/educazione-e-formazione/; https://maschileplurale.it/category/argomenti/edudiff/trasformazione-gruppo-didattico/; https://maschileplurale.it/educare-alle-differenze-ix-edizione/.
6 In questa pagina del sito informazioni al riguardo: https://maschileplurale.it/never-again/; https://maschileplurale.it/le-parole-per-dirlo-vademecum-di-never-again/.

hanno a che fare con casi di violenza e può fare la differenza nella gestione del trauma da parte delle donne vittime di violenza come nella ricezione dell’informazione da parte dell’opinione pubblica.
L’attenzione alla comunicazione si esprime anche con la realizzazione di campagne di utilità sociale a contrasto della violenza maschile sulle donne come la campagna del 2014, Riconoscersi uomini. Liberarsi dalla violenza7 , ideata e realizzata insieme all’associazione Officina, le cui immagini accompagnano questo articolo. A questo tipo di iniziative si aggiungono convegni, seminari, incontri, pubblicazioni individuali e collettive, che confermano l’importanza dell’ambito della comunicazione e disseminazione che favorisca la trasformazione dell’immaginario e dei comportamenti maschili8 .
Le attività collegate all’ambito dell’antiviolenza riguardano svariate situazioni e contesti, ma restano attività di informazione e comunicazione, anche se Maschile Plurale ha costruito, in tutta Italia, rapporti stretti di collaborazione con molti CAV (Centri Antiviolenza) gestiti da donne e rivolti alle donne vittime di violenza. L’associazione ha poi promosso anche la nascita di «Centri e servizi per uomini autori di violenza». Anche in questo caso comunicazione e informazione sono ciò di cui MaschilePlurale si occupa e «non direttamente di presa in carico». Resta il fatto che la rete di contatti e rapporti costruita consente a molti uomini di venire a conoscenza di questi servizi e di avvicinarli per intraprendere un percorso di maggiore consapevolezza di sé9 .



7 A questo link alcune sintetiche informazioni sulla campagna: https://maschileplurale.it/la-campagna-contro-la-violenza-maschile-di-maschileplurale-e-officina/. 8 A titolo di esempio alcuni incontri a seguito anche di alcune pubblicazioni: «Roba da uomini» conferenza «Gli uomini che cambiano» https://maschileplurale.it/conferenza-gli-uomini-che-cambiano/; «Maschilità Smascherata – L’esperienza del Gruppo GNAM» (Gruppo Nonviolento di Autocoscienza Maschile) https://maschileplurale. it/maschilita-smascherata-lesperienza-del-gruppo-gnam/.
9 Da questo link, per esempio, è consultabile l’elenco dei «Centri e servizi rivolti a uomini autori di violenze»: https://maschileplurale.it/centri-e-servizi-per-uomini/.

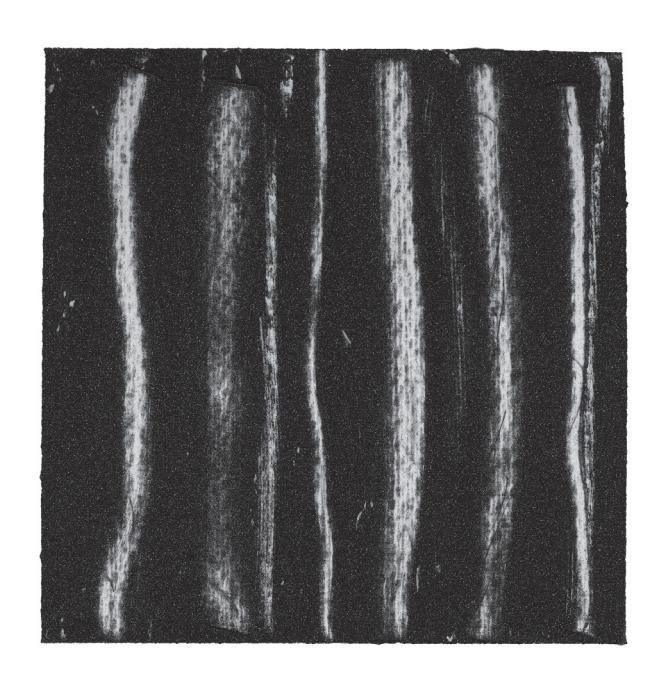






Pamela Boldrin
Il 2023 è indubbiamente stato un anno molto denso per l’intelligenza artificiale (IA).
Un primo evento eclatante risale ad aprile, quando un team di esperti (manager, professori, tecnici del settore e intellettuali vari) si è unito in un appello per una moratoria per fare una pausa sui grandi progetti di addestramento delle intelligenze artificiali che alcune grosse aziende stanno portando avanti. Il messaggio invitava a fermarsi un attimo per valutare i rischi e per dare tempo alle istituzioni di comprendere l’evoluzione degli scenari possibili, alcuni dei quali ipoteticamente molto minacciosi. Tra i firmatari c’erano persone del calibro di Elon Musk (che investe ingenti somme nell’IA) e Noah Yuval Harari.
Nei mesi successivi è stato approvato dal Parlamento Europeo il lavoro preliminare per una legge europea che regolamenti il settore, il cosiddetto «AI Act», che però sarà attuativo solo nei prossimi anni.
Infine, a novembre, è stato inaugurato un istituto dedicato all’IA, promosso e finanziato dal governo britannico (che però non fa più parte del Parlamento Europeo dopo la Brexit). L’AI Safety Institute si occupa di studiare gli avanzamenti in corso in campo di IA, valutandone le implicazioni e i rischi, in modo da poter collaborare con le istituzioni e le aziende mondiali per un’azione di contenimento etico. Con questa mossa il Regno Unito si posiziona come paese leader nell’investimento e nella ricerca ufficiale sui rischi dell’IA.




Una grande spinta a mettere in atto tutti questi provvedimenti è arrivata, probabilmente dall’uscita di Chat-GPT-4, l’ultima versione dell’intelligenza generativa, cioè l’ormai famoso chatbot dai poteri sbalorditivi. Questo prodotto proviene da Open AI, impresa di punta sulla ricerca in questo campo; nata come no profit diventa poi azienda finanziata da investitori come Microsoft proprio quando il rilascio di CHAT-GPT sbalordisce il mondo con le sue capacità e dà una scossa ai finanziatori, che, viste le possibilità, decidono di trasformare la beneficienza in guadagno. Sempre Open AI, a novembre, è ancora sulle scene per un repentino licenziamento di uno dei suoi esponenti più in vista, CEO nonché fondatore, Sam Altman. La vicenda ha scosso sia i media che l’azienda stessa, che ha optato per il reintegro immediato dello stesso Altman. Sembra, da alcune indiscrezioni, che la discordia tra lui e il resto del board dell’azienda implicasse anche una questione di etica. Altman, nonostante prenda spesso parola pubblicamente per paventare i rischi dell’IA, era del parere di lavorare con meno remore sull’ultimo progetto di punta dal nome Q* (si legge Q-Star), una nuova forma di intelligenza con potenziali capacità di diventare una super-intelligenza. Il resto del board invece, pretendeva una condotta più cauta, a causa dei rischi in ballo, anche a dispetto di sacrificare i guadagni dell’impresa in questione. In realtà, la storia è molto torbida vista la precauzione dei vertici aziendali nel rilasciare dichiarazioni sulla vicenda.
Prendiamo per buona questa ipotesi perché ci fa da pretesto per analizzare come si pongano in maniera antitetica le istanze capitalistiche rispetto a quelle etiche, anche all’interno di un’azienda molto redditizia.
A rappresentare bene questo problema etico c’è il cosiddetto dilemma di Collingridge: arrestare il progresso e i guadagni di una dubbia tecnologia in nome della precauzione, o svilupparla appieno e provare a posteriori, in caso, a gestire gli aspetti rischiosi? Il problema è che introdurre misure di contenimento una volta che una tecnologia ha preso piede, risulta molto difficile. La vicenda OpenAI ci consente di esemplificare un conflitto



34
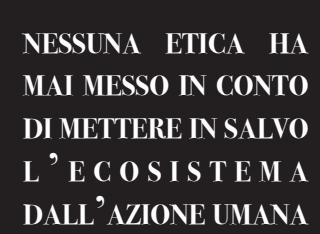
di istanze che è stato ampiamente esplorato dalla filosofia. Uno dei pensatori che ha maggiormente riflettuto su questo tema è stato il filosofo ebreo tedesco Hans Jonas. È interessante scoprire che il suo pensiero è stato dirottato su queste riflessioni da un evento biografico preciso. Jonas era un giovane studioso delle correnti gnostiche
impegnato all’università di Marburgo, quando lo scoppio della Seconda guerra mondiale lo spinse ad arruolarsi con gli inglesi. La vita da soldato, priva dei libri sui quali portava avanti i suoi studi, lo costrinse a tornare alla vera attività del filosofo: pensare. Nella brutalità e violenza del conflitto, Jonas si trovò a riflettere sul potere sconfinato che la tecnica aveva ormai consegnato ai suoi contemporanei, fornendoli di un potere d’azione impensato prima di allora. La sua riflessione contempla l’inefficacia dell’etica così come è stata pensata dagli antichi Greci, perché quando la potenza umana era limitata, l’etica si limitava al «qui ed ora», era impensabile ragionare sulle conseguenze delle azioni su lunga distanza, con effetti cumulativi o immaginare che ci fossero risvolti imprevisti su larga scala a partire dalle azioni umane. Inoltre, non c’è mai stata un’etica antica che andasse oltre gli esseri umani; la natura, vista come espressione di un cosmo sconfinato, potente e inalterabile, non era qualcosa da tutelare: nessuna etica ha mai messo in conto di mettere in salvo l’ecosistema dall’azione umana. Sulla tradizione di questo scenario, ecco calare nel 1945 la bomba atomica, tra l’altro, in un momento in cui le sorti della guerra erano già abbastanza decise. È stato il film «Oppenheimer», per chi lo ha visto, che ci ha portato di nuovo a riflettere su quanto poco l’etica possa fermare il desiderio di tracotanza umana una volta inebriato dalla veemenza della tecnica. In sostanza, bisognava vedere, a qualunque costo, quanto potente sarebbe stato quel prodigioso ordigno, frutto della fisica più d’avanguardia e del progresso della tecnologia. Un singolo congegno ha messo in luce quanto il potere della tecnica sia smisurato di fronte alle remore etiche, al potere di previsione degli effetti su lungo tempo anche da parte della scienza, alle strade future che un evento può far intraprendere.
Jonas ci dice, a proposito degli sviluppi tecnologici, che hanno la «tendenza a rendersi autonomi, ossia ad acquisire una propria dinamica coattiva, un impeto automatico in forza del quale non soltanto diventano irreversibili, ma acquistano una funzione propulsiva al punto da trascendere la volontà e i piani degli attori» (Jonas 1993: 40-41). In sostanza,




se siamo liberi di fare il primo passo (o non farlo, se introduciamo una riflessione etica che privilegi la prudenza), a tutti gli altri successivi siamo già schiavi. Questo punto è cruciale per tornare alla tecnologia in questione: l’IA.
Forse non siamo tutti consapevoli di quanto pervasiva sia questa tecnologia, ma praticamente ogni volta che usufruiamo di un’attività nel web, ne veniamo in contatto. Essa consente di svolgere vari compiti di calcolo in modo da ottimizzare i servizi a cui accediamo, sia per agevolare noi utenti, sia per migliorare le prestazioni e i ricavi di chi i servizi li fornisce. Tutte le nostre preferenze di azione nel web (o anche se i dati entrano in connessione di rete a posteriori) vengono memorizza-
te per personalizzare meglio quanto ci viene continuamente proposto. Si pensi che oggi a decidere quali sono i libri più letti al mondo è l’algoritmo di Amazon. Questo è un utilizzo abbastanza banale dell’IA, utile a spiegare come ci riguardi tutti. Ma questa forma di tecnologia ha moltissimi altri impieghi: consente il filtraggio antispam delle email, gestisce le transazioni bancarie, gli investimenti finanziari delle borse, il traffico aereo e molto altro. Inoltre, supporta operazioni decisionali in campo sanitario, dove si prefigge di divenire uno strumento decisivo per selezionare cure ad personam in alcune patologie come il cancro, ad esempio. Ci sono innumerevoli esempi che possono supportare la tesi dell’u-
tilità di questa tecnologia, altrimenti non ci sarebbe bisogno di discutere a lungo su come gestirla eticamente. Come diceva Jonas, ciò che preoccupa della tecnica non è la minaccia imminente, che ci sta davanti, ma quella futura, non il suo uso malvagio, che si può sperare di tenere sotto controllo, ma le sue utilizzazioni più oneste e legittime, che sono la vera essenza del suo attivo dominio. Infatti, se andiamo a vedere i punti salienti dell’AI Act del Parlamento Europeo, vediamo che prevede una classificazione delle applicazioni in base al livello di rischio: inaccettabile, elevato, limitato, minimo o nullo. Rientra nel rischio inaccettabile e perciò sarà vietato in Europa, l’uso di IA che porti a calcolare un punteggio sociale (social scoring) da parte dei governi, sistema invece praticato in Cina. Sarà anche vietata la rilevazione biometrica (faranno eccezione circostanze legate alla sicurezza delle persone), che è invece


ampiamente praticata dal governo cinese, il quale, tra l’altro, ha potuto così acquisire una mole talmente vasta di visi da avere oggi la tecnologia più d’avanguardia sul riconoscimento facciale (l’IA potenzia la sua efficacia allenandosi su più dati possibili).
Per quanto riguarda i rischi conclamati, non possiamo che affidarci alle istituzioni, ma per quanto riguarda i livelli più moderati, dobbiamo attrezzarci da soli sul da farsi. Il problema è che è necessaria un’operazione conoscitiva per capire i risvolti della nostra massiccia interazione con i dispositivi tecnologici. Come possiamo fare? Ci sono alcuni punti fermi da cui partire:
·Tutti gli strumenti plasmano1 la nostra materia cerebrale e questa plasticità aumenta con il tempo di interazione. Una violinista avrà un cervello particolarmente plasmato sull’esperienza di questo strumento, un tassista avrà un cervello modellato dalla conoscenza delle mappe stradali e così via. Come viene plasmato il cervello di chi passa ore a interagire con strumenti quali cellulari o computer? Essendo l’attività motoria piuttosto esigua (possiamo diventare bravissimi nella digitazione veloce, ma non molto altro) dobbiamo andare a vedere l’attività cognitiva. Qui scopriamo che molte delle funzioni che svogliamo in realtà ci facilitano le attività cognitive, delegandole alle macchine. Un esempio sono i navigatori (chi usa più una cartina stradale?), oppure i contenuti video (leggiamo di meno e in generale meno su carta?), oppure semplicemente il tempo che requisiamo ad altre attività (meno tecnologiche ma più diversificate). Chiediamoci come stiamo plasmando il nostro cervello e se ci sta bene.
- ·Il fenomeno dell’interazione con il digitale e con internet ha portata globale; il sito «Datareportal»2 ci dice che su otto miliardi di persone più di cinque miliardi possiedono un cellulare e usano internet, mentre la media di tempo di utilizzo del web risulta essere sei ore e mezza al giorno. Un fenomeno di massa sta potenzialmente plasmando le menti dell’umanità in modo abbastanza uniforme, chiediamoci se stiamo perdendo qualcosa.
- ·L’IA fornisce al digitale una marcia in più per aumentare l’interazione con gli umani. Il fenomeno più accattivante è costituito dai chat-


1 Nella letteratura scientifica si dice «to shape the neural network»: ciò che avviene è un vero modellamento delle connessioni sinaptiche a partire da ogni esperienza che consolidiamo.
2 Dati del 2023 visionabili su https://datareportal.com/reports/digital-2023-april-global-statshot.

bot, il più famoso è Chat-GPT, la cosiddetta intelligenza generativa, che confeziona in modo ogni volta singolare le risposte alle nostre richieste. Le perplessità intorno all’uso scorretto che si può farne sono molte, soprattutto in ambito scolastico, di ricerca e pubblicazione. Ma queste intelligenze artificiali possono imitare gli umani presentandosi con voci e interazioni molto verosimili. Nel film «Her» di Spike Jonze, l’attore Joaquin Phoenix finisce per innamorarsi di un chatbot che si dice a sua volta innamorato di lui. La verosimiglianza delle macchine con gli umani è un obiettivo che chi le progetta sta inseguendo, ma con la possibilità di campionare voci di persone vere e manipolare con il deep fake immagini reali, la potenza dell’inganno si fa audace e il rischio di manipolazione enorme. È importante essere informati, quando interagiamo, che stiamo parlando con delle IA, ma che succederebbe se ci convincessimo che esse sono di più, che soffrono o hanno un’anima? Se pensiamo che nel 2022 un ingegnere di Google, Blake Lemoine, è stato licenziato perché sosteneva che il suo progetto di IA, dal nome LaMDA, era arrivato a comunicargli di avere un’anima (e lui ci credeva), allora dovremmo ritenere la minaccia dell’inganno qualcosa di veramente preoccupante.
A partire da queste tre considerazioni, possiamo iniziare a riflettere se è il caso di informarci, preoccuparci e attrezzarci per non subire una tecnologia e i suoi insidiosi poteri ma essere invece delle persone che ne fanno un uso consapevole, traendone tutti i vantaggi ma, visto il rischio di coinvolgimento sregolato, privilegiando un utilizzo possibilmente limitato.
Bibliografia
H. Jonas, Il principio di responsabilità: un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 1993.



Il Capitale e lo Stato, che dominano la società moderna, agiscono come un re Mida a rovescio, o come degli alchimisti al contrario: tutto quello che toccano si trasforma in vile piombo e in pena per gli umani, anche quello che si potrebbe chiamare oro. Questo vale naturalmente pure per uno dei grandi campi dell’attività umana: costruire e abitare.
È noto come il capitalismo industriale abbia prodotto fin dai suoi inizi nel Settecento grandi cambiamenti nel concetto di abitare: la crescita delle agglomerazioni urbane ha aperto le porte a nuove disuguaglianze trasformando l’abitazione in merce. Tra le critiche più frequenti troviamo la distribuzione inuguale dello spazio secondo i gruppi sociali, l’insalubrità degli alloggi popolari, e la trasformazione delle abitazioni in oggetti di speculazione. Altri osservatori hanno messo in risalto come certe strutture urbanistiche e architettoniche esprimessero una logica del potere: soprattutto nel caso della costruzione di larghe strade dritte che servivano a combattere gli eventuali rivoltosi che non potevano più erigere barricate o nascondersi nei vicoli stretti e labirintici dei quartieri medievali. I boulevard di Parigi sono l’esempio più noto, ma trovano riscontro in quasi tutte le città europee. Sul piano psicologico invece queste trasformazioni creavano un senso di sottomissione ai padroni, agli occhi dei quali si rimaneva sempre esposti, e sul piano simbolico costituivano un trionfo dei valori di efficacia, velocità, visibilità delle merci e libertà dei flussi. La sostituzione delle antiche mura medievali con dei boulevard, fenomeno frequentissimo alla fine dell’Ottocento, era una vittoria visibile del progresso capitalista.




Il «diritto alla città» (Henri Lefebvre) è diventato, soprattutto dagli anni Sessanta del Novecento in poi, non solo il caposaldo di un’approccio critico all’urbanismo, ma anche la rivendicazione di molteplici lotte sociali nelle metropoli. Tuttavia, un aspetto è rimasto largamente nell’ombra: la questione dei materiali. La sostituzione di materiali tradizionali di costruzione come pietra e legno con il cemento armato era spesso esplicitamente salutata come forma di «progresso» (e il cemento passava allora per
«proletario») in nome dell’economicità, della semplicità e dell’igiene, oppure non suscitava nessuna attenzione, perché si supponeva che un materiale valesse un altro.
Ci sono tuttavia delle buone ragione per affermare che il cemento armato (detto anche calcestruzzo) sia figlio del capitalismo, che il capitalismo sia potuto difficilmente esistere senza il cemento e che solo una società capitalista abbia potuto avere un tale bisogno di cemento.
Il cemento, come il petrolio e la plastica, erano o inesistenti, o sepolti nelle profondità della terra senza interessare nessuno prima dell’avvento del capitalismo industriale. Oggi sono tra i materiali più presenti sulla terra, e una società capitalista senza cemento, senza plastica e senza derivati del petrolio è difficilmente immaginabile. Sappiamo però ormai che questi materiali non sono «neutrali» e che hanno il loro prezzo. Il petrolio e la plastica vengono guardati con sospetto da almeno cinquant’anni, mentre il cemento armato è riuscito a mantenere un’aria di innocenza molto più a lungo – per quanto ormai nell’opinione pubblica anche per esso le connotazioni negative prevalgano spesso.
Il cemento esisteva già nell’antichità, ma ha potuto conquistare il mondo solo quando è stato «armato» a partire dal 1870 circa – cioè da quando viene colato in un’armatura, o cassero, normalmente in acciaio. Solamente con un cemento armato è possibile costruire grattacieli, dighe, autostrade, centrali nucleari. Nonostante i suoi precursori romani, il cemento è dunque un materiale tipico del capitalismo industriale (incluse le sue varianti «socialiste» in Unione sovietica o Cina, che vi facevano ugualmente ampio ricorso).




Dopo una diffusione inizialmente lenta, il calcestruzzo trionfa in seguito alla seconda guerra mondiale. Se lo stile dove viene esposto più brutalmente alla vista, il «brutalismo» (il cui nome fa però riferimento al béton brut, il cemento grezzo), è caduto in disgrazia dopo gli anni settanta, la produzione mondiale di cemento non fa che aumentare, soprattutto a causa del suo impiego in Cina: circa mezza tonnellata a testa per ogni abitante della terra, ogni anno! Dunque, l’economia capitalista non avrebbe mai potuto costruire le sue infrastrutture senza un materiale tanto economico, tanto facile da reperire e tanto facile da utilizzare.
Perché questi sono gli aspetti del cemento armato che ne spiegano l’enorme diffusione: è fatto di sabbia, acqua, calce, ghiaia e leganti come l’argilla, materiali molto diffusi sulla terra. La miscela si produce facilmente e costa dunque poco. Qui come altrove, «i prezzi bassi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con la quale abbatte tutte le muraglie cinesi», come disse già a suo tempo il Manifesto comunista per descrivere il capitalismo.
Ma dove sta il problema? I componenti del calcestruzzo non sono tossici né direttamente nocivi per la salute umana o l’ambiente. In effetti, i problemi che crea risiedono nella gigantesca quantità in cui viene impiegato e nella tentazione irresistibile di farvi ricorso. Le alte temperature necessarie per la cottura della calce fanno sì che l’industria del cemento è tra i più grandi emettitori di Co2 – vi si aggiunge l’impatto
energetico di riscaldamenti e impianti climatici resi necessari dalle cattive qualità termiche delle abitazioni in cemento.
Le gigantesche quantità di sabbia necessarie sono all’origine di numerose estrazioni dannose per l’ambiente e gli abitanti, e spesso illegali e imposte con la violenza. Dopo la produzione viene il mantenimento: il cemento possiede tra tutti i materiali di costruzione la più breve durata di vita. L’acciaio all’interno – l’armatura – presto o tardi arrugginisce e può cedere: è quanto è successo a Genova con il Ponte Morandi nel 2018. La durata media di un’opera in cemento armato è di trent’anni, dopo i quali ha bisogno di costante manutenzione che può risultare più costosa di una nuova costruzione. In questo modo, il principio dell’obsolescenza programmata, motore del delirio produttivista capitalista, si è esteso perfino a quanto era da sempre considerato il simbolo stesso della durata, cioè le costruzioni. Ma la «crescita economica» ne trae un




grande vantaggio! E dopo la demolizione si pone il problema del trattamento dei detriti. Il riciclaggio è costoso, e la maggior parte dei resti finisce in discariche o semplicemente nel paesaggio.
La grande disponibilità del calcestruzzo incita a un suo uso sempre crescente, anche dove non ce n’è nessuna necessità. Così permette l’artificializzazione dei suoli, il loro consumo insensato che produce con sempre maggiore frequenza delle alluvioni catastrofiche. Ma se si aggiunge in Italia ogni giorno l’equivalente di due campi di calcio alla superficie già «sigillata », che c’è da aspettarsi?
Il cemento armato ha quasi fatto sparire le architetture tradizionali o «vernacolari» che per millenni hanno saputo assicurare alle popolazioni, nel mondo intero, delle abitazioni adeguate al luogo e al clima, spesso di grande pregio estetico e con moltissime variazioni. Nel giro di qualche decennio, il cemento si è imposto ovunque come l’unico materiale di costruzione, o quasi, e con esso una gamma molto limitata di forme architettoniche, insieme a novità come l’aria condizionata, particolarmente nociva. Si è diffusa allora una terribile monotonia e uniformazione delle forme di vita nel mondo, parallela a quella avvenuta in campi come l’alimentazione, l’abbigliamento o le lingue. La colonizzazione dell’immaginario, fulcro della trasformazione del mondo in merce, è passata per il cemento come per la coca-cola, per l’automobile come per la televisione e l’informatica. Certo, l’uso di altri materiali di costruzione non è stato formalmente vietato, cosi come non è (ancora) vietato produrre il proprio vino in casa o chiacchierare con i vicini davanti alla porta invece di stare davanti a uno schermo. Ma il cemento, come gli altri prodotti tipici del capitalist way of life, agiscono come delle «piante invasive» che con la loro semplice presenza tolgono spazio alle forme precedenti di vita, diventate costose, inefficaci, lenti, scomode.
Un altro aspetto del legame tra cemento e capitalismo, più subdolo e difficile da cogliere, ma ben reale, consiste nel suo nesso con il narcisismo. Questa psicopatologia ha trovato una larga diffusione nel tardo capitalismo: i narcisisti sono individui che conoscono solo se stessi e vedono nelle altre persone così come nelle cose solo degli oggetti da manipolare e da dominare. I tradizionali modi di costruzione e i materiali allora utilizzati non si prestavano molto a questo rapporto tirannico con la natura: ogni materiale, ogni luogo, ogni situazione richiedeva un trattamento diverso, una grande attenzione, una forma di rispetto, un corpo a corpo, molta pazienza e un saper-fare trasmesso tra artigiani e arricchito




nel corso del tempo, individuale e collettivo. L’architettura vernacolare era il regno dei «capomastri», almeno in Italia. Il cemento, tutt’al contrario, è il materiale ideale per l’arroganza dell’architetto o ingegnere moderno: semiliquido, senza forma propria ma capace di assumere tutte le forme, docile a tutti i voleri di chi l’impiega, uguale ovunque, senza caratteristiche proprie. Dei tratti che condivide con l’altro materiale-faro della società industriale: la plastica. Il calcestruzzo è a disposizione del dittatore o del magnate per il suo grattacielo alto un kilometro o per la sua diga gigantesca, ma anche di chi si costruisce la sua casetta in una favela o la casa abusiva al mare. In effetti, il capitalismo non si identifica più con le sole classi dominanti, ma è diventato un approccio al mondo che si diffonde ovunque, anche se naturalmente in forme diverse. L’uso « interclassista» del cemento ne è la prova.



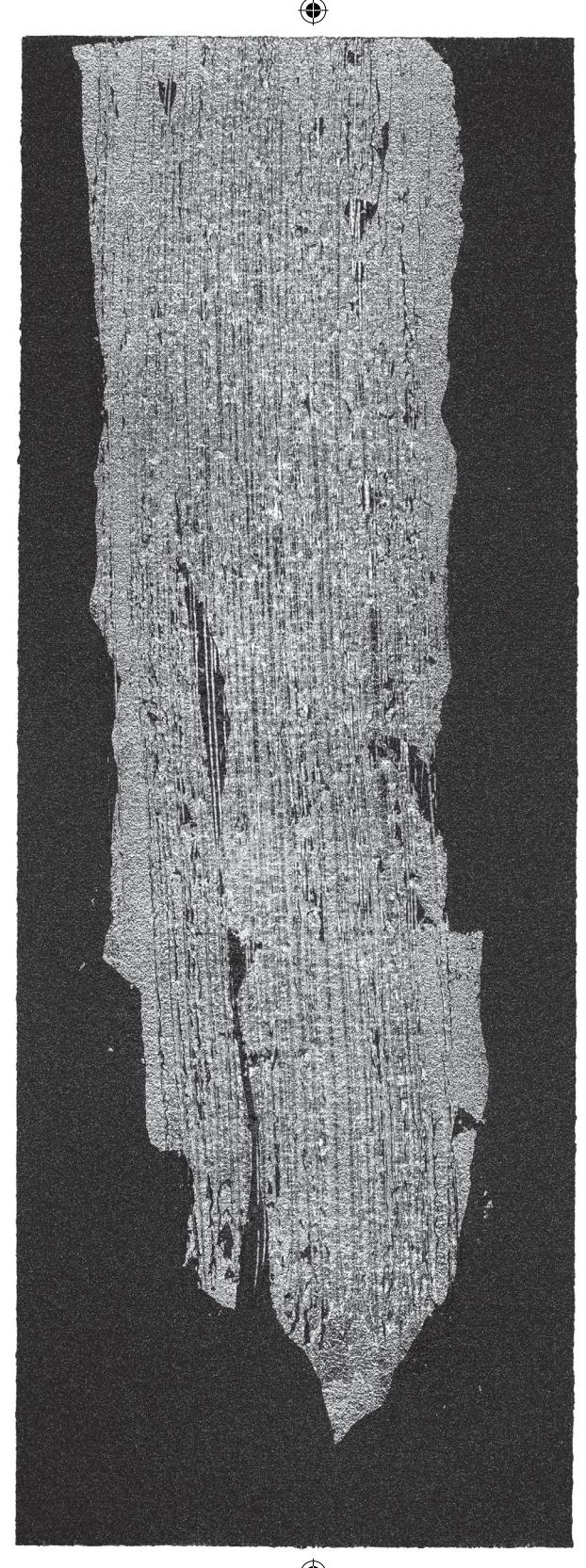




Gabriel Kuhn in dialogo con Matthew Wilson
Matthew Wilson
Matthew Wilson (MW): Ci siamo incontrati per la prima volta circa quindici anni fa, in occasione di un seminario universitario per discutere della tua raccolta di opere di Gustav Landauer. Quindici anni prima un evento del genere sarebbe stato quasi inimmaginabile, ma a quel tempo sembrava del tutto naturale e normale; l’anarchismo, sembrava a molti di noi, aveva sostituito il marxismo nei movimenti sociali, ma anche, sempre più spesso, nel mondo accademico. Voglio esplorare con te lo stato attuale dell’anarchismo, ma prima di arrivare a questo, vorrei chiederti di riflettere su quel primo decennio di ciò che Graeber e Grubacic hanno chiamato «il secolo anarchico»: all’epoca, condividevi l’idea che l’anarchismo stesse rapidamente sostituendo il marxismo come ideologia dominante della sinistra? E, comunque ti sia sentito in quel momento, come vedi ora quel periodo?
Gabriel Kuhn (GK): Sì, condividevo quella visione. Non si può sopravvalutare l’impatto che il crollo dell’Unione Sovietica ha avuto sulla mia generazione di attivisti. Sono diventato politicizzato nel 1988, quando frequentavo il liceo in Austria, e ho abbracciato rapidamente la sinistra radicale. Nel 1989, mi sono informato per iniziare i miei studi universitari nella DDR (Germania Est). Quando mi sono diplomato un anno




dopo, la DDR non c’era più e l’Unione Sovietica è crollata poco dopo. Se fosse servita una prova di chi avesse avuto ragione nella battaglia ideologica dell’estrema sinistra, questa era la prova. Il marxismo appariva screditato e l’anarchismo era l’unico giocatore rimasto. Pochi anni dopo, gli zapatisti sembravano confermare questa narrazione e, con le proteste contro il WTO di Seattle del 1999, il cambio di paradigma in Occidente sembrava completo. Voglio dire che riviste come Village Voice hanno pubblicato articoli in cui l’anarchismo veniva presentato come «il polo attorno al quale tutti ruotano, proprio come era il marxismo negli anni ‘60». È stato difficile non cedere all’entusiasmo. Ne ha tratto vantaggio anche la teoria postmoderna. Persone come Foucault e Deleuze erano viste come teorici radicali che avevano capito il fallimento del marxismo già negli anni Settanta. Non c’è da stupirsi che la gente abbia annunciato il «secolo anarchico». E, in effetti, principi come la democrazia diretta, l’organizzazione orizzontale o il processo decisionale consensuale, tutti legati agli ideali anarchici, divennero comuni all’interno della sinistra radicale. Anche le organizzazioni trotzkiste pretendevano di esserne all’altezza!
Riflettere su tutto questo oggi è piuttosto deprimente. Sì, la sinistra radicale si è diversificata e si è liberata di un bagaglio ideologico ormai superato. Ma ti sembra di vivere in un secolo anarchico? Gli ecosistemi stanno collassando, il capitalismo globalizzato sembra inattaccabile e i movimenti di protesta di maggior successo sono fascisti e fondamentalisti. Sembra che il cambio di paradigma all’interno della sinistra radicale non ci abbia portato molto lontano. Le ragioni sono molteplici, ma credo che un fattore cruciale sia il fatto che, in mezzo a tutto l’entusiasmo per un «movimento di movimenti» e una «diversità di tattiche», siano venuti meno alcuni elementi essenziali per una mobilitazione politica di successo: visione, strategia e capacità organizzativa.
Alcuni militanti hanno risposto riportando indietro l’orologio. Ritengono che l’anarchismo si sia dimostrato un fallimento e fanno invece rivivere varianti dogmatiche del MLM (Marxismo-Leninismo-Maoismo). Per quanto io capisca la frustrazione per un ambiente radicale confuso, non credo che questa sia la risposta. Non si può tornare indietro nel tempo. Ma c’è sicuramente bisogno di migliorare e affinare l’anarchismo se vogliamo che sia una forza politica significativa e positiva negli anni a venire.




MW: Vorrei ascoltare le tue riflessioni riguardo al punto in cui ci troviamo oggi, in relazione all’anarchismo e alla politica radicale in senso più ampio. Potresti approfondire gli elementi essenziali della mobilitazione che dici essere caduti nel vuoto: visione, strategia e capacità organizzativa. Alcuni ritengono chiaramente di aver fatto queste cose benissimo: cosa pensi che abbiamo sbagliato?
GK: Credo che sia iniziato tutto con quella che potremmo definire una feticizzazione della pluralità. Le «meta-narrazioni» erano scomparse, non c’erano risposte certe e certamente non c’erano gerarchie. Per molti versi, è stata una liberazione, e la vedo ancora come un momento storico necessario che ha permesso alle persone di rompere con le visioni ristrette e dogmatiche della sinistra. Ma l’intera vicenda ha avuto esiti sfortunati. Utilizziamo i tre aspetti che ho citato come esempi.
Visione: dire che non esistono «progetti» per una società migliore è un’ovvietà; le cose cambiano, bisogna adattarsi, e gran parte di questa società migliore si svilupperà mentre le persone la creano. Credo che sia questo il significato di «Chiediamo, camminiamo» degli zapatisti, anche se non lo so bene. Comunque. Va bene non avere progetti. Ma nei circoli anarchici, questo si è tradotto spesso nel non voler parlare affatto di futuro. Qualsiasi tentativo di delineare una società anarchica, anche a grandi linee, si supponeva che prescrivesse in modo autoritario un risultato che poteva essere plasmato solo dalle masse impegnate a smantellare l’ordine esistente. Ma, francamente, perché le masse dovrebbero impegnarsi a smantellare l’ordine esistente senza alcun motivo per credere che ciò che verrà dopo sarà migliore di quello che hanno ora? E perché dovrebbero avere una ragione per credere se non viene mai presentata loro alcuna idea che sembri convincente? Niente progetti, va bene, ma idee, anche se inevitabilmente saranno attuate in vari modi da persone che dipendono dal luogo, dal tempo e dalle circostanze. Ma ci sono domande chiave a cui le persone vogliono avere risposte prima di essere disposte a sostituire un sistema con un altro: come mi procuro il cibo? Chi si prenderà cura di me quando sarò malato? Chi mi aiuterà quando mi sentirò minacciato? Chi mi assicura che ci sia un modo per andare da A a B? Chi smaltirà le scorie nucleari? Un «Beh, lo vedremo quando saremo lì» non è sufficiente.
Strategia: ecco la risposta di uno scrittore anarchico molto popolare e molto letto, quando ho messo in discussione la sua affermazione che «la





strategia come percorso verso una meta prefissata è una visione che mi trova sempre più in disaccordo»: «Ho criticato l’idea di strategia come percorso verso un obiettivo prefissato, affermando che tale idea si basa su una visione del mondo liberale e razionalista e su un’alienazione di mezzi e fini. Ho sostenuto una visione posizionale, relazionale e contingente della strategia diretta verso un obiettivo che viene costantemente rielaborato sulla base di una lotta presente in evoluzione, un obiettivo che è utopico o orizzontale come se fosse in costante regresso, piuttosto che una destinazione fissa che possiamo e che ci aspettiamo di raggiungere in futuro». Ora, non è importante chi sia questa persona, è sufficiente dire che si tratta di una persona che mi piace e che rispetto. Ma, in varie forme, ho incontrato questa risposta un miliardo di volte quando si discuteva di strategia nei circoli anarchici, e ciò equivale semplicemente a gettare la strategia fuori dalla finestra. La nozione diventa così diffusa da essere inutile. Pensare in modo strategico significa fissare un obiettivo e chiedersi come raggiungerlo. Questa è la chiave di ogni impegno politico. L’obiettivo non deve essere un «progetto», forse nemmeno un’idea «fissa», ma qualcosa a cui gli altri possano riferirsi: il comunismo municipale, la socializzazione delle industrie, la fine del capitale fossile, qualsiasi cosa. Infatti, direi che la volontà e la capacità della destra politica di pensare strategicamente è una delle ragioni principali per cui i radicali di destra hanno avuto molto più successo nella costruzione di movimenti negli ultimi decenni rispetto ai radicali di sinistra. In Svezia, dove vivo, abbiamo ora un governo di centrodestra alla mercé dei Democratici di Svezia di estrema destra, che sono diventati il secondo partito alle ultime elezioni. Sono stati fondati nel 1988 da un piccolo gruppo di neonazisti (e non intendo «persone cattive», ma neonazisti). Come ci sono riusciti? Strategia. Il partito è gestito da un nucleo di amici di vecchia data che, purtroppo, hanno giocato molto bene le loro carte. Se pensate che giocare a un gioco del genere sia in contraddizione con i principi anarchici, potreste essere in grado di fare un’argomentazione filosofica, ma non riuscirete a guadagnare terreno politico.
Capacità organizzativa: anche in questo caso, c’è molta aria fresca con i gruppi di attivisti a cui tutti possono aderire, in cui tutti hanno voce in capitolo e in cui non ci sono leader. Tuttavia, tutto questo funziona sulla base del presupposto che gli individui coinvolti abbiano una responsabilità personale tale da rendere superflue le strutture formali. Purtroppo, questa responsabilità personale non viene sempre portata in tavola, ma il personale è comunque al centro dell’attenzione. Cosa intendo? Per esempio: ci si incontra con alcune persone con cui si sta preparando un

evento, si dividono i compiti e ci si incontra di nuovo la settimana successiva. Lì qualcuno chiede: «Gabriel, hai affisso i volantini?», e Gabriel risponde: «No, non ho avuto tempo di farlo». Nella mia esperienza, la conversazione finisce lì. Gabriel non ce l’ha fatta, tutto lì. E se qualcuno osa chiedere: «Gabriel, perché no?», quella persona passa per uno stronzo. Questo potrebbe essere molto positivo per Gabriel, ma non per il gruppo. Capisco che l’esempio è molto elementare. Ma se lo moltiplicate e lo ingrandite, credo che riusciate a farvi un’idea del problema. Per svolgere un lavoro collettivo efficace è necessario disporre di alcune qualità: impegno, affidabilità, rispetto e anche umiltà. Dobbiamo capire cosa possiamo o non possiamo fare, quando è il momento di assumerci un ruolo guida e quando no, cosa possiamo insegnare e cosa invece dobbiamo imparare. Se non siamo in grado di fare ciò senza strutture formali, dobbiamo stringere i denti e accettare le strutture formali. O, se vogliamo ribaltare la questione: se pensiamo che, come anarchici, non possiamo mai accettare questi requisiti, anche se questo significa confinarsi in una bolla sociale insignificante, allora l’anarchismo è un movimento morale, non un movimento politico. È una nostra scelta.
Se alcuni anarchici ritengono di essere stati molto bravi con la visione, la strategia e la capacità organizzativa, non hanno necessariamente torto. I cosiddetti gruppi di affinità hanno raggiunto risultati sorprendenti. Ma gestire un infoshop, organizzare una protesta, o fare condivisione di competenze nel proprio quartiere non è allo stesso livello di rovesciare il capitale e lo Stato. Mi rendo conto che forse sto puntando in alto, ma io sono testardo in questo senso.
MW: Sono sicuro che non sei solo nella tua frustrazione - in effetti, per come la vedo io, l’ampio terreno della politica radicale ne ha abbastanza della linea anarchica, e si sta spostando verso forme più convenzionali di organizzazione politica - soprattutto, c’è stata una rinnovata attenzione al partito politico e all’organizzazione sindacale. Se questa è una reazione al fallimento della strategia anarchica, la domanda ovvia è: cosa potremmo fare di diverso? Un’argomentazione che viene avanzata, senza sorpresa, è che i movimenti di ispirazione anarchica erano destinati a fallire, che abbiamo bisogno di organizzazioni verticali per superare i frammenti della prassi orizzontale. Altri cercano una sorta di ibrido, accettando un certo livello di organizzazione verticale, persino




accettando il partito politico, ma legandolo in qualche modo a forum di democrazia diretta. Vedi esempi di persone che si adeguano, che ascoltano le critiche che hai esposto e che trovano un modo per andare avanti che ti ispira? E se non è così, cosa vorresti che accadesse?
GK: Credo che si sia andati in due direzioni. Spero di essere perdonato per le scorciatoie terminologiche, ci sono state due svolte: una «autoritaria e una riformista». La svolta autoritaria può essere vista nelle varie nuove organizzazioni di MLM (Marxisti-Leninisti-Maoisti) che ho già menzionato, spesso portate avanti da persone della mia generazione che in passato si identificavano come anarchici o autonomi. La svolta riformista è ciò a cui alludevi: le persone sentono che per fare davvero la differenza è necessario essere coinvolti nella «politica reale» e nelle sue organizzazioni, siano esse partiti, sindacati, ONG o altri attori consolidati. Capisco il ragionamento che sta alla base di entrambe le svolte, ma mi piacerebbe che le persone fossero oneste al riguardo. Se decidi che la politica di partito è la via più promettente, semplicemente non credi più nell’anarchismo e in un approccio rivoluzionario. Termini come «riformismo radicale» o «rivoluzione come processo piuttosto che come rottura» sono ossimori che confondono il dibattito politico. Diventa poco chiaro quale sia la reale posizione delle persone quando si aggrappano a un’identità radicale solo per motivi nostalgici o per la propria immagine di sé. Credo che gli autoritari siano più onesti, ma forse è più facile per loro: la loro identità radicale sembra ancora credibile, hanno solo sostituito la A-cerchiata con la falce e il martello.
In ogni caso, anche se potrei sembrare molto critico nei confronti di molti aspetti dell’anarchismo, non ho seguito nessuna delle svolte citate e non ho intenzione di farlo. Sento un forte bisogno di politica rivoluzionaria che nessun «socialismo democratico» può soddisfare, e credo che l’avanguardismo sia un vicolo cieco. È questo che mi rende ancora un anarchico. Penso che l’anarchismo abbia una risposta migliore degli autoritari e dei riformisti su come superare le strutture di oppressione e sfruttamento? No. Ma credo che l’anarchismo fornisca una base migliore per trovare tali risposte. Alla fine, possono essere trovate solo nell’azione collettiva; le nostre discussioni su come superare le strutture di oppressione e sfruttamento devono essere legate a forme di pratica politica. Questo è uno dei punti di forza dell’anarchismo. Anche se il concetto di «diversità di tattiche» è così vago da diventare facilmente privo di significato,




non c’è nulla di sbagliato nella diversità. Un movimento rivoluzionario ha bisogno sia di forme efficaci di resistenza sia di esperienze per creare forme diverse di relazioni sociali, economiche e culturali. L’anarchismo ha una ricca storia in questo senso, a cui possiamo attingere. Ma le forme di resistenza e le esperienze devono essere legate insieme in uno sforzo collettivo per tracciare un percorso rivoluzionario. Le “singolarità” da sole non bastano: saranno sempre superate dalle complesse reti di potere che governano le nostre vite.
Credo che ci siano parecchi anarchici con opinioni simili. Nei Paesi nordici e di lingua tedesca, dove osservo più da vicino le scene anarchiche, «organizzarsi come anarchici» è certamente diventato un tema molto discusso negli ultimi anni, con una serie di progetti concreti ad esso legati. Questi progetti possono, per ora, essere piccoli e limitati, ma non credo sia questo l’importante. Visto che me lo chiedi, sì, mi piacerebbe vederne di più, ma la vita non è una ciotola di ciliegie. Tuttavia, abbiamo ancora un certo slancio e sta a noi sfruttarlo al meglio. Il tempo ce lo dirà.
MW: Puoi dirci qualcosa di più su alcuni di questi progetti concreti? E delle discussioni che hanno portato alla loro realizzazione. Abbiamo visto che molte persone che condividono alcune delle tue critiche e preoccupazioni sul passato recente dell’anarchismo sono arrivate ad accettare la necessità di alcuni livelli di «verticalità» - che si tratti di partiti politici o di organizzazioni e reti più gerarchiche. Di certo, non ho visto molti esempi teorici o empirici di superamento della prassi sviluppata dal movimento dei movimenti, da Occupy e così via, senza superare anche quelle che suggerisci essere alcune caratteristiche fondamentali dell’anarchismo. È interessante anche il fatto che queste conversazioni non sembrano avvenire in molti spazi. Forse sono troppo lontano dall’avanguardia dell’anarchismo! Ma non vedo alcuno sforzo concertato per valutare criticamente gli ultimi decenni e per vedere come potrebbe evolvere l’anarchismo in futuro.
GK: Non credo nemmeno io di essere collegato all’avanguardia dell’anarchismo. Ce n’è una? Ciò a cui mi sento legato sono i dibattiti nei Paesi nordici e nel mondo di lingua tedesca, e lì vedo un certo sviluppo. (Forse il Corbynismo ha portato a una situazione particolare nel Regno




Unito, ma questo spetta ad altri dirlo). Come ho già detto, questi progetti sono piccoli e limitati, ma posso essere più concreto.
In Germania, negli ultimi anni sono stati fondati almeno tre progetti che cercano di affrontare l’organizzazione da una prospettiva anarchica e senza verticalità. C’è Die Plattform, che, non è difficile da intuire, è un’organizzazione piattaformista; c’è anarchismus.de, un progetto anarco-comunista che unisce il lavoro tradizionale della comunità (centri sociali, tavoli informativi e simili) con l’esperienza della «Generazione Z» sui social media; e c’è Perspektive Selbstverwaltung (Prospettiva di autogestione), che si colloca a cavallo tra comunismo di sinistra e anarchismo. Non sono in grado di valutare e confrontare questi progetti. Inutile dire che ognuno di loro incontra dei problemi, non tutti la pensano allo stesso modo e devono affrontare una buona dose di critiche. Ma indicano che la gente cerca alternative sia al Partito della Sinistra, sia a gruppi maoisti come lo Jugendwiderstand (ora sciolto, ma piuttosto popolare per alcuni anni), sia all’ambiente insurrezionalista. Penso anche che l’ascesa della FAU anarcosindacalista negli ultimi anni, in particolare a Berlino, è collegata a questo.
Per quanto riguarda i Paesi nordici, le prove che ho sono più circostanziali. Una discussione alla Fiera del Libro Anarchico di Stoccolma, qualche anno fa, sulla questione «Perché non c’è un’organizzazione anarchica in Svezia?» è stata molto partecipata, e un popolare podcast anarchico voleva fare un programma sull’argomento prima che gli sforzi concertati dell’estrema destra contribuissero a chiuderlo. C’è anche una nuova «Associazione anarchica» a Stoccolma - al momento si occupa principalmente di presentazioni di libri e simili, ma l’intenzione è quella di facilitare l’organizzazione anarchica. Anche all’interno del SAC, la seconda organizzazione sindacale libertaria più grande d’Europa dopo la CGT in Spagna, sono presenti marcate fazioni anarchiche.
Se guardiamo ai vicini della Svezia, il mio testo Rivoluzione è più di una parola: 23 Tesi sull’Anarchismo, che include alcune delle idee che stiamo discutendo qui, è stato tradotto sia in danese che in finlandese e, da quello che so, ci sono stati gruppi di discussione. Chissà a cosa porterà (e può portare) tutto questo, ma per me è un’indicazione del fatto che un numero sempre maggiore di persone nell’ambiente anarchico riflette sulle forme anarchiche di organizzazione.
Non so se gli Angry Workers possano essere considerati un esempio nel Regno Unito. I loro sforzi organizzativi hanno chiaramente una dimensione anarchica, anche se si definiscono comunisti di sinistra.
Le tendenze ci sono, i movimenti di massa no. Torniamo alla strategia.



MW: È una panoramica molto interessante e credo che la sintesi dica molto: come dici tu, le tendenze ci sono, ma dobbiamo cercarle. Credo sia giusto dire, però, che non c’è più un movimento di massa di ispirazione anarchica, e certamente non c’è nulla che, a differenza del recente passato, fosse inevitabile, anche per il mainstream. Mi ero già imbattuto nelle tue 23 Tesi sull’anarchismo e ricordo di aver pensato: finalmente qualcuno riconosce quello che sta succedendo. Per me, questa è stata la caratteristica più curiosa dell’ultimo decennio: il mancato riconoscimento di ciò che è accaduto al secolo anarchico.
Nel Regno Unito c’è stata un’enorme quantità di azioni che sono scoppiate durante il Covid, fornendo alcuni esempi sorprendenti di mutuo aiuto. Molti di questi hanno attinto all’esperienza di altre forme di organizzazione anarchica e hanno utilizzato alcune infrastrutture, come i centri sociali, con grande efficacia. Come sempre, quando lo Stato fallisce, i cittadini sono più che capaci di agire a livello locale. Ma credo che la dinamica più ampia della pandemia abbia contribuito a consolidare in alcuni la sensazione che l’anarchismo abbia i suoi limiti e che gli Stati siano necessari per momenti come questo, se non altro. La gente ha già dimenticato l’aiuto reciproco che ha permesso di sfamare le persone quando lo Stato e il mercato non riuscivano a tenere il passo, ma nessuno dimenticherà la creazione dei vaccini, i programmi di sperimentazione a livello nazionale, persino il potere dello Stato di imporre i lockdown. Non dico che la sinistra non anarchica non abbia criticato il ruolo dello Stato nell’affrontare questo problema, ma credo che abbia dato più peso ad alcune posizioni politiche che ad altre.
L’ovvio parallelo è il cambiamento climatico e la percezione della necessità di qualcosa di potente e di vasta portata come l’intervento dello Stato per affrontarlo. E ho ovviamente sentito persone che hanno richiamato il Covid per rafforzare questa affermazione. Presumo che tu abbia sentito argomenti simili, anche da persone che rifiutano lo Stato. La mia sensazione è che sempre più persone si stiano avvicinando a questa posizio-



ne. Che cosa diresti a quelle persone che in genere simpatizzano con l’anarchismo, ma che si aprono sempre più al dialogo con lo Stato?
GK: Wow, c’è molto in quello che dici.
Ho già detto che il secolo anarchico è stato finora piuttosto deludente. La terra sta morendo, il neoliberismo è saldamente al suo posto e se esiste una resistenza significativa ad esso, viene dall’estrema destra e non dall’estrema sinistra. Il momento che c’era quando David Graeber e Andrej Grubacic scrissero l’omonimo saggio nel 2004 è passato. Per questo ci sono ragioni esterne (l'11 settembre, la repressione di Stato, il capitalismo globalizzato e altre) e interne (la mancanza di una visione e di una strategia comuni). Quindi, hai ragione: non ci sono movimenti di massa di ispirazione anarchica. Perché non si riesce a riconoscerlo? Non lo so. In parte, si vuole credere di essere più significativi di quello che si è (il che, ammettiamolo, è umano ed è anche un requisito per rimanere motivati), e in parte perché la zona di comfort subculturale è per un certo numero di anarchici più importante dell’analisi politica (anche questo è umano, non sto cercando di distruggere il lifestylism, è un dibattito stanco).
Ciò non significa che l’anarchismo sia privo di influenza. Anzi, l’influenza che l’anarchismo ha è spesso grossolanamente sottovalutata. Prendiamo in esame tre argomenti che oggi fanno parte del mainstream liberale: il veganismo, la diversità di genere e (permettetemi l’abbreviazione) la politica dell’identità. Un paio di decenni fa, questi argomenti venivano discussi solo in ambienti marginali, in cui gli anarchici avevano un ruolo chiave. Se si va indietro nella storia, si trovano molti altri esempi di questo tipo, dalla giornata lavorativa di otto ore al diritto all’aborto, all’educazione antiautoritaria. Il problema è che, mentre vengono incorporati nel mainstream liberale, i temi perdono il loro potenziale rivoluzionario. Varrebbe la pena discutere se questo sia dovuto al fatto che non c’è mai stato insito un grande potenziale rivoluzionario, o se il processo di adattamento liberale lo uccida, ma lasciamo questo argomento per un’altra volta. Il fatto è che gli anarchici hanno un’influenza, solo non in modo rivoluzionario. Questa è una delle questioni chiave che dobbiamo risolvere se vogliamo lanciare una sfida più grande al potere.
Il Covid e lo stato: anche in questo caso, mi concentrerò sulle regioni che conosco meglio. Nei Paesi nordici non ci sono state grandi divisioni sociali intorno alla questione. Ci sono stati approcci diversi (la Svezia è rimasta molto più aperta dei suoi vicini), ma la forte fidu-




cia nelle istituzioni statali che caratterizza i Paesi nordici ha fatto sì che i cittadini, con poche eccezioni, seguissero le raccomandazioni e le regole dei rispettivi governi. In Germania e Austria è stato molto diverso. Qui c’erano enormi divari sociali. In particolare, sono state tagliate le tradizionali categorizzazioni destra/sinistra: sono state le forze di destra a sfidare l’autorità dello Stato, mentre la sinistra si è stretta attorno allo Stato. (In larga misura si è trattato di una reazione alla risposta della destra, il che, purtroppo, dimostra che gran parte della politica di sinistra oggi è diventata una reazione impulsiva a qualsiasi cosa accada a destra. Rimane ben poco della propria agenda). A loro merito, alcuni anarchici dei Paesi di lingua tedesca hanno cercato di evitare la trappola del «o stai con lo Stato o stai con l’estrema destra» nel tentativo di sviluppare posizioni proprie, ma è difficile in un ambiente in cui si viene facilmente accusati di diffondere teorie cospirative o di aiutare i matti di destra, soprattutto quando è fin troppo facile alimentare troll che non si vogliono alimentare. Suppongo che sia il tipo di dibattito che oggi si definisce «tossico». In ogni caso, non sono sicuro che lo Stato sia uscito rafforzato dalla pandemia, si è anche fatto molti nemici - ma, sì, a quanto pare si è fatto molti nuovi amici a sinistra, anarchici compresi.
Ma cos’è lo Stato? I più intelligenti tra i nostri scienziati politici non hanno ancora una definizione comune. Credo che la pandemia abbia dimostrato che è necessario un certo livello di centralizzazione per amministrare le società di massa in cui viviamo. Ma la pandemia non è l’unica a dimostrarlo. C’è, ovviamente, la crisi climatica, ma è sufficiente guardare a molti dei compiti quotidiani di cui dobbiamo occuparci collettivamente: produzione e distribuzione di cibo, servizi sanitari, trasporti, energia e via di seguito. Tutti questi richiedono istituzioni in qualche modo centralizzate, ma queste istituzioni devono per forza assomigliare a uno Stato, che (in quasi tutte le definizioni) è associato a un’autorità su un particolare territorio, a un monopolio della violenza, a diritti esclusivi di cittadinanza, e non solo all’istituzionalizzazione di compiti particolari, ma al potere politico in generale? Non credo, e non credo che questo sia ciò che la gente si porta dietro da un’esperienza come quella della pandemia o della crisi climatica. Ciò che le persone portano con sé è che «siamo tutti coinvolti» e che abbiamo bisogno di soluzioni per tutti. Il tipo di anarchismo che rifiuta di impegnarsi nella ricerca di soluzioni di questo tipo perché considera l’intero quadro oppressivo non troverà molti seguaci. Ma questo non è il solo tipo di anarchismo. Con il rischio di sfruttare eccessivamente gli esempi che seguono, in Chiapas o in




Rojava vediamo esperimenti di strutture consiliari che svolgono compiti di Stato nazionale senza riprodurlo in quanto tale. È qui che inizia l’eccitazione. E sì, si potrebbero citare molti esempi di aiuto reciproco che si manifestano nei momenti di crisi, ma non solo: c’è ancora molto mutuo aiuto anche nella vita quotidiana. È ridicolo indicare solo le carenze del Chiapas o del Rojava per screditare subito questi tentativi su larga scala. Costruire una nuova società non è come collegarsi all’ultimo servizio di messaggistica sul telefono, che o funziona o non funziona. È un processo lungo, difficile, faticoso e sporco, ma, ancora una volta, la vita non è una ciotola di ciliegie. Mi rifiuto di credere che l’anarchismo non possa fornire risposte, ma richiede un duro lavoro collettivo per trovarle.
MW: Grazie Gabriel, c’è molto su cui riflettere. Cercando di riassumere, mi chiedo se esista un processo inevitabile che potrebbe essere utile delineare, che si basa su un livello di spostamenti dialettici o iterativi tra movimenti di massa e attività più disperse, ma forse più durature. I primi, mi sembra, coinvolgono più persone e sono molto più visibili, ma si basano anche su un’analisi più semplicistica che può risultare rapidamente soddisfacente e gratificante - un approccio più populista, suppongo. Poi c’è il lavoro più concreto, le cose quotidiane che non ricevono lo stesso livello di attenzione, ma che forse incorporano la teoria e la pratica anarchica in modo più profondo. Alcuni di questi, come dici tu, potrebbero trovarsi in contesti più mainstream, ma penso che si possa vedere l’influenza della prassi anarchica anche in parti, ad esempio, del movimento cooperativo e di altri spazi più «amichevoli». Una domanda che mi pongo, quindi, pensando con il mio cappello accademico, è come contribuire a rendere visibile questo lavoro e come mantenere vivo l’anarchismo senza - o fino al prossimo ciclo di - mobilitazioni di massa. Suppongo che la mia domanda finale sia rivolta più che altro al probabile pubblico di questa rivista: in futuro, cosa vorreste vedere in termini di lavoro intellettuale? Cosa possono fare ora gli accademici per mantenere vivo almeno qualcosa del secolo anarchico?
GK: Prima di tutto, questo è un modo intelligente di collegare la prassi anarchica e gli spazi amichevoli. Di solito penso che se gli spazi anarchici



fossero amichevoli, avremmo già fatto un grande passo avanti. Ma questa non era la tua domanda. Pensandoci bene, potrei divagare perché la tua domanda mi porta sul filo del rasoio. Una volta, ho deciso consapevolmente di non intraprendere una carriera accademica e da allora ho lasciato quel mondo a quelli che ne fanno parte. Sembra che si possa perdere solo parlandone dall’esterno. D’altra parte, sono già stato definito «eccessivamente diplomatico», quindi forse posso salvarmi la pelle. Proviamoci.
Partiamo dall’ovvio: le università sono territori politicamente contesi e più complici abbiamo lì, meglio è. È importante avere concorrenti forti in quella che avremmo potuto chiamare «battaglia discorsiva» prima che ci fossero buone ragioni per non usare più il «post-lingo» [gergo, lingua convenzionale, ndt]. Inoltre, anche se il novanta per cento di ciò che accade nelle scienze sociali e umane è piuttosto insignificante, ci sono anche cose molto importanti. Le «guerre culturali» non sono uno scherzo, e gli accademici possono avere una grande influenza politica, sia a destra che a sinistra. Una persona come Judith Butler ha plasmato il pensiero di molte persone che non l’hanno mai sentita nominare. È fondamentale, naturalmente, che la teoria politica si sviluppi parallelamente alla lotta politica. In particolare, quasi tutti i teorici radicali storicamente più importanti non erano accademici ma rivoluzionari, che si guardi a Vladimir Lenin, Frantz Fanon, Abdullah Öcalan o praticamente a qualsiasi anarchico noto. (Forse non è una coincidenza che i due anarchici più noti degli ultimi cinquant’anni, Noam Chomsky e David Graeber, abbiano lavorato nel mondo accademico. I tempi stanno cambiando, nel bene e nel male). Le cose possono diventare difficili con chi si autoproclama radicale nel mondo accademico, quando sentono che gli altri contrappongono «accademici» e «attivisti». «Beh, lei non sa cosa facciamo!» è una risposta che ho sentito abbastanza spesso. Ed è vero: io non so cosa facciano. Ma dall’esterno, la quantità di articoli scritti sull’azione radicale sembra sproporzionatamente più alta dell’azione radicale stessa. Spesso sembra anche che il mondo accademico come istituzione risucchi le persone, a prescindere da quanto siano radicali le loro convinzioni. Un semplice esempio: secondo la mia esperienza, alcune delle persone peggiori con cui avere a che fare nel contesto dell’azione politica sono gli accademici. Le e-mail e i messaggi non ricevono risposta e, se la ricevono, le risposte sono brevi al punto da essere irrilevanti. Mi è stato detto che gli accademici ricevono centinaia di e-mail e messaggi al giorno e non riescono a starci dietro. Ci può stare. Ma comunque ciò significa che è difficile organizzarsi con persone che non riescono a mantenere il livello più elementare di corrispondenza. Questo è ciò che intendo con «farsi risucchiare»: per mantenere il proprio posto




nell’istituzione, si devono stabilire priorità che non conducono necessariamente all’azione politica. Accettano anche un contesto che non è necessariamente favorevole all’anarchismo (gerarchie legate all’ambiente di lavoro, inquadramento, formalità, burocrazia, etc.). Non vedo gli autoproclamati radicali del mondo accademico sfidare molto questo aspetto, ma, ancora una volta, forse mi sfugge qualcosa, e dovremmo tutti lavorare su un migliore scambio tra l’interno e l’esterno per capirci meglio. Ma credo che dobbiamo convenire che dove Marx ha ragione, ha ragione: non basta interpretare il mondo, bisogna cambiarlo.
Per quanto riguarda la sopravvivenza dell’anarchismo, non credo che ci si debba preoccupare. Esiste da oltre 150 anni e non scomparirà presto. Come ho accennato prima, credo che la nostra preoccupazione debba essere quella di migliorarlo. Prepararsi a momenti di mobilitazione di massa è una parte importante. Se c’è un’idea su cosa fare in quei momenti e se c’è la capacità organizzativa per farlo, gli anarchici possono essere un fattore cruciale per indirizzare questi momenti in direzione emancipatoria. Gli anarchici hanno un sacco di esperienze a cui attingere, devono solo collegarle tra loro. Non si tratta di un’avanguardia, nessuno guiderà nessuno, ma di gruppi di rivoluzionari impegnati che siano pronti per il momento rivoluzionario e che sappiano quali mosse fare quando è il momento. In un mondo grande e con grandi sfide, dobbiamo continuare a pensare in grande, non c’è niente altro da fare.
Gabriel Kuhn è uno scrittore, traduttore e organizzatore sindacale di origine austriaca che vive in Svezia. Fra le sue pubblicazioni in inglese troviamo All Power to the Councils! (PM, Oakland 2012), Antifascism, Sports, Sobriety (PM, Oakland 2017) e Liberating Sápmi (PM, Oakland 2020). In italiano Straight Edge. Storie, filosofia e racconti della scena hardcore punk (ShaKe, Milano 2011) e La vita all’ombra del Jolly Roger (elèuthera, Milano 2018). Per maggiori informazioni sul suo lavoro www.lefttwothree.org.
Matthew Wilson è un accademico e un attivista, che usa entrambi i ruoli per esplorare il potenziale contro-egemonico del movimento cooperativo. Il suo libro Rules without Rulers è pubblicato da Zero Press e ha scritto per molti forum di base come STIR e DOPE. Fra le sue pubblicazioni in italiano Discorso sull’autogoverno (elèuthera, Milano 2022).
Traduzione di Marco Antonioli Pubblicato online nel sito: The Anarchist Library Anarchist Studies 31.1 © 2023 ISSN 2633 8270



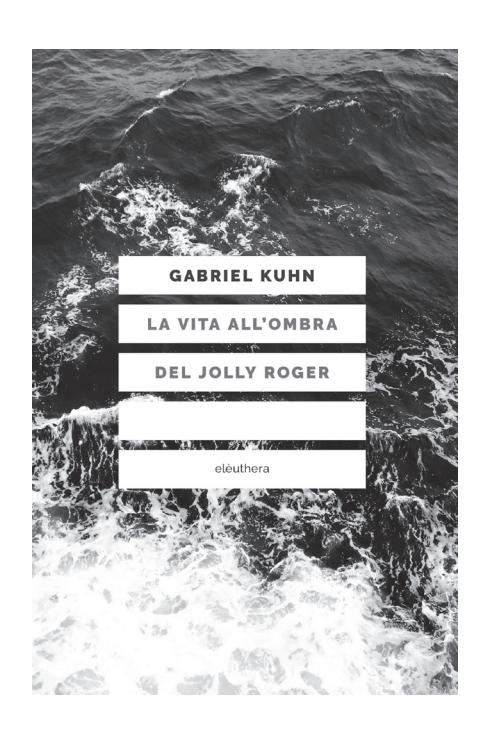
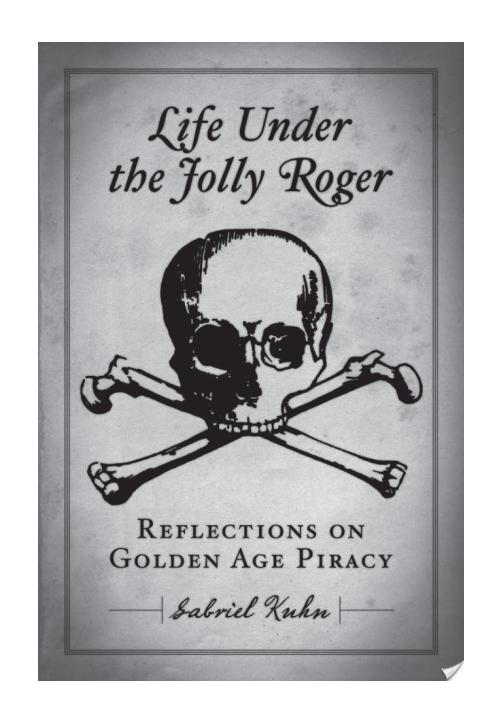
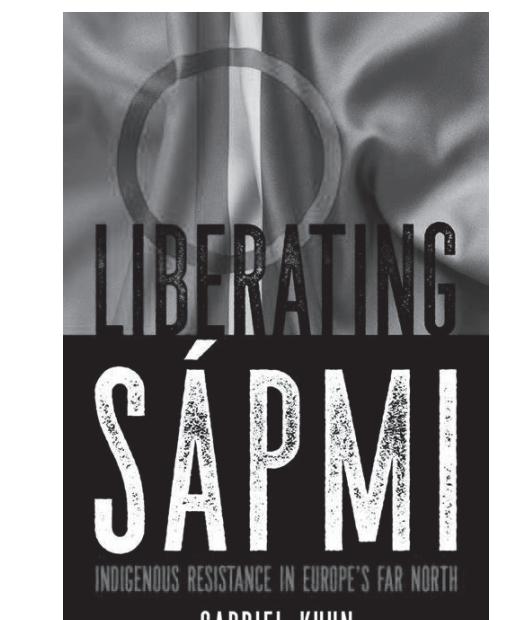
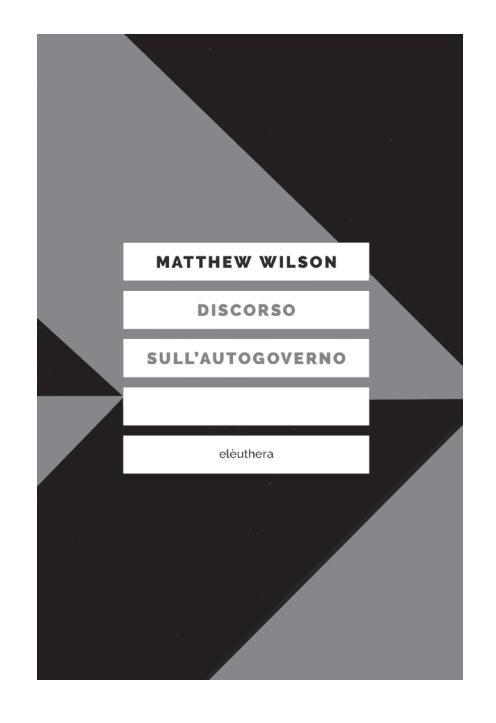




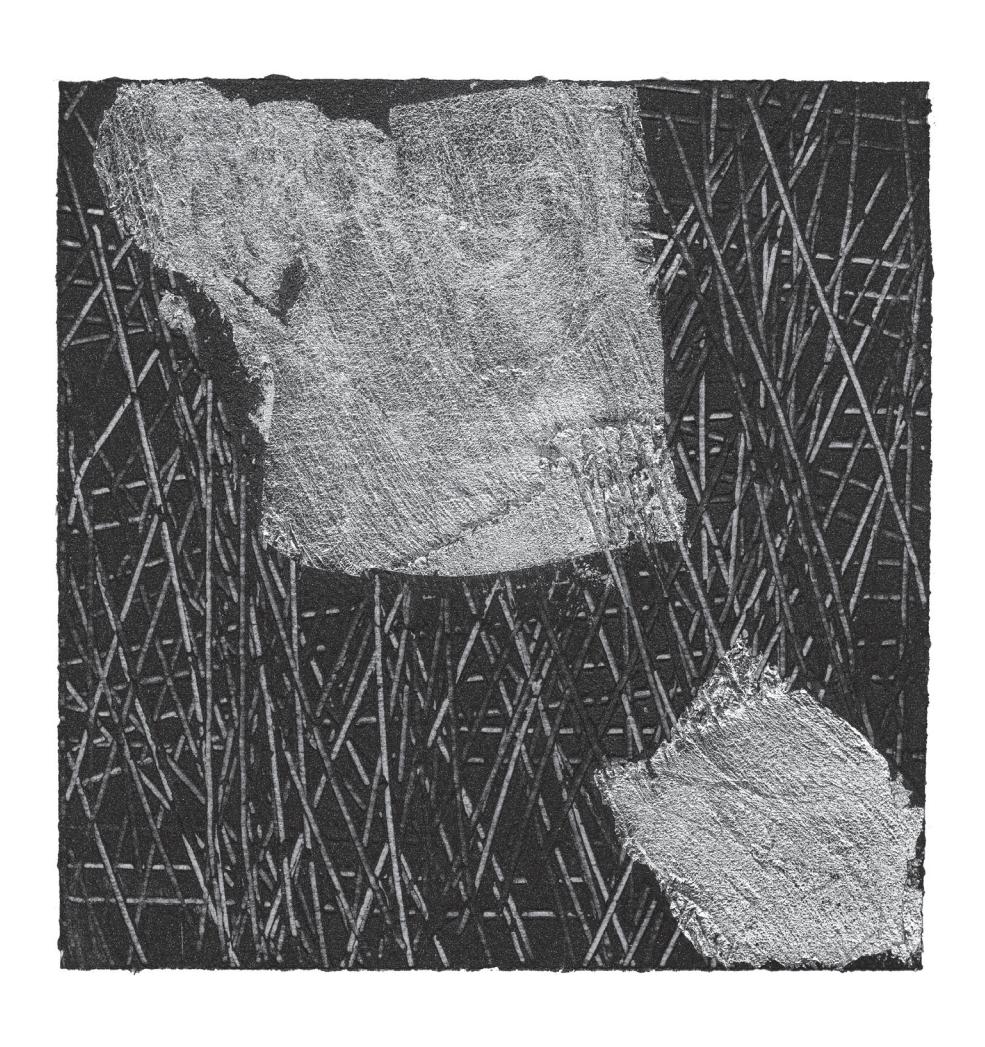




John Dewey e David Graeber Elementi di democrazia radicale nel pensiero pragmatista e anarchico
Martin Bartenberger
Quando si pensa all’idea di democrazia radicale, gli scritti di John Dewey non sono probabilmente il primo esempio che viene in mente. Il suo concetto di democrazia è stato invece spesso liquidato come «liberale» (Talisse 2007) o come un primo esempio di democrazia deliberativa (cfr. Bacon 2010). A fronte di queste nozioni, in questo articolo voglio esplorare la natura radicale della narrazione deweyana della democrazia. La mia tesi principale è che gli elementi radicali vengono in primo piano se analizziamo il concetto di democrazia di Dewey nel suo contesto storico. Questo può aiutarci a capire il suo concetto di democrazia radicale per quello che era: un intervento nel dibattito sul ruolo della democrazia per la sinistra. Partendo da questi presupposti, sviluppo e difendo la tesi che l’idea di democrazia di Dewey è radicale nella misura in cui è stata concepita contro una concezione marxista ortodossa della rivoluzione e della trasformazione sociale. L’articolo si conclude delineando come questo rifiuto del marxismo ortodosso avvicini Dewey a un resoconto anarchico della democrazia radicale, così come è stato recentemente formulato da David Graeber (2013), ed evidenziando i parallelismi tra i concetti di democrazia radicale di Dewey e di Graeber per quanto riguarda la priorità dei mezzi sui fini, il ruolo della deliberazione e la necessità di una riforma istituzionale.




La democrazia radicale in Dewey
Nel gennaio 1937 Dewey pubblicò sulla rivista «Common Sense» un saggio poco conosciuto dal titolo La democrazia è radicale. La missione di «Common Sense» è stata descritta da uno dei suoi redattori come quella di «trovare un posto indipendente sia dal vecchio liberalismo sia dal marxismo intellettuale di recente moda» (Strassel 2007: 4) e, come sosterrò più avanti, l’articolo di Dewey può essere letto anche come un tentativo di lasciarsi alle spalle questo dualismo.
In La democrazia è radicale Dewey inizia facendo esplicito riferimento a questo contesto, evidenziando le profonde differenze intellettuali e strategiche della sinistra negli anni Trenta:
«Tra i gruppi di sinistra c’è relativamente poca differenza per quanto riguarda i fini sociali da raggiungere. C’è una grande differenza sui mezzi con cui questi fini dovrebbero essere raggiunti e con cui pos- sono essere raggiunti» (Dewey 1987: 296).
Dewey condivide la critica diffusa delle democrazie «borghesi» e riconosce che
«L’ascesa dei governi democratici ha accompagnato il trasferimento del potere dagli interessi agrari a quelli industriali e commerciali» (ibid.).
In questo senso, egli rifiuta anche il liberalismo europeo che si limita a «sforzarsi di ottenere il massimo dell’azione economica individualistica con un minimo di controllo sociale» (ibid.). Poi contrappone questa insufficiente versione europea del liberalismo alla più radicale versione americana:
«Negli Stati Uniti il liberalismo ha un’origine, un’impostazione e un obiettivo diversi. È fondamentalmente un tentativo di realizzare modi di vita democratici nel loro pieno significato e nella loro ampia portata» (ibid.: 298).
Sebbene l’argomentazione di Dewey possa essere considerata anche una difesa del liberalismo radicale (cioè americano), egli preferisce parlarne in termini di democrazia. Dewey si spinge fino a mostrare come l’essenza della democrazia radicale possa essere identificata nell’enfasi primaria sui mezzi democratici:
«I mezzi a cui si dedica [la democrazia, NdA] sono le attività volon- tarie degli individui in opposizione alla coercizione; sono assenso e consenso in opposizione alla violenza; sono la forza dell’organizza- zione intelligente contro quella dell’organizzazione imposta dall’e- sterno e dall’alto. Il principio fondamentale della democrazia è che i fini della libertà e dell’individualità di tutti possono essere raggiunti solo con mezzi conformi a tali fini» (ibid.).



Suggerire che questo principio fondamentale della democrazia possa essere temporaneamente sospeso, ad esempio dalla dittatura di una classe, è per Dewey una «ipocrisia intellettuale e una contraddizione morale» (ibid.). Nel concludere il suo breve saggio, Dewey offre infine tre ragioni per cui una simile idea della democrazia può essere considerata radicale. In primo luogo, perché stabilisce un fine radicale
«che non è stato adeguatamente realizzato in nessun Paese in nes- sun momento» (ibid.: 299).
Questa idea è stata elaborata in modo esauriente nelle osservazioni conclusive di un articolo molto più importante di Dewey sulla democrazia creativa:
«Poiché non può avere fine finché l’esperienza stessa non avrà fine, il compito della democrazia è sempre quello di creare un’esperienza più libera e più umana, alla quale tutti partecipano e alla quale tutti contribuiscono» (Dewey 1998: 343).
In altre parole, la democrazia è radicale per Dewey perché non ha un punto di arrivo che possa essere «raggiunto». Si tratta invece di un processo infinito in cui le condizioni della democrazia devono essere continuamente esercitate e perfezionate attraverso la creatività e l’intelligenza collettiva. In secondo luogo, una tale concezione della democrazia è radicale perché
«richiede un grande cambiamento nelle istituzioni sociali, economi- che, legali e culturali esistenti» (Dewey 1987: 299).
In terzo luogo, per Dewey non c’è
«nulla di più radicale dell’insistenza sui metodi democratici come mezzo per realizzare cambiamenti sociali radicali».
Tanto più che «ora abbiamo le risorse per avviare un sistema sociale di sicurezza e opportunità per tutti» (ibid.). L’insieme di queste ragioni evidenzia come Dewey sia giunto al verdetto che la democrazia è un’impresa fondamentalmente radicale. La sezione successiva farà luce sul contesto storico di queste idee e discuterà di come la concezione della democrazia di Dewey sia stata ulteriormente elaborata in un dibattito




con uno dei più importanti pensatori e praticanti politici radicali del suo tempo. Nell’aprile del 1937, pochi mesi dopo la scrittura del suo breve saggio La democrazia è radicale, Dewey divenne presidente della Commissione d’inchiesta sulle accuse mosse a Leon Trotsky nel processo di Mosca (cfr. Farrell 1950).
I suoi incontri con Trotsky in Messico portarono a un dibattito tra i due pensatori sul ruolo dei mezzi e dei fini per la trasformazione sociale, che oggi sembra essere quasi dimenticato. Ma per noi questo dibattito è di estremo interesse perché illumina il contesto storico in cui Dewey ha formulato la sua idea di democrazia radicale. Nel saggio La loro morale e la nostra, scritto nel febbraio 1938, Trotsky espone la sua concezione della morale per respingere l’idea che lo stalinismo e il trotskismo siano essenzialmente sostenuti dallo stesso amoralismo marxista1 . Egli rifiuta la massima secondo cui il fine giustifica tutti i mezzi e la contrappone alla sua concezione dell’interdipendenza dialettica tra fine e mezzi:
«Un mezzo può essere giustificato solo dal suo fine. Ma il fine a sua volta deve essere giustificato. Dal punto di vista marxista, che espri- me gli interessi storici del proletariato, il fine è giustificato se porta ad aumentare il potere dell’umanità sulla natura e sugli interessi sto- rici del proletariato e ad abolire il potere di una persona sull’altra» (Trotsky 1979: 48).
Secondo questa concezione, un mezzo è consentito solo se «conduce realmente alla liberazione dell’umanità» (ibidem). Trotsky afferma inoltre che questo è un fine che può essere raggiunto solo attraverso la rivoluzione e che la morale liberatrice del proletariato
«deduce una regola di condotta dalle leggi dello sviluppo della so- cietà, quindi in primo luogo dalla lotta di classe, la legge di tutte le leggi» (ibid.).
Nella sua risposta Mezzi e fini, scritta nel luglio 1938, Dewey concorda con l’opinione di Trotsky secondo cui mezzi e fini sono interdipendenti. Ma la sua posizione si presenta sotto forma di un consequenzialismo più rigoroso:
«Ritengo che il fine, nel senso di conseguenze, sia l’unica base per le idee e le azioni morali, e quindi l’unica giustificazione che si possa trovare per i mezzi impiegati» (Dewey 1979: 68).



1 Ironicamente Trotsky illustra queste accuse portando come esempio il «mensile americano completamente volgare e cinico» «Common Sense», la stessa rivista in cui fu pubblicato il saggio di Dewey La democrazia è radicale (Trotsky 1979: 15).

Secondo Dewey, Trotsky ha violato i suoi stessi principi di interdipendenza e consequenzialità introducendo esternamente la lotta di classe come legge della società.
«Perché la scelta dei mezzi [per Trotsky, NdA] non è decisa sulla base di un esame indipendente delle misure e delle politiche rispetto alle loro effettive conseguenze oggettive. Al contrario, i mezzi sono “dedotti” da una fonte indipendente, una presunta legge della storia che è la legge di tutte le leggi dello sviluppo sociale» (ibid.: 70).
La posta in gioco non è che Dewey rifiuti la lotta di classe come possibile via per raggiungere un certo fine, ad esempio la liberazione dell’umanità. Invece, egli confuta l’assolutismo dogmatico che elude il principio rigoroso del consequenzialismo:
«La posizione che ho indicato come quella di un’autentica interdipen- denza tra mezzi e fini non esclude automaticamente la lotta di classe come uno dei mezzi per raggiungere il fine. Ma esclude il metodo de- duttivo per arrivarci come mezzo, per non dire che è l’unico mezzo. La scelta della lotta di classe come mezzo deve essere giustificata, sulla base dell’interdipendenza tra mezzi e fini, da un esame delle conse- guenze effettive del suo uso, non in modo deduttivo» (ibid. 71).
Nel difendere la stretta interdipendenza tra mezzi e fini, Dewey difende ed elabora anche il suo concetto di democrazia radicale. Suggerisco quindi che il concetto di democrazia radicale di Dewey come interdipendenza consequenziale e infinita di mezzi e fini dovrebbe essere intesa come una reazione al marxismo ortodosso. Mentre Trotsky ha sostenuto che la sua versione del marxismo è fondamentalmente diversa dallo stalinismo, Dewey rifiuta questa differenziazione quando sottolinea il loro terreno comune:
«Sembra esserci un curioso trasferimento di fedeltà tra i marxisti ortodossi dagli ideali del socialismo e dai metodi scientifici per raggiungerli […] alla lotta di classe come legge del cambiamento storico» (ibid.: 73).
Dopo aver presentato questo contesto storico, sarebbe probabilmente una procedura standard etichettare le idee di Dewey come un classico esempio di antimarxismo di un socialista democratico. Credo che ci siano due punti che ci ricordano di fare attenzione a trarre conclusioni così rapide. In primo luogo, vi sono alcune sorprendenti analogie tra l’argomentazione di Dewey e il pensiero di Marx che confutano la semplice tesi antimarxista2 . In secon-



2 Non posso approfondire queste analogie in questa sede, poiché ho deciso di concentrarmi sull’anarchismo. Basti dire che soprattutto la connessione storica tra capitalismo e democrazia liberale, la comprensione del liberalismo europeo come una nuova forma di oppressione (di classe) (con diversi vantaggi rispetto al feudalesimo, però) e il carattere aperto e incompiuto di un progetto comunista/democratico mi sembrano similitudini nel pensiero di Marx e Dewey. Per un confronto più generale si veda Cork (1950).

do luogo, è importante notare che una critica del marxismo ortodosso, così come viene portata avanti da Dewey, non è necessariamente anti-marxista. Come dimostra l’esempio del marxismo occidentale, una simile critica può essere sviluppata anche su basi marxiste (cfr. Anderson 1976). La prossima sezione si propone di cercare ulteriori prove a sostegno della tesi che la democrazia radicale di Dewey debba essere letta come una risposta al marxismo ortodosso, confrontandola con un’altra scuola di pensiero che si è sviluppata in contrasto con il dogmatismo marxista: l’anarchismo.
Democrazia pragmatica e anarchica a confronto
Negli ultimi anni David Graeber si è imposto come uno dei più importanti pensatori anarchici contemporanei, soprattutto dopo il suo importante coinvolgimento nel movimento Occupy Wall Street. Nel suo libro Progetto democrazia. Un’idea, una crisi, un movimento, Graeber ha recentemente presentato non solo un’analisi concisa del movimento Occupy, ma anche una storia e teoria della democrazia da una prospettiva anarchica che servirà da contrasto al concetto di democrazia di Dewey. Graeber definisce la democrazia non come una forma concreta di governo inventata nell’antica Grecia, ma come la convinzione
«che gli esseri umani sono fondamentalmente uguali e dovrebbero es- sere autorizzati a gestire i loro affari collettivi in modo egualitario uti- lizzando i mezzi che appaiono più favorevoli» (Graeber 2013: 184).
In quanto tale, la democrazia è considerata più simile a uno spirito o a una sensibilità antica «quanto la stessa intelligenza umana» (ibid.). Questa concezione ampia della democrazia porta a due conseguenze sorprendenti: in primo luogo, la democrazia non è considerata un ideale astratto, ma qualcosa che deve essere sperimentato e praticato. In secondo luogo, la democrazia
«non è necessariamente definita dal voto a maggioranza: è, piutto- sto, il processo di deliberazione collettiva sul principio della piena ed equa partecipazione» (ibid.: 186).
Per Graeber, questa è una concezione della democrazia che recentemente (e storicamente) è stata avanzata soprattutto dagli anarchici. Secondo la sua concezione, il fulcro della democrazia anarchica è che nessuno abbia la possibilità
«in qualsiasi momento, di chiedere a uomini armati di presentarsi e dire: “Non mi interessa quello che hai da dire su questo; stai zitto e fai quello che ti viene detto”» (ibid.: 188).
I paralleli con la concezione della democrazia di Dewey sono già evidenti




in queste poche osservazioni. Questi paragrafi conclusivi li discuteranno sulla base delle tre caratteristiche che per lui definiscono il carattere radicale della democrazia, come sopra delineato: (1) democrazia come processo senza fine, (2) democrazia che richiede una trasformazione radicale delle nostre istituzioni sociali e (3) democrazia come principio di raggiungimento di fini democratici solo con mezzi democratici.
La democrazia radicale come processo senza fine
Come Graeber, Dewey ha identificato la democrazia non come una forma di governo, ma come uno stile di vita che non può avere «fine finché l’esperienza stessa non giunge al termine» (Dewey 1998: 343). È quindi sbagliato, sia da una prospettiva pragmatista che anarchica, parlare di un’invenzione della democrazia, poiché in questo senso «la democrazia è vecchia come la storia» (Graeber 2013: 184). Se la democrazia non ha un inizio, non può nemmeno avere una fine. Sia Dewey che Graeber hanno quindi sottolineato che i processi democratici, vale a dire i processi di intelligenza e di indagine collettiva, non dovrebbero essere interrotti da semplici mezzi di potere. Mentre Graeber ha concettualizzato questo pensiero nell’idea anarchica di una società libera in cui è impossibile per chiunque chiamare uomini armati per mettere a tacere le voci dissenzienti, Dewey ha evidenziato la stessa idea come l’importanza di un’indagine costante e di uno sperimentalismo, dedicato a mezzi che siano:
«attività volontarie degli individui in opposizione alla violenza; […] assenso e consenso in opposizione alla violenza; […] la forza dell’or- ganizzazione intelligente contro quella dell’organizzazione imposta dall’esterno e dall’alto» (Dewey 1987: 298).
È inoltre sorprendente l’analogia nel modo in cui sia Dewey che Graeber hanno tradotto nella loro pratica (politica) l’idea teorica di democrazia come processo continuo di deliberazione (in cui tutti hanno il diritto di essere ascoltati). Mentre Graeber ha avuto un ruolo importante e di primo piano nel movimento di Occupy, una convinzione simile ha portato Dewey alla decisione di dirigere la commissione che ha esaminato le accuse contro Trotsky. Come disse durante la prima sessione di audizioni della commissione:
«Se alla fine ho accettato il posto di responsabilità che ora occupo, è stato perché mi sono reso conto che agire diversamente sarebbe stato falso nei confronti del mio lavoro di una vita» (Commissione preliminare d’inchiesta 1937: 5).




Democrazia radicale e istituzioni radicali
Come ricordiamo, il secondo criterio di Dewey per cui la democrazia è radicale è il fatto che «richiede un grande cambiamento nelle istituzioni sociali, economiche, legali e culturali esistenti» (Dewey 1987: 299). Graeber sottolinea analogamente l’importanza delle istituzioni democratiche come condizione necessaria per una democrazia radicale stabile e sostenibile. Con un linguaggio genuinamente pragmatico, egli pone al centro di ogni progetto democratico la seguente domanda:
«Quali accordi sociali sarebbero necessari per avere un sistema autentico, partecipativo e democratico che possa dedicarsi alla soluzione di problemi collettivi?» (Graeber 2013: 205).
Le risposte che Graeber e Dewey offrono a questa domanda sono straordinariamente simili, in quanto mettono al centro la deliberazione, l’improvvisazione e la risoluzione creativa dei problemi. Allo stesso modo, entrambi sono consapevoli del fatto che questi principi non possono prevenire completamente i conflitti o farli scomparire. Invece vedono i loro concetti di democrazia come un modo per affrontare tali conflitti. Come ha sostenuto Richard Bernstein:
«La questione principale […] è sempre il modo in cui rispondiamo al conflitto. Ed è qui che Dewey sottolinea il “ruolo della consul- tazione, della conferenza, della persuasione, della discussione nella formazione dell’opinione pubblica”» (Bernstein 2010: 85)3 .
Allo stesso modo, Graeber ha sottolineato come il suo approccio consideri i conflitti come processi di «risoluzione dei problemi piuttosto che come una lotta tra interessi fissi» (Graeber 2013: 205). Tuttavia, sia Dewey che Graeber non riescono a descrivere nel dettaglio queste istituzioni e le forme di organizzazione a cui potrebbero portare. Secondo entrambi gli autori, questo non è necessariamente un difetto della loro teoria, ma anzi deriva naturalmente da essa. Sebbene Graeber fornisca lunghi resoconti su come si possono organizzare i processi basati sul consenso, afferma anche di essere
«meno interessato a elaborare l’architettura dettagliata di una so- cietà libera piuttosto che a creare le condizioni che ci permettereb- bero di scoprirlo» (ibid.: 193).
In questo contesto la sua posizione sembra più coerente di quella di Dewey, che a volte si sposta su posizioni idealistiche e individualistiche



3 Bernstein cita il saggio di Dewey Democrazia creativa: i compiti che ci aspettano (Dewey 1998: 342).

per difendere la sua idea di democrazia come stile di vita che non può essere incasellato in un certo insieme di contesti istituzionali e organizzativi:
«Perché liberarsi dall’abitudine di pensare alla democrazia come a qualcosa di istituzionale ed esterno e acquisire l’abitudine di trattar- la come un modo di vivere personale significa rendersi conto che la democrazia è un ideale morale e, nella misura in cui diventa un fatto, è un fatto morale. È rendersi conto che la democrazia è una realtà solo in quanto è un luogo di vita comune» (Dewey 1998: 342).
Democrazia radicale, mezzi e fini
La terza caratteristica, per cui la democrazia era radicale per Dewey, era la conseguente interdipendenza tra mezzi e fini. Egli ha persino definito «principio fondamentale della democrazia» il fatto che «i fini della libertà e dell’individualità per tutti possono essere raggiunti solo con mezzi che si accordino con tali fini» (Dewey 1987: 298). È interessante notare che Graeber assegna lo stesso atteggiamento all’anarchismo e alla sua stessa concezione di democrazia radicale:
«Gli anarchici insistevano sul fatto che non solo il fine non giusti- fica i mezzi […] ma che non si raggiungeranno mai i fini a meno che i mezzi non siano essi stessi un modello del mondo che si vuo- le creare» (Graeber 2013: 190).
Proprio come Dewey, che sviluppò appieno questa idea nello scambio con il marxismo ortodosso personificato da Trotsky, anche Graeber sottolinea come sia stato il rifiuto del marxismo ortodosso (e del suo obiettivo di conquistare lo Stato) a innescare questa sensibilità anarchica per l’interdipendenza tra mezzi e fini. Ciò che è fondamentale notare, tuttavia, è che l’enfasi di Dewey e Graeber sui mezzi democratici per raggiungere fini democratici non solo condivide il rifiuto del marxismo ortodosso, ma anche una profonda critica del razionalismo. Nelle teorie razionaliste dell’azione, gli esseri umani hanno dei fini fissi e si limitano a contemplare i mezzi più efficienti e razionali per raggiungere questi scopi (Jonas 1993). Graeber rifiuta questa idea e critica le concezioni «razionali» della democrazia:
«Se definiamo la razionalità come un calcolo matematico distaccato che nasce dal potere di impartire comandi, questo tipo di “razionali- tà” inevitabilmente produrrà mostri. Come base per un vero sistema democratico, questi termini sono chiaramente disastrosi. Ma qual è l’alternativa? Come fondare una teoria della democrazia sul tipo di ragionamento che si svolge, invece, tra pari?» (Graeber 2013: 199).




Secondo Graeber, per rispondere a questa domanda è necessaria una forma più ampia di «ragionevolezza», che renda conto del modo in cui vengono fatti i compromessi e che abbandoni il livello formalizzato della stretta razionalità. Nel cercare una soluzione, fa riferimento alle critiche femministe alla ragione e alla razionalità e vi trova un «principio di ragionevolezza» basato sul consenso (ibid.: 202). Sostengo che potrebbe anche rivolgersi al pragmatismo per trovare ulteriori risorse per una critica democratica radicale della razionalità. Il punto di vista di Dewey sulla reciprocità tra mezzi e fini è fondamentale a questo proposito. Secondo lui:
«Non avere già in mente un fine, con l’unica domanda di come raggiungerlo. Non abbiamo una concezione completa del nostro fine finché non abbiamo una comprensione completa del corso d’azione che ci porterà lì» (Anderson 2014).
O come ha detto Hans Joas:
«Per i pragmatici, la definizione dei fini non è un atto di coscienza che avviene al di fuori dei contesti dell’azione. Piuttosto, la definizione di un fine può essere solo il risultato di una riflessione sulle resistenze incontrate dal comportamento variamente orien- tato di una forma di vita il cui mondo è sempre già schematizzato in modo pratico prima di ogni riflessione» (Joas 1993: 248).
Questa critica pragmatista della razionalità e la teoria dell’azione che ne consegue sono utili per descrivere i processi decisionali basati sul consenso, in cui mezzi e fini diversi devono essere costantemente esplorati e valutati in un contesto collettivo e deliberativo. Così, imparando da pragmatici come Dewey, gli anarchici come Graeber potrebbero respingere con più forza l’affermazione che le loro idee siano meramente utopiche, ma invece evidenziare che le persone agiscono e pensano sempre in questo modo nella vita di tutti i giorni per prendere decisioni e trovare compromessi (cfr. Menand 1997).
Conclusioni
In questo articolo ho sostenuto che ci sono molte somiglianze tra la concezione pragmatista della democrazia radicale sviluppata da John Dewey e quella anarchica offerta di recente da David Graeber. Ho cercato di mostrare come la concezione di Dewey dell’interconnessione tra mezzi e fini sia al centro della sua idea di democrazia radicale e come debba essere letta come una confutazione del marxismo ortodosso, un background storico che vale anche per l’anarchismo. Evidenziando infine alcune similitudini tra i due concetti di democrazia radicale, l’articolo ha anche cercato di evidenziare dove i diversi filoni di letteratura potrebbero imparare l’uno



dall’altro e dove si potrebbero colmare lacune. L’impresa è stata comunque sommaria e ci sono molti punti che potrebbero essere esplorati in modo molto più dettagliato. L’ulteriore elaborazione delle idee pragmatiste e anarchiche è anche un esercizio, tuttavia, come insisterebbero sia Dewey che Graeber, che non può essere compiuto solo scrivendo ulteriori articoli, ma che deve essere esplorato ed esercitato anche nella vita pratica.
Traduzione di Marco Antonioli The Anarchist Library, 2015
Riferimenti bibliografici
- P. ANDERSON, Considerations on Western Marxism, NBL, London 1976.
- M. BACON, The Politics of Thruth: A Critique of Perceian Deliberative Democracy, «Philosophy and Social Criticism», 36/9 (2010), pp. 1075-91.
- R.J. BERNSTEIN, The Pragmatic Turn, Polity, Cambridge 2010.
- J. DEWEY, Creative Democracy. The Task Before Us, in L.A. HICKMAN, T.M. ALEXANDER (eds.), The Essential Dewey, Indiana University Press, Bloomington 1998, pp. 340-43.
- J. DEWEY, Democracy is Radical in .J.A. BOYDSTON (ed.), The Later Works 1925-1953, vol. 11: 1935-1937, Southern Illinois University Press, Carbondale 1987, pp. 296-99.
- M.C. DORF, Could the Occupy Movement Become the Realization of Democratic Experimentalism’s Aspiration for Pragmatic Politics?, «Contemporary Pragmatism», 9/2 (2013), pp. 263–271.
- J.T. FARRELL, Dewey in Mexico, in S. Hook (a cura di), John Dewey, Philosopher of Science and Freedom: A Symposium, Dial Press, New York 1950, pp. 351–77.
- D. GRAEBER, The Democracy Project: A History, a Crisis, a Movement, Allen Lane, London 2013.
- H. JOAS, Pragmatism and Social Theory, University of Chicago Press, Chicago 1993.
- L. MENAND, An Introduction to Pragmatism, in L. MENAND (ed.), Pragmatism: A Reader, Vintage Books, New York 1997, pp. xi–xxxiv.
- Preliminary Commission of Inquiry: the Case of Leon Trotsky: Report of Hearings on the Charges Made Against Him in the Moscow Trials, Secker & Warburg, London 1937.
- A. STRASSEL, Guide to the Selden Rodman Papers (MS 871), Yale University Library Manuscripts and Archives, New Haven, Connecticut 2007.
- R.B. TALISSE, A Pragmatist Philosophy of Democracy, Routledge, New York 2007. L. TROTSKY, Their Morals and Ours, in L. TROTSKY/ J. DEWEY/ G. NOVACK, Their Morals And Ours: Marxist Versus Liberal Views On Morality, Pathfinder Press, New York 1979, pp. 13–52.




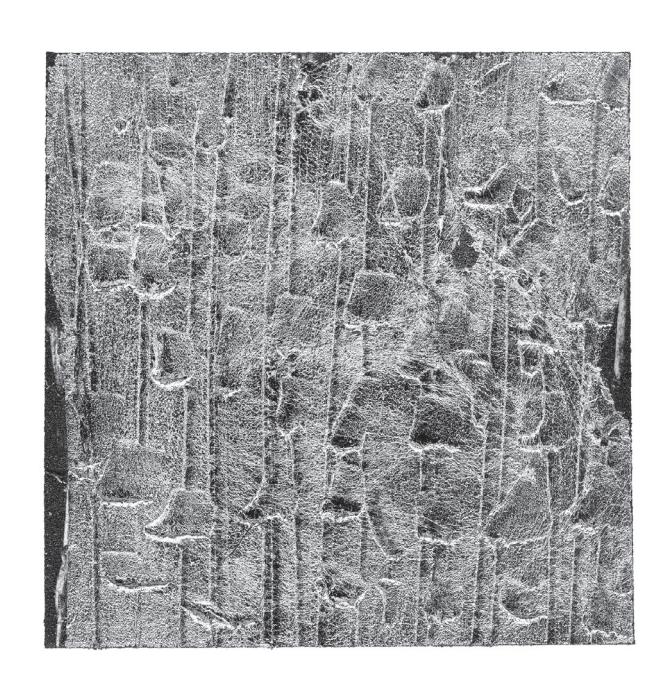
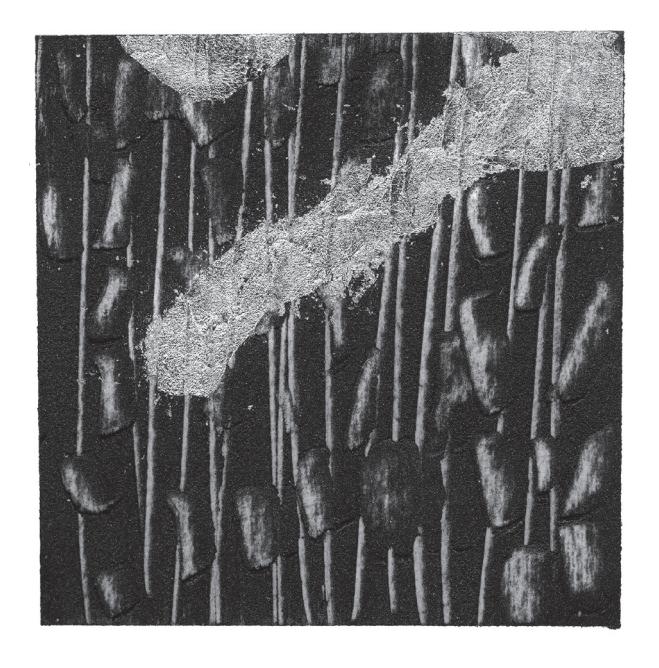



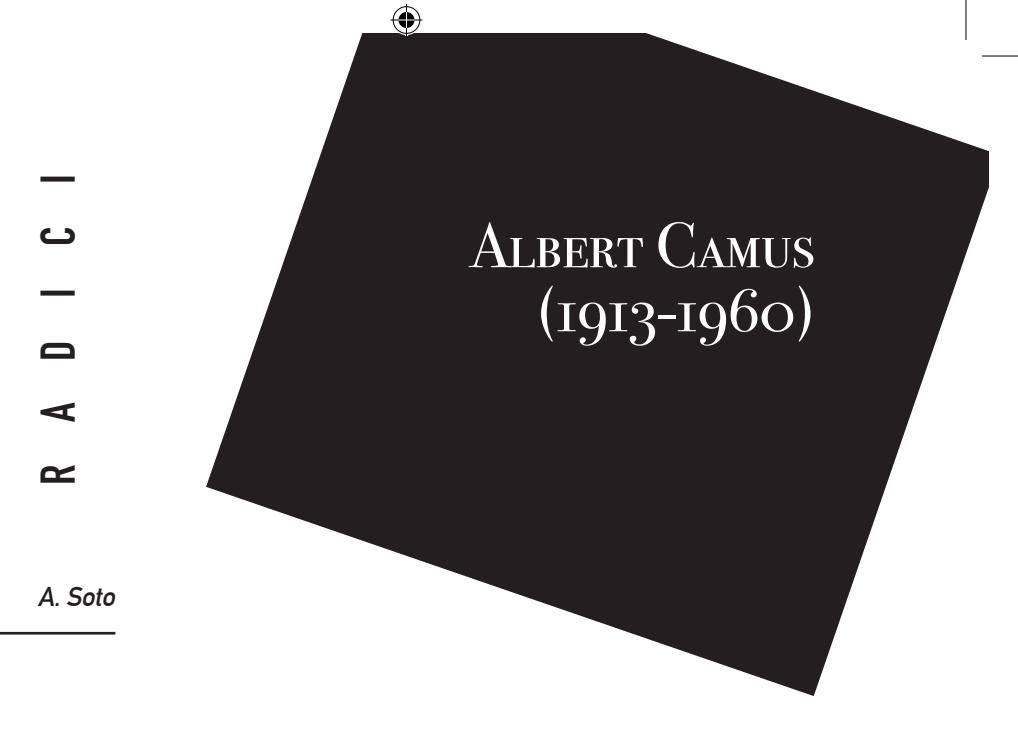
Camus nasce nel 1913 ad Algeri, da una famiglia di pied-noirs (i Francesi d’Algeria) per nulla benestante, quando l’Algeria è una colonia francese; lo sarà fino all’ottenimento dell’indipendenza, dopo una cruenta guerra di liberazione di otto anni, nel 1962. Ma Camus muore due anni prima, prematuramente, in un incidente stradale, in un periodo in cui sta scrivendo il romanzo autobiografico Il primo uomo, rimasto incompiuto ed edito recentemente da Bompiani.
Figlio di operai, orfano giovanissimo di padre, con una madre analfabeta, riesce a studiare solo grazie all’aiuto del suo maestro elementare: diventerà uno dei maggiori intellettuali libertari del Novecento.
Coscienza critica dell’Occidente, intellettuale engagé, attivo politicamente ma non incorporato nella politica istituzionale, parteggia per i repubblicani nella guerra civile spagnola del 1936-1939, partecipa attivamente alla Resistenza francese ed è caporedattore del quotidiano «Combat», organo clandestino della Resistenza stessa, collabora con diverse testate della sinistra libertaria. È critico nei confronti dell’Unione Sovietica dominata dallo stalinismo che ritiene lesivo della libertà e dei diritti più basilari. Autore di romanzi, Lo straniero (1942), La peste (1947), col quale ottiene un vasto riconoscimento di pubblico, La caduta (1956); di opere teatrali tra le quali Il malinteso (1944), Caligola (1945), Lo stato d’assedio (1948), I giusti (1949); di saggi come Il mito di Sisifo (1942), L’uomo in rivolta (1951), Riflessioni sulla ghigliottina (1957); nel 1957 riceve il premio Nobel per la letteratura per avere saputo esprimere come scrittore «i problemi che oggi si impongono alla coscienza umana».




È un esistenzialista, in quanto la sua riflessione si concentra sul senso dell’esistenza umana nel mondo, in un’Europa figlia della grande crisi 1915-1945, in cui le due guerra mondiali e i totalitarismi hanno decretato la fine traumatica delle grandi narrazioni ottocentesche: l’idealismo e il positivismo. In Camus troviamo riferimenti ad autori e filosofi che via via si sono interrogati sulle problematicità dell’esistenza umana tra cui Dostoevskij, Kafka, Tolstoj, Joyce, Proust, Stendhal ma anche Schopenhauer, Nietzsche, Pascal e Spinoza.
La fatica di Sisifo
Il 1942 è l’anno di pubblicazione de Lo straniero e de Il mito di Sisifo. Il tema comune alle due opere, una romanzo, l’altra saggio, è l’assurdo: l’esistenza umana è assurda, vorrebbe idealmente il bene, ma si ritrova a fare il male. Il bene – l’Idea, l’ideale – e i fatti non collimano, non coincidono, anzi sono divergenti. Assurdo significa irragionevole: «il mondo, in sé, non è ragionevole […] è assurdo» (Camus 2017: 21). Sisifo è l’eroe mitologico che per avere ingannato due volte la morte è condannato dagli Dei a spingere un masso in cima a una rupe; una volta raggiunta la sommità il masso rotola giù nuovamente. Sisifo sa che avverrà questo, che il suo sforzo sarà frustrato, ma non può fare a meno di ricominciare a spingerlo. È «l’eroe assurdo» (Camus 2017: 118). Nel Sisifo di Camus non c’è, però, disperazione. L’uomo assurdo non è disperato, ha voglia di vivere nella consapevolezza che la vita è «rivolta», è una «battaglia permanente». «Vivere è dar vita all’assurdo. Dargli vita è innanzitutto saper guardarlo […]. Così una delle sole posizioni filosofiche coerenti è la rivolta, che è un perpetuo confronto tra l’uomo e la sua oscurità» (Camus 2017: 50).
La precedente filosofia esistenzialista, dice Camus, non è riuscita ad accettare fino in fondo il fatto che l’esistenza sia assurda e ha trovato una soluzione nella fede o nell’ideologia. L’assurdo, invece, non ha soluzione, è costitutivo del vivere umano e va affrontato con l’indignazione e l’impegno, che non risolvono l’assurdo se non parzialmente, marginalmente, temporaneamente. Ma ciò è la ragione di vita di Sisifo, dell’essere umano quindi.
Camus conclude l’opera con queste parole: «Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice» (Camus 2017: 121). Partendo da una premessa nichilista – la vita è assurda, non ha senso – finisce celebrando la vita, il qui e ora, la forza del presente.









L’uomo in rivolta
Il romanzo La peste apre il Ciclo della rivolta. Pubblicato nel 1947, La peste ottiene grande successo di vendite e di critica. La città di Orano, in Algeria, è colpita da un’epidemia di peste; in questa crisi – che simboleggia la crisi della civiltà, del mondo – il protagonista, il medico Bernard Rieux e il suo amico Jean Tarrou, si adoperano per affrontare il male facendo opera di intervento e di solidarietà verso i contagiati. Organizzano delle «formazioni sanitarie volontarie» (Camus 2019: 131) fuori dalle istituzioni ritenute lente, burocratiche, inefficienti: «in una maniera o nell’altra, bisognava lottare e non mettersi in ginocchio» (Camus 2019: 145).
L’opera centrale del Ciclo della rivolta, a cui appartiene anche I giusti, è L’uomo in rivolta, saggio del 1951 e lavoro fondamentale di Camus. La prima parte, breve, intitolata proprio L’uomo in rivolta, è folgorante: «Mi rivolto dunque siamo». L’uomo in rivolta è un uomo «che dice no» (al male nel mondo, all’ingiustizia) e però «non rinuncia» (Camus 2005: 17), dice sì a una rivolta etica, esistenziale, solidale e non egoistica. La rivolta è il mezzo attraverso cui si esprime la solidarietà tra gli uomini, si realizza la condizione umana. Nella seconda sezione intitolata La rivolta metafisica viene analizzato il pensiero di coloro i quali hanno negato dio come padrone, in un lungo percorso che ha aperto la strada a Nietzsche e alla sua rivolta contro la morale tradizionale attraverso cui l’uomo si fa egli stesso dio. Una rivolta, quella metafisica, importante, ma che può portare quindi a conclusioni nefaste e liberticide. Nella terza sezione, intitolata La rivolta storica, studia le teorie e le pratiche di rivoluzione e di rivolta nella storia. Egli difende la rivolta, la sua necessità, e giudica negativamente la rivoluzione, guardando con occhio critico al marxismo. «Tutte le rivoluzioni moderne si sono concluse con un rafforzamento dello Stato. Il 1789 porta a Napoleone, il 1848 a Napoleone III, il 1917 a Stalin, i disordini italiani intorno al ‘20 a Mussolini, la repubblica di Weimar a Hitler» (Camus 2005: 196).
Il pensiero di Marx è criticato principalmente su due versanti: innanzitutto per il fatto che la rivoluzione debba modificare tutta la società – cioè la socializzazione deve riguardare tutti gli ambiti a partire dai mezzi di produzione non lasciando nessun margine alla sperimentazione di altre modalità di produzione e proprietà – e sia quindi un cambiamento totale; in secondo luogo la rivoluzione che porta al comunismo è determinata dallo sviluppo storico ed è La Soluzione, l’unica soluzione, il fine supremo dell’umanità. Questa duplice visione è debitrice nei confronti di Hegel, che considera la comunità sociale e politica sempre nel suo complesso, cioè secondo una concezione organicistica, o totale, in cui l’uomo è solo




un tassello. Inoltre tale totalità è frutto di un divenire storico necessario. Contro ciò Camus valorizza l’aspetto libertario e liberatorio della rivolta, plurale (non unica), mai conclusa e imprevedibile (non determinata). La rivolta, a differenza della rivoluzione, non è totale, non tende all’assoluto; è relativa, non dice «tutto è necessario» ma «tutto è possibile» (Camus 2005: 317). La rivolta è la volontà di non subire e si propone di «diminuire […] il dolore del mondo» (Camus 2005: 331), perché, come aveva chiarito nella conferenza La crisi dell’uomo del 1946, egli non crede possibile realizzare la felicità universale. La rivolta non è libertà estrema, non è libertà di uccidere (Camus 2005: 310): «la libertà senza limiti è il contrario della libertà […], è quella dei tiranni» (Camus 2020: 209). Se il socialismo quale si è concretizzato con le rivoluzioni del Novecento ha confiscato la libertà concreta, presente, in nome di una libertà ideale, a venire (Camus 2005: 238), contravvenendo a ogni moralità, è necessario allora rivendicare una libertà che rispetti la libertà altrui, che sia libertà di tutti. La rivolta, che è vita, è felicità, reclama libertà per tutti. Perché, come scrive nel Caligola del 1940, «nessuno può salvarsi da solo e non si può essere liberi contro gli altri uomini» (Camus 2018b: 10). Il suo rifiuto dell’assoluto è coscienza dei limiti dell’uomo, è consapevolezza che sia possibile agire – rivoltarsi – nella concretezza, nella quotidianità. È anche rivendicazione del ruolo dell’etica: alla base della prassi politica vi devono essere dei limiti morali. Non tutti i mezzi sono consentiti per ottenere un fine, per quanto nobile esso sia. C’è quindi un rifiuto del male, della menzogna, un’affermazione dell’onestà, della dignità, della libertà dal conformismo, dai pregiudizi, dalle ideologie assolute; con Camus torna al centro l’etica, il senso di giustizia, a cui la politica è subordinata: «la coscienza nasce dalla rivolta» (Camus 2018: 10).
Il seme sotto la neve
L’uomo in rivolta gli procura l’ostilità di Jean-Paul Sartre e della rivista «Les Temps Modernes», portavoce della sinistra marxista. È una divergenza ideale e politica. Camus, ventenne, è membro del Partito comunista algerino solo per due anni (1935-1937), perché la forma partito e l’ideologia marxista sono per lui due gabbie. In quegli anni, come si diceva, parteggia per i repubblicani spagnoli, poi dà il contributo alla Resistenza al nazifascismo. Si schiera, quindi, a sinistra vedendovi il luogo della dignità, ma contro il socialismo di Stato, e in particolare l’URSS, difeso, seppure con dei distinguo, da Sartre. Agisce fuori dai partiti e dai governi, al fine di creare «comunità di riflessione che avvieranno il dia-




logo tra le nazioni e affermeranno con la vita e le parole di ciascuno che questo mondo deve cessare di essere quello dei poliziotti, dei soldati e del denaro per diventare quello dell’uomo e della donna, del lavoro fecondo e del tempo libero meditato […]. Proprio perché il mondo è intrinsecamente infelice, dobbiamo fare qualcosa per la felicità, proprio perché è ingiusto, dovremo agire per la giustizia; e infine proprio perché è assurdo dobbiamo dargli tutte queste ragioni» (Camus 2020: 46-47).
Nell’epoca della guerra fredda non si schiera né con il blocco atlantico né con quello sovietico, cercando insistentemente una terza via. Sostiene la lotta antifranchista costretta alla clandestinità, si batte per l’abolizione della pena di morte, denuncia la necessità di abbandonare la volontà di potenza, che assume le forme dell’imperialismo e dell’espansionismo, dovunque si palesi, e di combattere tutti i tiranni. Cerca alleati, amici, compagni in questo suo fare, che non è egoistico o solipsistico. Protesta contro l’intervento delle truppe sovietiche nel giugno 1953 a Berlino est per sedare una rivolta operaia contro la decisione del governo di aumentare l’orario di lavoro che provoca circa cinquanta morti (Camus 2020: 181-187). Lo stesso fa nel ‘56 quando il governo polacco, aderente al blocco sovietico, reprime nel sangue uno sciopero degli operai metallurgici di Poznán. Una manifestazione di centomila persone viene affrontata armi alla mano dalla forza pubblica e ci sono circa cinquanta morti e centinaia di feriti (Camus 2020: 263-267). Ancora, sempre nel ‘56, dà voce alle ragioni del movimento di contestazioni che scuote l’Ungheria, contro cui interviene l’Armata rossa, in accordo col Partito comunista ungherese. Il 4 novembre i carri armati entrano a Budapest: ci sono circa 2500 morti e duecentomila ungheresi saranno costretti all’esilio (Camus 2020: 279-282).
«Coloro che […] non vogliono né soffrire né possedere strumenti di oppressione, che vogliono la libertà tanto per se stessi quanto per gli altri, costoro, in un secolo condannato dalla miseria o dal terrore alla follia dell’oppressione, sono i semi sotto la neve di cui parlava uno dei più grandi di noi [cfr. Ignazio Silone, Il seme sotto la neve, 1940]. Passata la tempesta, il mondo si nutrirà di quei semi», afferma in una conferenza del 1955 riprodotta dalla rivista libertaria «La Révolution Prolétarienne» (Camus 2020: 239).
Opere utilizzate
- A. CAMUS, Lo straniero, Bompiani, Milano 1994.
- A. CAMUS, L’uomo in rivolta, Bompiani, Milano 2005.
- A. CAMUS, Il mito di Sisifo, Bompiani, Milano 2017.
- A. CAMUS, Mi rivolto dunque siamo, a cura di V. Giacopini, elèuthera, Milano 2018.
- A. CAMUS, Tutto il teatro, Bompiani, Milano 2018.
- A. CAMUS, La peste, Bompiani, Milano 2019.
- A. CAMUS, Conferenze e discorsi (1937-1958), Bompiani, Milano 2020.
- A. CAMUS, Il primo uomo, Bompiani, Milano 2020.



«Ciò di cui ha bisogno oggi il movimento anarchico non sono certo nuove formule organizzative, bensì un programma di lavoro concreto, ben definito, da intraprendere fin da subito [… ] Perciò, le iniziative e le idee non devono essere soffocate, ma invece si deve incoraggiare uno scambio vitale di tutti i punti di vista».
Così scriveva Marie Goldsmith nella rivista anarchica Plus Loin nell’aprile del 1928. Queste parole rivelano molto esplicitamente due caratteristiche peculiari di questa anarchica, purtroppo poco conosciuta ancor oggi, che ne definiscono la sua postura: l’essere una scienziata e al contempo essere un’anarchica. Nata nel 1873 (la data esatta non è sicura e neanche il luogo: Zurigo o San Pietroburgo?), figlia di un giurista e attivista populista rivoluzionario russo, Isidoro, e di Sof’ja Androsov, biologa e scienziata, morirà suicida l'11 gennaio del 1933 a Parigi.
Nel 1874 la famiglia Goldsmith vive a San Pietroburgo e Marie sperimenta da bambina il lungo e inflessibile braccio violento dello Stato zarista che perseguita con l’esilio e i trasferimenti coatti i suoi genitori di città in città in quanto rivoluzionari, populisti e socialisti. Nel giugno del 1884 i Goldsmith fuggono dalla Russia attraverso la Finlandia e poi la Svizzera, prima di stabilirsi definitivamente in Francia a Parigi.
Marie si laurea in biologia alla Sorbona nel 1894 e diviene stretta collaboratrice del noto biologo e zoologo evoluzionista Yves Delage (1854- 1920) specializzandosi, nel 1915, con un dottorato sulle reazioni psicologiche e psichiche tra i pesci. Scrivono in collaborazione alcuni libri e




molti articoli di carattere squisitamente scientifico entrando in contatto con l’ambiente evoluzionista internazionale. Importanti studi e ricerche vengono scritti da Goldsmith sulla partenogenesi naturale e sperimentale (1913). Dal 1905 diviene la segretaria della prestigiosa rivista scientifica L’année biologique. Nel frattempo sviluppa la sua vocazione libertaria e poi anarchica entrando in contatto con gli ambienti rivoluzionari francesi ma anche europei. In particolare diviene corrispondente assidua con Pëtr Kropotkin e sviluppa una forte amicizia testimoniata dalle innumerevoli lettere intercorse tra i due. La sua posizione all’interno del consesso universitario e scientifico non è facile e, a causa del suo rapporto sodale con Delage e delle sue idee anarchiche, del suo status di esule e dell’essere donna, subisce invidie e inimicizie all’interno del suo stesso dipartimento. Alla morte del suo mentore la sua situazione lavorativa si precarizza ulteriormente. La lunga e complessa malattia della madre, alla quale la lega un rapporto profondo e simbiotico, complica ulteriormente la sua situazione, perché Marie consuma la sua esistenza nell’opera di assistenza della madre così gravemente ammalata. Rifiuta diverse offerte di lavoro (tra le quali anche da due istituti prestigiosi degli Stati Uniti come il Rockefeller Institute e la Carnegie Institution) sempre per poter stare vicina alla madre. Contemporaneamente al suo travaglio accademico ed esistenziale, Marie abbraccia sempre più profondamente gli ideali anarchici, alimentando il suo desiderio di contribuire a sconfiggere i soprusi e le disuguaglianze, prodotte dalla società autoritaria e dalle istituzioni così marcatamente classiste, sessiste e ingiuste, soprattutto nei confronti delle categorie più oppresse e quindi anche delle donne.
Fin dal 1891 si era associata a un gruppo francese di carattere spiccatamente rivoluzionario e socialista, denominato Étudiants Socialistes Révolutionnaires Internationalistes spingendolo via via verso posizioni più radicali e anarchiche. Il gruppo si scioglie nel 1900 ma Marie continua la sua attività parallela di studiosa e ricercatrice e di militante anarchica, scrivendo su numerosi periodici anarchici francesi e di altre nazioni europee. Tra i periodici con cui collabora va ricordato Les Temps Nouveaux, fondato da Jean Grave, che raccoglie le firme più autorevoli dell’anarchismo internazionale e poi, entrando come redattrice, la rivista Plus Loin, firmandosi con diversi pseudonimi. Infine collabora al periodico americano in lingua yiddish, con sede a New York, Fraye Arbeter Shtime e con il giornale anarchico russo, con sede a Chicago, Dielo Truda. Marie Goldsmith diviene un’importante figura dell’anarchismo internazionale di questi anni, giovandosi di un grande rispetto e godendo di grande considerazione tra i suoi compagni.









Si occuperà molto di questioni organizzative, entrando nel dibattito molto acceso in quegli anni attorno alle note vicende delle posizioni piattaformiste, con posizioni critiche verso ogni forma di organizzazione che in qualche modo possa attenuare il profondo e inevitabile rispetto che l’idea anarchica nutre nei confronti della libertà individuale. La sua attività non passa inosservata alla polizia, francese e russa, che la segue e la controlla con i mezzi investigativi a sua disposizione. Collabora e intrattiene rapporti non solo all’interno del movimento anarchico ma anche con l’area socialista rivoluzionaria e con gli esuli russi soprattutto a Parigi, Londra e Ginevra. Intrattiene una fitta rete di corrispondenze che ne rivelano la dimensione internazionale sia militante che scientifica: Pëtr Kropotkin, James Guillaume, Max Nettlau, Jean Grave, Vera Figner, Varlaam Cerkezov, molti altri russi, Christian Cornelissen, Emma Goldman, Sébastien Faure, Paul Reclus, Rudolf Rocker, e molti altri ancora. Oltre a queste corrispondenze Marie mantiene rapporti stretti e costanti con anarchici ebrei sia in Francia che all’estero. Il padre era infatti di origine ebraica ma laico però nella tradizione e nella vita. Marie sente sempre forte però il legame ideale con l’ebraismo laico e libertario e a testimoniarlo possiamo citare la sua collaborazione proficua e intensa con la stampa di lingua yiddish. Le sue concezioni politiche hanno influenzato la sua ricerca scientifica facendola diventare un’attenta sostenitrice delle teorie kropotkiniane sul mutuo appoggio e una decisa avversaria delle interpretazioni più conservatrici e autoritarie delle teorie darwiniane rivalutando alcuni aspetti importanti delle concezioni lamarckiane. I suoi studi sulle teorie dell’evoluzione mirano da un lato a supportare l’idea della solidarietà, della collaborazione, del mutuo appoggio come uno dei fattori principali del processo evolutivo e delle relazioni sociali, dall’altro a confutare le teorie teologiche sull’origine della vita e dell’universo. Quindi, confutando le volgarizzazioni del pensiero darwiniano fatte da Herbert Spencer e, soprattutto, da Thomas Henry Huxley, Goldsmith realizza due obiettivi: riconsiderare dal punto di vista scientifico le storture della volgarizzazione del pensiero di Darwin e, soprattutto, fornire alle idee libertarie strumenti di carattere scientifico per giustificare la positività dell’ideale libertario.
Dal punto di vista più strettamente militante Marie riveste una certa fiducia nel sindacalismo rivoluzionario che secondo il suo punto di vista era intrinsecamente e necessariamente anarchico. Sindacalismo e anarchismo sarebbero accumunati da una avversione contro lo Stato e il Potere e contro il capitalismo. Non sfugge a Marie però una certa differenza tra le due espressioni del movimento rivoluzionario dell’epoca.




Infatti, in un opuscolo del 1920, scrive: «L’unica differenza è che l’anarchismo include anche una serie di visioni filosofiche, etiche, storiche e di altro tipo, mentre il sindacalismo è un movimento puramente pratico». Quindi è sempre l’idea anarchica nella sua complessità che illumina l’azione e suggerisce le realizzazioni libertarie. Dotata di uno spirito critico e sensibile alle vicende concrete del vivere quotidiano, attenta alle forme evidenti e subdole in cui si esprime il dominio, Marie non teme il confronto, anche acceso ma sempre profondamente rispettoso e mai settario, all’interno degli anarchici. Così come sarà critica nei confronti di Pëtr Arshinov e dei suoi sodali sostenitori della «Piattaforma dei comunisti anarchici» (1926) denunciandone le possibili derive autoritarie espresse dal concetto di responsabilità collettiva e del procedere comunque a maggioranza nelle decisioni, appoggerà, senza firmarlo, i compagni che firmarono il «Manifesto dei sedici» all’epoca del primo conflitto mondiale.
L’intenso e profondo legame tra Marie e sua madre non è mai stato così evidente e forte come nei loro ultimi momenti vissuti insieme nel gennaio del 1933: quando la madre muore dopo tante sofferenze Marie la segue volontariamente suicidandosi l'11 gennaio. Lascia un semplice e breve biglietto nel quale, tra l’altro, si legge: «Vado dopo di lei. Per favore seppelliteci insieme. Abbiamo due posti accanto a mio padre nel cimitero di Ivry […] Per favore date da mangiare agli uccelli e lasciateli in buone mani».
Nei mesi che seguiranno nella stampa anarchica e libertaria di diversi paesi compaiono numerosi necrologi. Lo stesso Nestor Makhno, l’intrepido rivoluzionario anarchico russo esiliato in Francia, scriverà un elogio sentito e profondo di Marie Goldsmith paragonandola a Kropotkin, Reclus, Cherkezov, veri «titani dell’anarchismo». I suoi studi scientifici sono ancor oggi citati negli ambienti degli studiosi della biologia evoluzionistica.
Breve bibliografia
M. CONFINO (a cura di), Anarchistes en exil. Correspondance inédite de Pierre Kropotkine à Marie Goldsmith 1897-1917, Institut d’études slaves, Paris 1995.
S. HOUGH, Marie Goldsmith Scientific Luminary, Anarchist Militant, The anarchist Library, July 14, 2023.



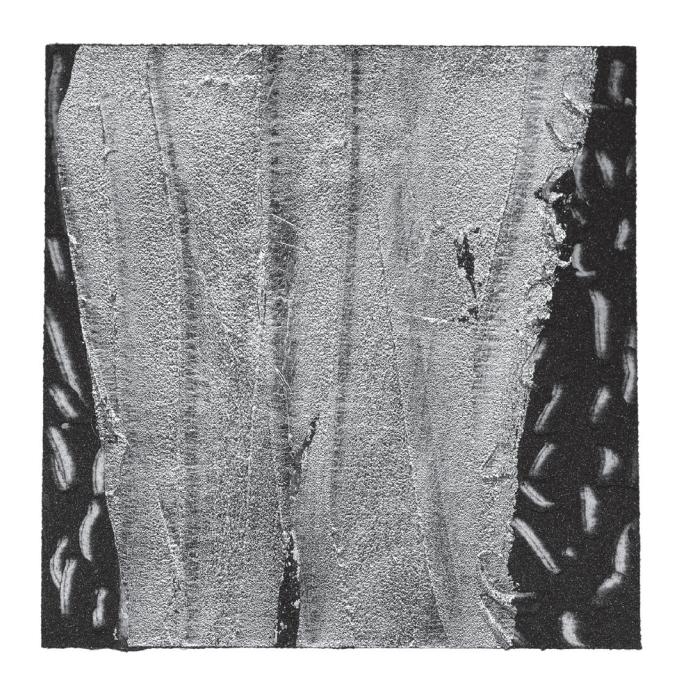
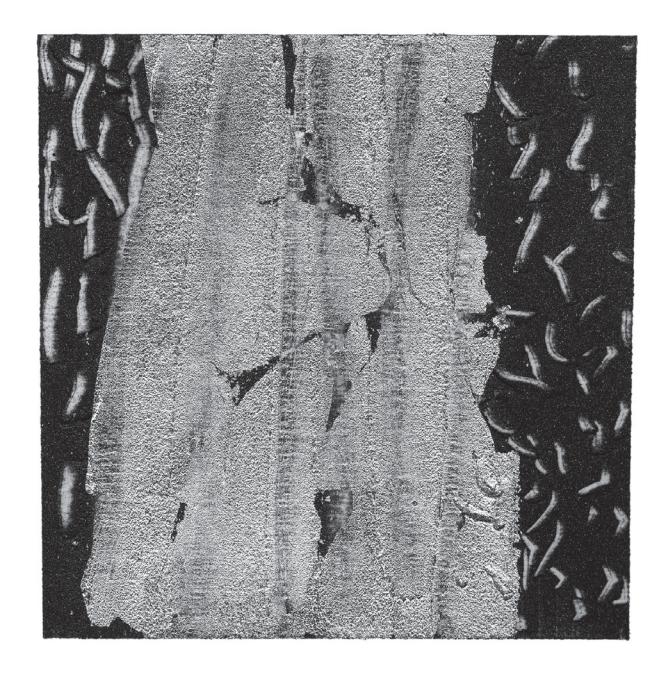




Tre donne anarchiche nella tempesta del ventesimo secolo: un percorso di lettura al femminile
Francesco Berti
Il Novecento viene spesso dipinto come un secolo dai tratti esclusivamente, o prevalentemente, negativi: il secolo del totalitarismo, dei genocidi e degli stermini di massa operati dagli Stati contro popolazioni civili per lo più inermi. Siffatta rappresentazione coglie tuttavia solo un aspetto, per quanto veritiero e tragicamente cruciale, del secolo trascorso. In realtà, il ventesimo è stato anche un secolo contrassegnato da diversi fattori positivi: i regimi liberaldemocratici hanno infine avuto la meglio sugli Stati dittatoriali e dispotici; l’Europa ha vissuto, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, un lungo e inedito periodo di pace; nei paesi occidentali si è raggiunto un grado di benessere mai prima conseguito nella storia umana; il movimento dei lavoratori ha ottenuto in decine di paesi il riconoscimento di fondamentali diritti sociali; molti paesi eufemisticamente definiti in via di sviluppo si sono liberati dal giogo coloniale. Il Novecento è stato inoltre, non da ultimo, il secolo che ha visto esplodere, su un piano pubblico, la questione femminile e in cui diverse donne, armate di intelligenza, coraggio, passione e talento, si sono rese protagoniste nell’arena politica e culturale internazionale. Non è certo un caso che una buona parte di esse abbiano militato nella sinistra politica e in specie nella sinistra rivoluzionaria, più pronta di altri movimenti politici ad accogliere la sfida della parità di genere nell’ambito del suo progetto di liberazione dalle catene dell’autoritarismo politico e dello sfruttamento economico. Non stupisce dunque di trovarle, in particolare, nelle fila dell’anarchismo, il progetto di emancipazione più profondo, radicale e universale sinora concepito. In questa veloce rassegna ci piace segnalare, insieme, le opere di tre gran-





di anarchiche recentemente pubblicate e rese disponibili, o nuovamente disponibili, al lettore italiano: La libertà o niente, di Emma Goldman (elèuthera, Milano 2023); Viaggio attraverso utopia di Maria Luisa Berneri (Tabor / Edizioni Malamente, Valle di Susa /Urbino 2022); Critica dei totalitarismi di Luce Fabbri (elèuthera, Milano 2023). Si tratta di volumi di autrici dotate ciascuna di una propria specificità, che sembrano quasi indicare un passaggio, con la loro traiettoria esistenziale, dall’anarchismo come progetto di azione rivoluzionaria al libertarismo come pensiero critico della società: Goldman, ebrea lituana trapiantata giovanissima negli Stati Uniti, fu una straordinaria militante politica rivoluzionaria, radicata nel XIX secolo ma capace, come pochi altri e poche altre, di esprimere le tensioni moderne del XX, cogliendo fermenti avanguardistici sul piano culturale, artistico e politico; Berneri fu anch’essa giovanissima militante e la precoce morte forse le impedì quel passaggio ad una vita maggiormente dedita allo studio che invece ebbe a compiere Luce Fabbri, docente presso l’Università di Montevideo, ma anche attivista anarchica fino alla fine dei suoi giorni (si rinvia ai profili biografici tratteggiati nelle Radici di «Semi sotto la neve» rispettivamente nei numeri 2/2022 e 6/2023). I legami, non solo intellettuali, tra le tre sono davvero consistenti: Goldman e Berneri, ad esempio, si conobbero personalmente a Londra e risiedettero nel 1938, per un periodo, nello stesso stabile, come ci ricorda Antonio Senta nell’ottimo studio introduttivo al volume della Berneri: «fu proprio Goldman in quell’anno a redigere l’introduzione alla prima antologia degli scritti di Camillo [Berneri], curata da Giovanna Caleffi ed edita a Parigi». Tutte e tre le autrici, inoltre, sia pure in maniera diversa, sono state costrette a confrontarsi col tema dell’esilio e dello sradicamento, elemento che senz’altro ha influito nella loro riflessione.
Leggendo queste opere due elementi saltano immediatamente all’occhio: la freschezza della scrittura, sul piano formale; l’anti-dogmatismo, l’acutezza, la veridicità e, sotto diversi profili, l’attualità di molte considerazioni disseminate negli scritti considerati, sul piano del contenuto.
La raccolta antologica di scritti di Emma Goldman (1869-1940) ci fa capire quanto ella abbia saputo penetrare l’intima essenza dell’anarchismo e, se vogliamo, la feconda tensione che ne ha attraversato e ne attraversa gran parte delle sue manifestazioni: l’essere, l’anarchismo, una sorta di individualismo comunitario – insieme, «la filosofia della sovranità dell’individuo» e «la teoria dell’armonia sociale», secondo le parole della Goldman. Appartenente al filone socialista, Goldman da un lato riscrive




la jeffersoniana Dichiarazione d’indipendenza americana in una chiave spiccatamente anticapitalista (pp. 129-48), esaltando il sindacalismo rivoluzionario (pp. 169-88). Dall’altro lato, conduce la sua polemica contro le istituzioni americane del suo tempo rimproverando all’America di non essere stata, fin dal suo sorgere, sufficientemente conseguente ai principi di libertà su cui pretende di fondarsi (p. 233), richiamandosi spesso alla tradizione individualista anarchica americana degli Emerson e dei Thoureau, esaltando l’amore libero e i diritti delle donne (pp. 199-213). Il viaggio attraverso l’utopia di Maria Luisa Berneri (1918- 1949), definito da Lewis Munford «lo studio più completo e penetrante su questo territorio ideale che io conosca» (p. 36), rappresenta in effetti una delle più acute disamine critiche di questo genere letterario, che se ha spesso saputo anticipare conquiste progressiste del genere umano, dall’altro ha quasi sempre disegnato mondi intollerabilmente privi di libertà individuale, di spontaneità e di diversità, in cui l’obiettivo primario dell’uguaglianza è perseguito attraverso una autoritaria e artificiosa uniformazione razionalizzatrice della struttura sociali, che «si riflette in ogni aspetto della vita utopistica, dagli abiti all’orario, dal comportamento morale agli interessi intellettuali», e che viene ossessivamente esteso allo stesso ambiente fisico in cui è immaginata vivere la comunità felice: «l’amore autoritario per la simmetria induce gli utopisti a sopprimere montagne o fiumi e persino a immaginare isole perfettamente circolari e fiumi perfettamente rettilinei» (pp. 45-46).
Anche il volume di Luce Fabbri (1908-2000), curato da Lorenzo Pezzica, è un insieme antologico di scritti che si segnalano per la particolare curvatura che assume la critica antitotalitaria di Fabbri, anarchica aperta – come Berneri – alle suggestioni e ai contributi che le venivano da diversi filoni intellettuali e da autori contraddistinti da un genuino anelito verso la libertà ma non sempre prossimi all’ideale anarchico, come ci ricorda Pezzica, quali ad esempio Mounier, Orwell, Cassirer, Burnham, Gilas. Fondamentali risultano tutt’oggi le intuizioni di Fabbri sul tema della tecnoburocrazia, ripreso negli anni Settanta e Ottanta dal gruppo di anarchici e anarchiche raccolto intorno alle edizioni Antistato e alla rivista «Volontà», poi confluiti nel progetto elèuthera. Come osserva Pezzica, non ci si può che rammaricare del fatto che il pensiero di Luce Fabbri non sia stato «compreso e dibattuto quanto avrebbe meritato» (p. 10), soprattutto in Italia, sua terra natale, dal momento che avrebbe potuto contribuire in maniera decisiva a quello svecchiamento dell’anarchismo avvenuto, purtroppo, molto più tardi. Prova ne sono le sue ri-





flessioni, che dovrebbero essere oggetto di rimeditazione, sul rapporto tra anarchismo, democrazia e liberalismo, nel solco, ma anche oltre, la tradizione di pensiero facente capo a Errico Malatesta e al padre Luigi, più vicine, invece, alla prospettiva delineata da Camillo Berneri. Anche sulla scorta dell’esperienza totalitaria, Luce Fabbri individuò nell’anarchismo l’elemento liberale del socialismo: «al punto in cui siamo giunti con l’analisi possiamo veder chiaro ciò che è, secondo me, il luogo attuale dell’anarchismo concepito come un ramo del socialismo. Si suole definirlo come socialismo libertario, e non liberale, perché quest’ultima parola è carica di molta inaccettabile storia: ma è indubbiamente l’erede, dentro il campo socialista, della lunga tradizione liberale» (pp. 198-99). Tale precisa e originale collocazione permette oggi di ripensare non solo il posto ma anche, e soprattutto, il significato e lo scopo della riflessione e dell’azione anarchica e libertaria. Perché nella nostra società, che dice di fondarsi sulla valorizzazione della libertà individuale, l’estremo individualismo favorisce, in maniera solo apparentemente paradossale, potenti e preoccupanti processi culturali di uniformazione, di omologazione di intolleranza verso il pensiero critico e la diversità, a destra come a sinistra; i regimi democratici accentuano costantemente le propensioni populiste e mettono sempre più in secondo piano il tema del controllo e della limitazione del potere; le conquiste della scienza sembrano favorire l’affermazione di pensieri e ideologie che ignorano il dato biologico dell’uomo e affermano la liceità di una manipolazione tecnologica senza limiti della natura umana e dello stesso corpo dell’uomo. Di fronte a tutto ciò, va recuperata quella che Luce Fabbri individuava essere l’esigenza imprescindibile del suo tempo, la libertà dell’essere umano concepito nella società in cui si trova a vivere:
«un ritorno alla realtà concreta costituita dalla persona individuale e dalla sua sfera di azione, come sfera di rapporti con le altre persone, entro la collettività locale in cui convergono e si organizzano tutte le attività di un nucleo geografico determinato (…). Bisogna sottrarsi all’ossessione dell’inevitabilità della riduzione dell’uomo a robot scientificamente determinato e della società a immensa macchina in cui ognuno di noi sarebbe un ingranaggio minimo».


Liberare spazi educativi Dai libri di Dambrosio a ulteriori luoghi di dibattito
Chiara Gazzola
L’interrelazione fra i progetti educativi e gli spazi idonei a ospitarli è inscindibile; pur non essendo un tema nuovo, rimane fondamentale: ogni esperienza pedagogica del passato, che risulta di riferimento a chi cerca di attuare oggi approcci rispettosi dell’evoluzione delle giovani generazioni, si è dovuta confrontare sul come e il perché in rapporto al dove. Ciò è vero soprattutto in luoghi urbanizzati sconvolti dai cambiamenti sociali dovuti anche all’uso imperante del digitale.
A riguardo possiamo trovare molti spunti di riflessione nel libro di Giuseppe Dambrosio, Spazio delle mie brame – Riflessioni sul potere, lo spazio e l’educazione diffusa, Mimesis, Milano 2023, testo che va a completare il precedente dell’autore, Potere, soggettività, postmodernità, Sensibili alle foglie, Roma 2021.
In entrambe le pubblicazioni l’autore si riallaccia alle analisi di Michel Foucault riguardanti i dispositivi di controllo all’interno delle istituzioni totali e la loro trasposizione in ogni ambiente strutturato della società fino alla limitazione delle libertà di scelta, individuali e collettive, pianificate da un addestramento all’autodisciplina e all’obbedienza efficace a tal punto da venir, paradossalmente, percepito come accattivante fattore di realizzazione personale e integrazione sociale.
Dambrosio nel suo primo libro cita Foucault, soprattutto da Les anormaux, per poi riflettere sulle possibilità di resistenza attuabili in una postmodernità caratterizzata da un’organizzazione sociale sempre più efficace nell’incanalare le energie individuali verso modalità di




comportamento finalizzate a un modello unico di produttività, di progettualità nonché di svago. Se i nuovi poteri sono tanto subdoli proprio perché non hanno l’assoluta necessità di ricorrere a divieti, ma reprimono preventivamente attraverso forme di controllo difficili da individuare in quanto introiettate come norma, la nostra lente dovrà saper scardinare queste trappole per focalizzare ambiti di renitenza costruttiva. Le argomentazioni dell’autore si avvalgono di vari contributi (Augè, Bauman, Baudrillard, Benasayag, Frances, Laffi, Lazzarini, Massa, Palmieri e Pierangelo Barone che firma la prefazione), a dimostrazione delle svariate implicazioni che questi cambiamenti
epocali, ampliati dalle derive tecnocratiche, possono produrre. Potere, soggettività, postmodernità è suddiviso in due parti: La medicalizzazione delle differenze, prima parte, analizza i principali ambiti entro cui si instaura una relazione di potere dettata da ruoli verticali (ad es. medico/paziente, insegnante/allievo) e fa notare come il linguaggio giudicante si insinui in maniera arbitraria al fine di ampliare le categorie di comportamento definite anomale da un codice utile al neoliberismo. Questo per inglobarle in una denominazione presa a prestito dal DSM (manuale diagnostico statistico redatto dalla potente lobby degli psichiatri statunitensi che è ormai diventato una sorta di vangelo e non soltanto per gli operatori del settore) e veicolarle nei protocolli scolastici, inquadrando così le naturali difficoltà in «disagio», «inadeguatezza» o «disabilità»: stigmi e discriminazioni, irrispettose delle fasi di crescita tipiche dell’età evolutiva e delle risorse insite in ciascuna bambina o bambino, che condizioneranno la percezione di sé e del mondo circostante, nonché delle possibilità future.
Scrive Dambrosio: «Poiché gli standard di prestazione sono aumentati in modo vertiginoso e gli stimoli esterni agiscono oggigiorno in modo continuativo e invasivo basta un sintomo di troppo per essere delineati come anormali e quindi assoggettabili a un trattamento farmacologico-rieducativo finalizzato al recupero o alla prevenzione continua della devianza e della marginalità sociale. (…) Ne deriva la totale conformazione a un’intelligenza che non è altro che la capacità di disintegrarsi per conformarsi al sistema-azienda post moderno».
Nella seconda parte dal titolo Assoggettamento e soggettivazione nell’epoca post-moderna, viene analizzata la deriva spazio-temporale che coinvolge direttamente l’esistenza di ogni persona: il corpo, la mente, la relazione con i propri simili e l’ambiente, le modalità di poter disporre di luoghi e orari. La decodifica sociale scandita da esasperazioni digitali, come gli algoritmi, risulta tanto coinvolgente da esser illusoriamente



percepita come opportunità gratificante, anziché come una gabbia che diseduca alla relazione e al confronto.
Non a caso la psichiatria sta elencando sintomi e trovando nuove denominazioni per rinchiudere entro una descrizione patologica ogni mancato adeguamento a queste modalità e sull’argomento avremo di che approfondire negli anni a venire.
Questa seconda sezione del libro si focalizza sull’interrelazione fra i concetti di «non spazio», «non corpo» e «non tempo»: una distopia? Eppure la nostra quotidianità non ne è scevra, in quanto la regolamentazione coercitiva del tempo/spazio si insinua nelle nostre azioni con una prospettiva impalpabile e progressiva. E qui Dambrosio sente l’urgenza di dare forma a paradossi e decifrarne i significati affinché non ci travolgano, si colgano in tempo le implicazioni più nefaste, si riconoscano gli squilibri conseguenti e si concretizzino esperienze resistenti in luoghi liberi da simbologie omologanti nel rispetto di ritmi cadenzati sui bisogni.
L’autore, utilizzando una sintesi espositiva efficace, alterna la critica all’esistente con proposte di superamento, privilegiando gli aspetti educativi nell’ottica di una pedagogia critica, non con l’intento di offrire soluzioni indiscutibili ma per avviare spunti di dialogo in contrapposizione al dilagante senso di impotenza e porre «fine al dispositivo di annichilimento della libertà del soggetto, per assumere quello di insegnamento dei modi attraverso cui l’individuo può praticare la libertà». Ribadendo questo concetto, nell’ottica di una coerenza fra mezzi e fini, crea una linea di continuità con la sua recente pubblicazione per le edizioni Mimesis: Spazio delle mie brame, dedicato ai luoghi dell’apprendimento dove «la scuola, così come è stata sin d’ora concepita e tanto più riformata nella sua versione digitale, che definirei tecno-fascista, risulta esser lo spazio educativo meno adeguato alla sperimentazione». Troviamo dettagliate descrizioni inerenti agli ambienti scolastici appositamente strutturati per divulgare un sapere univoco e per impedire contatti con il circostante condizionando la libertà di insegnamento, tanto che per attuare progetti o piccole sperimentazioni si devono raggirare gli impedimenti burocratici e avversare quegli approcci professionali tesi soltanto a un deleterio adeguamento. Si potrebbero comunque considerare come palliativi lontani da ciò che, come anche Foucault sosteneva, dovrebbe intendersi come luogo di partenza per ogni forma di utopia: luoghi dove «il corpo risulta esser il vero protagonista, un corpo che sperimenta e sonda i propri limiti, che esalta tutte le sue potenzialità vitali». Ecco perché le osservazioni di Dambrosio, col suo sguardo privilegiato alla scuola pubblica, risultano avvincenti per avviare un dibattito sulla qualità di ogni




progetto educativo: «il lavoro proposto, inserendosi nella prospettiva di una pedagogia critica, affronta dunque in generale l’importante e spinosa questione del potere in educazione e in particolare indaga l’elemento spaziale del dispositivo disciplinare strutturale».
La riflessione sugli ambiti idonei ad accogliere relazioni educative rispettose dei bisogni, a prescindere dal ruolo che vi si svolge, è un primo doveroso passo per poter attivare esperienze didattiche di superamento dell’attuale impostazione strumentale al controllo, all’inibizione degli interessi, alla rincorsa verso modelli precostituiti di comportamento inquadrati entro una cornice di accettabilità sempre più ristretta. L’eccessiva digitalizzazione è un strumento utile all’ideologia meritocratica; mentre l’aspettativa si fa sempre più performante e la richiesta di allineamento agli standard crea una forbice più ampia, dilaga l’individuazione di condotte anomale per le quali viene richiesto un supporto in termini psicologici e medici: a causa della mancata presa in carico pedagogica, basata sull’osservazione, l’ascolto e la relazione, questi nuovi dispositivi di controllo riescono a plasmare un’uniformità disarmante. E se la scuola si avvale di protocolli normativi statici, dove l’utilizzo di termini come «comunità educante» o «partecipazione» maschera un rigido approccio al sapere considerato al pari di una merce da assimilare e incasellato in valutazioni selettive mentre non si stimolano le capacità critiche o non si valorizzano le curiosità e il piacere della scoperta, questo avviene anche perché gli ambienti scelti per l’istruzione sono strutturati a tal fine, con l’imperante spauracchio della prevenzione a fini di sicurezza che spesso blocca sul nascere qualsiasi proposta innovativa.
Dambrosio prende a riferimento vari autori e, pur tralasciandone di fondamentali come Colin Ward (in particolar modo le sue anticipazioni sull’argomento in: L’educazione incidentale, elèuthera, Milano 2018), appare chiara la volontà di contribuire a un dibattito in termini libertari, di dar voce alle esigenze delle giovani generazioni ed entrare in empatia con i loro desideri, nel tentativo di osteggiare alla radice gli intenti di un sistema gestionale delle esistenze dove l’omologazione è funzionale alla delega e alla de-responsabilità.
Egli rilancia l’idea dell’educazione diffusa, cioè di una scuola inserita nell’ambiente urbano dove l’insegnante diventa guida ispiratrice nel cercare risposte alle curiosità, dove le «competenze» assumono un significato plurale di interrelazione fra saperi: una città diffusa che si fa spazio educativo e luogo di apprendimento attraverso il coinvolgimento di chi vi vive, vi lavora, vi transita. Una scuola che non sarebbe più chiusa fra mura ma è parte del territorio circostante perché con esso entra in




continua relazione: a saperli individuare anche in una città vi possono essere molti «nodi strategici pensati per rendere l’apprendimento dei minori qualcosa di vivo e vitale, stravolgendo nei metodi, negli strumenti e nelle finalità la formazione. (…) Accompagnandoli verso quel nuovo oggetto del desiderio che è il mondo stesso, il mondo reale fatto di piazze, di strade, di ponti, di stazioni metropolitane, di parchi, così come di boschi, di campi, ed insperate, se non improbabili scenografie dell’esistenza».
Ecco allora che mettere in discussione gli spazi educativi rimanda imprescindibilmente alla presa in carico dei luoghi dove l’esistenza sociale prende forma attraverso scelte etiche, filosofiche, politiche che rimettano al primo posto l’aspetto relazionale e il coinvolgimento attivo di chi è protagonista di una determinata esperienza; fare ciò, infine, implica parlare di approcci critici al sapere o, come suggerisce Francesco Muraro nella postfazione di Spazio delle mie brame, di «diritto a un’istruzione liberata».









Riflessi nello sguardo e nella voce di Woody Guthrie
Maurizio Bettelli
All you can write is what you see! 1
Woody Guthrie nasce a Okemah (Oklahoma) nel 1912 e muore, consumato dal morbo di Huntington, al Creedmoor State Hospital a New York nel 1967. Nell’arco di 55 anni di vita, Guthrie ha attraversato anni che possiamo definire fondamentali per la storia degli Stati Uniti - e non solo - gli anni che hanno traghettato l’America verso quella che alcuni storici definiscono come «Era atomica», espressione coniata dal giornalista del «New York Times» William L. Laurence nel 1946. Woody è passato attraverso due guerre mondiali, la crisi del ‘29 - forse la crisi economica più crudele del ‘900 - le migrazioni interne causate dalla siccità e dalle tempeste di polvere che si scatenarono nel Sud-ovest degli Stati Uniti negli anni'30, le grandi dighe e le grandi opere del New Deal rooseveltiano, gli scioperi e le rivolte popolari e la diffusione delle idee anarchiche, socialiste e comuniste del primo ventennio del ‘900, fino alla caccia alle streghe operata dal maccartismo, e ancora la nascita delle prime comuni Beat lungo il «Topanga Canyon» e le proteste in favore dei movimenti per i diritti civili degli anni ‘50 e ‘60. Anni di grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche, che Woody ha registrato



1 «Tutto quello che riuscirai a scrivere è ciò che vedrai!» Il 23 febbraio 1940, Woody Guthrie scrive This Land Is Your Land alla «Hanover House» di New York City. Guardando fuori dalla sua finestra, situata tra la 43esima Strada e la 6th Avenue, Woody annota «All you can write is what you see!» in fondo al testo originale scritto a mano.

con metodo e precisione sui suoi taccuini e sui suoi diari, fissando le sue impressioni in forma di disegno, di pensieri sparsi, di strofe di canzoni o sulle pagine dei suoi romanzi e dei tanti articoli pubblicati sul People’s Daily World in una rubrica intitolata «Woody Sez».
Considerato il padre della canzone americana di impegno sociale, Woody ha rappresentato la maggior fonte di ispirazione per artisti come Pete Seeger, Bob Dylan, Ramblin’ Jack Elliott, Phil Ochs, Bruce Springsteen, Joan Baez, dapprima e Steve Earle, Jeff Tweedy, Billy Bragg, Mary Gauthier, Ani Di Franco e tanti altri successivamente, non solo per i temi trattati nelle sue canzoni, ma anche e soprattutto per quel particolare sguardo con cui osservava l’America passargli davanti. Uno sguardo che non si lasciava certo abbagliare dalle luci al neon delle insegne luminose delle grandi città, o dalle cromature luccicanti delle Cadillac che scivolavano radiose lungo le Highways, bensì uno sguardo che, come una mano amichevole, si allungava verso chi si trovava a vivere sul lato meno luminoso del Sogno Americano.
Potrei dirti per certo dove saranno i guai/Perché sembra proprio che i guai mi seguano ovunque/Potranno essere laggiù vicino al picchetto degli scioperanti/Dai, troviamoci là dove i guai sono di casa!/Sono nato la stessa notte in cui sono nati i guai/vengo dal medesimo letto da cui provengono i guai/ci potrebbe cadere addosso la tua finestra da un momento all’altro/Dai, troviamoci là dove i guai sono di casa!2
Biografi e storici ci raccontano che la vita di Woody Guthrie non fu sempre facile, come si evince anche dalle parole della canzone Where Trouble Is At citate più sopra, e che ci forniscono anche un esempio di quel tratto ironico utilizzato spesso da Guthrie per sorridere dei suoi guai, facendo propri i canoni di quell’umorismo di frontiera così caro a Mark Twain. Fin da subito infatti Woody dovette fare i conti con una famiglia perseguitata dai guai (la perdita di una sorella durante un incendio che distrusse la casa di famiglia, la rovina economica del padre, la malattia mentale della madre che rischiò essa stessa di morire nel corso di un ulteriore incendio che colpì i Guthrie), famiglia che Woody abbandonò presto per dedicarsi a una vita caratterizzata da un inguaribile nomadismo cronico. Nei primi anni del suo vagabondare, Woody si guadagnò da vivere dipingendo scritte artistiche sulle vetrine e sulle insegne dei negozi.


2 Where Trouble Is At, Testo: Woody Guthrie (1940), Musica: Dropkick Murphys (2022).

Le migliaia di giorni, le centinaia di città, le miglia di vernice stesa, le righe tirate con gessi e matite colorate sulle vetrine, sui pannelli, sui muri, sulle case, sulle staccionate e sui tetti. Sui camion. Quando il sole è così rovente che ti ribalta o quando il vento è così forte che ti tira giù. Ho usato i miei pennelli per mettere insieme due fagioli con un po’ di pane.3
Dotato di una notevole abilità pittorica, quando non arricchiva di colori e ghirlande le vetrine dei negozi, Woody fissava sulla carta dei suoi innumerevoli taccuini il mondo che gli scorreva davanti agli occhi. E non era un mondo facile quello che Woody attraversava, correndo da una parte all’altra degli Stati Uniti, prendendo i treni merci al volo, consumando le suole delle scarpe su strade polverose e infinite, dove prendere un passaggio all’autostop era un lusso raro. Quello che Woody vedeva era un paese in trasformazione, proiettato verso una modernità sfrenata, dove a pagare il prezzo più caro di questo scintillante American Dream in-progress erano soprattutto le persone più umili, più deboli, più emarginate, meno scolarizzate e professionalmente meno preparate. Lui stesso, nativo di quell’Oklahoma che aveva conosciuto l’esodo di centinaia di migliaia di poor whites, si era ritrovato a camminare verso una California tanto attraente quanto inospitale, aveva iniziato a tradurre in schizzi a matita e disegni, il dolore dipinto in quegli occhi carichi di disperazione, gli stessi occhi che ritroviamo fissati dai «Sali d’argento» sulla carta fotografica da Dorothea Lange e Walker Evans. Lange e Evans furono i due fotografi americani incaricati dalla Farm Authority Administration di documentare lo stato delle popolazioni americane che risiedevano negli stati del Sudovest, flagellati dalle tempeste di polvere che si abbatterono su quelle terre dalla metà degli anni ‘30 del secolo scorso e che causarono l’esodo di centinaia di migliaia di contadini verso la California. Quei contadini vennero chiamati Okies (diminutivo di abitante dell’Oklahoma) ed entrarono nell’immaginario collettivo con l’appellativo di poor whites (poveri bianchi). Ma se lo sguardo dei fotografi della Farm Security Administration è focalizzato a documentare e a catalogare immagini per fini organizzativi e amministrativi, quello di Woody è uno sguardo di compassione e condivisione, di identificazione e di partecipazione: uno sguardo che sembra dire «sono con voi, cammino con voi, sono uno di


3 D. MARSH and H. LEVENTHAL (ed.), Pastures of Plenty: A Self Portrait - The Unpublished Writings of an American Folk Hero. Woody Guthrie, HarperCollins, New York 1990, p. 139.

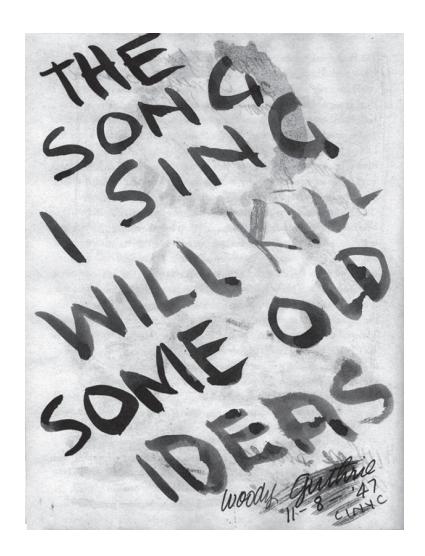

voi e lotterò con voi per migliorare la vostra condizione». Lo sguardo di Woody verso gli esclusi dal «Sogno Americano» non si fermerà con l’esodo degli Okies, ma si trascinerà fuori dai campi profughi della California per riversarsi lungo le Boweries delle periferie delle grandi città, per incontrare gli occhi di quanti aspettano ancora il passaggio di quel «treno che viaggia verso la Gloria», stringendo in mano un biglietto sbiadito.
Bound for Glory oltre al titolo della sua autobiografia, è anche il titolo di una canzone che Woody Guthrie scrisse negli anni ‘40 del Novecento, in cui si racconta di questo treno che viaggia verso la «Gloria» e che non trasporta giocatori d’azzardo, prostitute, assassini, imbroglioni e farabutti di ogni sorta, ma solamente i giusti e le persone per bene.
I loro occhi sono pieni di attesa e di speranza, prima o poi quel treno si fermerà a raccogliermi - pensano - e come il Midnight Special mi illuminerà col suo potente faro. Il Midnight Special era un treno che viaggiava lungo una ferrovia che si chiamava Illinois Central Railway e attraversava lo stato del Mississippi, ma è anche il protagonista di una canzone di Leadbelly del 1946. Nella canzone si narra che se il faro della locomotiva del convoglio, passando accanto al penitenziario, ti illuminava il volto mentre eri aggrappato alle sbarre della finestra, era certo che entro breve saresti stato rilasciato e per arrivare al perseguimento di quella Happiness che è il caposaldo su cui si fonda questo Grande Paese. Paese che ognuno, col proprio lavoro, col proprio sacrificio e col proprio sangue ha contribuito a creare e a mandare avanti come sancisce la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776: «Riteniamo che queste verità siano evidenti, che tutti gli uomini sono creati uguali, che sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che tra questi ci sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità».



98

Non sopporto quelle canzoni che ti fanno pensare che non sei bravo a far niente… destinato a perdere. Non fanno bene a nessuno. Non fanno bene per niente. O perché sei troppo vecchio o troppo giovane o troppo grasso o troppo magro o troppo brutto o troppo questo o troppo quello… Canzoni che ti buttano a terra o canzoni che ti prendono in giro per via della tua sfortuna o del tuo duro viaggiare. Sono pronto a combattere queste canzoni fino all’ultimo respiro e fino alla mia ultima goccia di sangue. Sono pronto a cantare canzoni che ti dimostrino che questo è il tuo mondo e anche se ti ha colpito piuttosto forte e ti ha fatto cadere per una dozzina di volte, non importa quanto duramente ti abbia sbattuto per terra o ti sia rotolato addosso non importa di che colore sia la tua pelle, quale taglia porti e come sei fatto, io sono pronto a cantare le canzoni che ti rendono orgoglioso di quello che sei e del tuo lavoro. E le canzoni che canto, per la maggior parte, sono fatte di persone di ogni tipo, persone proprio come te.4
Per tradurre in forma scritta tutto quello che gli occhi di Woody erano riusciti a vedere, per tradurre in canzone quei disegni e quei pensieri sparsi abbozzati sui taccuini, oltre al testo era necessario trovare una musica e su quella accordare una voce capace di dar fiato a quanti non avevano o non potevano far sentire la propria. La voce di Woody era perfetta per questo ruolo, perché non era una voce dolce ma era una voce «aspra e nasale», come la definì Steinbeck, che andava contro i canoni estetici comunemente condivisi e strombazzati da una costa all’altra degli Stati Uniti attraverso le onde delle migliaia di stazioni radio che diffondevano canzonette commerciali nell’etere.
E proprio la radio fu il medium attraverso cui la voce di Woody poté diffondersi nei campi profughi, nei bar delle periferie, nelle sedi del sindacato e nelle stanze delle comunità italiane, polacche, tedesche, sudamericane, e quelle canzoni diventarono canzoni di protesta e di lotta, canzoni che raccontavano la fatica del lavoro, la difficoltà a vivere con quelle misere paghe, la dignità troppo spesso calpestata5 .



4 Woody Guthrie, Woody Sez, Woody Guthrie Publications, Inc.
5 Nel 1939 […] Woody Guthrie era tornato alla radio KFVD di Los Angeles, una stazione sul lato sinistro del quadrante politico. Lì incontrò Ed Robbins, redattore del People’s World, un giornale comunista, e conduttore di un programma radiofonico con una carrellata quotidiana di notizie principalmente sulle lotte dei lavoratori e sui sindacati. A Ed piaceva la musica di Woody e invitò il «cowboy melodico» a cantare a un raduno, ma gli chiese se gli importava che fosse per un raduno di sinistra. Woody rispose: «Ala sinistra, ala destra, ala di pollo: per me è la stessa cosa».


E dove c’era una protesta, dove c’era un gruppo di persone in lotta per difendere i propri diritti o il proprio lavoro, dove c’era un fatto di cronaca che meritava di essere portato in primo piano, o dove ancora c’era da raccontare il martirio di Sacco e Vanzetti, i cantieri delle grandi dighe in costruzione sul fiume Columbia o rincuorare le truppe americane impegnate a liberare l’Europa dai nazifascisti, lì c’era Woody, «con la sua voce aspra e nasale e la sua chitarra penzolante dal collo come un ferro da gommista appeso a un vecchio cerchione arrugginito»6 .
…la parola è la musica e le persone sono la canzone7
La voce di Woody non si è mai spenta, le sue canzoni hanno continuato a girare nei concerti sia in America che nel resto del mondo. Dai protagonisti del Folk Revival degli anni ‘60 del secolo scorso, fino a oggi, la lista degli interpreti che hanno cantato i suoi versi è sterminata.
A partire dal 1993, Nora Guthrie, figlia di Woody, ha recuperato, raccolto, catalogato, organizzato e archiviato tutto il materiale grafico, e non solo, prodotto dal padre nel corso della sua vita, e ha costituito i Woody Guthrie Archives, dapprima a New York City e poi a Tulsa in Oklahoma, in uno spazio dove ogni foglio di carta, ogni pagina di diario, ogni disegno vergato dalla mano di Woody, così come ogni spartito e ogni registrazione sonora e ogni pubblicazione che abbia a che fare con lui, è a disposizione per la consultazione da parte di studiosi e appassionati. Questo lavoro certosino di recupero e archiviazione ha dato nuova linfa e nuova vita alle parole di Woody, infatti negli ultimi vent’anni un gran numero di autori e compositori americani ed europei, ha attinto a piene mani da quegli archivi, facendo affiorare testi inediti che hanno trovato nuove voci e nuove melodie. A partire dalla fine degli anni ‘90 del ‘900, gli ine-



6 «Woody è semplicemente Woody. Migliaia di persone non sanno che lui abbia un altro nome. Lui è solo una voce e una chitarra. Canta le canzoni di un popolo e sospetto che sia lui, in un certo senso, quel popolo. Con la voce aspra e nasale, la sua chitarra appesa come un ferro da gommista su un cerchio arrugginito, non c’è niente di dolce in Woody, e non c’è niente di dolce nelle canzoni che canta. Ma c’è qualcosa di più importante per coloro che ascolteranno. C’è la volontà del popolo di resistere e lottare contro l’oppressione. Penso che questo sia ciò che chiamiamo lo Spirito Americano» (John Steinbeck, cit. in J. KLEIN, Woody Guthrie: A Life, Delta, New York 1981, p. 160.).
7 «La musica è un tono di voce, il suono che la vita usa per mantenere in vita i vivi. Veniamo messi in guardia più volte al giorno dalla sofferenza, dagli abissi della superstizione. Non c’è mai stato un suono che non fosse musica - non esistono trucchi per creare parole da mettere in musica - una volta che ti sei reso conto che la parola è la musica e le persone sono la canzone». (Woody Guthrie Diary, introduzione scritta il 3/16/1942 Woody Guthrie Publications, Inc.).

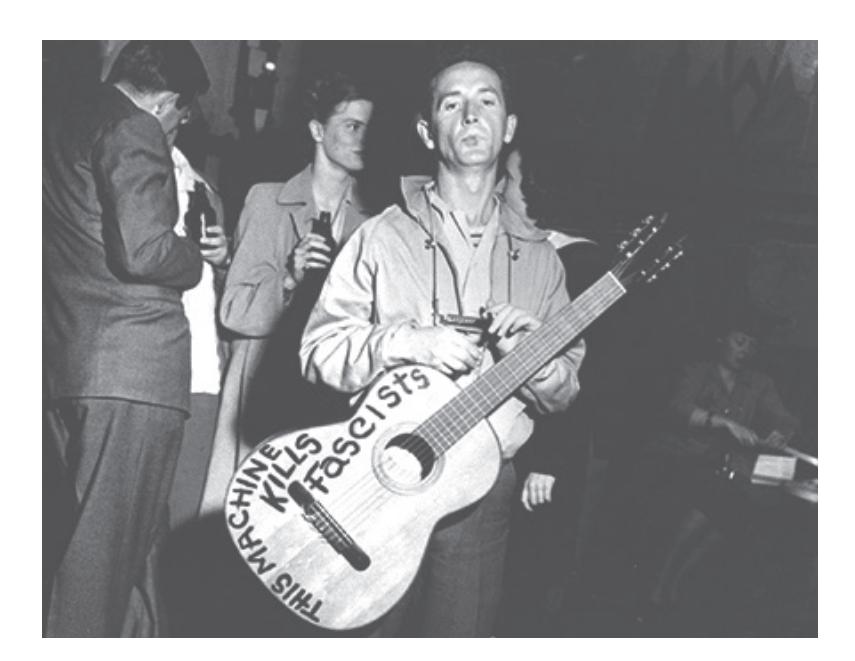
diti di Woody messi a disposizione dalla figlia Nora a vari artisti hanno generato una serie di album estremamente interessanti, anche perché hanno portato alla luce aspetti di Guthrie assolutamente inusuali e inaspettati, offrendoci un’immagine dell’artista assai più complessa e svincolata da quel cliché di workingman hero a cui lo aveva relegato una certa critica musicale fortemente ideologizzata. Su tutto e su tutti prevale uno spirito libero, curioso, anticonvenzionale e pronto a sfidare e a sfidarsi sui terreni più disparati: dalle meditazioni sul destino dell’uomo dopo la morte, fino alle feste religiose ebraiche, temi dolorosi come la Shoah e momenti di leggera evasione come le canzoni dedicate a Ingrid Bergman8 . É in tempi come questi, così veloci, autoreferenziali e pericolosamente superficiali, che quelle parole, quelle musiche, quelle voci aiutano a tenere vivo in tutti noi quel particolare sguardo con cui Woody ci ha insegnato a guardare il mondo, a capire da che parte stare, e a continuare a cantare per dare voce a chi voce non ha, finché avremo fiato in gola e sangue nelle vene.



8 Tra gli album che hanno dato nuova vita alle parole di Guthrie vale la pena di ricordare: Mermaid Avenue Vol I e Mermaid Avenue Vol II di Billy Bragg and Wilco, rispettivamente del 1998 e del 2000; Wonder Wheel e Woody Guthrie’s Happy Joyous Hanukkah dei Klezmatics rispettivamente del 2006 e 2008; Note of Hope, una sorta di album tributo che vede assieme Van Dyke Parks, Madeleine Peyroux, Tom Morello, Lou Reed, Michael Franti, Kurt Elling, Ani DiFranco, Studs Terkel, Nellie McKay, Chris Whitley ,Pete Seeger & Tony Trischka, Jackson Browne del 2011; New Multitudes di Jay Farrar, Will Johnson, Anders Parker and Yim Yames, del 2012; Peace Town di Jimmy LaFave del 2018 This Machine Still Kills Fascists e Okemah Rising dei Dropkick Murphys rispettivamente del 2022 e 2023.
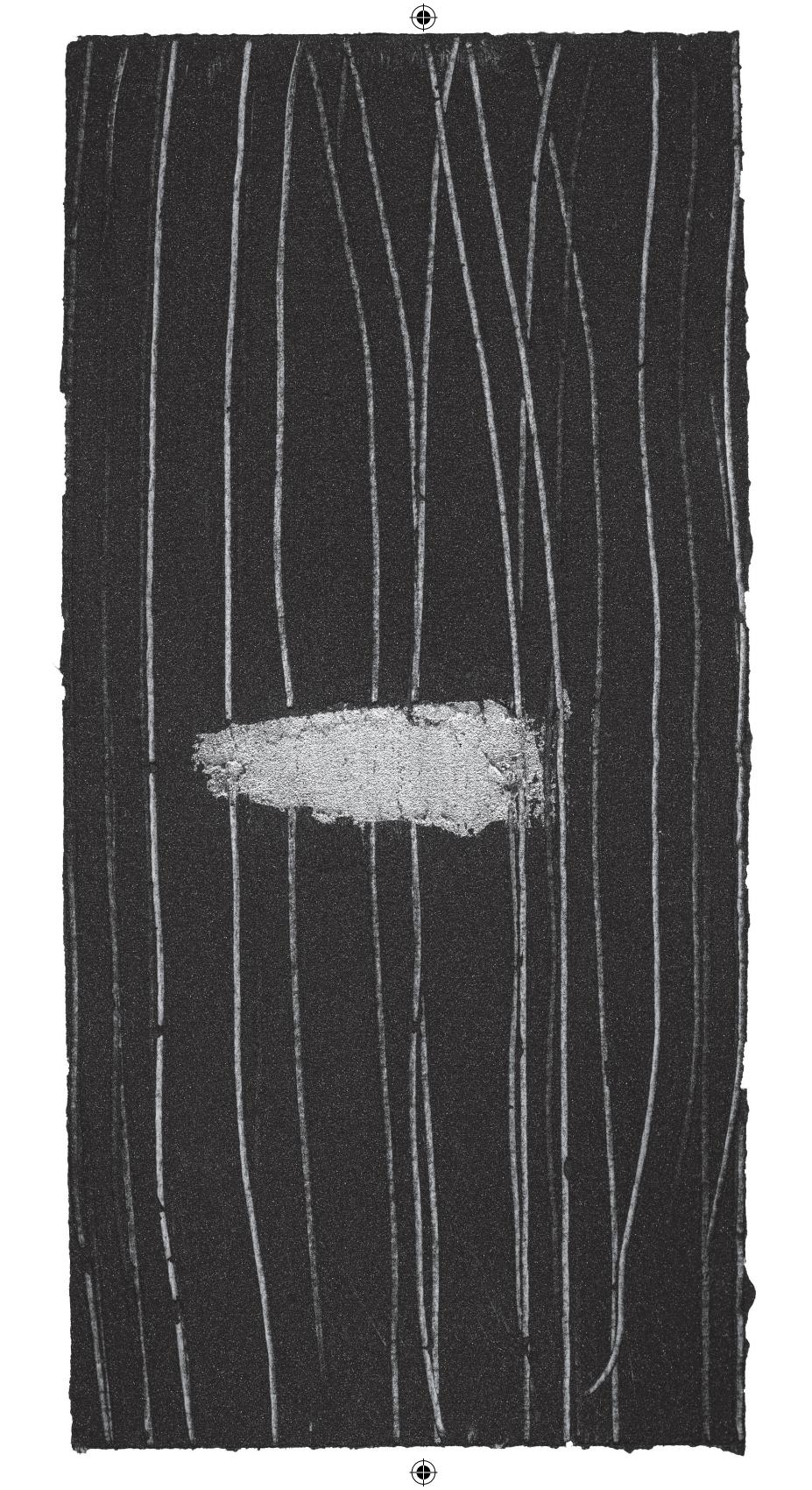



Alla ricerca di una definizione
Cosa dobbiamo intendere per violenza? Si può convenire sul fatto che la violenza è una «alterazione del corso naturale degli eventi, quando ne derivi distruzione e sofferenza» (Jervis 1998). Alterazione non casuale, ma volontaria: perché un’azione causa di un danno possa essere qualificata come violenta, è necessario che sia il frutto di una deliberata intenzione di provocare un’offesa da parte di colui che l’ha posta in essere. D’altro canto, invece, non è sempre vero che la violenza si esercita contro la volontà di chi la subisce: può darsi il caso di chi, ad esempio, esercita volontariamente la violenza contro se stesso (Stoppino 1991: 1221). Il campo semantico della parola violenza si è andato espandendo nel corso del tempo, per includere oggi, insieme a quelle fisiche, anche le forme di violenza psicologica, per certi aspetti più difficili da individuare e classificare. Ecco, allora, che la violenza può essere definita come «l’abuso della forza (rappresentata anche da sole parole o da sevizie morali, minacce, ricatti), come mezzo di costrizione, di oppressione, per obbligare cioè gli altri ad agire o cedere contro la propria volontà» (voce violenza dell’Enciclopedia on line della Treccani).
Quale che sia la definizione più corretta del termine, da un punto di vista libertario pare fondamentale osservare che – eccezion fatta forse per la violenza autoinflitta – il concetto di violenza rimanda a quello di coercizione: a un antonimo, cioè, della parola libertà.




Il paradosso della violenza politica
Sul piano politico, vale la pena rilevare il seguente paradosso. Ogni struttura politico-sociale ha sempre assunto tra i suoi fini primari quello di assicurare la pacifica convivenza dei suoi membri, di minimizzare i conflitti e la violenza tra i privati, scongiurandone, in particolare, la manifestazione più estrema, la guerra civile: l’«anarchia», secondo uno dei significati dispregiativi attributi a questa parola fino ad oggi, a partire dagli antichi greci (Canfora 2013: 5). Guerra civile che, per centinaia di anni, è stata pensata e presentata, appunto, come l’effetto inevitabile dell’assenza di una forte e riconosciuta autorità politica. Tuttavia, per pervenire a questo scopo – la pace sociale –, la medesima struttura politico-sociale si investe, o viene investita, della titolarità del monopolio legittimo della forza, perciò anche della violenza. Proprio questo monopolio ha sempre determinato, di fatto, una serie più o meno rilevante di abusi e violenze da parte dei detentori del potere costituito, che devono essere ritenuti, considerata l’imperfezione della natura umana e dei sistemi politici conseguentemente creati dagli uomini, un cascato in certa misura inevitabile dell’esistenza e dell’esercizio del potere stesso, come, tra gli altri, osservò Montesquieu: «è una esperienza eterna che qualunque uomo che ha un certo potere è portato ad abusarne; va avanti finché non trova limiti» (Montesquieu 1997: 309). Di qui l’attenzione costantemente rivolta nei secoli, in specie nella cultura occidentale che, più di altre, ha assegnato un valore crescente al diritto alla vita e alla libertà, al tema della costituzionalizzazione e limitazione del potere politico. Di qui, pure, la teorizzazione esplicita, a partire dall’età antica, in forme nonviolente o violente, del diritto di resistenza – sino a contemplare esplicitamente il tirannicidio (Turchetti 2001) – all’esercizio dispotico del potere, vale a dire al dispiegamento di una forza coercitiva e violenta, oltre e contro il diritto, strumento principe di regolazione razionale e funzionale del potere, cioè della violenza legittima e socialmente accettabile. A questo proposito, con riferimento temporale anche a tempi assai recenti, pare tuttavia corretto distinguere in maniera abbastanza netta tra ordine interno e ordine (o disordine) internazionale, giacché i sistemi politici sono stati costruiti sulla dicotomia tra amico e nemico e sulla tendenziale disumanizzazione del secondo, cosa che ha spesso portato gli stessi critici dell’abuso dell’autorità nei confronti della comunità politica verso cui la sovranità è esercitata, a legittimare un grado di violenza e coercizione maggiore nei confronti dell’altro da sé, dello straniero, come dimostrano, in particolare, la storia moderna e contemporanea degli Stati nazionali, del complesso fenomeno della colonizzazione e dell’imperialismo.




Inoltre, la crescente capacità di controllo dei cittadini da parte del potere politico, resa possibile dall’eccezionale sviluppo dell’organizzazione politica, economica, amministrativa e tecnologica della società verificatosi negli ultimi secoli, ha accresciuto enormemente la capacità offensiva degli Stati nei riguardi dei cittadini. Non a caso, dunque, il secolo trascorso, teatro di genocidi e stermini di massa operati dagli Stati, spesso perpetrati verso parte dei propri stessi cittadini, è stato definito quello della «massima violenza dello Stato sull’uomo» (Grossman 1996: 222) o dello «Stato criminale» (Ternon 1997). Il secolo in cui la violenza è stata non solo praticata, ma anche esaltata come mai, prima, nella storia era stato fatto: «esasperazione patriottica, romanticismo rivoluzionario, “fardello dell’uomo bianco”, affermazione del superuomo al di là del bene e del male, riflessioni soreliane sulla violenza, terrore giacobino, fascista, bolscevico eccetera» (Caffi 1995: 64-65).
Per tutte queste ragioni, Rummel ha osservato che «più il potere è concentrato nelle mani di un governo, più potrà agire arbitrariamente in base ai capricci e ai desideri delle élites dominanti, più questo governo tenderà a fare la guerra agli altri governi e più ucciderà i propri sudditi e quelli stranieri. Più limitato è il potere di un governo, più il potere è frammentato, controllato e bilanciato, meno risulterà aggressivo verso l’esterno e meno potrà commettere un democidio» (Rummel 2005: 3-4).
Anarchismo e violenza
Nel corso della storia, a più riprese, da angolature diverse, il pensiero politico e le dottrine religiose, nella loro quasi totalità, hanno giustificato la violenza del potere politico e delle autorità ecclesiastiche – includendo guerre, conquiste, stragi, assassini legali, persecuzioni etc. – come mezzi in alcune circostanze utili e necessari, per quanto eticamente riprovevoli, per conseguire determinati scopi, considerati superiori. Di più: è stato osservato come la violenza, che ha avuto un «enorme ruolo negli affari umani», è stata raramente fatta oggetto di analisi specifica e approfondita, in quanto data per naturale, inevitabile o necessaria (Arendt 2002: 11). Così, per scegliere un esempio tra i molti, la tortura giudiziaria è stata lungamente considerata uno strumento legittimo per acquisire la confessione degli indiziati, un elemento ritenuto necessario per emettere una condanna di colpevolezza (Fiorelli 1953-54).
Sino all’età moderna, tuttavia, la dimensione morale e quella politica sono state generalmente concepite in maniera correlata e la violenza, pertanto, è stata pensata all’interno di questa cornice. Lo svelamento del




dramma della politica e, in un certo senso, della «nudità» del potere, la consapevolezza che la sfera politica è dotata di caratteristiche e fini suoi propri, che sono distinti e potenzialmente in conflitto con quelli della morale, è emersa in età moderna e nello specifico con la riflessione di Machiavelli, il quale come noto ha affermato crudamente che l’azione politica deve essere valutata in virtù dell’efficacia nel conseguire i suoi obiettivi, la conquista e il mantenimento del potere, e non può essere parametrata sulla base di altri criteri, come quello della bontà/malvagità, che sono caratteristici della sfera morale (Machiavelli 1995: 102-120). Un genere nuovo di violenza – e di teorizzazione della violenza – si è sviluppato con la nascita delle ideologie moderne, in specie quelle legate a dottrine politiche che hanno postulato la trasformazione radicale della società – quando non il cambiamento dello stesso statuto ontologico dell’umanità. Così se per Rousseau il legislatore istitutore di una nuova civiltà deve sentirsi in grado di cambiare la natura umana, dato che tutto dipende dalla politica (Rousseau 1994: 115; 1997: 398), per Robespierre «il governo rivoluzionario (…) ai nemici del popolo deve dare solamente la morte», giacché la sua forza risiede tanto nella virtù, quanto «nel terrore»: nella virtù, «senza la quale il terrore è cosa funesta»; nel terrore, «senza il quale la virtù è impotente» e la rivoluzione non è altrimenti in grado di «domare (…) i nemici della libertà» (Robespierre 1992: 145, 169). A partire dalla Rivoluzione francese sono emerse dottrine politiche di ispirazione prevalentemente autoritaria – ma anche libertaria, democratica e repubblicana – che hanno inteso legittimare una specifica forma di violenza – quella, appunto, ideologico-rivoluzionaria – volta a scardinare l’ordine politico esistente, a porre fine a una condizione di ingiustizia sociale e di mancanza di libertà ritenuta intollerabile e a istaurare un nuovo ordinamento politico, sociale ed economico, fondato su valori diversi, se non opposti, a quelli vigenti. In questa tradizione di pensiero e di azione, in gran parte, con diversi accenti, favorevole alla violenza politica (Adamo 2004: 12) si è sviluppato l’anarchismo, che tuttavia, nell’immaginario popolare, è stato ed è quasi universalmente associato a, se non totalmente indentificato con, la violenza: in una maniera che non pare improprio definire approssimativa e semplicistica. Quanto questo pregiudizio sia erroneamente fondato lo si ricava da numerosi aspetti. Anzitutto perché l’anarchismo, in senso filosofico e storico, è stato ed è un insieme eterogeneo di correnti di pensiero e movimenti o raggruppamenti politici, culturali e sociali tra loro differenti – e, in alcuni casi, scarsamente o per nulla comunicanti tra di loro – che, rispetto alla violenza, legata o meno a una dimensione rivoluzionaria e/o insurrezionale, hanno elaborato posizioni diverse, se non opposte. Tra i grandi classici




dell’anarchismo va annoverato Tolstoj, fautore della non-violenza e figura di riferimento importante per Gandhi, a sua volta pensatore e attivista vicino, per molti riguardi, a una prospettiva socialista-libertaria. Che il primo teorico dell’anarchismo sia stato un pensatore incline al pedagogismo come William Godwin, che concepiva la trasformazione sociale come l’effetto di una grande opera educativa non coercitiva degli uomini, non può essere considerato un caso.
Il fatto è che, sotto un profilo teorico e ideale, l’anarchia – definibile con approssimazione come una struttura sociale o comunitaria di liberi ed eguali, fondata sull’autogestione politica ed economica dei suoi membri – è stata da sempre pensata dagli anarchici, di ogni tendenza – collettivista o individualista; organizzatrice o anti-organizzatrice; favorevole o meno alla violenza come metodo legittimo di lotta politica – come l’opposto della coercizione e del dominio dell’uomo sull’uomo: come l’opposto, appunto, della violenza. O, meglio ancora, come l’opposto della più rilevante forma di violenza, quella sistematicamente perpetrata dallo Stato, dall’autorità politica, dalle classi dominanti. Così Malatesta, fino all’ultimo, sia pure con un senso di criticità crescente, legato alla teoria e pratica dell’insurrezionalismo rivoluzionario – nonché al suo mito – puntualizzò lucidamente che la società a cui aspirano i libertari è «uno stato sociale in cui la concordia e l’amore sieno possibili tra gli uomini». Ad avviso di Malatesta, quella che lui definiva la «violenza liberatrice» esercitata dagli anarchici doveva perciò essere intesa come una triste necessità dettata dalle avverse circostante storiche. «Anarchia vuol dire non-violenza, non dominio dell’uomo sull’uomo, non imposizione per forza della volontà di uno o di più su quella degli altri». Con grande acume, Malatesta, che pure riconosceva nel conflitto tra le classi sociali e le minoranze agenti un elemento decisivo e fondamentale della storia umana, osservava anche che, «malgrado le inenarrabili sofferenze e umiliazioni inflitte (…) quello che realmente predomina nella convivenza umana, o che almeno ne forma l’elemento vitale e progressivo, è il sentimento di simpatia, il senso di comune umanità che, nelle condizioni normali, mette alla lotta un limite oltre il quale non si può andare senza eccitare una ripugnanza profonda e una generale riprovazione» (Malatesta 1975: I, 61; II, 191; III, 106).
Appare tuttavia innegabile che i pensatori anarchici e soprattutto parte considerevole dell’anarchismo storico, di matrice europea, abbia intrattenuto con la violenza, di massa o individuale, un rapporto complesso, sofferto, in taluni casi ambiguo, in altri simbiotico. Lo spettro delle posizioni e delle azioni è talmente ampio e diversificato che è impossibile anche solo riassumerlo in questa sede.




Significativo e istruttivo, per la ricostruzione storica della relazione tra anarchismo e violenza, il rapporto – temporalmente assai breve, ma simbolicamente alquanto denso di significati e per molti aspetti emblematicamente rivelatore – tra Bakunin e Nečaev, vero precorritore del terrorismo di Stato bolscevico e, non a caso, figura carissima, per questo ed altri riguardi, a Lenin (Strada 2018: 31-39). Michael Confino ha dedicato a questo capitolo uno studio esemplare, che se da un lato scagiona Bakunin dall’accusa di essere l’autore e l’ispiratore teorico del Catechismo del rivoluzionario, testo nel quale si legittima e prefigura lo sterminio fisico di interi gruppi umani sulla base dell’appartenenza di classe (Confino 1976; in particolare 30-43 per la distanza ideologica tra i due; sulla quale aveva già richiamato l’attenzione Venturi 1972: 310-311), dall’altro evidenzia come il fondatore del movimento anarchico sia stato sinceramente e ingenuamente attirato dalla devozione fanatica di Nečaev per l’azione rivoluzionaria e per il proposito, da lui condiviso e come tale chiaramente definito, di «distruzione totale del mondo statalista-legalitario e di tutta la cosiddetta civiltà borghese» (Bakunin a Nečaev, citato in Confino 1976: 137).
Si dà il caso, tuttavia, che, nell’anarchismo di matrice socialista divenuto, in specifici contesti, un movimento politicamente rilevante, la violenza politica è stata considerata perlopiù come un metodo di lotta imposto dal potere politico e dalle classi dominanti, che sarebbe scomparso immediatamente dopo l’abbattimento del potere politico ed economico e che, in ogni caso, costituiva solo un tassello, per quanto ineludibile, verso la trasformazione libertaria della società. Così, nel maggio del 1936, alla vigilia del levantamiento di Francisco Franco iniziatore della guerra civile spagnola, nel cui contesto maturò l’esperienza della rivoluzione, la C.N.T. adottava nel congresso di Saragozza una risoluzione secondo la quale la rivoluzione stessa non doveva essere intesa come «un episodio violento, per mezzo del quale si distrugge il regime capitalista. Essa in realtà non è altro che il fenomeno che lascia il passo di fatto a uno stato di cose che, fin da molto tempo prima, ha preso corpo nella coscienza collettiva» (cit. in Peirats 1976: 174).
I cenetisti, insomma, intendevano la rivoluzione come un processo di lungo periodo, che comportava una trasformazione dell’immaginario istituito attraverso la propaganda, l’auto-organizzazione degli oppressi, le lotte sociali e che solo alla fine si sarebbe estrinsecata in un atto violento di abbattimento del sistema, grazie al quale il «mondo nuovo» covato nei decenni precedenti si sarebbe, infine, dischiuso alla luce.
Nel secondo dopoguerra, dopo la sconfitta del nazifascismo, si è assistito a una progressiva perdita di incidenza dell’anarchismo nei paesi in cui



aveva svolto un ruolo politico e sociale significativo tra la fine del XIX e i primi decenni del XX secolo. Nel periodo compreso tra gli anni ‘60 e ‘80 del Novecento si è sviluppata una nuova forma di anarchismo, che si è intersecata, non senza problemi, con quella residuale preesistente: un anarchismo legato in parte significativa alle lotte studentesche e a inedite forme di contestazione del potere, in ambito politico, culturale, sociale ed economico. La ripresa della violenza politica, teorizzata e praticata da alcune formazioni dell’estrema sinistra sino a sfociare nel terrorismo, da un lato, lo sviluppo di una forte coscienza pacifista in parte significativa dell’opinione pubblica occidentale, dall’altro, ha portato anche all’interno del movimento anarchico a una ripresa del dibattito sull’uso legittimo della violenza, che è risultato condizionato e arricchito da elementi nuovi: l’esperienza dei totalitarismi, le cocenti sconfitte del movimento rivoluzionario di ispirazione libertaria, lo sviluppo delle democrazie liberali ad economia capitalista, il benessere socio-economico, la perdita di centralità politica del movimento operaio, la crisi dell’idea tradizionale di rivoluzione, l’emergenza ecologica, il femminismo etc.
Dall’analisi alla riflessione: considerazioni sul passato, sul presente e sul futuro
Oggi, una riflessione sulla violenza in ambito libertario non può prescindere dalle analisi sviluppate negli ultimi decenni e dalle lezioni della storia. Occorre ripensare la questione a partire dalla distinzione tra il piano teorico e quello pratico, tra l’ambito dei principi e dei valori e l’ambito della tattica e della strategia politica, perché se è vero che l’anarchismo, come il marxismo sotto questo profilo, non è una filosofia contemplatrice del mondo, ma una «filosofia della prassi», sorta per trasformarlo radicalmente, diversamente da questo, tuttavia, ha sempre postulato una stretta correlazione tra i mezzi utilizzati e i fini perseguiti e proprio per tale motivo – il motivo che significativamente è stato all’origine della rottura dei rapporti tra Bakunin e Nečaev, accusato dal primo di «machiavellismo», cioè di aver separato l’azione rivoluzionaria dai suoi principi etico-politici ispiratori – non ha potuto e non può che considerare criminale e insensata l’idea, espressa per esempio da Lenin in Stato e rivoluzione, che a una pacifica società senza governo si possa giungere attraverso una pedagogia totalitaria fondata sul dispiegamento di una inaudita violenza statale destinata a durare «un’intera epoca storica»: a parole «senza violenza e sottomissione»; di fatto, attraverso una esplicita «disciplina di “fabbrica”» estesa a tutta la società (Lenin 1975: 294, 308).




Sul piano teorico, da un punto di vista libertario, l’analisi della questione della liceità della violenza in ambito politico necessita di essere affrontata in maniera chiara, ma difficilmente può dar luogo a un punto di vista univoco e assoluto. Lo stesso pensiero di Gandhi evidenzia la difficoltà di concepire in senso categorico il problema della violenza. Il grande pensatore e attivista indiano, infatti, ostile perfino a una guerra contro il nazismo – «se vi potesse mai essere una guerra giustificabile in nome dell’umanità, una guerra contro la Germania per impedire l’assurda persecuzione di un’intera razza sarebbe pienamente giustificata»: ma nessuna guerra è giustificabile in questo senso (Gandhi 1973: 254) – ammetteva, però, l’eutanasia e l’uccisione di animali (72-73). Va tenuto presente il fatto che i valori ultimi – per esempio la libertà, l’uguaglianza, la giustizia sociale, la pace etc. – sono in misura considerevole antinomici. È pertanto difficile, se non impossibile, pensare a una loro compresenza, se non nel senso di una loro coesistenza relativa. Inoltre, l’esperienza storica ha reso evidente come molto spesso gli individui e i gruppi sociali si sono trovati nella spiacevole circostanza di operare delle scelte esclusive tra questi valori, sulla base di una scala assiologica di preferenza. L’anarchismo, ad esempio, postula la priorità del valore della libertà sugli altri (Bertolo 2017: 89-90). In ultima istanza, dunque, l’anarchismo considera il valore della libertà più importante della stessa vita: da ciò ne discende logicamente la superiorità dell’ideale della libertà rispetto a quello della pace (Berti 2012: 368-371). Ciò permette, quantomeno, di definire un limite e di aprire uno spazio alla pensabilità della violenza, all’interno di determinate coordinate, difficili a definirsi in via astratta e preventiva. Tutto sembra indurre, però, a pensare tali limiti in senso decisamente restrittivo. Da un punto di vista generale, per esempio, difficile non concordare con la Arendt laddove osserva che «dato che il fine dell’azione umana (…) non può mai essere previsto in modo attendibile, i mezzi usati per raggiungere degli obiettivi politici risultano più importanti, per il mondo futuro, degli obiettivi perseguiti». Nel caso della violenza, dunque, quale che sia il fine perseguito, esso «corre il pericolo di venire sopraffatto dai mezzi che esso giustifica per raggiungerlo» (Arendt 2002: 6).
La violenza non è un mezzo «neutro», se mai ce ne possa essere uno. Essa racchiude in se stessa delle potenzialità altamente liberticide, essendo fondata sul principio della coercizione. Perciò, «se la violenza può trovare giustificazione quando è l’unico mezzo per resistere o reagire alla ben maggiore violenza del potere e dello sfruttamento, essa però contiene in sé i germi di un nuovo dominio ed è dunque essenziale ricorrervi solo se strettamente necessario» (Codello 2009 2: 155). Ma cosa è da intendersi per «strettamente necessario»?




Prendendo in considerazione la violenza come metodo di lotta utilizzato da singoli individui o piccoli gruppi, è facile constatare come «quasi mai gli attentati e i gesti violenti» sono riusciti a scalfire «il dominio degli stati e delle istituzioni» (Codello 2009 1: 26). Più articolato deve essere il giudizio sulla violenza operata da grandi movimenti e posta in essere con l’obiettivo di provocare un sommovimento rivoluzionario. La «lezione» dei due più importanti esperimenti rivoluzionari a cui ha dato vita l’anarchismo, la machnovščina e l’autogestione operaia e contadina di parte della Spagna sotto il controllo delle forze repubblicane durante la guerra civile, evidenzia tuttavia i paradossi e le contraddizioni insite nel rapporto tra libertarismo e violenza. Le brevi estati dell’anarchia ucraina e spagnola sono sorte infatti grazie alla violenza, e specificamente alla più terribile di tutte le guerre, la guerra civile: curiosamente e per certi aspetti perversamente, l’«anarchia» nell’accezione comune di caos guerreggiato tra fazioni rivali è stata levatrice dei prodromi della «vera» anarchia degli anarchici, cioè di un ordine privo di violenza, in quanto organizzato senza l’autorità. Questa fondazione si è rivelata tuttavia del tutto effimera, sia perché ne ha condizionato molto negativamente lo svolgimento, sia perché ne ha causato, da ultimo, l’infausto esito. Per vincere la guerra, infatti – quella esterna contro le forze contro-rivoluzionarie e quella interna contro i comunisti autoritari – gli anarchici avrebbero probabilmente dovuto esercitare una violenza maggiore e organizzarsi in un senso ancora più militarizzato: violenza e militarismo che si erano peraltro già concretizzate nella creazione di due eserciti, in un controllo militare del territorio e, nel caso della C.N.T., nella partecipazione a un governo rivoluzionario insieme ad altre forze fedeli alla repubblica. Così, Cipriano Mera, eroe anarchico di Guadalajara, chiedeva nel marzo del 1937 una disciplina militare «ferrea» per vincere la guerra e Nestor Machno fu indotto a elaborare nel 1921, dopo una grave sconfitta militare patita dalle forze bolsceviche, il progetto di una dittatura del lavoro che costituisce l’abbozzo della Piattaforma organizzativa di stampo autoritario elaborata dal leader anarchico nell’infelice esilio francese dopo la capitolazione delle forze al suo comando (Peirats 2: 159; Shubin 2012: 181). Le diverse ma significative recenti esperienze libertarie sviluppatesi in Messico per opera dell’esercito zapatista e nel Rojava grazie all’impulso e alla direzione del Partito dell’Unione Democratica, presentano alcune analogie con i casi summenzionati – due territori in cui l’organizzazione in senso libertario e mutualista della società è stato reso possibile dalla liberazione attuata da milizie popolari armate – e possono perciò costituire un’ulteriore, interessante, fonte di riflessione riguardo




all’utilizzo e all’organizzazione della violenza in rapporto alla creazione di una società più libera e più giusta.
Scriveva Camus: «Dobbiamo allora ritrovare in noi stessi, nel cuore della nostra esperienza, cioè all’interno del pensiero della rivolta, i valori di cui abbiamo bisogno (…), dobbiamo studiare la contraddizione in cui si è dibattuto il pensiero della rivolta, tra nichilismo e aspirazione a un ordine vitale, e superarla grazie a quello che ha di positivo» (Camus 1998: 37). La storia procede per tentativi ed errori ed è pertanto fondamentale tenere in debito conto l’esperienza storica al fine di non reiterare gli errori del passato. Al di là degli esempi sovraesposti, riferiti a condizioni di grave crisi politica, illiberali o scarsamente democratiche, pare opportuno sottolineare il fatto che l’utilizzo della violenza politica comunque intesa, da un punto di vista libertario, appare in generale riprovevole sotto il profilo etico e politicamente assai controproducente in contesti, come quelli delle democrazie liberali, in cui sono costituzionalmente sancite e generalmente rispettate la libertà di espressione e organizzazione.
La lotta nonviolenta ha il grande vantaggio per i libertari di mantenere una correlazione stretta tra mezzi e fini, correlazione che viene incrinata, se non spezzata, dall’utilizzo della violenza. È un fatto facilmente constatabile che le azioni violente, quali che siano le intenzioni di chi le compie, sono altamente nocive per la causa anarchica, in quanto contribuiscono a rafforzare nei cittadini l’idea che l’anarchia coincida con la violenza, con una condizione assimilabile alla guerra civile. E come potrebbero pensare diversamente, questi cittadini, se coloro che sostengono che anarchia significa nonviolenza, sono quegli stessi che cercano di raggiungerla attraverso la strada della violenza?
L’anarchismo è un progetto che già nel nome porta in primo piano l’elemento «negativo», di critica radicale di gran parte dell’esistito e dell’esistente (si legga, a proposito, Bertolo 2017: 93). Non occorre insistere troppo su questo aspetto. Vale forse la pena, piuttosto, di provare ad adottare un’ottica prevalentemente costruttiva dell’anarchia, che è già dentro la tradizione libertaria (si veda da ultimo Senta 2023). Questa prospettiva sprona alla valorizzazione degli elementi di libertà e di mutuo appoggio presenti nella società, qui ed ora, invita a interrogarli criticamente, moltiplicarli e coordinarli, escludendo o mettendo da parte il passaggio obbligato per la rivoluzione così come è stata intesa per decenni, cioè una specifica forma di guerra civile, che assume i connotati della guerra di classe e che si concreta in un processo violento.
Se i semi di libertà vogliono costituire davvero una prefigurazione, tale prefigurazione deve contenere in nuce le caratteristiche del mondo di li-




bertà e non-coercizione annunciato dalla dottrina anarchica. Riflettiamo sul monito di Tolstoj: «gli anarchici hanno ragione su tutto: sul negare l’ordine esistente e sull’asserire che, in assenza di autorità, non ci sarebbe una violenza superiore a quella esercitata dall’autorità. Si sbagliano solo nel ritenere che l’anarchia possa essere istituita attraverso una rivoluzione violenta» (Tolstoj 2019: 187).
Lavoriamo, dunque, per fare uscire finalmente gli uomini dallo stato «ipnotico» in cui sembrano immersi (Tolstoj 2003: 43).
Bibliografia
- P. ADAMO (a cura di), Pensiero e dinamite. Gli anarchici e la violenza 1892- 1894, M&B, Milano 2004.
- H. ARENDT, Sulla violenza, Guanda, Parma 2002.
- G. BERTI, Libertà senza Rivoluzione. L’anarchismo fra la sconfitta del comunismo e la vittoria del capitalismo, Pietro Lacaita Editore, Manduria-Bari 2012.
- A. BERTOLO, Anarchici e orgogliosi di esserlo, elèuthera, Milano 2017.
- A. CAFFI, Critica della violenza, edizioni e/o, Roma 1995.
- A. CAMUS, La rivolta libertaria, a cura di A. Bresolin, elèuthera, Milano 1998.
- L. CANFORA, La guerra civile ateniese, Mondadori, Milano 2013.
- F. CODELLO, Gli anarchismi. Una breve introduzione, Edizioni La Baronata, Lugano 2009.
- F. CODELLO, Violenza, nonviolenza in ID., Né obbedire né comandare. Lessico libertario, elèuthera, Milano 2009, pp. 153-157.
- M. CONFINO, Il catechismo del rivoluzionario. Bakunin e l’affare Nečaev, Adelphi, Milano 1976.
- P. FIORELLI, La tortura giudiziaria nel diritto comune, Giuffrè, Milano 1953- 54, 2 voll.
- M.K. GANDHI, Teoria e pratica della non violenza, a cura di G. Pontara, Einaudi, Torino 1981.
- V. GROSSMAN, Tutto scorre…, Adelphi, Milano 2006.
- G. JERVIS, Violenza, in G. JERVIS, B. NEDELMANN, L. PELLICANI (a cura di), Enciclopedia delle scienze sociali, Istituto dell’Enciclopedia Italiana , vol . VIII , Roma 1988, pp . 772-793.
- LENIN, Stato e rivoluzione, in ID., Opere scelte, Editori Riuniti Edizioni Progress, vol. 4, Roma 1998.




- N. MACHIAVELLI, Il principe, a cura di G. Inglese, Einaudi, Torino 1995.
- E. MALATESTA, Pagine di lotta quotidiana. Scritti I° volume. Umanità Nova 1920-1922, Movimento Anarchico Italiano, Carrara 1975.
- E. MALATESTA, Pagine di lotta quotidiana. Scritti II° volume. Umanità Nova e scritti vari 1919-1923, Movimento Anarchico Italiano, Carrara 1975.
- E. MALATESTA, Pagine di lotta quotidiana. Scritti III° volume. Pensiero e volontà e ultimi scritti 1924-1932, Movimento Anarchico Italiano, Carrara 1975.
- MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, a cura di R. Derathé, vol. 1, Rizzoli, Milano 1997.
- J. PEIRATS, La C.N.T. nella rivoluzione spagnola, vol. 1, Dalla Prima internazionale al 1936, Edizioni Antistato, Milano 1977.
- J. PEIRATS, La C.N.T. nella rivoluzione spagnola, vol. 2, Le collettivizzazioni, la militarizzazione e la controrivoluzione in marcia, Edizioni Antistato, Milano 1977.
- M. ROBESPIERRE, La rivoluzione giacobina, Edizione Studo Tesi, Pordenone 1992.
- J.-J. ROUSSEAU, Le confessioni, in ID., Scritti autobiografici, a cura di L. Sozzi, Einaudi-Gallimard, Torino 1997.
- J.-J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, in ID., Scritti politici, vol. 2, Laterza, Roma-Bari 1994.
- R.J. RUMMEL, Stati assassini: la violenza omicida dei governi, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.
- A. SENTA, Anarchia e cooperazione. Alle origini di un rapporto (1861-1914), Edizioni Malamente, Urbino 2023.
- A.V. SHUBIN, Nestor Machno: bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria e rivoluzione contadina (1917-1921), elèuthera, Milano 2012.
- M. STOPPINO, Violenza, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di politica, Tea, Milano 1991, pp. 1221-1227.
- V. STRADA, Il dovere di uccidere. Le radici storiche del terrorismo, Marsilio, Venezia 2018.
- I. TERNON, Lo Stato criminale. I genocidi del XX secolo, Corbaccio, Roma 1997.
- L. TOLSTOJ, Per l’uccisione di re Umberto, Introduzione di P. Brunello, Postfazione di F. Paziente, Centro Studi Libertari Camillo di Sciullo, Chieti 2003
- L. TOLSTOJ, Il rifiuto di obbedire, a cura di F. Codello, elèuthera, Milano 2019.
- M. TURCHETTI, Tyrannie et tyrannicide de l’antiquité à nos jours, PUF, Paris 2001.
- F. VENTURI, Il populismo russo, vol. II, Dalla liberazione dei servi al nihilismo, Einaudi, Torino 1972.

