Numero Completo 06






Editoriale
Nell’arco di tempo che passa da un numero all’altro, circa quattro mesi, accadono così tante cose che è difficile darne conto. Soprattutto, si rischia di essere sorpassati dagli eventi. Solitamente sono eventi – o dinamiche, o processi – negativi dal punto di vista di chi, come noi, si prova a muovere per allargare gli spazi di libertà e dignità. Sembra quasi che ogni cambiamento, qualsiasi trasformazione sia peggiorativa della situazione precedente. Dal lavoro alla sanità, dall’ambiente alla guerra, dalla violenza di genere alla repressione della polizia (abbiamo cominciato ad abbozzare questo editoriale subito dopo l’omicidio di un diciassettenne di Nanterre per mano delle guardie), dal carcere alle varie forme di limitazione della libertà, tra cui quella di movimento di chi cerca prospettive di vita migliori lasciando i sud del mondo. Potremmo non finire più.
Forse è perché – nella nostra vecchia Europa – siamo ancora e sempre immersi, da quasi cinquant’anni ormai!, in una fase di regressione dei diritti acquisiti nella stagione del lungo ‘68 e allora, ci si dice, bisogna tenere duro e il quadro prima o poi muterà.
Oppure è questione di percezioni distorte, le nostre che stiamo buttando giù queste note, e la realtà è che il male è sempre ben presente nell’esistenza umana come ci ha fatto vedere con la sua scrittura graffiante Cormac McCarthy, scomparso in primave-




ra. Contrastarlo, combatterlo – che lo si chiami male o assurdo come fa Albert Camus – è però quell’attitudine, anch’essa tutta umana, a cui non rinunciamo. Lo facciamo a modo nostro, anche in questo numero, mettendo in luce tre diverse esperienze, due contemporanee e una storica, che toccano alcune tematiche: l’impegno in prima persona nel salvare vite in quella fossa comune che è il Mediterraneo, le attività di un collettivo barcellonese che si occupa di architettura e di urbanistica da un punto di vista femminista, e le modalità di autogestione dei processi economici ad Alcoi nell’inebriante esperienza della rivoluzione spagnola.
Trovate quindi approfondimenti su altri temi a noi cari: il turismo, e quindi una critica a esso nella sua funzione distruttiva e una valorizzazione, invece, di pratiche turistiche più consapevoli; un’analisi e una proposta concreta a opera di Paolo Cognetti per ridare centralità alla montagna e far scoprire la sua ricchezza ai ragazzi immersi nella vita di città. Nell’internazionale c’è una riflessione originale su un caso di autoamministrazione della società, quello delle isole Fiji; la conversazione è dedicata alla casa editrice elèuthera, che svela qui la complessità e la ricchezza delle pratiche di lavoro cooperativo che si celano dietro a ogni loro libro; la radici si concentrano sulle figure di Lev Tolstoj e di Luce Fabbri (su di loro, tra l’altro, proprio elèuthera ha curato due agili antologie: Il rifiuto di obbedire del 2019 e Critica dei totalitarismi del 2023); le recensioni consistono in un percorso di lettura riguardante il tema, anch’esso a noi caro, della prefigurazione.
Un evento che ha colpito da vicino alcuni di noi è stata l’alluvione che si abbattuta su parte dell’Emilia e della Romagna,




a maggio. Un evento che non si può definire eccezionale, nel senso che, è vero, è caduta una quantità d’acqua mai vista in alcune zone, ma, stante il cambiamento climatico, questi fenomeni accadono sempre più di frequente. È la nuova normalità, si potrebbe dire e il fato c’entra ben poco. È l’azione umana che provoca l’aumento costante di emissioni di CO2 e il conseguente innalzamento delle temperature che va di pari passo con precipitazioni improvvise e violente. Scienziati, divulgatori, attivisti ce lo dicono da molto tempo: è ora di cambiare rotta. C’è bisogno di amplificare il messaggio lanciato dalle nuove generazioni di ambientalisti, di elaborarlo e di dare vita a pratiche di riorganizzazione della società in senso ecologico e libertario. Questo comporta tutto un insieme di pratiche che vanno in direzione opposta a quanto fanno gli amministratori, compresi quelli «di sinistra»: cemento, cemento e ancora cemento e poi auto, strade, fabbriche, fabbrichette e capannoni e ancora strade – sempre più larghe, a sei otto, nove corsie – e auto e camion e centri della logistica che spuntano ovunque. Ettaro su ettaro siamo sempre più fagocitati dal nostro stesso cemento.
Una delle cose che più ci ha colpito quando siamo andati a spalare il fango alla periferia di Faenza, là dove il fiume Lamone aveva invaso del suo fango le case fino al secondo piano, è stata la quantità di rifiuti accumulati. Nel giro di pochi giorni si sono sommate, nella sola Faenza, circa centomila tonnellate di rifiuti, così che il disastro e la distruzione di case, strade, e campi è stata accompagnata anche da ulteriori fonti di inquinamento con cumuli di rifiuti dati alle fiamme e aria e falde acquifere contaminate. Abbiamo visto, anche, la realtà degli allevamenti intensivi, questi luoghi di tortura che per decenza non dovrebbero avere più ragione di esistere. Sono luoghi insostenibili, dal



punto di vista ambientale ed etico, la cui mostruosità è venuta alla luce con la pioggia e con le decine di carcasse di maiali trasportate dai flutti. Davvero le più lancinanti distopie, oggi di gran moda, sono superate dalla realtà: «volevamo cambiare il mondo, e l’abbiamo distrutto», così ci ha detto un compagno di quelle parti.
Abbiamo visto anche, però, Un paradiso all’inferno, per citare il titolo del fortunato testo di Rebecca Solnit che analizza «le straordinarie comunità solidali dei terremoti e di altri disastri». Tante migliaia, difficile quantificarle, le persone provenienti un po’ da tutta Italia che hanno dato una mano. Arrivati a Faenza, abbiamo trovato le compagne e i compagni del luogo organizzati in Brigate di solidarietà, mentre gruppi e grupponi arrivavano da Bologna, Modena, dall’Abruzzo, ecc.
Pensiamo che, a fronte di un modello di sviluppo bacato, marcio alle fondamenta, sarebbe necessario trovare soluzioni concrete, che privilegino il riuso e non il consumo e che facciano leva su forme di tecnologia partecipate e condivise; praticare cioè soluzioni libertarie combattendo e superando l’inefficienza, la burocrazia esasperata, il proceduralismo fine a se stesso della gestione statale.
Questa strada è aperta anche perché – altra cosa che abbiamo potuto constatare con i nostri occhi nei giorni e nelle settimane subito dopo l’alluvione – lo stato, inteso come garante di servizi, non esiste più. Solo in alcune zone si sono visti i pompieri e, in ritardo, la protezione civile. Per non parlare della fantomatica ricostruzione. Le strade franate sono state sgomberate dal fango dagli stessi abitanti che, in alcune aree, hanno addirittura





ricostruito con le loro mani le infrastrutture crollate, come nel caso di un ponte nel comune di Monterenzio, vicino a Bologna, travolto da una frana e sostituito da un guado autocostruito dagli abitanti.
Oltre un secolo fa Pëtr Kropotkin nel suo Campi, fabbriche, officine denunciava il sistema economico e sociale che trasformava gli esseri umani in «semplici inservienti di una determinata macchina» e provocava diversi piani di separazione nella società – tra consumatori e produttori, tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, tra agricoltura e industria, tra le varie mansioni del lavoratore. Oggi tale sistema, come scrive Giacomo Borrella nella prefazione alla nuova edizione del testo (elèuthera 2023) si è esteso e perfezionato e si sono moltiplicati i piani di separazione. Kropotkin proponeva, facendo leva su esempi concreti – i «semi sotto la neve» di cui scriverà Colin Ward – il ribaltamento di questo schema, partendo dalla dimensione piccola, o intermedia, in cui si afferma nelle attività umane la cooperazione e l’autorganizzazione. Una valorizzazione della piccola dimensione, indipendente e motivata eticamente, che rifugga la mentalità del profitto e del consumo volto alla crescita continua.
La solidarietà pratica nei disastri e i movimenti per la giustizia climatica con le loro proposte, decentrate e variamente declinate a seconda della realtà geografica e sociale dei territori, ci indicano la strada da percorrere, che non è quella della fiducia acritica verso nuove tecnologie che risolveranno i problemi ambientali, ma è praticare forme antiautoritarie, libertarie, attuabili qui e ora nel rapporto con il territorio e nelle relazioni tra chi lo abita.




In ultimo diamo conto del fatto che tra le varie tematiche che sono oggetto di frequente dibattito in redazione due ritornano ripetutamente nelle nostre riflessioni con particolare forza. La guerra e la violenza di genere. Per quanto riguarda il conflitto armato causato dall’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo noi abbiamo sostenuto, e sosteniamo, il diritto all’autodifesa da parte del popolo aggredito. Vediamo però che a questo punto del conflitto l’autodifesa si sta accompagnando sempre più, anche da parte ucraina, con azioni offensive che utilizzano tutto l’armamentario per colpire il territorio russo con droni, missili e aerei, e riteniamo che questa prosecuzione del conflitto non sia accettabile. Le truppe russe si devono ritirare e la guerra deve finire: per raggiungere questo obiettivo bisogna che la mobilitazione civile e le iniziative diplomatiche guadagnino spazio a discapito delle armi. È giusto non piegare la testa di fronte ai soprusi, ma è anche necessario operare in una prospettiva ideale che faccia a meno degli eserciti e della violenza brutale della guerra. Il passaggio tra violenza e nonviolenza è stretto e noi ci siamo in mezzo, in una maniera interrogativa e problematica che non nascondiamo.
Siamo infine scossi e turbati per le dinamiche di violenza contro le donne frequenti nella nostra società, anche tra giovani e giovanissimi. È un tema che tocchiamo anche in questo numero, convinti che per fermare uccisioni e violenze sia necessario lavorare alle radici, dando vita a pratiche educative diverse, come è il caso del collettivo Equal Saree di Barcellona che nel rinnovare lo spazio urbano da un punto di vista femminista mette al centro il tema del dialogo, del confronto, dell’inclusività. Ritorneremo su questo tema nei prossimi numeri con altre esperienze e approfondimenti.















Anarchia e solidarietà nel Mediterraneo
Anabel Montes Mier, a cura di UrLa
Anabel Montes Mier è una pioniera a bordo delle navi umanitarie. Dopo quasi otto anni trascorsi a salvare vite nel Mediterraneo – capo missione dapprima con Open Arms e poi con Geo Barents (MSF) –, testimone d’accusa nel processo a Salvini, divenuta famosa per la sua foto con il bimbo in braccio che fece il giro del mondo nel 2017, ha deciso di lasciare: sopraffatta dalle troppe morti, dal troppo dolore e dalle troppe campagne di odio nei riguardi suoi e delle ONG. Queste esperienze le hanno causato una sindrome da stress post-traumatico. È scesa dalla Geo Barents a metà maggio 2023 e ha scritto con il cuore questa lucida testimonianza.
Anarchia e solidarietà, nel Mediterraneo centrale, sono concetti che si intrecciano, particolarmente in situazioni di crisi umanitaria come quella che si sta verificando con i flussi migratori marittimi. Prima di parlare della mia visione di donna soccorritrice, vorrei chiarire questi termini nel loro contesto del Mediterraneo centrale. Quanto mi appresto a dire si potrebbe probabilmente estendere anche ad altre rotte o altri luoghi, ma preferisco parlare sulla base della mia esperienza diretta e su quanto ho personalmente visto e vissuto.
Per solidarietà intendo l’atto concreto di sostegno e aiuto agli altri nel momento del bisogno. Nel Mediterraneo centrale, le ragioni per cui migliaia di persone rischiano la vita cercando di attraversare il mare in condizioni drammatiche sono tanto diverse, quanto legittime: fuggire dalla violenza, dalla povertà, da qualsiasi tipo di persecuzione che si manifesti nei loro paesi d’origine. Cercare una vita migliore o il semplice fatto di poter esercitare una libertà di movimento sono diritti che vengono totalmente




negati da parte di coloro che vivono in altre realtà e difendono i propri privilegi, nella paura di perdere il proprio potere.
Ho una visione molto impegnata, e ritengo che la lotta per la libertà e la giustizia sociale siano intrecciate in modo indissolubile con la necessità di offrire sostegno a coloro che, per svariati motivi, sono stati costretti a vivere una situazione di vulnerabilità e disperazione.
Il Mediterraneo centrale non è solo un territorio di separazione geografica, un mare tra le terre, ma rappresenta uno spazio vivo, dove le vite umane si incontrano e si perdono; dove gli stati e i confini artificiali mostrano tutta la loro brutale e crudele realtà, perpetuando la disuguaglianza e l’ingiustizia sociale, di classe, di genere e di ogni altro tipo di identità. La lotta deve mirare a sfidare questi sistemi nel concreto, a dimostrare che la solidarietà è molto più di una parola: è reale e può essere sentita, toccata, vissuta e creata.
Inoltre, come dice il testo di una canzone di un gruppo spagnolo chiamato Habeas Corpus: «Bisogna chiamare le cose con il loro nome», recuperare le parole, riconoscere la forza che posseggono e che si cerca sempre di pervertire per distorcerle, cambiarne il significato, in modo che i muri che il fascismo vuole continuare a costruire appaiano in tutta la loro crudele drammaticità e vengano abbattuti.
Questa macchina di distruzione sociale ha una grande presenza nel Mediterraneo centrale. Per me, la cosa più grave che si sta verificando è il processo in atto di privazione dell’identità individuale di quelle persone che, a causa di circostanze avverse, si trovano, loro malgrado, a far parte di quel grande collettivo eterogeneo che va sotto il nome di migranti. Sono persone in movimento, costrette a fuggire, a migrare, spinte ad abbandonare le loro vite verso luoghi ignoti.
La vera forza della parola, in questo caso, è data dal fatto che ogni persona, la cui vita è in pericolo in mare, diventa un persona naufraga e chi è naufrago ha diritto di essere aiutato, salvato.



È qui che entra in gioco tutto l’ampio, preciso e chiaro apparato giuridico degli accordi e delle convenzioni internazionali sul salvataggio delle vite in mare sottoscritti da molti Paesi: la UN-CLOS, la Convenzione SOLAS, la Convenzione SAR, la IAM-SAR, l’IMO, che definiscono le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare. Chi comanda una imbarcazione, quando avvista una persona dispersa o in pericolo in mare, è tenuto a prestare assistenza il più rapidamente possibile, senza mettere in pericolo se stesso o l’equipaggio (mi sembra importante segnalare qui, con questo piccolo inciso, che, mentre in inglese è neutro, sia in spagnolo che in italiano il termine «comandante» viene reso con la forma maschile, perché è risaputo che i comandanti donna non esistono).
In questa situazione è da evidenziare come Malta costituisca un esempio particolarmente negativo nella pratica dei soccorsi, nonostante gli obblighi imposti dalla legislazione internazionale in materia: non ha sottoscritto gli emendamenti del 2004, non fornisce un porto sicuro ai migranti e inoltre non rispetta l’obbligo di soccorso in mare nell’area di competenza, contravvenendo alla legge del mare e a ogni dettato etico.




13

Questo non vuole essere un implicito invito a dare credibilità e giustificazione alle leggi vigenti, né ritenere che non si possano cambiare, combattere o abrogare. Il fatto che una legge sia una legge non significa che sia necessariamente giusta. La mia intenzione è quella di denunciare e dimostrare come coloro che fanno le leggi, impongono le regole e costringono con la forza al loro rispetto sono i primi a non rispettarle, a voltare le spalle e a cercare mille scappatoie quando quanto viene previsto non è in linea con i loro interessi o con le loro strategie politiche.
Qui non c’è spazio per l’interpretazione. Ogni singolo criterio è ben stabilito e chiaro, probabilmente per ovviare alle ingiustizie commesse in passato. Quello che trovo curioso è che ci sia stato bisogno di un gruppo di persone che si sono riunite per stabilire che ogni persona merita di essere salvata e portata in una terra sicura dove sarà curata. Il fatto che sia necessario legiferare che le persone devono essere salvate dall’annegamento dimostra quanta poca umanità, quanto poco rispetto per la vita e quanta poca coscienza collettiva ci sia.
Ma cosa succede quando spogliamo la parola «naufrago» della sua forza primordiale ed enfatizziamo invece la parola «migrante» con tutte le sue lettere? Le mie viscere si ribellano quando penso all’intenzione malvagia che sta dietro a tutta questa pantomima: negare la realtà di migliaia di persone, chiudere gli oc-
Il fatto che sia necessario legiferare che le persone devono essere salvate dall’annegamento dimostra quanta poca umanità, quanto poco rispetto per la vita e quanta poca coscienza collettiva ci sia
chi davanti alla tragedia e rubare la loro identità, negare la loro esistenza, calpestare i loro diritti operando sulla base del privilegio e infine spiegare paternalisticamente la loro morte. Giustificare il loro omicidio.
Come diretta conseguenza di tutto questo, si ha la mancata attivazione del sistema di ricerca e soccorso. Gli stati competenti, nella loro area di responsabilità, sono obbligati dal diritto internazionale - ciò dovrebbe costitu-



ire anche un dovere morale - ad avviare le operazioni di ricerca e salvataggio il più rapidamente possibile. Quanto sta accadendo negli ultimi mesi dimostra con assoluta evidenza la volontà, da parte delle autorità preposte, di sottrarsi agli obblighi di soccorso. Ad esempio, vediamo come siano centinaia i casi in cui Malta ha omesso di prestare assistenza ordinando addirittura alle navi mercantili di non prestare soccorso e di continuare la loro rotta, il che oltre a essere inumano appare anche incredibile, viste le implicazioni che derivano se consideriamo che secondo le norme internazionali è il capitano il responsabile ultimo delle conseguenze che possano verificarsi in caso di omissione di assistenza.
Il naufragio di Cutro – in cui, per motivi ancora poco chiari, anche se appaiono via via sempre più evidenti, non è stata attivata l’operazione di salvataggio, cosa che ha provocato l’agonia e la morte di decine di persone annegate, i cui corpi sospinti dalle onde, hanno raggiunto le coste italiane – ha trovato larga eco nei media, attirando una grande attenzione da parte dell’opinione pubblica. Sembra quasi che quando invece i corpi non raggiungono la terraferma e rimangono in fondo al mare non meritino tanta attenzione pubblica e mediatica.
Altro esempio, il naufragio di Pyros, dove non solo non è stata data comunicazione della gravità della situazione, che avrebbe potuto e dovuto attivare una grande operazione di soccorso, ma a seguito delle prove e delle analisi forensi si è dimostrato invece come la guardia costiera greca abbia effettuato manovre estremamente pericolose, agendo in modo irresponsabile e cercando poi giustificazioni attraverso dichiarazioni assolutamente contraddittorie.
Se non c’è soccorso, non ci sono naufraghi, e se non ci sono naufraghi, non c’è bisogno di prestare loro soccorso. E quindi non c’è la necessità di un porto sicuro in cui farli sbarcare. Se la parola «naufraghi» viene eliminata dal contesto marittimo di cui stiamo parlando ed essi vengono descritti solo ed esclusivamente come «migranti», con l’aggiunta di una connotazione peggiorativa, magari «clandestini», vengono privati dello stesso




valore umano delle altre persone, di uno status che invece non dovrebbe nemmeno essere messo in discussione. Non si deve permettere di stravolgere il vero significato delle parole.
Troppi i simboli in gioco, le dichiarazioni, bandiere ostentate (per chi le vuole…), le parole d’ordine utilizzate per manipolare, per conquistare consenso, per nascondere la tragica realtà. Il dramma delle morti in mare viene utilizzato ciclicamente per la ricerca di consenso politico: non possiamo permettere che tutto questo accada. È in questo contesto che il salvataggio dei migranti naufraghi non solo è un atto umanitario, ma è anche un atto politico, che sfida le politiche migratorie restrittive e le campagne di odio. È un atto con il quale si mettono in pratica i valori dell’uguaglianza e dell’aiuto reciproco.
Il dramma delle morti in mare viene utilizzato ciclicamente per la ricerca di consenso politico: non possiamo permettere che tutto questo accada
Non si tratta solo di salvare persone che rivendicano l’elementare diritto di continuare a vivere, di non essere cancellate, quasi non fossero mai esistite. Si tratta di proteggerle con la presenza, denunciando qualsiasi violazione dei diritti umani in alto mare; di essere testimoni diretti dei rimpatri immediati effettuati dalle milizie in uniforme, sovvenziona-
te dall’Unione Europea; di essere testimoni della violenza fisica esercitata su persone che già fuggono da un passato di cui la maggior parte di loro non potrà mai liberarsi, perché sempre presente come un incubo nella mente.
Ancora, di essere testimoni della connivenza degli stati europei con quelle stesse cosiddette guardie costiere libiche, dell’esistenza di una polizia di frontiera che spende milioni di euro per sorvegliare dal cielo – nel Mediterraneo centrale – frontiere ancora più diffuse, dove la possibilità di vita delle persone dipende dalla rapidità con cui si segnalano le loro coordinate e dalla rapidità con cui arrivano le imbarcazioni della guardia di finanza italiana per riportarle in quell’inferno in terra che è la Libia.





Il solo fatto di restare lì a navigare è una dichiarazione di intenti, di non essere più d’accordo con le versioni date o con la loro mancanza, di non voler più godere di privilegi esclusivi, di essere disposti ad andare, a vedere, ad ascoltare, a sentire, a toccare e a denunciare.
Il fallimento del sistema di accoglienza europeo e mancanza di volontà di cambiarlo è ciò che ha portato alla nascita di tante organizzazioni che operano in mare, che cercano di colmare, in vari modi questo vuoto, questo bisogno non soddisfatto. Anche se la responsabilità diretta non dovrebbe ricadere su cittadini e cittadine e dovrebbe essere assunta dall’Unione Europea, con un sistema di ricerca e salvataggio efficace e professionale, questo dimostra la capacità di autogestione, organizzazione e solidarietà inter-organizzativa che si è sviluppata negli ultimi anni. Non c’è niente di nuovo sotto il sole, manca la volontà, la volontà di riconoscere che tutte le persone hanno gli stessi diritti.
È ovvio che le prospettive individuali variano in modo diverso e che non tutte le persone nelle ONG hanno una filosofia




anarchica. Tuttavia, nel bel mezzo di una crisi umanitaria come questa, la solidarietà e l’impegno per i principi di giustizia sociale possono essere una potente forza di cambiamento per tentare di promuovere una visione di un mondo più inclusivo e combattivo. Occorre riconoscere l’interconnessione di tutte le persone ed essere consapevoli che tutti hanno la responsabilità di aiuto e sostegno reciproco nei momenti di bisogno. È necessario quindi continuare a lottare per la giustizia sociale e contro le politiche migratorie oppressive che perpetuano le tragedie.

Lavorare nella ricerca e nel soccorso non è così bello come può sembrare. È duro, difficile, richiede una preparazione e un addestramento costanti, ti distrugge a livello psicologico, anche se passi il tempo a cercare di prepararti. Si è venuta a creare una visione romantica della realtà delle operazioni di ricerca e di soccorso, quasi che i soccorritori siano persone privilegiate che possono trascorrere il loro tempo andando sulle barche a salvare vite umane, si perpetua una visione, da neocolonialismo del XXI secolo, secondo cui sono importanti solo i valori ideali che tengono saldi i principi del soccorritore, che però non è il vero protagonista del dramma.



18


Sono sempre stata una persona molto critica e con una mia visione delle ONG. Non credo nella meritocrazia, ma nell’organizzazione, nella preparazione e nel fatto che in questo contesto salvare vite in alto mare richiede molte conoscenze. Gli ideali politici non sono sufficienti se non sono accompagnati da competenze e conoscenze che hanno un impatto diretto sulla vita e sulla morte delle persone, ma le competenze e le conoscenze devono essere accompagnate e guidate dai valori umanitari. Questo non è, né dovrebbe essere, un luogo di ostentazione dell’ego, di promozione del proprio io o dell’organizzazione a cui si appartiene, ma un luogo in cui un sostegno reciproco organizzato e consapevole è in grado di fare ciò che è meglio per le persone che hanno bisogno di aiuto. Per restare umani in un mondo disumanizzato.
L’evoluzione che ho visto, lavorando in prima linea a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo centrale dal 2016 al 2023, è terrificante, non in termini di necessità di salvataggio delle persone, ma in termini di aumento esponenziale degli ostacoli legali e amministrativi, di manipolazioni mediatiche, di diffamazioni diffuse che hanno il solo e unico scopo di infangare, di impedire alle ONG di operare. Ma il vero bersaglio, le vere vittime di questo attacco capitalista sono i migranti che non sono ancora naufraghi ma che, vista l’im-
passibilità e l’inerzia di questa Europa antiquata e stantia, rischiano di diventarlo, con tutto ciò che ne consegue.
In questi quasi 8 anni ho visto così tante migliaia di volti che mi addolora non poterli ricordare tutti. Ho sentito tante storie che non sono mai state raccontate, perché non è stato permesso di parlare a chi voleva raccontare, o perché è stata data voce a persone come me, che




possono trasmettere il messaggio ma non farlo mai proprio. Sono anche consapevole delle difficoltà che ho dovuto affrontare e subire in questo mondo come donna soccorritrice, come donna di mare, come donna in una posizione di responsabilità e di vedere come la mia parola fosse meno ascoltata e considerata se non alzavo la voce, in un mondo storicamente maschile come quello marittimo e del soccorso in mare. Ho imparato a dimostrare le cose quando era il momento giusto di farlo e non quando mi veniva chiesto per vedere se ne ero capace. Ho più pazienza della maggior parte dei miei colleghi, anche se qualche maschio fragile ha cercato di farmi sembrare isterica per aver alzato la voce sostenendo le mie ragioni. E poiché so, come donna, cosa si prova quando qualcuno ha un privilegio rispetto a te a causa di qualcosa che non ha altra giustificazione se non il caso e lo usa contro di te, come un mero esercizio simbolico di potere, io non farò mai lo stesso con chi ha meno privilegi di me.
Purtroppo il mondo è pieno di persone con storie da raccontare, di voci da ascoltare. Lasciate che vi raccontino le loro storie con la loro voce, non permettete che sia negato a nessuno il diritto di parlare, il diritto di lottare per la propria vita.
Continuerò la mia battaglia fino a quando, guarita dalle conseguenze della scelta di aver fatto questo lavoro, sarò pronta ad aiutare ancora – se sarò in grado di farlo – ma soprattutto a riprendere ad accompagnare.
A presto.










Urbanistica femminista il collettivo Equal Saree Espe
Valeria Giacomoni
Gli spazi pubblici sono fondamentali come punti d’incontro, di gioco e di rappresentazione sociale, culturale e politica. Gli spazi urbani non sono neutri, sono la rappresentazione fisica dei valori della società che li pianifica, li costruisce, li gestisce e li abita. Gli spazi ci parlano, trasmettono messaggi che integriamo in maniera incosciente e che possono riprodurre disuguaglianze sociali.
L’urbanistica è la disciplina che si occupa di definire questi spazi, e nella grande maggioranza dei casi gli architetti e urbanisti che prendono decisioni sull’organizzazione delle nostre città sono uomini, bianchi, normodotati e generalmente si muovono in macchina. L’urbanismo istituzionale tende a semplificare e a progettare solo per un tipo di persona e gli spazi riflettono quindi le esigenze solo di una parte della popolazione.
Per esempio è dai tempi dell’agorà greca che le donne vengono escluse dagli spazi dove si prendono le decisioni: l’urbanismo è patriarcale e gerarchico e gli uffici urbanistici continuano a essere «mascolinizzati». Inoltre questi ultimi tendono a essere chiusi alle contaminazioni e generalmente non si confrontano con esperti di altre discipline come l’antropologia o le scienze sociali e ambientali, fondamentali al momento di organizzare gli spazi comuni della popolazione. L’urbanismo di oggi si muove spesso al servizio degli interessi del capitale e anche se qualche volta ha la reale volontà di migliorare le condizioni di vita della cittadinanza non tiene quasi mai in conto ciò che essa vuole o semplicemente di cosa ha bisogno. Risposte alternative da parte dell’ambito accademico o teorico a questo modo di intendere lo sviluppo della città hanno almeno mezzo secolo di vita e negli ultimi anni si sono visti esempi concreti, ad esempio in Spagna.





Si parla di urbanismo femminista e questo non significa rivendicare solo una visione di genere, ma una che tenga conto della diversità di persone che abitano le città: diversità di genere, ma anche di origine, di classe, di età e di mobilità.
A Barcellona sono attivi diversi collettivi che lavorano in quest’ottica e la fervente attività dal basso ha trovato un riscontro nelle istituzioni, particolarmente sensibili al tema: negli ultimi anni questa visione sta quindi avendo un’influenza concreta sullo sviluppo degli spazi della città.
Nascita e obiettivi del collettivo Equal Saree
Equal Saree è un collettivo di architettura e urbanistica con prospettiva di genere che disegna strategie inclusive, promuove pratiche orizzontali e genera lavoro in rete. È costituito da quattro ragazze ed è nato nel 2010, prendendo forma poco a poco a partire da un lavoro costante di sensibilizzazione e attivismo che dà un nuovo significato alla diversità e complessità del paesaggio urbano. Dal primo momento le fondatrici sono state sicure dei benefici che può apportare all’urbanistica una visione di genere, che permette di incrociare gli aspetti fisici, sociali e psicologici dello spazio per portare alla luce le disuguaglianze e generare strategie per sradicarle.
Si sono conosciute all’università di Barcellona, ma è stato un viaggio in India a cambiare loro la vita; o meglio, a cambiare la visione che avevano, fino a quel momento distorta dall’accademicismo europeo, sull’architettura e sul suo impatto sulle città. Tutto ebbe inizio durante le lezioni di un’architetta argentina
specialista nell’affrontare politiche pubbliche sulla città e le donne, e le basi del collettivo sono nate durante il progetto da lei proposto in un quartiere musulmano di Nuova Delhi, dove le studentesse sono arri-
Dal primo momento le fondatrici sono state sicure dei benefici che può apportare all’urbanismo una visione di genere




vate con una borsa di studio. La scelta del nome del collettivo riflette l’importanza che ha rivestito il progetto in questo processo: il saree o sari è il vestito tipico delle donne in India, costituito da teli avvolgenti che rappresentano le donne al plurale, poichè il telo è sempre lo stesso ma utilizzato diversamente secondo la regione. Per il nome del collettivo hanno quindi hanno combinato la parola equal (uguale in inglese) con il saree, che simboleggia sia le donne al plurale che l’uguaglianza nella differenza. L’obiettivo di questo collettivo è che non venga perpetuato il sistema che accompagna lo sviluppo delle città e che prevede un unico tipo di abitante, rivendicando un urbanismo che tiene conto della complessità e della diversità dei residenti. E come si mette in pratica tutto questo?
Metodi e strumenti per un’architettura femminista
«La partecipazione comunitaria e i processi di co-creazione sono strumenti che permettono di riflettere sulla nostra forma di vivere, affrontando questioni come la convivenza di persone con realtà diverse o la gestione della cura in città. I processi partecipativi rafforzano le relazioni tra persone, stimolano il lavoro di gruppo e mettono al centro il bene comune, al di sopra degli interessi individuali. Per rendere le città più umane bisogna ascoltare l’opinione della cittadinanza» (Goula, Cardona e Saldaña 2019).
Il lavoro di questo tipo di collettivi spesso comincia da «marce esplorative» ovvero passeggiate per il quartiere con le abitanti (donne), spesso compiute di notte. Queste passeggiate permettono alle donne di esprimere finalmente il loro punto di vista e dare voce alle loro necessità nello spazio pubblico; inoltre costituiscono un elemento di socializzazione e di empowerment. Lo strumento delle marce esplorative è nato negli anni Ottanta in Canada e aiuta anche semplicemente a individuare quali sono i luoghi di incontro e quali invece i luoghi più bui e meno frequentati; quali zone avrebbero bisogno di essere riorganizzate





per compiere meglio la loro funzione. Si tratta di ridisegnare la città da dentro, da chi la abita e la vive tutti i giorni.
Per quanto riguarda la progettazione Equal Saree insiste sull’importanza di mescolare usi e funzioni degli spazi: per una semplice questione di sensazione di sicurezza, è importante ad esempio che le strade siano frequentate, le zone pedonali vissute e che ci sia buona visibilità e illuminazione. Questo perchè non prevalga la legge del più forte, in cui sono sempre le stesse a rimetterci, e per evitare il ricorso costante alla polizia che normalmente non risolve i conflitti né elimina la sensazione di insicurezza. Per le necessità quotidiane inoltre sarebbe importante che non fosse sempre necessario usare il trasporto pubblico o l’auto. Un altro criterio importante al momento di organizzare gli spazi è l’accessibilità: una persona giovane e con buone capacità di movimento sicuramente non ci pensa, ma semplicemente la collocazione nel punto giusto delle strisce pedonali è una questione fondamentale per una parte della popolazione.
In questo modo ci si può rendere conto anche di come la collocazione di panchine possa fare la differenza nella mobilità degli anziani, che hanno spesso bisogno di fare delle pause, e sulla possibilità di interazione con gli altri, soprattutto dopo la pan-




demia. Le panchine sono generalmente utilizzate dalle fasce più «deboli» della popolazione – anziani o chi si occupa dei bambini – ma negli ultimi anni anni le politiche urbanistiche (almeno in Italia) hanno puntato a ridurle o toglierle, per evitare che vengano utilizzate per dormire da chi non ha una casa. Ripensare l’ubicazione delle panchine, oltre a favorire gli spostamenti di chi ha ridotte capacità motorie, aumenta la possibilità di intavolare relazioni con il vicinato e di evitare la sensazione di solitudine.
Progetti di Equal Saree
Il collettivo Equal Saree ha portato avanti progetti in Spagna, Marocco e India e ha lavorato per diverse amministrazioni mettendo al centro proprio le categorie normalmente meno ascoltate: le donne, gli anziaIl loro progetto di maggiore successo è stato nei cortili delle scuole
ni, i bambini. Coinvolgendo la popolazione con processi partecipativi hanno ripensato l’organizzazione di piazze, parchi ed edifici, ma il loro progetto di maggiore successo è stato nei cortili delle scuole. L’analisi degli spazi di gioco ha evidenziato come questi siano il primo luogo fuori casa dove i bambini e le bambine possono organizzarsi spontaneamente, senza la guida di un adulto e da qui l’importanza di non riprodurre schemi usuali. Lo studio ha fatto luce sul modo di interagire dei bambini e delle bambine e ne è risultato che l'80% dei cortili delle scuole spagnole è «calcio centrico», ovvero uno spazio in cui il campo da calcio occupa la maggior parte dello spazio mettendo al centro generalmente i bambini maschi più grandi e più forti e dove gli altri giochi sono collocati nella periferia del cortile, in posizione defilata. Attraverso processi partecipativi che hanno coinvolto le comunità educative di 14 scuole pubbliche di Barcellona è nato il progetto Empatitzem (gioco di parole con pati – il cortile in catalano – e il verbo empatizzare), un approccio che propone l’uguaglianza nei cortili delle scuole



26

durante la ricreazione. Una nuova progettazione dello spazio che evita la divisione gerarchica tra un’attività principale e altre periferiche permette di immaginare un mondo non gerarchico e favorisce una maggiore interazione tra generi; inoltre la possibilità di proporre diverse attività stimola la creatività ed evita di mettere la forza fisica al centro. La proposta di Equal Saree si è concretizzata nella pubblicazione di una guida dal titolo El pati de l’escola en igualtat. Guia de diagnosi e d’intervenciò amb perspectiva de gènere (ndT: Uguaglianza nel cortile della scuola. Guida per diagnosi e intervento con prospettiva di genere), inizialmente in catalano e poi tradotta in spagnolo, francese, inglese e greco.

Un’altra installazione proposta da Equal Saree è la Mamífera, un punto di allattamento collettivo in strada per portare l’attenzione sulla mancanza di spazi per la cura negli spazi pubblici, a seguito di alcuni studi in cui è risultato che il 52% delle donne si nasconde per allattare, il 63,5% si è sentita giudicata a farlo in spazi pubblici, mentre un 15% è stato addirittura richiamato mentre allattava. Questa difficoltà di allattare nello spazio pubblico fa sì che molte donne vivano l’allattamento in modo individuale e isolato, fatto controproducente dato che la maggior parte delle




complicazioni si potrebbero risolvere condividendo esperienze con altre madri. Mamífera rivendica la necessità dell’allattamento in collettivo, rompendo un tabù su un argomento considerato una cosa privata.
Riferimenti teorici
Come ben segnalato da Colin Ward nel suo Il bambino e la città quella dell’infanzia è una delle voci meno ascoltate al momento di disegnare un progetto urbano; non vengono tenute in conto le sue esperienze, percezioni e necessità. Per la sua condizione di dipendenza, l’infanzia interagisce continuamente con altri soggetti e per questo migliorare la sua qualità di vita significa inevitabilmente fare lo stesso con la qualità di vita di altre categorie. Mettere i bambini al centro delle decisioni urbane porterebbe beneficio anche al resto della società permettendo di avanzare verso modelli urbani più inclusivi.
Per quanto riguarda l’urbanistica femminista Jane Jacobs (1916- 2016) è la teorica che forse più di tutte ha influito sul modo di analizzare i fenomeni urbani nelle città contemporanee. Le sue idee, ridicolizzate negli anni Sessanta dai tecnocrati, oggi vengono recuperate. L’attivista statunitense ha portato il focus sulle persone e non sugli edifici, puntando sull’uso misto, sul bottom-up (strategia dal basso verso l’alto), sulla disobbedienza civile, al contrario della città immaginata sull’esempio di Le Corbusier,
con zone di uso esclusivo e mastodontici edifici. A sessant’anni dalla pubblicazione di Vita e morte delle grandi città, i concetti dell’attivista politica, divulgatrice scientifica e giornalista continuano a essere validi tra le generazioni emergenti, come dimostra ad esempio la recente pubblicazione di Città e libertà, una raccolta di suoi scritti inediti in italiano. Jacobs ha sottolineato la mancanza di spazi verdi, le strade poco




sicure e l’assenza di cordialità tra i vicini. Inoltre ha denunciato la superiorità delle auto sui pedoni. Pioniera della critica dell’impianto urbanistico tradizionale, ha dato vita a diversi movimenti regionali e internazionali.
La prospettiva anarchica sull’urbanismo si avvicina a quella femminista poiché anch’essa punta a ribaltare l’approccio dall’alto verso il basso come fa Colin Ward in L’educazione incidentale (2018) e nell’Architettura del dissenso (2016). L’obiettivo è riuscire a spostare il potere decisionale in mano a chi il territorio lo abita e lo conosce, contrariamente all’urbanistica convenzionale degli architetti chiusi nei loro uffici. Nell’urbanistica femminista una delle chiavi è considerare le abitanti (donne) del quartiere come massime esperte del loro territorio e quindi offrire loro la possibilità di fare la diagnosi e le proposte di miglioramento dei loro quartieri, considerando fondamentali la prossimità e l’esperienza quotidiana. Il lavoro degli architetti si limiterebbe quindi a fornire gli strumenti tecnici per trasformare queste idee in proposte fattibili a livello costruttivo. Le metodologie partecipative utilizzate da questi collettivi dovrebbero poi fornire le basi per la pianificazione urbana, e diciamo «dovrebbero» perchè nonostante la buona volontà delle amministrazioni, spesso rimane una certa tensione o distanza tra il vicinato coinvolto nel processo partecipativo e i tecnici e i politici che alla fine approvano ai progetti.




Conclusioni
I buoni risultati ottenuti dal collettivo e la sensibilità delle amministrazioni spagnole negli ultimi anni hanno portato Equal Saree a crescere negli anni. L’obiettivo del collettivo è lavorare in gruppo, con rispetto e riconoscimento per il lavoro dell’altro, senza aggressioni, rifiutando le posizioni dominanti e le lotte di potere. Si propongono di riaffermare la posizione femminista con il dialogo e senza gridare.
Come frutto degli oltre dieci anni di lavoro, il collettivo propone La Generadora, un corso online ormai alla settima edizione che aspira a condividere la loro esperienza e consolidare ed espandere una linea di pensiero e di pratica innovativa più democratica sulla città, l’urbanistica e il design. Il corso si propone anche di generare nuove forme di produzione della conoscenza, basate sull’orizzontalità, la trasversalità, l’interdisciplinarietà e il lavoro in rete. Allo stesso tempo vuole promuovere un interscambio costante tra la teoria e la pratica, per generare conoscenza applicata e vincolata al territorio e alle realtà sociali.





Manifesto di Equal Saree
Come intendiamo l’architettura e l’urbanistica femminista? I femminismi hanno come obiettivo smascherare le disuguaglianze sociali, politiche, economiche e giuridiche che soffriamo noi donne e le persone con identità non normate, tenendo in conto la diversità e complessità e decostruendo gli stereotipi e i ruoli di genere perchè tutte le persone si possano sviluppare in
L’urbanistica è uno strumento chiave per la democratizzazione dell’uso delle città e ha un ruolo fondamentale nel garantire la qualità di vita dei cittadini. Con l’urbanistica e l’architettura femminista cerchiamo, tramite il disegno degli spazi e della pianificazione urbana, di pensare, costruire o rigenerare:
libertà e con le stesse opportunità.
- Città diverse: che non perpetuino disuguaglianze di genere, condizione sociale, origine di provenienza, etnia, stato di salute, orientamento sessuale o età, tra le altre. In conclusione, città inclusive che considerino e diano risposte alle necessità della vita quotidiana di tutte le persone.
- Città che si prendono cura: che diano uno spazio ai compiti di cura nelll’ambito pubblico per renderli visibili, valorizzarli e creare una responsabilità collettiva.
- Città sostenibili: che abbiano rispetto dell’ambiente e delle comunità che le abitano da una prospettiva ambientale, ma anche da economica e sociale.
Crediamo necessario dare voce alle persone per individuare gli usi, le necessità, i desideri specifici delle comunità che abitano i diversi territori. Puntiamo sulla partecipazione attiva di chi generalmente rimane escluso dalle decisioni sul territorio che lo circonda come i bambini o gli anziani. Crediamo nel potere dell’educazione, che applicata ai processi collettivi decisionali sugli spazi che abitiamo può diventare uno strumento chiave per la trasformazione sociale.




Articolo scritto con materiale tratto da
- Conversazione con Dafne Saldaña Blasco, membro del collettivo, luglio 2023.
- https://equalsaree.org.
Bibliografia
- A. CRESPO, Fer ciutat fora del despatx, in «La Directa», 14 maggio 2019.
- J. GOULA, H. CARDON, D. SALDAÑA, Co-crear una ciutat co-educadora, «Protagonistes ja!» https://protagonistesja.files.wordpress.com/2019/12/ saree.pdf 2019.
- J. JACOBS, Vita e morte delle grandi città. Saggio sulle metropoli americane, Einaudi, Torino, 2009. 1961.
- J. JACOBS, Città e libertà, elèuthera, Milano, 2020.
- M. OVELAR, Ciudades feministas: hacia un futuro sostenible e integrador, «Traveler», 25 marzo 2021.
- V. URFEIG, Las grandes ciudades son hostiles a las mujeres?, in «La Nacion», 25 luglio 2021.
- C. WARD, Il bambino e la città, L’ancora del Mediterraneo, Napoli, 2000.
- C. WARD, Architettura del dissenso: forme e pratiche alternative dello spazio urbano, elèuthera, Milano, 2016.
- C. WARD, L’educazione incidentale, elèuthera, Milano, 2018.





È possibile un’organizzazione economica anarchica? Le imprese tessili del distretto industriale di Alcoi durante la
guerra civile spagnola (1936-39)
Joaquin Cuevas Casaña, Lina Gálvez Muñoz e Lluis Torrís Torró Gil
Traduzione e introduzione di Guido Candela e Antonio Senta
Presentiamo qui la traduzione di un articolo apparso sulla rivista spagnola «Disjuntiva. Crítica de les Ciències Socials», vol. 0, n. 1, luglio 2019. I tre autori, Joaquim Cuevas Casaña, Lina Gálvez Muñoz e Lluís Torró Gil sono ricercatori rispettivamente delle Università di Valencia, Siviglia e Alicante. Il loro lavoro, attraverso un’analisi storica, sostiene due tesi, una generale e una particolare.
A) La tesi generale è che nella Spagna rivoluzionaria del 1936-39, dove vi è stata una trasformazione economica e produttiva guidata dal sindacato anarchico (e socialista), la cooperazione e il fare rete secondo la pratica del mutuo appoggio siano stati mezzi più efficienti rispetto a un’organizzazione gerarchica e autoritaria. Questo è un ulteriore caso che si aggiunge a quelli raccolti da Kropotkin per dimostrare nei fatti che non è vero che le società più efficienti siano quelle segnate dalla lotta per la sopravvivenza e non dalla collaborazione reciproca.
Un gruppo sociale che si autoregola secondo principi libertari e quindi senza autorità dominanti è in grado di mettere da parte il principio della competizione meritocratica: «Alfie Khon (1999), infatti, dal punto di vista teorico cerca sia di rivalutare la cooperazione sotto molti punti di vista sia di svalutare la competizione,




fattore di infelicità che mina la stima in noi stessi e avvelena tutta la vita sociale, a cominciare dal lavoro e dalla scuola, e che si dimostra controproducente anche dal punto di vista economico» (Candela e Senta 2017: 75). Khon richiama l’analisi antropologica di molte comunità primitive e non (indiane: Inuit, Irochesi, Piedi Neri e Zuñi; africane: Bathonga, Kikuyu e Tangu; messicane delle aree rurali e i Mixtechi; i kibbutz israeliani, gli aborigeni australiani, i norvegesi e i giapponesi). Casaña, Muñoz e Gil dimostrano che questo si è avverato in un altro importante tratto della storia, in un contesto di rivoluzione e di guerra.
B) La tesi particolare risponde alla domanda: v’è «possibilità di successo dell’organizzazione economica anarchica?», Gli autori non pongono una domanda retorica, perché la loro risposta è affermativa ma solo dopo una disamina effettiva del caso di Alcoi. Essi riportano una precisa misura dell’efficienza: la rivoluzione consegnò alla restaurazione un sistema produttivo più «ricco», più «razionale e più efficiente di prima». Questo rende l’esperienza storica del distretto tessile di Alcoi rilevante, anche perché non abbiamo a disposizione molte altre osservazioni su casi effettivi di sistemi produttivi anarchici di vasta dimensione, dal momento che essi sono stati repressi in breve tempo per mano dello Stato o tramite lo Stato (Candela e Senta 2017). Come, in effetti, è stato anche per Alcoi, ma con più lentezza, grazie alla resistenza dei repubblicani.
A fronte di queste due tesi, Casaña, Muñoz e Gil sollevano alcune perplessità. In particolare fanno notare che l’anarchismo in questa regione della Spagna: a) ha accettato la collaborazione dei vecchi proprietari nelle fabbriche collettivizzate; b) ha generato un’effettiva organizzazione; c) ha valorizzato il lavoro amministrativo dei burocrati. Gli autori si meravigliano di questi fattori e non li riconoscono come coerenti con le idee anarchiche. Noi, invece, sosteniamo che questi tre punti non sono in contraddizione con l’idea libertaria e che il loro studio dà una conferma della praticabilità di tale idea.




a) A proposito della collaborazione con gli imprenditori e i manager appartenenti alla precedente gerarchia capitalistica, richiamiamo una distinzione riguardo al modello di impresa tra il pensiero di Marx e quello di Proudhon. Nell’impresa capitalista “pura” sia il capitale sia il prodotto sono di proprietà dell’imprenditore, che esclude il lavoratore da ogni diritto di proprietà sull’intrapresa comune. Tuttavia, concettualmente, i due diritti possono essere distinti, essendo correlati storicamente ma non connessi giuridicamente.
Secondo Marx ciò che caratterizza l’impresa capitalista è che l’imprenditore è il proprietario del capitale (le macchine e i mezzi di produzione), quindi in forza di questa proprietà, anche appartenendo a una classe oziosa, è in grado di imporre un contratto a ogni lavoratore escludendolo così, in cambio di un salario, dalla proprietà del prodotto. Il capitalista è il solo proprietario del prodotto, in tal modo si appropria del pluslavoro di ciascun lavoratore. Questo è il tasso di sfruttamento à la Marx.
Secondo Proudhon ciò che caratterizza l’impresa è lo sforzo comune in vista della produzione, quindi dovrebbero essere co-proprietari del prodotto tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato. Così in questo modello, passa in secondo piano la proprietà del capitale, la distinzione fra lavoro manuale e organizzativo, mentre è importante la proprietà del prodotto che è di tutti i lavoratori. Fra di loro potrebbero esserci anche i proprietari del capitale, che sarebbero co-proprietari se e solo se contribuissero col loro lavoro, organizzativo e/o manuale, all’ottenimento del prodotto. L’impresa capitalista per Proudhon è quella in cui l’imprenditore esercita una forma di dominio attribuendosi la proprietà esclusiva del prodotto, escludendo i lavoratori. Questo è il «furto» à la Proudhon.
Nell’impresa di Marx capitalisti (proprietari) e proletari (senza proprietà) sono due classi strutturalmente divise. Nell’impresa di Proudhon vi è ancora una contrapposizione di classe, ma la ragione divisiva è esclusivamente il dominio di una classe sull’altra che si concretizza anche nella proprietà privata del capitale da parte di una delle due classi.




Una conseguenza di questa differenza è che nel modello auspicato da Marx il capitalismo cede le sue armi se perde la proprietà privata del capitale, mentre nel modello desiderato da Proudhon la classe dominante cede le sue armi se perde il suo dominio, e quindi il prodotto diviene di comunità. Entrambi i modelli sono conseguenza di azioni rivoluzionarie che possono eventualmente coincidere se la proprietà del capitale è la causa principale del dominio di classe; ma se il fine non è anarchico – cioè la co-proprietà del prodotto – si può riformare il dominio nello Stato proprietario della produzione. Il decentramento, o meno, del potere nella gestione del prodotto è ciò che contrappone il comunismo anarchico teorizzato da Malatesta e Kropotkin al comunismo autoritario e centralista di tipo bolscevico (Candela 2014). Di conseguenze nella società anarchica, dove non vi sono relazioni di dominio, l’imprenditore che collabora, con il suo lavoro, al prodotto comune diverrebbe – secondo Proudhon – co-proprietario come ogni altro lavoratore, indipendentemente e prescindendo dalla proprietà del capitale. Questa organizzazione è ciò che Casaña, Muñoz e Gil ritrovano storicamente nel distretto di Alcoi, dove i proprietari capitalisti lavoravano nelle stesse fabbriche tessili insieme agli operai rinunciando a posizioni di dominio: «alcuni imprenditori si diedero alla fuga, ma molti di loro rimasero nelle imprese come membri dei comitati tecnici»; analogamente «molti manager rimasero nelle loro fabbriche, pur se collettivizzate, e si impegnarono nel dare consigli e nello svolgere funzioni tecniche». Sempre nella Spagna del 1936 qualcosa di simile è accaduto in agricoltura, dove furono i contadini che si attivarono per provvedere ai raccolti e rimettere in produzione le terre abbandonate (Leval 1952). Migliaia di contadini collettivizzarono le terre, ma «autorizzando quei pochi singoli proprietari desiderosi di mantenere la propria proprietà a farlo, a patto che non sfruttassero nessuno. Spesso questi proprietari finirono comunque per riunirsi alla collettività per goderne i vantaggi» (Jourdan 2022).



- b) A proposito del rapporto tra organizzazione e anarchia, tutta una lunga tradizione anarchica ha evidenziato che l’anarchia è «la più alta espressione dell’ordine», per citare Elisée Reclus, perché il processo decisionale è autogestito e quindi realmente partecipato, evitando che la decisione sia imposta dall’alto. L’anarchismo pragmatico (e rispettabile) che questa rivista intende valorizzare e che si rifà al pensiero, tra gli altri, di Ward, Landauer, Buber, Goodman, Read, Comfort, ecc. applica tale principio anche alla produzione, qui e ora, di beni e servizi: «il compito dell’anarchico è dimostrare come le iniziative anarchiche possano dare una risposta soddisfacente ai bisogni cruciali, anche in modo più efficace degli interventi che si basano sull’iniziativa statale o di mercato» (White et al.: 19).
- c) A proposito degli impiegati e dei lavoratori della banca, ovvero di quei burocrati chiamati a collaborare all’organizzazione collettivizzata delle fabbriche per il lavoro amministrativo e contabile, essi si dimostrano necessari al buon esito del prodotto comune e proprio per questo sono «chiamati» dal sindacato. Per lo stesso principio anarchico teorizzato da Proudhon (punto a), quello della forza del lavoro comune, non vi è distinzione fra lavoro intellettuale e manuale, non vi sono lavoratori produttivi e improduttivi à la Smith, ma tutti concorrono al risultato con un impegno comune ed efficiente, che non si otterrebbe se mancassero gli uni o gli altri. Il pensiero anarchico non fa distinzione né gradua i lavoratori, anzi sostiene il lavoro totale (Codello 2017).
Ci pare quindi che l’organizzazione descritta da Casaña, Muñoz e Gil sia anarchica, almeno per i tre dubbi che pongono e che abbiamo analizzato. Rimangano però, a nostro avviso, due questioni ancora irrisolte, prima di essere sicuri di una risposta certa riguardo all’efficienza di un’organizzazione economica anarchica.
I) Quanto il successo del tessile di Alcoi è dovuto alla domanda di prodotti tessili forzata della guerra, domanda che ha dissolto,




ancor più che risolto, i problemi della destinazione del prodotto e del marketing distributivo? È una questione più volte espressa nell’articolo, a cui non c’è possibile risposta.
II) L’organizzazione descritta nell’articolo consiste in un effettivo autogoverno delle relazioni sociali e personali? L’autogestione anarchica non è originata e diretta da un potere centrale, ma si fonda su un modello di organizzazione sociale che: i) è ispirato a un federalismo che nasce dal basso: ii) è pratica sociale e metodo orizzontale, antiautoritario, antigerarchico che pratica la decentralizzazione e la democratizzazione delle possibilità decisionali; iii) è democrazia diretta, che si applica per frammenti, porzioni più o meno piccole della società, in uno schema di interdipendenza federalista; iv) si estrinseca ponendo l’uomo e la natura al primo posto; v) è pratica quotidiana (Candela e Senta 2017; Candela 2021). Poco sappiamo su come fossero nei fatti le relazioni nel distretto di Alcoi 1936-1939, e questo è un tema su cui i tre ricercatori, che ne hanno le competenze, potrebbero lavorare in una ricerca che completi quella che qui presentiamo.
***
Dopo il colpo militare del generale Franco nel luglio 1936, una porzione della Spagna, pressappoco corrispondente alla parte meno industrializzata del paese, fu occupata dalle forze militari di Franco e vi fu istituito un regime fascista. Il resto del paese rimase leale al governo repubblicano democraticamente eletto e fu lì – escluse le province basche – che, mentre si combatteva una guerra civile, scoppiò una rivoluzione sociale condotta dai lavoratori e dai loro sindacati, che innescò un processo rivoluzionario contro la proprietà privata. Nel distretto produttivo di Alcoi i lavoratori presero il controllo delle imprese dei tre princi-




pali settori industriali: il tessile, il cartaceo e il metallurgico. Alcuni imprenditori si diedero alla fuga, ma molti di loro rimasero nelle imprese come membri dei comitati tecnici, privati però del loro potere amministrativo, che di fatto passò ai sindacati. Nel settore tessile il sindacato anarchico, oltre ad avere il controllo di un centinaio di imprese familiari, realizzò un processo di razionalizzazione che unificò la produzione di tutte le imprese tessili. Il passo definitivo verso una completa integrazione fu compiuto nel settembre 1936, quando il sindacato confiscò l’Associazione degli imprenditori (d’ora in poi AdI) e unificò l’intera industria come fosse una sola impresa.
Sebbene l’ispirazione fosse politica – realizzare la rivoluzione – la collettivizzazione si tinse della giustificazione economica di razionalizzare la produzione e di realizzare un’economia di scala. Impiegati di banca e lavoratori del sindacato furono chiamati a coprire la domanda crescente di lavoro burocratico derivante dall’unificazione, beneficiando di incrementi salariali, migliorando le condizioni del lavoro e quindi generando risparmio. Ad Alcoi, l’unificazione aiutò a risolvere la crisi in cui l’industria tessile spagnola era caduta durante i primi anni Trenta. Infatti, la crisi dell’industria tessile negli anni precedenti la guerra civile, che coincise con la crisi economica internazionale del 1930, fu risolta in due modi: da una parte, grazie alla forzata e costante domanda costituita dagli ordini delle coperte e delle uniformi per l’esercito repubblicano; dall’altra, a causa del processo rivoluzionario, che portò alla collettivizzazione e all’unificazione dell’intera industria tessile coordinata dal Sindacato del Textil, anarchico. Entrambe queste circostanze, la domanda forzata e l’organizzazione centralizzata, spiegano la performance economica del sindacato, che superò nel 1939 quella delle imprese indipendenti del 1936. Alla fine della guerra, la Direzione generale dei rimborsi, instaurata dal regime di Franco, realizzò un sistema che consentì ai precedenti proprietari di recuperare le proprietà confiscate, cui si aggiunsero i benefici ottenuti durante la guerra dalla gestione da parte del sindacato anarchico.




Al di là del fatto che i precedenti proprietari goderono effettivamente di questi benefici, recuperando le loro proprietà, i risultati conseguiti dall’organizzazione anarchica della produzione non ebbero mai un riconoscimento. Questo fatto può essere collegato a due cause: I) la repressione della classe lavoratrice dopo la vittoria armata di Franco; II) lo sviluppo delle relazioni industriali ad Alcoi, come parte di un processo industriale dove capitale e lavoro erano in conflitto, come normalmente avviene nei periodi di mutamento tecnologico che riguardano il controllo e la distribuzione del reddito. Tutto questo avvenne in un periodo di aumento del costo della vita, iniziato prima della guerra civile, associato a una diminuzione delle vendite e a una scarsità di lavoro disponibile.
Questo conflitto risultò molto creativo in termini organizzativi sia per gli impiegati che per gli operai, che svilupparono importanti tendenze associazioniste. Gli operai videro i loro sindacati smantellati dopo la guerra, mentre gli impiegati incrementarono la loro cooperazione, senza però raggiungere una vera integrazione – che invece a volte si era realizzata nei sindacati anarchici durante la guerra – ma continuando a lavorare con l’organizzazione produttiva che caratterizzava i distretti industriali. Questo aumento della cooperazione fra le imprese tessili può essere compreso se inserito nel nuovo contesto industriale, entro, cioè, il regime corporativo di Franco, per il quale le influenze e le relazioni politiche erano più importanti della competizione per garantire il successo produttivo. Come dato di fatto, per le piccole e medie imprese familiari, come quelle tessili ad Alcoi, la cooperazione si dimostrò essere un’utile strategia.
Lo studio di un caso singolo come questo solleva alcune questioni generali, che riguardano l’organizzazione economica: il ruolo dell’autorità e della gerarchia versus la cooperazione e il far rete; la distribuzione del reddito fra capitale e lavoro; il ruolo svolto dai mutamenti tecnici e organizzativi. Accanto a questi dovrebbero essere considerati altri aspetti, come l’affidabilità, il superamento del mercato, il mutamento istituzionale e la sopravvivenza delle imprese.




Il caso di Alcoi durante la guerra civile dimostra la possibilità di successo dell’organizzazione economica anarchica? L’organizzazione delle imprese tessili ad Alcoi realizzata dal sindacato anarchico dal 1936 al 1939 rese effettivamente possibile il superamento della precedente crisi produttiva e la copertura della domanda di prodotti tessili generata dalla guerra. La collettivizzazione delle imprese e l’amministrazione da parte dei lavoratori durarono solamente negli anni di guerra fino alla sconfitta del governo repubblicano, nel 1939. Di fatto, non è possibile sapere se l’amministrazione dei lavoratori sarebbe continuata con successo senza lo scenario di guerra e avrebbe potuto mantenersi nel lungo periodo. I lavoratori avevano il know-how tecnico e perfino quello organizzativo, sia per la loro precedente esperienza nei
comitati d’impresa, come richiedeva la legge repubblicana della metà del 1930, sia perché fu possibile utilizzare gli impiegati di banca, come già detto. Tuttavia, i lavoratori non sapevano nulla di marketing, che invece è particolarmente importante in un settore altamente competitivo come il tessile. Durante la guerra questo però non
L’obiettivo di realizzare la rivoluzione sociale fu di fatto subordinato a un obiettivo più importante, quello di vincere la guerra
fu un problema, poiché il mercato coincideva con la domanda generata dall’esercito repubblicano. Inoltre, l’obiettivo di realizzare la rivoluzione sociale fu di fatto subordinato a un obiettivo più importante, quello di vincere la guerra. Dunque, tutto ciò costituì una condizione speciale del distretto industriale in quel periodo. Le imprese tessili di Alcoi si adattarono al mutamento del mercato e delle istituzioni attraverso l’adattabilità della loro rete di coordinamento.
Infatti, per rispondere alla domanda se l’organizzazione economica anarchica sia stata efficiente e per comprenderne la natura dobbiamo prendere in considerazione sia le caratteristiche del distretto industriale sia il proseguire della guerra civile, entrambe importanti.




1. Il distretto industriale di Alcoi
Prima di descrivere il distretto industriale di Alcoi come un esempio di rete produttiva, in cui datori di lavoro e lavoratori affrontano i cambiamenti associandosi al fine di ottenere incrementi di produttività, è necessario fare riferimento all’evoluzione storica del settore tessile in Spagna e in particolare ad Alcoi, passo fondamentale per comprendere la situazione ereditata dal settore tessile agli inizi della guerra civile e capire le soluzioni adottate e adottabili dalla rivoluzione produttiva anarchica. L’inizio delle attività tessili nella città di Alcoi risale al XV e XVI secolo. Nel 1560 nacque il Gremio de Peraire (la gilda dei tessitori), mentre Acoi era da sempre uno dei più importanti centri tessili della lana in Spagna, dopo Sabadell e la Catalogna. Altri due settori industriali erano importanti nella regione di Alcoi sempre legati al tessile: quello del metallo e della carta; questa differenziazione settoriale, con la prevalenza delle imprese tessili e la localizzazione delle attività secondarie situate vicino ai villaggi, consente di parlare di un vero e proprio distretto industriale (Becattini 1987; Becattini e Rullani 1996).
1.1 Cooperazione
La principale caratteristica del settore tessile di Alcoi era la sua struttura produttiva atomizzata, più tipica della prima fase industriale che della seconda (SUCH 1993). La concentrazione della proprietà fu difficile da realizzare, perché la tipologia delle imprese familiari aveva come priorità la conservazione del controllo familiare piuttosto che l’efficacia produttiva e la realizzazione di benefici economici. Il lavoro familiare sviluppò specifiche relazioni lavorative fra tessitori indipendenti e datori di lavoro, generando guadagni unitari più bassi rispetto ad altre aziende concorrenti. Di fatto, le imprese tessili di Alcoi durante la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX secolo si specializzarono nella produzione di articoli low cost che richiedevano bassi investimenti.




Il tessile di Alcoi non si distingueva per l’introduzione di innovazioni tecnologiche e quindi soffriva di un arretramento tecnologico. Lo stimolo al processo di meccanizzazione corse parallelo all’evoluzione delle lotte e delle conquiste dei lavoratori, che raggiunsero il loro picco negli anni attorno alla rivoluzione del 1868 e alla rivolta dei lavoratori del 1873.
Una delle peculiarità del caso di Alcoi è che il costo del lavoro impegnava la maggiore quota del costo totale, rispetto ad altre aziende concorrenti. Questo divenne un grosso problema dopo la prima guerra mondiale, da un lato a causa dell’importante e combattivo movimento sindacale e dall’altro a causa dall’avversione al rischio di imprenditori restii a
sostenere investimenti innovativi e ad aprirsi a nuovi mercati. Sebbene questa seconda ragione fosse almeno tanto importante quanto la prima, gli imprenditori hanno sempre fatto riferimento alla forza del movimento sindacale e agli alti salari per giustificare la perdita di competitività.
La divisione dei mercati e la struttura del settore, le conoscenze degli
imprenditori locali, assieme alle minacce esterne furono causa di un sistema scarsamente integrato e favorirono accordi di cooperazione fra le imprese, tramite la nascita dell’AdI. Questa rete di collaborazione può essere classificata secondo la tipologia di Mark Casson, definendola come caratterizzata da legami di fiducia fra compagnie con differenze produttive e diversi livelli tecnici (Casson 1997: 815). Il comportamento cooperativo fra i datori di lavoro è un elemento chiave nello spiegare sia la sopravvivenza secolare delle imprese sia il successo dell’organizzazione produttiva anarchica durante la guerra civile, per gli aspetti che riguardano le relazioni industriali, il mercato e la tecnologia.




1.2 Rete produttiva
L’origine dell’organizzazione degli imprenditori nella città di Alcoi risale al XV e XVI secolo. Fu nel 1560 che nacque la Gilda dei tessitori, più tardi denominata Fabrica de Paños che nel 1731 divenne la Real Fabrica de Paños de Alcoi (RFPA), il fornitore ufficiale dell’esercito reale. Durante il processo di industrializzazione del XIX secolo – tempo in cui l’industria in Alcoi crebbe e venne meccanizzata, divenendo uno dei più competitivi centri industriali della Spagna – il RFPA divenne un’associazione industriale vera e propria. Questa associazione comprendeva la maggiore parte degli imprenditori tessili, consentendo un comportamento cooperativo al fine di risolvere i problemi comuni. Durante il XVIII secolo l’associazione permise di controllare il lavoro specializzato necessario per la standardizzazione della produzione, inoltre il RFPA fu molto attivo come lobby (per esempio a proposito della tassazione) così come nella diffusione delle nuove tecnologie e nella trasformazione produttiva che ebbe luogo fino agli inizi del XIX secolo (Torró 1996). Questo accordo cooperativo si sviluppò ulteriormente negli anni precedenti la guerra civile come reazione alle crisi economiche internazionali e al nuovo contesto creatosi nel 1931 con il governo repubblicano, molto più favorevole del precedente governo alle richieste dei lavoratori.
Questi progressi nella cooperazione e nel management collettivo sono essenziali per comprendere il successo anarchico durante la guerra, una volta che il sindacato ebbe preso il controllo dell’AdI nel settembre 1936. Infatti, questo quadro – caratterizzato da una grande tendenza alla cooperazione in una rete di imprese senza concentrazione di proprietà – subì un mutamento radicale quando iniziò la guerra. La rottura istituzionale del 1936-1939 propiziò una nuova esperienza, una collettivizzazione che portò a un’integrazione della proprietà e a un’unificazione dell’amministrazione. Come si vedrà, tutto questo finì con la vittoria del generale Franco, nel 1939. Cionondimeno questa integrazione continuò e aumentò anche nel dopoguerra.




1.3 Relazioni industriali
Nella prima parte del XX secolo nel distretto industriale si verificò un doppio fenomeno. Da un lato, cambiarono la tecnica produttiva e le condizioni del mercato con un effetto negativo specialmente per quei distretti industriali dove le imprese non erano integrate e centralizzate come ad Alcoi. D’altro lato, questa situazione, particolarmente grave durante la prima guerra mondiale e per effetto della crisi internazionale del 1930, era compatibile con un maggiore grado di cooperazione fra i produttori al fine di affrontare i problemi comuni. L’accelerazione nel processo di meccanizzazione fu accompagnata anche da una forte rinascita, agli inizi del XX secolo, del movimento dei lavoratori. Infatti, le relazioni industriali ad Alcoi non furono semplici; alcune caratteristiche erano comuni alle relazioni industriali spagnole, altre invece erano effetto della particolare struttura produttiva di Alcoi: la forte avversione al rischio degli imprenditori e la loro specializzazione in prodotti low cost, dove gli investimenti in innovazioni e tecnologia non erano essenziali. La proclamazione del regime repubblicano nel 1931 segnò un punto di svolta, e la legislazione spagnola del lavoro mutò tanto che prima della fine della guerra civile si registrò un record di accordi collettivi firmati. Il sindacato socialista UGT era stato fondato nel 1888 e il sindacato anarchico CNT nel 1910. Ad Alcoi un importante movimento dei lavoratori si era sviluppato nel XIX secolo e per questo alto livello di mobilitazione i salari – o meglio – il costo del lavoro risultava relativamente più alto rispetto agli altri centri di produzione della lana, come Sabadell in Catalogna. La forza dei sindacati di Alcoi impose la redistribuzione del lavoro in situazioni difficili come nella crisi del 1930, impedendo agli imprenditori di procedere a licenziamenti massivi. In uguale maniera, si consentì ai lavoratori tessili di partecipare ai vantaggi della produttività derivanti dai mutamenti tecnici e organizzativi del lavoro. Se non si considerano tutte queste circostanze, difficilmente si possono comprendere sia l’impulso rivoluzionario alla collettivizzazione sia le sue peculiari caratteristiche locali.




2. Collettivizzazione durante la guerra civile spagnola. Le imprese tessili di Alcoi
L’organizzazione produttiva era differente nelle due parti della Spagna coinvolte nel conflitto dal 1936. In termini generali, l’organizzazione produttiva nel campo leale alla Repubblica fu caratterizzata da collettivizzazioni e dal controllo dei lavoratori delle imprese. Quando i lavoratori tornarono alla loro occupazione dopo i primi giorni di combattimento, trovarono che molti dei proprietari delle imprese erano fuggiti e quindi si fecero carico della produzione nelle fabbriche. Così facendo, realizzarono una rivoluzione, trasformandosi in soldati-produttori il cui scopo era sconfiggere le truppe fasciste. Tuttavia, la collettivizzazione non si affermò in tutti i territori repubblicani, in particolare non nelle Province Basche, dove la rete produttiva restò fondata su relazioni capitaliste, con il controllo rimasto nelle mani dei datori di lavoro. In più, molte delle imprese collettivizzate diventarono proprietà dello stato. In ogni caso, le industrie collettivizzate mutarono la loro produzione per coprire la domanda indotta dalla guerra, e dunque l’industria delle scarpe produsse scarponi per l’esercito, l’industria dei giocattoli si trasformò per produrre coltelli, cartucce, cappelli e tute per la milizia, e l’industria del legno produsse scatole per le munizioni o calci per i fucili (Gálvez 2006).
Nel campo dei ribelli, l’industria fu militarizzata e, quando la legislazione del lavoro della Repubblica fu smantellata, relazioni di lavoro asimmetriche presero il sopravvento in tutti i settori, cosicché i lavoratori non ebbero possibilità di reclamare i loro diritti o avere accesso ad accordi collettivi. Questo significò maggiore intensità nell’impiego del fattore lavoro, il che favorì a volte l’aumento della produzione di guerra. L’esempio più estremo di questa sottomissione dei lavoratori furono le condizioni di lavoro forzato dei battaglioni dei prigionieri.
Al fine di comprendere perché l’organizzazione produttiva anarchica ebbe successo nelle imprese tessili di Alcoi durante la guerra civile, due aspetti devono essere presi in considerazione:




I) il lascito dell’AdI, come già detto: II) la guerra stessa. La guerra fu importante per due differenti motivi. La rivoluzione sociale anarchica e socialista dei sindacati divenne in Spagna in molti casi il secondo fine dopo quello di vincere la guerra; dunque le industrie dovevano essere bene organizzate per raggiungere questo scopo. La partecipazione dell’Unione Sovietica dal lato repubblicano lavorò in questa direzione, sebbene in molte località distrusse le precedenti e più spontanee organizzazioni socialiste e anarchiche, riducendo così gli incentivi per i lavoratori. Alcoi rimase nelle mani dei sindacati anarchici non senza conflitto con il governo repubblicano. La domanda forzata dalla guerra fu essenziale per spiegare il successo economico, ma la conoscenza del mercato e delle relazioni con la clientela era patrimonio dei precedenti proprietari e molto difficilmente sarebbe stata acquisita dai sindacati. Anche se l’intera produzione tessile di Alcoi era richiesta dall’esercito repubblicano, risultò un vantaggio dove i manager della collettivizzazione lavorarono duramente con le autorità repubblicane per mantenere i canali di reperimento delle materie prime e di consegna.





2.1 Guerra, rivoluzione sociale e processo di collettivizzazione
Una buona organizzazione è basilare per far funzionare la produzione industriale in un contesto di guerra. Inoltre, l’effetto negativo di un cattivo management è tanto maggiore quanto più complesse sono le imprese, a livello tecnico e amministrativo. La riorganizzazione industriale dei sindacati socialista e anarchico fu diversa. Le differenze organizzative nella collettivizzazione sono spiegate dalle diverse ideologie che le sostenevano, dal grado di concentrazione produttiva del settore e soprattutto dal fatto che il sindacato anarchico fu parte di un movimento spontaneo che comportò tentativi ed esperimenti legittimati solo più tardi e gradualmente dal governo.
Ci furono tre tipi basilari di gestione delle imprese amministrate dai sindacati:
-
- il controllo dei lavoratori era effettuato da un comitato, dove tutte le operazioni nell’impresa erano regolate senza bisogno di espellere i proprietari d’impresa; questo tipo fu molto comune nelle piccole imprese commerciali;
-
- l’esproprio dell’impresa, per donazione o per operazioni di compra-vendita, che trasferiva i diritti ai lavoratori mentre il proprietario rimaneva nell’impresa come lavoratore tecnico o amministrativo;
-
- la socializzazione o collettivizzazione di tutti i beni (stabilimenti, macchinari, materie prime, conti bancari ecc.) che passarono nelle mani del sindacato, anche unificando l’intera industria di una specifica città. La collettivizzazione significò che il valore aggiunto, dedotte le imposte, gli interessi e le rendite pagate, rimase ai lavoratori come salari e sotto forma di benefici diversi. In alcuni casi la produzione fu razionalizzata per conseguire economie di scala. Le officine e le imprese considerate non produttive furono smantellate, i loro macchinari trasferiti a imprese economicamente solventi e queste furono poste sotto il controllo del comitato amministrativo che fu responsabile di fronte al sindacato, posse-




dendo tutti gli attributi tipici del precedente sistema capitalistico.
Quest’ultima gestione sindacale fu quella adottata dall’industria tessile di Alcoi per far fronte alla crisi e coprire la domanda di guerra. Certamente, l’industria di Alcoi soffrì della crisi del 1930. È alla luce di questa situazione che deve essere compresa l’unificazione dell’industria della carta nel 1934 e quella dell’industria L’incremento dei salari e la creazione di un’assicurazione medica furono le più importanti novità nell’estate 1936, quando venne avviata la collettivizzazione delle fabbriche
metallurgica agli inizi della guerra. Durante il conflitto, il sindacato interpretò la crisi pre-guerra nell’industria tessile come un boicottaggio degli imprenditori contro l’aumento del potere sindacale in seguito alla vittoria del governo della sinistra nelle elezioni del febbraio 1936: la produzione tessile passò dai 15,2 milioni di pesetas nel periodo del governo della destra a 10,1 milioni nel periodo del governo della sinistra, per tornare a 20,1 milioni nel periodo rivoluzionario (Ata 1937). È evidente che la – forzata – domanda causata dalla guerra fu una componente essenziale nel motivare l’aumento della produzione, ma altrettanto lo fu la strategia applicata dai sindacati nell’organizzare l’economia di produzione nel settembre 1936.
Una parte della storiografia sulla guerra civile (Gálvez 2006c) ha rilevato come le cause della sconfitta dei repubblicani furono la mancanza di un’organizzazione produttiva, il difetto del capitale umano e l’incremento dei costi in conseguenza degli alti salari dovuti alla collettivizzazione e al controllo delle imprese da parte dei lavoratori. L’incremento dei salari e altre specifiche misure, come la creazione di un’assicurazione medica, furono le più importanti novità nell’estate 1936, quando venne avviata la collettivizzazione delle fabbriche. Vi fu, infatti, un aumento salariale del 20% dopo che i lavoratori presero il controllo delle imprese anche se questo non sembra sia stato un grande problema commerciale perché la domanda generata dalla guerra era alta e




ci fu un’inflazione generale durante il periodo di guerra. Ciò che costituì un vero peso per le imprese collettivizzate fu la decisione di pagare tutti i salari anche in caso di interruzione della produzione. Tuttavia, ad Alcoi la dinamica della domanda generata dalla guerra evitò la disoccupazione e il pagamento delle relative indennità. Non sembra che le assicurazioni sociali mediche, di pensionamento o di vedovanza, così come la creazione di cooperative di consumo e un istituto politecnico che si occupava dell’apprendimento tecnico – spese finanziate utilizzando i profitti non più accaparrati dagli imprenditori – fossero un peso per gli equilibri economici delle imprese unificate.
L’idea che la carenza di capitale umano fosse una caratteristica del campo repubblicano e fosse di ostacolo per la buona amministrazione delle imprese collettivizzate deve essere collegata al fatto che molti dei manager e dei proprietari scapparono, furono imprigionati o uccisi, specie quelli collegati alle imprese maggiori e quelli il cui nome era associato alle difficili relazioni lavorative che si erano instaurate nelle loro imprese. Cionondimeno, il fatto che manager e proprietari fossero fuggiti unendosi alle truppe di Franco e portandosi via il loro know-how amministrativo, il loro capitale umano e la loro rete produttiva non è stato il principale problema che la collettivizzazione dovette affrontare. Due ragioni lo dimostrano: I) molti uomini d’affari, tecnici e supervisori rimasero nella loro funzione produttiva. Ad Alcoi questa fu la maggioranza poiché molti proprietari delle imprese piccole e medie rimasero nelle loro fabbriche collaborando, sebbene vi siano state anche azioni di sabotaggio di alcuni imprenditori (Quilis 1992); II) il fatto che prima della guerra i lavoratori avessero partecipato ai comitati di fabbrica fece sì che molti di loro avessero familiarità con le strategie delle imprese in cui lavoravano e avessero sviluppato il senso della concorrenza di mercato. I comitati dei lavoratori avevano, quindi, conoscenza dei libri contabili, del problema dell’assegnazione dei compiti, del controllo e del coordinamento con le altre imprese all’interno dell’industria. Per mezzo di questi comitati i sindacati coordina-




rono l’intera industria, raggiunsero una razionalizzazione attraverso la realizzazione di economie di scala, superarono i problemi di un’economia di guerra. Quando ai lavoratori mancavano delle conoscenze per gestire l’amministrazione e la contabilità, chiesero aiuto agli impiegati di banca, che collaborarono; questo è proprio quello che accadde ad Alcoi.
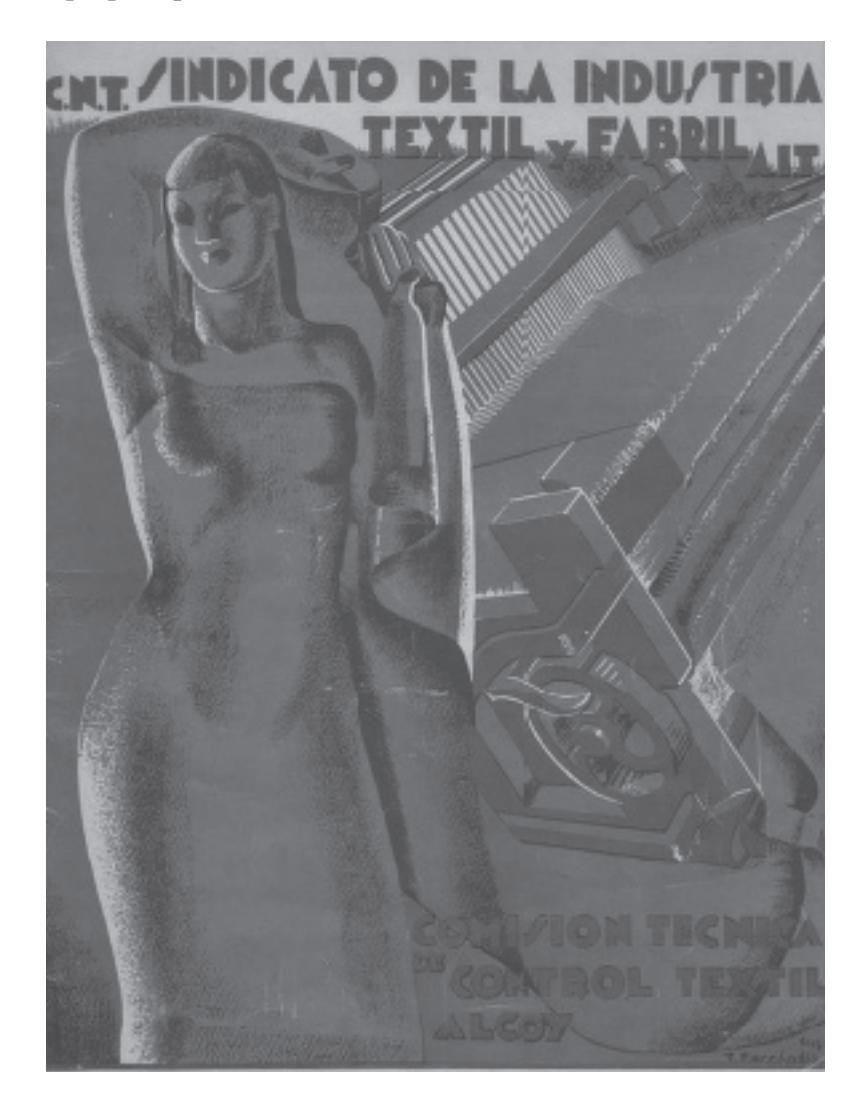




2.2 L’organizzazione produttiva anarchica nelle imprese tessili dell’Alcoi
L’organizzazione implementata dagli anarchici durante la guerra fu un elemento chiave per interpretare la buona performance delle differenti imprese che in quel periodo si integrarono. Il sindacato il 14 settembre dichiarò confiscata l’AdI, e furono poche le imprese che cercarono di resistere a questo processo. In questo caso, chi intratteneva con le imprese relazioni commerciali si dimostrò totalmente riluttante nel far fronte alle proprie obbligazioni e il sindacato ricevette comunicazioni di questa loro decisione, che così si palesò con chiarezza (Ata 1936).
Con la confisca delle fabbriche, i servizi furono centralizzati, come invece non erano all’inizio della guerra, e così rimasero anche dopo la vittoria di Franco
Con la confisca delle fabbriche, i servizi furono centralizzati, come invece non erano all’inizio della guerra, e così rimasero anche dopo la vittoria di Franco. I flussi di cassa per le confische e il pagamento dei debiti furono il vero problema. Tramite i fondi ottenuti dalla confisca dei macchinari e delle proprietà, stimati in circa 80 milioni di pesetas, e i 1.050.000 pesetas di prestiti ottenuti dal Comitato rivo-
luzionario, l’industria tessile di Alcoi e i sindacati di fabbrica furono in grado di iniziare a pagare tutti i precedenti debiti, evitare la bancarotta e la chiusura delle imprese, usando razionalmente le risorse in un processo decisionale centralizzato, comprensivo dell’acquisto delle materie prime, della gestione degli ordini e della consegna del prodotto. In ogni caso, l’unificazione si dimostrò essere la scelta migliore per il superamento della crisi. La confisca dell’AdI fu il primo ed essenziale gradino in questo processo di unificazione dell’industria: «Noi procediamo alla totale confisca dell’Associazione, perché è chiaro che, dopo avere confiscato le fabbriche, dobbiamo naturalmente procedere nello stesso tempo alla confisca dell’Associazione» (Ata 1936).




Il Sindacato tessile di Alcoi sviluppò una rivoluzione organizzativa che si focalizzò su due punti: informazione e struttura burocratica. Le linee guida per raccogliere i flussi di informazioni furono parzialmente imposte dai capi del sindacato (Piqué 1937). Per questo, fu istituito un inventario completo delle imprese, datato al momento della collettivizzazione, e un libro di prima nota giornaliero delle operazioni commerciali; ciò si rese necessario per rendere legali le confische di fronte alle autorità locali (Quilis 1992). Infatti il sindacato non procedeva prima che i seguenti dati fossero raccolti dalle imprese: I) il valore totale dei beni, II) il numero di unità di ciascun articolo prodotto, III) le settimane operative e le relative risorse, IV) l’ammontare dei crediti imputabili ad aree isolate nei collegamenti e a quelle insolvibili a causa della guerra, V) i crediti maturati, VI) e in generale le difficoltà, i problemi nella gestione degli stock e le relative soluzioni proposte. Molte imprese chiesero la collaborazione delle banche nell’allungare i tempi della restituzione dei debiti e nella moderazione degli interessi. Il sindacato riceveva tutte queste informazioni che conservava trascritte in un libro generale. Questo sistema informativo fu la base della razionalizzazione industriale e dell’unificazione degli ordini, delle vendite e dei crediti.
Il flusso delle informazioni rese fondamentale l’aumento della burocrazia al fine di un efficiente management e dell’organizzazione. Entrambe queste cose accaddero ad Alcoi durante la collettivizzazione con l’unificazione dell’intera industria e il controllo imposto sul settore, sebbene questa idea fosse completamente l’opposto delle idee ispiratrici del programma anarchico. Una contraddizione che gli anarchici vollero giustificare: «la realtà ci impone di improvvisare una presa di responsabilità nel controllo del tessile e delle fabbriche industriali, in queste serie circostanze dobbiamo introdurre in fretta queste innovazioni» (Ata 1938). La spiegazione fornita dal rapporto del sindacato del 1937 mostra come un’organizzazione centralizzata, il controllo di tutta la produzione, dei movimenti finanziari e degli aspetti commerciali fossero essenziali.




Dunque l’unificazione totale delle 129 imprese collettivizzate dimostra da un lato che i leader del sindacato possedevano abbastanza conoscenze sull’amministrazione della produzione da comprendere che la più efficiente opzione manageriale fosse l’accentramento delle decisioni e, dall’altro, che erano in grado di imporre i loro criteri al resto del sindacato. Quest’ultimo adottò una struttura decisionale moderna in cui la proprietà della fabbrica non determinava come la produzione dovesse essere organizzata, ma era piuttosto la forza lavoro, attraverso le indicazioni del sindacato, a partecipare direttamente all’amministrazione dell’impresa. La struttura organizzativa si componeva di due parti principali: una superiore, con i compiti di regolare le condizioni lavorative nelle fabbriche e di coordinare l’assegnazione del lavoro nell’industria unificata; una inferiore, che era responsabile di organizzare gli aspetti relativi al processo manifatturiero e di commercializzare il prodotto finito. Il nucleo centrale, cuore della collettivizzazione, fu la Commissione tecnica del controllo tessile (una sorta di comitato esecutivo) composta dai leader e dallo staff tecnico del sindacato; essa prendeva le decisioni, appoggiandosi ai diversi organi con cui aveva relazioni dirette. Questi erano sia il Comitato direttivo del sindacato, per le questioni che avevano a che fare con l’organizzazione del lavoro, sia i vari Dipartimenti in cui le funzioni tecniche della tessitura erano divise: vendita, acquisti, produzione, segreteria ecc.
Quindi i lavoratori erano organizzati dal sindacato seguendo le indicazioni della Commissione tecnica, che assegnava i lavoratori alle fabbriche in base alle necessità dell’industria unificata. Per far questo, e a dispetto del fatto che i lavoratori generalmente fossero occupati nella stessa piazza, i lavoratori considerati qualificati potevano essere riallocati in altre fabbriche o in altri compiti, in accordo con le necessità generali o in base alla domanda proveniente dalla guerra. Ogni fabbrica aveva un suo Comitato di fabbrica (composto dai lavoratori delegati) che eseguiva gli ordini della Commissione tecnica, mentre organizzava gli orari, risolveva i conflitti fra i lavoratori e trasmetteva alla Commissione



tecnica suggerimenti per migliorare o intensificare la produzione, attraverso il Comitato direttivo del sindacato. Inoltre, ogni fabbrica aveva un direttore nominato dalla Commissione tecnica le cui funzioni erano essenzialmente di collegamento fra Commissione tecnica (l’effettivo capo dell’industria) e il Comitati di fabbrica (i lavoratori). I direttori di fabbrica – che in molti casi erano i precedenti proprietari forzati a collaborare con le collettivizzazioni e in altri invece erano i membri del sinIl sindacato adottò una strutturadecisionale moderna in cui la proprietà della fabbrica non determinava come la produzione dovesse essere organizzata, ma era piuttosto la forza lavoro, a partecipare direttamente all’amministrazione dell’ impresa
dacato con maggiore esperienza nel settore – si dimostrarono essenziali nel coordinare i ritmi delle attività di ogni fabbrica: infatti a volte il processo produttivo doveva fermarsi (per difetto di materie prime, mancanza di energia ecc.) e un’agile organizzazione era richiesta in coordinamento con la Commissione tecnica.
A proposito della Commissione tecnica, la grande complessità dei compiti che doveva sviluppare suggerì di dividerla in dipartimenti com’è nelle grandi imprese manifatturiere. Il più energico e attivo dipartimento fu quello della manifattura accanto al quale c’erano quelli degli acquisti, delle vendite e del tesoro. Il Dipartimento della manifattura aveva il compito di progettare la produzione manifatturiera giorno per giorno, di regolare e organizzare le giornate lavorative in accordo con la disponibilità delle risorse. Inoltre, ordinava il trasferimento della manodopera fra le fabbriche, distribuiva le materie prime, ordinava l’arresto di quelle sezioni in cui le condizioni della domanda lo richiedevano, organizzava i trasferimenti dei macchinari fra le diverse fabbriche cercando di aumentarne la produttività, e infine predisponeva le ispezioni nelle fabbriche al fine di verificare che l’intero processo di collettivizzazione corrispondesse al programma stabilito. Mentre il Dipartimento degli acquisti e il Dipartimento delle



55

vendite avevano rispettivamente il compito di risolvere i problemi del reperimento delle materie prime e dell’invio dei prodotti finiti alle loro destinazioni. Questo era un compito essenziale ma non sempre semplice da svolgere, a causa sia dei problemi di comunicazione tipici di un paese in guerra, sia delle condizioni imposte dalle banche per amministrare i conti e mantenerli in ordine, effettuare i pagamenti regolarmente ecc.
A proposito dell’aumento della burocrazia nell’amministrazione, questo fu un processo necessario causato dall’incremento della scala di produzione nell’industria unificata. Nel dicembre 1936 il numero degli occupati dell’industria tessile collettivizzata era
di circa 7.172 persone, di cui 6.452 lavoratori manuali, 72 direttori, 316 caposquadra, 55 tecnici, 276 impiegati e magazzinieri. L’alto numero degli occupati spiega la rapida adozione di uno statuto dei lavoratori, delle regole sui salari e sulle condizioni del lavoro, quindi un regolamento sulle assicurazioni e sul pensionamento. Le retribuzioni corrispondevano alle differenti professioni e ai diversi giorni di lavoro. L’unificazione non sarebbe stata possibile senza i lavoratori amministrativi, impiegati nell’or-
ganizzazione manageriale: l’aumento dei lavoratori negli uffici fu il vero mutamento organizzativo (Ata 1937).
In questa nuova struttura, ciascuna fabbrica collettivizzata avrebbe potuto tenere il precedente sistema contabile per coordinarsi con l’ufficio centrale, ma questo risultò impossibile a causa dell’impossibilità di integrare le molteplici procedure.
Pur con la mancanza di fonti di archivio, è possibile osservare un aumento nelle vendite, specialmente dopo la conquista nell’autunno 1938 del più importante centro industriale tessile in Catalogna. Anche il saldo bancario realizzò un importante aumento,




che – come vedremo meglio – permise ai precedenti proprietari di recuperare le loro imprese e i loro risparmi, ma anche di godere dei benefici raggiunti con l’unificazione e la collettivizzazione delle imprese durante la guerra. Come dato di fatto, non sembra che nel caso di Alcoi né l’organizzazione, né la mancanza di capitale umano, né gli alti salari siano stati un problema. Le più rilevanti preoccupazioni nella collettivizzazione dell’industria in campo repubblicano furono la disponibilità di materie prime e dei macchinari per far ripartire le fabbriche, unitamente ai problemi degli stock e dei crediti dei clienti prima della guerra ora situati nei territori controllati da Franco.
I peggiori risultati delle imprese situate a Madrid – se comparate con quelle in Catalogna e a Valencia – possono essere riferiti a una collettivizzazione più limitata e a un maggiore isolamento del mercato (Catalán 2006). Nei Paesi Baschi non vi furono collettivizzazioni e fu la regione in area repubblicana il cui livello di produzione industriale realizzò il maggiore incremento quando le truppe di Franco entrarono in questi territori. Che l’organizzazione centralizzata di Alcoi nel periodo in cui il sindacato amministrò l’industria tessile sia stata invece un successo è dimostrato dal fatto che quando la guerra finì i manager recuperarono i loro beni senza danno o perdite, avvantaggiandosi dei servizi centralizzati e dei processi produttivi realizzati dal sindacato.
2.3 L’eredità della guerra e la rete produttiva di Alcoi
Si può definire un successo? I repubblicani – che difendevano esplicitamente una differente organizzazione della società e un sistema produttivo che favoriva il lavoro – persero la guerra. L’organizzazione produttiva durante la guerra fu l’aspetto chiave che consentì il buon risultato economico. La storiografia sulla guerra civile ha sempre messo in rilievo la migliore organizzazione economica di Franco, in termini sia militari sia produttivi, sistematicamente fondati sulla disciplina. Tuttavia, altre sono le ragioni che spiegano la sconfitta repubblicana, come l’isolamento internazio-




nale del governo repubblicano e le dispute interne. Molte collettivizzazioni furono un insuccesso, ma non devono essere valutate indipendentemente dall’evoluzione delle armate repubblicane, e in generale dalla particolarità dei territori repubblicani. Come detto nell’introduzione, i territori che rimasero leali al governo repubblicano erano i più industrializzati del paese. Negli anni Trenta la Spagna aveva un mercato interno relativamente integrato con alcune aree specializzate nel settore industriale e altre fondate sulla produzione primaria. Mentre la produzione alimentare fu sempre alimentata dalla domanda durante la guerra, questo non fu il caso di molti prodotti industriali, specialmente i beni di consumo. Tuttavia, molte di queste industrie trasformarono le loro produzioni come risposta alla domanda della guerra. Inoltre, la carenza della domanda di molti prodotti tradizionali si affiancò ai problemi legati alla ricerca delle materie prime, a volte molto difficili da reperire a causa dell’isolamento internazionale del governo repubblicano. Nel caso di Alcoi, le migliori prove del successo organizzativo nel tessile sono due: I) i precedenti proprietari non solo recuperarono le loro proprietà senza registrare perdite, ma arrivarono ad avvantaggiarsi dei benefici dalla unificazione e collettivizzazione realizzate durante la guerra; II) il grado di integrazione della rete produttiva aumentò rispetto agli anni precedenti la guerra. Tuttavia, questo secondo risultato deve essere considerato non solo un’eredità dell’organizzazione di guerra, che realizzò il maggior grado di cooperazione e integrazione proprietaria di sempre, ma anche la conseguenza del tradizionale comportamento cooperativo all’interno del distretto industriale e – come vedremo – delle strategie di reazione imprenditoriale al nuovo contesto stabilito da Franco. Infatti, quando la guerra finì, nel 1939, l’AdI dell’industria e delle fabbriche tessili di Alcoi riprese il controllo della produzione e iniziò un progetto di separazione delle imprese associate. Ripreso il controllo delle fabbriche, i manager diedero la priorità al recupero dei conti bancari precedentemente confiscati; mentre l’AdI giocava un ruolo rilevante nella difesa degli interessi degli associati, in particolare quelli delle società tessili.



L’atto amministrativo del 7 dicembre 1939 restituì ai precedenti proprietari il denaro corrispondente ai loro precedenti conti bancari, imputandolo a ogni impresa, aumentato di ciò che il sindacato aveva raccolto nelle diverse banche. Problemi particolari sorsero dal conto aperto alla filiale della banca di Spagna a Barcellona, il cui titolare era la Delegazione commerciale dell’industria tessile e delle fabbriche del sindacato di Alcoi e che Antonio Matarredona Pascual, come presidente dell’AdI dell’industria e delle Quando la guerra finì, nel 1939, l’AdI dell’industria e delle fabbriche tessili di Alcoi riprese il controllo della produzione e iniziò un progetto di separazione delle imprese associate
fabbriche di Alcoi, reclamò nel luglio 1940. L’esistenza di questo deposito straordinario e il suo ammontare sono una precisa dimostrazione dei benefici conseguiti durante i due anni e mezzo di amministrazione sindacale. L’AdI fu chiara nel motivare la richiesta di questi fondi. Nella loro visione, non vi fu alcuna innovazione nell’amministrazione del sindacato e nessuna reale innovazione e quindi non c’era motivo che i vecchi e nuovi proprietari non avessero un diritto sui profitti realizzati (Ata 1941).
Il messaggio lanciato dalle forze vittoriose nel momento in cui ripresero il controllo fu chiaro, e molto meno rispettoso di quello che il sindacato aveva mandato ai datori di lavoro. Altrettanto rilevante è il mancato riconoscimento da parte degli imprenditori dell’innovazione apportata dalla nuova forma organizzativa realizzata dai sindacati.
Oltre agli sforzi nel recuperare i fondi bancari, l’AdI dovette adattarsi ai mutamenti economici introdotti dal regime di Franco. Il nuovo sistema legale ebbe effetto immediato su tutte le associazioni imprenditoriali, perché il sistema corporativo forzò la loro integrazione nella struttura dei sindacati di Franco. Ad Alcoi l’AdI adottò un rilevante mutamento non solo nella denominazione ma anche nella struttura, al fine di aggirare il


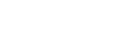
59

diretto controllo amministrativo di Franco: nel 1940 fu costituita la Textil Alcoyana s.a. (Terol 2000). Le relazioni sociali dei manager si estesero alla pubblica amministrazione e questo favorì l’intera rete, specialmente nei più alti livelli d’integrazione. Fu in questo modo che si ottennero le risoluzioni che favorirono il recupero delle attività finanziarie delle imprese collettivizzate. La nuova associazione fu costituita in forma di società per azioni, i cui soci erano gli stessi imprenditori, e con questa struttura fu possibile, nella seguente decade, adeguarsi meglio ai cambiamenti indotti dal nuovo regime politico. Infatti, questa forma societaria corrispose agli interessi degli imprenditori di avere una soluzione istituzionale che mantenesse un’integrazione nella cooperazione produttiva senza integrazione proprietaria delle imprese.
Il distretto industriale di Alcoi aveva una struttura imprenditoriale atomizzata, con grandi differenze fra le imprese – in dimensione, specializzazione, integrazione verticale ecc. – e con una forte caratterizzazione personale basata sulla continuità generazionale, essendo quasi tutte imprese familiari. Questa situazione ostacolava l’integrazione proprietaria valutata come molto costosa – ovviamente il sindacato non tenne conto di questo fatto – anche per la lunga e positiva esperienza dei datori di lavoro. Il grado di complessità ed efficienza che l’AdI aveva
Il distretto industriale di Alcoi aveva una struttura imprenditoriale atomizzata, con grandi differenze fra le imprese e con una forte caratterizzazione personale basata sulla continuità generazionale, essendo quasi tutte imprese familiari
raggiunto negli anni precedenti la guerra, durante gli anni Trenta, fu assunto come modello per superare la traumatica esperienza di recuperare i conti bancari e i fondi bloccati immediatamente d’autorità da parte di Franco. L’azione dell’AdI, quindi, fu cruciale nel condurre con successo le negoziazioni. Questa esperienza diede vigore alle organizzazioni impegnate nel difendere gli interessi cooperativi degli uomini d’affari.




Il fine principale della Textil Alcoyana fu inizialmente solo quello dell’organizzazione del settore, assumendo quelle funzioni nelle quali aveva maggiore esperienza, e quindi di offrire servizi ai soci, specialmente quelli inerenti alla legislazione sul lavoro e i rapporti con la pubblica amministrazione, come si legge nell’art. 2 del suo statuto. A proposito della sua struttura e del suo finanziamento, l’associazione seguì gli schemi esistenti prima della guerra. Da una parte, la società fu finanziata con i contributi dei soci e, poiché senza scopo di lucro, non aveva la responsabilità di distribuire dividendi. D’altra parte, essendo costituita come società a responsabilità limitata, essa sviluppò una complessa struttura organizzativa, che si adattò negli anni alla necessità delle imprese associate, ottenendo un elevato grado di coordinamento simile a quello degli anni di guerra. Nella prima riunione sociale del 1941 si crearono commissioni per l’acquisto delle materie prime per gli associati, in accordo con il sistema economico delle quote che caratterizzò le prime due decadi del periodo franchista. In termini generali, questo organo rappresentativo degli imprenditori rafforzò il meccanismo di fiducia reciproca fra i soci del tessile, specialmente considerando le difficoltà nel momento in cui la produzione doveva riprendere: restrizioni nelle forniture (lana, elettricità, oli ecc.), difficoltà nelle comunicazioni, disequilibrio nei flussi di cassa, mutamento radicale della struttura legale, ecc. Gli scopi principali della Textil Alcoyana durante il periodo autarchico, cioè fino alla metà degli anni Cinquanta, furono due: superare gli ostacoli incontrati nella produzione industriale e collaborare con la pubblica amministrazione in tema di lavoro e di interpretazione delle leggi. Cionondimeno, il fatto che gli imprenditori mantenessero le funzioni centralizzate – come il sindacato aveva fatto in precedenza – dimostra un certo riconoscimento del lavoro realizzato dal sindacato, sebbene questo riconoscimento non sia manifesto nei documenti dell’associazione, nonostante il recente sblocco del contenzioso. In questo contesto, possiamo portare solo una testimonianza favorevole, che si legge in un’intervista resa a un leader del sindacato: «quel-




lo che avete fatto è molto importante, se noi abbiamo continuato in quella linea» (Moltó 1986). D’altro canto, è comunque chiaro che il sindacato beneficiò del modello di produzione dei precedenti proprietari e della domanda di tessuti forzata dalla guerra, ma il successo realizzato non sarebbe stato possibile senza l’organizzazione e senza l’aumento degli impiegati amministrativi.
Conclusioni
In questo lavoro abbiamo tentato di comprendere sia lo sviluppo di un’economia senza un’organizzazione capitalistica sia il ruolo di una produzione in rete. Infatti, durante gli anni di collettivizzazione mutarono la proprietà delle imprese, le funzioni dei manager, le retribuzioni, le dimensioni delle imprese, unificate per creare una sola grande impresa.
Al fine di comprendere i modi con cui l’organizzazione economica anarchica risultò di successo nell’industria tessile di Alcoi durante la guerra civile, questo lavoro ha prestato attenzione a due aspetti: I) le particolari condizioni che si sono verificate nel distretto industriale, principalmente per l’eredità lasciata dall’AdI, le cui funzioni si erano già sviluppate collettivamente prima della guerra e prima del processo di collettivizzazione; II) l’effetto economico della guerra stessa.
La guerra fu importante da due punti di vista. Da un lato, perché la rivoluzione sociale che il sindacato anarchico e il sindacato socialista vollero realizzare in Spagna divenne in qualche modo un obiettivo secondario rispetto a quello di vincere la guerra. Questo significa che i sindacati dovevano essere ben organizzati per raggiungere l’obiettivo della vittoria.
Questo caso dimostra che i due obiettivi, produrre e vincere, non furono incompatibili. Il progetto organizzativo e l’amministrazione del processo di collettivizzazione sono un esempio di come la socializzazione delle proprietà e (almeno parzialmente) il processo di democratizzazione diretta delle decisioni non abbiano impedito razionalità ed efficienza. D’altro canto, il più im-



portante aspetto economico della guerra fu la domanda forzata di prodotti tessili, essenziale per conseguire il successo.
A proposito della collettivizzazione durante la guerra, questo lavoro dimostra le due principali caratteristiche dell’intervento sindacale, entrambe rivolte a una reale rivoluzione organizzativa della rete imprenditoriale: il flusso delle informazioni e il processo di burocratizzazione. Cioè ad Alcoi, i profitti realizzati durante la guerra non si realizzarono solo a causa dell’esistenza di un mercato forzato, ma anche grazie all’efficienza dell’organizzazione produttiva del sindacato. Questo non è un caso generale, perché non tutte le collettivizzazioni in Spagna diedero un profitto. Tutte le imprese collettivizzate come il resto delle imprese in area repubblicana dovettero far fronte agli stessi problemi di reperimento delle materie prime e dell’energia, ma le difficoltà che provenivano dalla disorganizzazione e dalla scarsità di capitale umano si verificarono solamente in determinate aziende. Ad Alcoi la scarsità di capitale umano non fu un problema né lo furono le difficoltà organizzative. Infatti qui molti manager rimasero nelle loro fabbriche, pur se collettivizzate, e si impegnarono nel dare consigli e nello svolgere funzioni tecniche. D’altro canto, vi fu un importante numero di lavoratori che possedevano un’ampia conoscenza industriale e tecnica grazie alla loro partecipazione ai comitati di fabbrica negli anni precedenti la guerra. Fu, infine, la collaborazione con gli impiegati delle banche nelle funzioni burocratiche e di contabilità che consentì di realizzare con successo la centralizzazione produttiva e di aumentare la struttura burocratica necessaria. Proprio l’aumento del numero dei lavoratori amministrativi dimostra il cambiamento dell’organizzazione. In più, bisogna ricordare che i lavoratori in quel periodo erano soldati nella produzione, quindi non solo i capifamiglia, ma tutti stavano facendo la rivoluzione, e pressoché tutti e tutte vollero collaborare alla ricerca di una vittoria repubblicana.
La struttura economica esemplare realizzata dal sindacato dimostra l’alto grado di conoscenza nell’amministrazione degli affari posseduta da chi sostenne il processo. Questo successo chia-



63

ramente influenzò la decisione degli imprenditori di mantenere e anzi allargare la struttura istituzionale ereditata dalla vecchia associazione industriale delle imprese e delle fabbriche tessili di Alcoi. Non è difficile, infatti, concepire lo sviluppo dei servizi e delle funzioni nella rete produttiva di Alcoi come il risultato di quell’esperienza di collettivizzazione, almeno in parte. Fu certamente un’esperienza di successo anomala per il contesto economico particolare e per un periodo così breve, tuttavia dimostra che non esiste un rapporto meccanico fra le forme di proprietà e le strutture amministrative. La proprietà collettiva in mano ai lavoratori può essere, in determinate situazioni, tanto efficiente quanto la proprietà privata o, come nel caso presentato, perfino più efficiente. In questo caso, la forte tradizione organizzativa e l’alta politicizzazione della classe dei lavoratori di Alcoi consente di capire sia i risultati della collettivizzazione che l’efficienza del progetto e l’efficacia del management. Probabilmente, non abbiamo descritto un’organizzazione anarchica in senso ideale stretto, ma è indubitabile che i lavoratori abbiano dimostrato la loro capacità di realizzare un’amministrazione economica efficiente e funzionale.



Bibliografia
Archive of the Textil Alcoyana, Alcoi.
- G. BECATTINI, Mercato e forze locali: Il distretto industriale, il Mulino, Bologna, 1987.
- G. BECATTINI, E. RULLANI, Sistemas productivos locales y mercado global. Información Comercial Española, in «ICE: Revista de Economía», n. 754, 1996, pp. 11-24.
- G. CANDELA, Economia, Stato, anarchia. Regole, proprietà e produzione fra dominio e libertà, elèuthera, Milano, 2014.
- G. CANDELA, Verso un’economia comunitaria, elèuthera, Milano, 2021.
- G. CANDELA, A. SENTA, La pratica dell’autogestione, elèuthera, Milano, 2017.
- M.C. CASSON, Entrepreneurial Networks in International Business, «Business and Economic History», n. 26, 1997, pp. 811-823.
- J. CATALÁN, Guerra e industria en las dos Españas, 1936-1939, in P. MARTÍN-ACEÑA, E. MARTÍNEZ RUIZ (a cura di), La Economía de la Guerra Civil, Marcial Pons, Madrid, 2006, pp. 161-227.
- F. CODELLO, 2017, La condizione umana nel pensiero libertario, elèuthera, Milano, 2017.
- L. GÁLVEZ, 2006, Produciendo para la revolución y produciendo para la reacción. Trabajo y Guerra Civil, 1936-9, in P. Martín-Aceña e E. Martínez Ruiz (a cura di), La Economía de la Guerra Civil, cit., pp. 461-489.
- E. JOURDAN, I beni comuni nel pensiero libertario, in «Semi sotto la neve», n. 2 (2022).
- G. LEVAL, «Né Franco, né Stalin». Le collettività anarchiche spagnole nella lotta contro Franco e la reazione staliniana, Istituto editoriale italiano, Milano, 1952.
- S. MOLTÓ, Una nueva economía. Socialización y colectividades alcoyanas, Papallona, Alcoi, 1986.
- R. PIQUÈ, L’aspecte econòmic-comptable de la collectivització, Editorial Bosch, Barcelona, 1937.
- F. QUILIS, Revolución y Guerra Civil. Las colectividades obreras en la provincia de Alicante, 1936-1939, Diputació d’Alacant, Alacant, 1992.
- R. TEROL, La Textil Alcoyana S.A. Historia de una etapa de la Industria Textil de Alcoy (1940-1988), Agrupación Empresarial Textil Alcoyana, Alcoi, 2000.
- S. WHITE ET AL., L’anarchismo pragmatico di Colin Ward, Centro studi libertari, Milano, 2023.




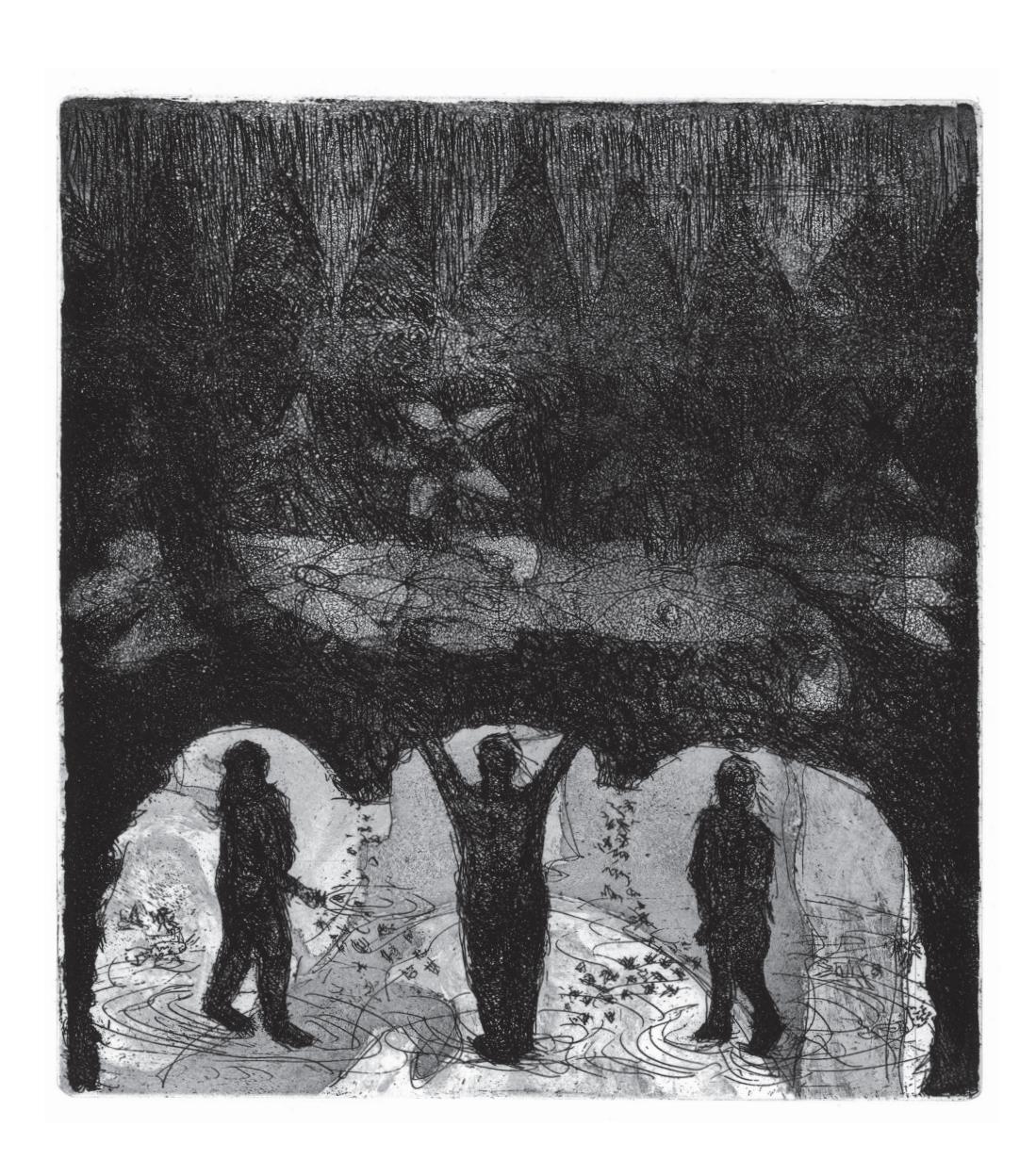





Scuola di montagna
Paolo Cognetti
Vado spesso nelle scuole a parlare dei libri che scrivo, invitato dagli insegnanti. Incontrando i ragazzi e le ragazze, e ascoltando i loro interventi, non ne ho affatto l’impressione di un pubblico annoiato: anzi sono tra i lettori più acuti, e quelli che mi fanno le domande più difficili. A differenza di tanti adulti, cercano ancora nei libri delle chiavi di comprensione del mondo. Hanno antenne sensibili al loro tempo, e in questi anni sono sempre più allarmati dalla crisi ambientale. Io nei libri racconto storie della montagna contemporanea, con uomini, donne, animali, alberi, torrenti e ghiacciai, con le cose che stanno succedendo in montagna ora, e loro ci trovano notizie da quella crisi. I cambiamenti non sono solo verso il peggio, questo ci tengo a raccontarglielo. È vero che i ghiacciai scompaiono, la neve è scarsa e l’acqua sempre più rara e preziosa, ma intanto sono avanzati i boschi, per esempio. È tornato il lupo e la fauna selvatica sta meglio di un tempo, almeno in Italia. Con il lupo è arrivato anche un altro genere di abitante: persone che, con pochi anni più di loro, scelgono la montagna come luogo in cui vivere, dopo che tanti di quelli che ci erano nati sono andati via. Racconto che per alcuni di noi quello è un luogo di libertà, dove c’è più spazio, conta un po’ meno il denaro, e possiamo vivere nel modo che ci piace – così in questi incontri riesco a infilare anche un po’ di anarchia! Le ore volano e ogni tanto alla fine dico: perché la prossima volta non venite a trovarmi voi? Lo dico anche agli insegnanti quando mi invitano. Invece che portare me in un’aula, a parlare di alberi e torrenti, perché non portate i ragazzi nel bosco, e ne parliamo lì?
Le poche volte in cui poi è successo, li ho trovati del tutto spaesati. Gli studenti delle grandi città in particolare: alcuni non hanno mai camminato su un sentiero in vita loro. Pochi sono in grado




di distinguere gli ecosistemi, i segni delle stagioni e del lavoro umano, e di nominare gli alberi e gli animali. Il paesaggio che hanno intorno è una lingua straniera. Immagine cara a Mario Rigoni Stern: il paesaggio, diceva il grande scrittore-montanaro, è una forma di scrittura. Quella della città la impariamo fin da piccoli, tutti sappiamo che cos’è un semaforo, un marciapiede, un autobus, un grattacielo, una chiesa: è diventata la nostra lingua madre. Ma quella del bosco non la sappiamo più leggere né parlare. Quale segno più evidente della crisi ambientale, che è una spaccatura tra l’uomo e la terra? Come potremmo prendercene cura, o vivere in armonia con lei, se non la conosciamo più?
Propongo di fare scuola in montagna. In fondo in inverno la facciamo già: con i maestri che sulle piste insegnano ai ragazzi a sciare. Ma perché non continuare anche nelle altre stagioni, e insegnare le tante cose che in montagna si possono imparare?
Dall’altra parte, mi interrogo e mi interrogano spesso sul futuro economico delle nostre montagne. Agli ambientalisti viene sempre rimproverato di battersi contro i vari progetti, senza averne uno da proporre a chi in montagna ci vuole vivere e lavorare, non per forza tornando a pascolare le capre. Capisco la critica perché il tema riguarda tanti miei amici. L’economia, su da noi, oggi è fondata sul turismo, tolta quella poca agricoltura che resiste (ma anche il vino, il formaggio, le patate, in fin dei conti è ai turisti che vengono venduti). E il turismo è una di quelle economie che



sembrano non conoscere un punto di equilibrio: per stare bene deve crescere, a quanto pare, e produrre sempre più clienti, e così più cantieri, più alberghi, più ristoranti e centri benessere, più funivie e piste da sci. Da qui, le lotte di noi ambientalisti. E tu che non vuoi la funivia e la pista, mi chiedono i miei vicini, che cosa proponi di fare?
Propongo di fare scuola in montagna. In fondo in inverno la facciamo già: con i maestri che sulle piste insegnano ai ragazzi a sciare. Ma perché non continuare anche nelle altre stagioni, e insegnare le tante cose che in montagna si possono imparare? Per esempio, da dove viene l’acqua e come la usiamo. Com’è fatto il ghiaccio, la neve, che cos’è una sorgente, come funziona un acquedotto, un canale d’irrigazione, una centrale idroelettrica (questa è la Storia di un ruscello di Elisée Reclus: ci infilo sempre un po’ di anarchia). Oppure la vita del bosco: come convivono tra loro gli alberi, quali diversi caratteri hanno, come l’uomo ha imparato a coltivarli e usarli, come il bosco può rappresentare un modello di comunità armoniosa e cooperativa (e questo è lo splendido lavoro di Stefano Mancuso, altro anarchico prestato alla botanica). E ancora, l’allevamento del bestiame, che a conoscerlo ci renderebbe un po’ più consapevoli quando decidiamo cosa mangiare o non mangiare, gli infiniti usi delle piante selvatiche, il comportamento degli animali. O semplicemente: guarda com’è fatta una nuvola, tocca la corteccia del larice, senti cosa si prova a immergere i piedi in un torrente. Non credete che ogni scuola di città dovrebbe portare i ragazzi a imparare queste cose? Penso che loro ne sarebbero felici.





L’era del dominio del turismo Come conviverci
Marco Antonioli
Quella che abbiamo vissuto dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi può sicuramente essere definita l’era del dominio del turismo. C’è stata una breve interruzione di crescita negli anni pandemici, ma il trend è destinato a tornare a crescere. I dati ufficiali dell’Organizzazione Mondiale del Turismo ci dicono che a livello globale nel 2022 si sono mosse 917 milioni di persone, nel 2019 erano 1,4 miliardi, mentre nel 1950 erano solo 10 milioni di persone circa.
Un turismo che è cambiato con grande frequenza. Nonostante le numerose crisi che si sono succedute dal 2008 in poi, un unico fattore non è mutato: la voglia di viaggiare delle persone è aumentata costantemente. Parafrasando Graeber (Graeber 2022) la prima forma di libertà primordiale era la libertà di andarsene, che è anche la libertà di viaggiare.
Per analizzare in maniera adeguata quanto sta avvenendo nel turismo attuale è necessario fare un minimo di storia di questo settore.
Il turismo di massa che ha caratterizzato tutta questa epoca vede la luce nel 1841, quando Thomas Cook fonda il primo tour operator per vendere pacchetti di viaggio alla borghesia inglese.
Il momento però che segna una vera cesura nel modo di viaggiare precedente e lo avvicina sempre di più a quello contemporaneo è il 1936, quando in Francia, per la prima volta a livello mondiale, viene istituito un periodo di ferie pagate per tutte le lavoratrici e i lavoratori. In Italia questo passaggio è sancito dalla Costituzione del 1948 dove troviamo scritto, all’articolo 36, che «il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi».




Come è facile comprendere la nascita del primo tour operator, cioè di qualcuno che per lavoro organizza il viaggio per il cliente, e le ferie pagate che iniziano a consentire ai lavoratori di spendere e di spostarsi per piacere hanno accelerato la diffusione del turismo di massa, diventata poi esponenziale durante il boom economico quando molte persone, in Italia e
Due grandi eventi hanno rivoluzionato completamente il modo di viaggiare e portato il mondo ai dati del 2019: l’avvento delle compagnie aeree low cost e la digitalizzazione di massa
non solo, hanno iniziato a poter acquistare l’automobile e ad aver maggiori risorse per muoversi. Così sono nate le prime destinazioni turistiche nel più classico scambio domanda-offerta tipico del libero mercato, come sulla costa romagnola dove numerose famiglie hanno capito l’opportunità di business che si stava venendo a generare e hanno iniziato ad affittare le stanze libere e ad aumentare le dimensioni delle proprie abitazioni trasformandole in pensioni e successivamente in alberghi.
Per alcuni decenni il turismo è continuato a crescere in maniera graduale, ma costante, fino ad arrivare ai primi anni ‘90 quando altri due grandi eventi hanno rivoluzionato completamente il modo di viaggiare e portato il mondo ai dati del 2019: l’avvento delle compagnie aeree low cost e la digitalizzazione di massa.
Ryanair, la compagnia low cost per eccellenza che ha abbattuto fortemente i costi dei viaggi aerei a scapito del servizio, è nata nel 1985 e ha iniziato a crescere intorno agli anni 2000.
Con l’avvento di Ryanair, Easyjet, Wizzair e altre i viaggi aerei sono diventati alla portata di chiunque e questo, sommato alle modificazioni sostanziali avvenute nel mondo del lavoro, ha causato un cambiamento anche nel modo di viaggiare delle persone: se prima si facevano oltre venti giorni di vacanze in località vicino a casa e non ci si spostava dal proprio albergo, adesso si prediligono vacanze brevi di 2-3 giorni nel corso dell’anno in destinazioni facilmente raggiungibili in un paio d’ore di aereo.




Infine la digitalizzazione ha portato alla nascita di piattaforme che hanno agevolato la prenotazione di strutture ricettive e addirittura la condivisione della propria casa come struttura di vacanza per altri.
Ultimo evento in ordine di tempo che ha modificato le abitudini di consumo del viaggio è stata la pandemia da Covid-19. In un momento in cui si era costretti a restare a casa, un settore che vive solo grazie al concetto di spostamento ha sofferto in maniera considerevole ed è stato costretto a ripensarsi.
Pandemia e digitalizzazione ci portano a una riflessione imprescindibile sul livello di sostenibilità ecologica, economica e sociale del turismo. A livello ecologico il turismo di massa risulta essere uno dei settori più inquinanti al mondo, non solo a causa di mezzi di trasporto da cui non si può prescindere per «fare turismo», ma anche a causa di comportamenti che le persone in media tengono all’interno delle strutture ricettive: minor attenzione rispetto all’utilizzo dell’acqua e dell’energia elettrica all’interno delle stanze, asciugamani cambiati ogni giorno e così via.
A livello economico sicuramente il turismo è stato per molti anni un settore che ha consentito a numerose persone di avere un reddito. Negli ultimi anni l’avvento delle grandi piattaforme digitali ha causato un depauperamento delle persone a fronte di un incremento della ricchezza delle grandi catene internazionali. Basti pensare che per ogni camera affittata su Booking. com oltre il 18% della transazione non va nelle casse della struttura, ma finisce per finanziare il portale.
A livello sociale invece, se da un lato un turismo fruito in maniera rispettosa dei luoghi e delle persone ha consentito e consentirà scambi socio-culturali altrimenti impossibili, dall’altro alcune realtà, soprattutto le grandi città, sono diventate musei a cielo aperto a uso e consumo dei turisti che hanno estromesso cittadini residenti e studenti fuori sede. Tre esempi italiani della gentrificazione generata dal turismo sono Venezia, Firenze e Bologna.




Venezia e Firenze sono due casi molto simili: grandi città d’arte da vedere almeno una volta nella vita (così scrivono le guide turistiche internazionali) che hanno estromesso dalla città i propri residenti storici per fare spazio ai turisti. Firenze nel 2019 contava oltre 15.000 appartamenti in affitto su Airbnb e di questi il 10% sono gestiti da grandi fondi del settore immobiliare.
Bologna è invece un caso più complesso da analizzare. L’impennata del turismo in città è avvenuta nel momento in cui l’aeroporto ha iniziato ad accogliere le compagnie low cost. Questo evento ha riversato nel centro storico numeri di turisti mai visti in precedenza. I proprietari immobiliari hanno fiutato l’affare e, invece che continuare ad affittare i propri alloggi a studenti fuori sede, hanno preferito offrire le proprie case ai turisti. Con due effetti immediati: la lievitazione dei costi degli affitti delle case e l’estromissione di studentesse, studenti e cittadini residenti dal centro storico.
A proposito di impatto sociale del turismo bisognerebbe iniziare a fare una riflessione anche su quanto i marchi internazionali, tipo UNESCO, siano da una parte fattore di reputazione per una destinazione, ma portino con sé anche una serie di problematiche non indifferenti: «il tocco dell’UNESCO è letale: dove appone il suo label, la città muore sottoposta a tassidermia» (D’Eramo 2017). Un esempio lampante di questo tocco letale è la città croata di Spalato, dove la città romana è fisicamente marchiata con il simbolo UNESCO e questo crea un dentro-fuori fra centro e periferia che si riflette anche nel modo di fruizione della città.
Dopo aver fatto un’analisi storica del turismo e aver descritto brevemente quanto stiamo vivendo ai giorni nostri la conclusione sembra essere una sola: il turismo è l’emblema di un capitalismo in cui per soddisfare i bisogni di divertimento del maggior numero di persone che se lo possono permettere si passa completamente sopra al rispetto dei luoghi e di chi quei luoghi li vive, del loro essere e delle loro storie.



73

Se vogliamo avere minor impatto sul nostro pianeta dobbiamo imparare a viaggiare in modo nuovo
Ma quindi dobbiamo smettere di viaggiare? Come scritto in premessa credo che il viaggiare, il bisogno di spostarsi per scoprire, sia alla base della natura umana fin da quando vivevamo in comunità di cacciatori-raccoglitori. Solo che allora ci si spostava per sopravvivenza, ora per divertimento. Il bisogno di viaggiare, di spostarsi e di scoprire è
caratteristica imprescindibile della maggior parte delle società contemporanee. Ma se vogliamo avere minor impatto sul nostro pianeta dobbiamo imparare a viaggiare in modo nuovo, dobbiamo imparare a prenderci i nostri tempi mentre siamo in viaggio, non consumare le città e i luoghi in cui andiamo come qualsiasi altro prodotto del capitalismo, ma viverle fino in fondo. Dobbiamo imparare ad andare alla radice dei nostri luoghi di vacanza. Dobbiamo capire «come sia possibile socializzare un territorio astenendoci dal rimodellarlo materialmente da cima a fondo e limitandoci a inscrivevi simboli che non imprimano il loro marchio imperituro su quello spazio». (Christin 2019).
Cerchiamo di sfatare un mito: il turismo sostenibile è un ossimoro. Se pensiamo a cosa vuol dire «fare turismo» capiamo quanto sia in realtà un’attività insostenibile per l’impatto economico, sociale e ambientale che può avere. Per «fare turismo» dobbiamo spostarci da casa, nella maggior parte dei casi con mezzi profondamente inquinanti, e trasferiamo il nostro impatto antropico dalla realtà da cui proveniamo a una realtà altra in cui siamo un corpo estraneo – ma impattante – per un periodo di tempo più o meno breve. Le destinazioni che vivono di turismo stagionale si ritrovano – soprattutto nei mesi estivi – con un incremento della popolazione di 5 volte rispetto a quella che vive in maniera stanziale nei restanti periodi dell’anno. Questo incremento dei numeri ha un impatto su tutti quei fattori collaterali che servono per far star bene chi vive un territorio: qualità dell’aria, capacità di portata delle fognature, consumo di risorse idriche, gestione dei rifiuti, ecc.




In questa analisi non possiamo nemmeno negare alcuni impatti positivi che il turismo – e soprattutto un turismo gestito correttamente – porta ai territori. Basti pensare al fatto che in Italia, prima della pandemia, il PIL turistico del Paese era di circa il 13%, un’industria numericamente ben più importante della moda e della produzione di automobili. Prodotto Interno Lordo che altrimenti andrebbe recuperato da altri settori produttivi.
Il turismo poi è un’economia di persone in cui l’essere umano e le relazioni umane svolgono una funzione fondamentale. Per quanto ogni settore sia a rischio automatizzazione, credo che il turismo subirà sicuramente delle conseguenze, ma non tali da sostituire il contributo umano.
Infine è forse l’unica economia addittiva. Se un turista arriva in una struttura ricettiva o in un comune, è quasi certo che questo turista porterà benefici anche alle altre strutture limitrofe e agli altri comuni del circondario.
Proviamo a fare una sintesi estrema di quanto detto finora: il turismo è un sistema figlio del capitalismo in cui stiamo vivendo che riesce a generare alcuni indubbi benefici a livello territoriale, a differenza di altri settori produttivi, ma non può essere definita un’attività realmente sostenibile perché genera questi benefici in maniera assolutamente ineguale sfruttando e distruggendo l’ambiente naturale e l’ambiente sociale di tutte le destinazioni turistiche. Come possiamo allora continuare a viaggiare senza sentirci in colpa, ma anzi contribuendo a generare quegli effetti positivi che il turismo può portare?
Se «turismo sostenibile» è un ossimoro, un concetto diverso e molto più diretto al rispetto dei territori e delle persone che li abitano è il cosiddetto turismo lento. Nato nel 2009 trova le sue linee guida nel Slow Travel Manifesto, che invita a mettere in campo alcune accortezze nel momento in cui si viaggia per avere un impatto il meno possibile negativo: fai di tutto per vivere come un locale, acquista solo prodotti locali, valorizza la cultura del posto e non cercare di cambiarla, ricordati sempre che sei tu l’ospite, quindi rispetta le comunità autoctone.


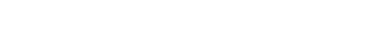

Se così facciamo possiamo contribuire a generare quegli effetti positivi che il turismo può innescare.
Ci sono esempi pratici di attività che possiamo compiere per andare in questa direzione? Nel numero precedente in un articolo di Valeria Giacomoni vi abbiamo presentato l’esperienza degli ecomusei del Trentino – musei calati perfettamente nelle realtà anche ambientali locali e che consentono ai visitatori di apprendere informazioni sul territorio senza avere un impatto sullo stesso.
Altri esempi sono tutte quelle esperienze fattibili a piedi o in bicicletta anche nelle grandi destinazioni balneari che consentono di esplorare l’interno con guide locali esperte del territorio e di vivere un’esperienza assolutamente reale in luoghi altrimenti inaccessibili.
Ultima questione fondamentale: per fare turismo in maniera rispettosa bisogna avere la capacità di mettersi in gioco fino in fondo. Ovunque andiamo se ci comportiamo da turisti o da residenti temporanei cambia completamente come viviamo la vacanza e l’impatto positivo o negativo che possiamo avere sul territorio che ci ospita. Se viviamo un luogo come residenti temporanei ne abbiamo cura, se invece facciamo solo i turisti siamo dei consumatori. E le destinazioni sono il nostro supermercato.
Bibliografia
R. CHRISTIN, Turismo di massa e usura del mondo, elèuthera, Milano, 2019.
M. D’ERAMO, Il selfie del mondo – Indagine sull’età del turismo, Feltrinelli, Milano, 2017.
D. GRAEBER, Dialoghi sull’anarchia, elèuthera, Milano, 2022.









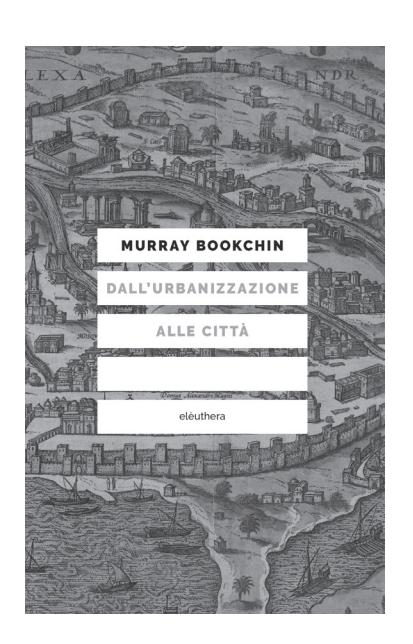
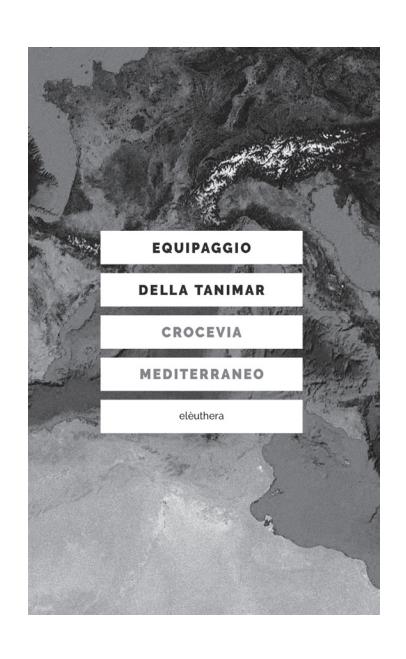

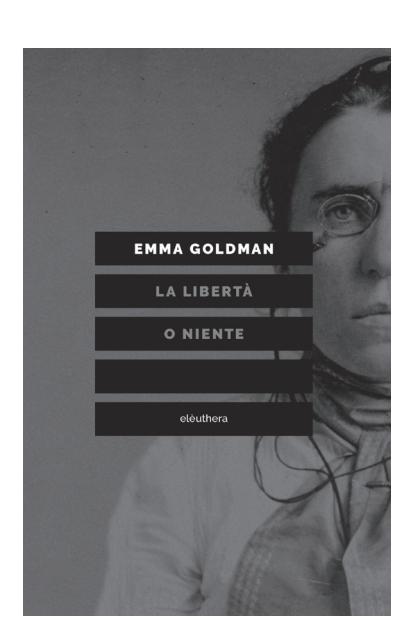
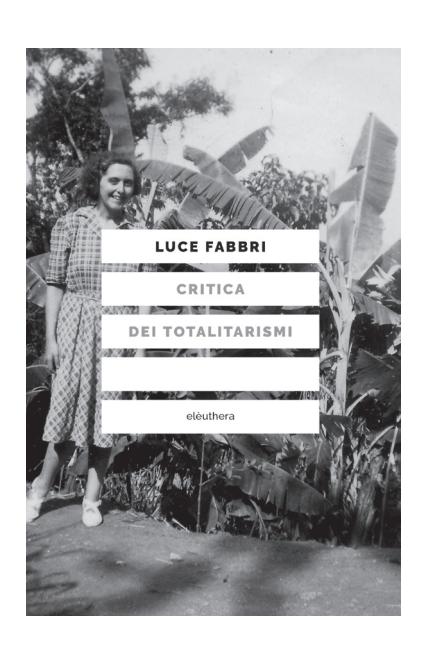



Conversazione con elèuthera
A cura della redazione
Siamo a Milano, in via Jean Jaurès, nella sede di elèuthera. Incontriamo la redazione della casa editrice al completo: Rossella, Abi, Sara Giulia, Franz, Simone, Francesco.
Elèuthera – “libera” in greco – è anche il nome che alcuni eretici inglesi, in fuga dalle persecuzioni religiose, diedero a un’isola delle Bahamas dove approdarono intorno alla metà del Seicento. Lì gli Eleutheran Adventurers fondarono una comunità di «liberi ed eguali» che diede vita alla prima, seppur effimera, Repubblica del nuovo mondo. In sintonia con quei precursori alla cui storia si sono ispirati – come testimonia il loro logo – anche gli elèutheriani di Milano, nel 1986, hanno iniziato la loro avventura editoriale in rotta verso un mondo migliore… Fortunatamente (e fortunosamente) questa avventura si è dimostrata meno effimera, e alcuni decenni dopo sono ancora qui, programmaticamente piccoli e ostinatamente libertari.
I titoli mediamente pubblicati ogni anno sono circa 25 (tra novità e nuove edizioni) e sono tutti molto curati, sia editorialmente sia graficamente, in quest’ultimo caso grazie al prezioso lavoro di Ferro Piludu prima e di Riccardo Falcinelli poi. Numerose e continue le ristampe dei testi in catalogo, a conferma della validità nel tempo dei testi selezionati. L’età media della redazione è di circa 50 anni, ma il dato non rispecchia bene la situazione, perché l’attuale collettivo redazionale è composto da 3 anziani (intorno ai 70) e 3 giovani (tra i 30 e i 40).




La storia di elèuthera – che inizia alla metà degli anni Ottanta – è anche la storia di un gruppo libertario che passa da una militanza politica a una dimensione più culturale (tra virgolette). Che cosa ha determinato questo passaggio e quindi l’inizio delle attività della casa editrice?
Intanto va precisato che il gruppo era dichiaratamente anarchico e con una pratica di militanza quotidiana molto comune all’epoca (anni Sessanta e Settanta). Il progetto editoriale che prende le mosse nel 1986 per iniziativa di due membri di quel gruppo (per inciso, Bandiera Nera) nasce invece su altre basi: ad aprire i battenti è una casa editrice – se vogliamo usare questo termine un po’ pomposo – libertaria e non strettamente anarchica, a prescindere dalle granitiche convinzioni dei suoi fondatori. Non è una questione puramente terminologica, o di semplice cosmesi per apparire meno terrificanti agli occhi di un pubblico generico… Tutt’altro, è la consapevole scelta di aprirsi – da anarchici – a quanti, pur non condividendo una specifica ideologia, esprimono valori, metodi e visioni profondamente libertari che li rendono ottimi compagni di strada. E di strada da fare ce n’era e ce n’è tanta.
A determinare questo passaggio dall’attività prevalentemente militante all’attività prevalentemente culturale (perché ovviamente i due elementi rimangono strettamente intrecciati) sono state le mutate circostanze storiche e culturali. Dopo un ventennio socialmente e politicamente molto attivo (e pienamente novecentesco, visto con il senno di poi), ci si era infatti ritrovati, volenti o nolenti, in un’epoca in cui le modalità dell’agire sociale e politico sin lì prevalenti e lo stesso immaginario su cui poggiavano avevano perso di significato. Erano diventate pura retorica. Liturgie consolatorie ma inefficaci. Bisognava quindi trovare altre modalità operative a partire da nuove riflessioni improntate all’oggi. Detto altrimenti, il Novecento era finito e il futuro (più nebuloso che radioso) era tutto da inventare.




Ci siamo allora concentrati sul presente, ed elèuthera nasce qui – in questo territorio incerto che si crea nella transizione da un’epoca all’altra – per rispondere a un’esigenza che non si placa nei vari corsi e ricorsi storici, ovvero l’esigenza di esplorare un territorio poco conosciuto per tracciare le nuove strade che portano al mutamento sociale. Perché di questo si tratta: non sarà più la rivoluzione otto-novecentesca, ma l’urgenza di cambiare il mondo resta intatta.
L’idea è dunque quella di mettere insieme i tanti stimoli che vanno emergendo sia nel milieu anarchico, che non coincide più con il movimento anarchico così come si è storicamente configurato, sia in quella vasta galassia libertaria, estremamente fluida e multiforme, che tuttavia è una fucina di riflessioni e sperimentazioni contemporanee. Ed è così che nel catalogo di elèuthera entrano a pieno titolo anche temi e autori non strettamente anarchici, riconducibili a quella poliedrica cultura libertaria internazionale che – pur con tutte le sue contraddizioni – produce un pensiero antiautoritario quanto mai attuale e fecondo.
Ma perché proprio i libri?
La carta stampata ha tradizionalmente avuto un ruolo rilevante nel movimento anarchico nazionale e internazionale. Che si trattasse di periodici o di libri e opuscoli, la propaganda – come si diceva un tempo – aveva trovato nella carta stampata un mezzo privilegiato di diffusione. E questo oltretutto in tempi con alti tassi di analfabetismo. Chiaramente oggi le cose sono cambiate, ma ancora negli anni Settanta libri e giornali erano molto diffusi nel movimento anarchico. Dunque la strada verso l’editoria appariva larga e accogliente, e noi l’abbiamo imboccata volentieri. E qui per noi intendo anche le iniziative sorelle: «A rivista anarchica», «Volontà», «Interrogations», «Libertaria» e ovviamente le edizioni Antistato che hanno preceduto l’esperienza di elèuthera. Diciamo pure che il gruppo originale prima evocato, da cui tutte queste iniziative discendono,



con la carta stampata ci è andato a nozze. Prima in maniera piuttosto amatoriale, poi con sempre maggiore competenza. E passione.
Ci siamo dunque maggiormente concentrati su un’attività che prima è stata giustamente definita culturale tra virgolette. Qui va fatta una precisazione, perché il termine cultura ha vari significati e si presta a fraintendimenti. Nel nostro lavoro di ricerca non ci rifacciamo né alla cosiddetta cultura «alta» (quella astratta e disciplinare degli specialisti) né alla cultura «bassa» (il pop più becero spacciato per genuina cultura popolare). Il senso del nostro lavoro – da sempre improntato a un binomio che riteniamo inscindibile: pensiero/azione – rimanda piuttosto alla definizione antropologica del termine autodeterminazione e quindi autoproduzione della società, ovvero la creazione collettiva dei codici simbolici che informano la vita quotidiana di ogni cultura (il linguaggio, la gestualità, i legami sociali e parentali, i modi di nutrirsi, le espressioni artistiche…). In altri termini ci interessa il fare che diventa pensiero e il pensiero che diventa azione. E ci interessano i modi in cui una società si autoistituisce. Dunque non privilegiamo solo la critica della società del dominio (che comunque rimane un punto focale, perché è qui che ci tocca vivere), ma anche la costruzione del nuovo.
Qui va introdotto il concetto di prefigurazione. Il termine è recente e di provenienza anglo-americana, ma la pratica che ci sta sotto è ben più vecchia e ampiamente diffusa nel milieu anarchico. Per esempio, in Italia nella seconda parte del Novecento il dibattito sul «vivere l’anarchia nel qui e ora» era ben presente. E le discussioni internazionali, anche aspre, sul lifestyle anarchism erano diffusissime. Comunque sia, l’argomento qui è rilevante perché elèuthera non è soltanto un’iniziativa editoriale con una ragione sociale, una partita iva, un fatturato annuo ecc. Tutto questo c’è, ma è francamente secondario, perché elèuthera – lungi dall’essere una «azienda» (per l’esattezza una cooperativa) – è un luogo di vita e lavoro in cui sperimen-




tare concretamente la pratica anarchica. E questo non ha niente a che vedere con il fatto di pubblicare testi anarchici: ha a che vedere con le modalità (sperimentali e fallibili) con cui si prova a gestire in modo cooperativo e orizzontale un’attività che non è solo culturale ma anche economica. E questo non in una società «ideale», ma in una società reale, plasmata dal capitalismo e dallo statalismo. Una bella sfida, ma è quello che dà un senso forte al progetto.
Cambiamo canone: la nostra seconda domanda si concentra su un argomento diverso, anche se strettamente legato al discorso complessivo. Dall’inizio della vostra avventura, oltre 35 anni fa, siete distribuiti in libreria, state quindi sul mercato. Con quale risultato concreto, se è lecito trarre un bilancio di questi anni di attività? Abbiamo presente quali sono le difficoltà, i tranelli, l’incongruenza di stare dentro il sistema distributivo. Per questo ci interessa capire quali sono le difficoltà che un’esperienza libertaria concreta come elèuthera, strutturalmente antisistema, deve affrontare nella sua pratica quotidiana all’interno del sistema che rifiuta. E questo è qualcosa che sperimentano tutte le esperienze concrete attuate nel qui e ora, a cui noi come rivista intendiamo dare spazio.
La scelta di «stare sul mercato» ha segnato un importante cambio di passo tra il nuovo progetto editoriale e quello precedente: le edizioni Antistato, gestite tra il 1975 e il 1985 dalle stesse persone che hanno poi fondato elèuthera. È stata una scelta non facile perché l’idea di realizzare una «controsocietà» che stesse fuori o ai margini del circuito economico dominante per sperimentare alternative sostenibili è sempre stata un’esigenza molto forte. L’Antistato era tutto dentro questa visione, e infatti nasceva negli anni della «contestazione globale», anni in cui la protesta sociale era enormemente più vivace e creativa di oggi. Si sperimentavano costantemente forme diverse di vivere e lavorare. Certo, molte di queste sono finite nel nulla, ma di sicuro c’è sta-




to uno sforzo collettivo per trovare alternative immediatamente praticabili. E poi è arrivato il «grande riflusso» degli anni Ottanta. Tanti gruppi si sono sciolti, tante sedi hanno chiuso, e quella voglia di leggere e discutere che aveva costituito la linfa vitale del circuito militante e che ci aveva permesso di rimanere fuori dal mercato (o quasi) svanisce… A quel punto la «scelta» diventa quasi obbligata, e infatti il nuovo progetto editoriale decide giocoforza di entrare nel circuito librario.
È stata quindi una decisione pragmatica, non di principio. E lungamente meditata, perché accedere al circuito librario comporta costi notevolmente più alti e un impegno lavorativo commisurato (o sarebbe meglio dire smisurato…). Ma la scelta è stata fatta anche in vista di un’altra esigenza fortemente sentita: raggiungere un pubblico più ampio che non si limitasse ai «già convinti» ma aprisse un dialogo con i tanti che, pur restando al di fuori di ogni ideologia, rifiutano il mondo così com’è e cercano soluzioni intrinsecamente libertarie. Anche per intercettare questa vasta area libertaria e post-ideologica, non raggiungibile attraverso il circuito militante, abbiamo deciso di esporci maggiormente, di renderci più visibili e dunque di «entrare nel mercato». Però l’abbiamo fatto alle nostre condizioni, cioè rimanendo sempre con un piede dentro e un piede fuori. Una posizione scomoda, che tuttavia ci ha lasciato sempre vigili. Siamo così riusciti a trovare un nostro (precario) equilibrio. Detto altrimenti, il mercato non ci ha fagocitato, anche se noi siamo dovuti venire a patti con certe regole e certe procedure. Quel che è certo è che siamo riusciti a intercettare la galassia libertaria citata prima che di fatto costituisce lo zoccolo duro dei nostri lettori.
Fare questa scelta ha cambiato il vostro modo di lavorare?
Non lo ha tanto modificato quanto complicato. Infatti abbiamo dovuto «piegare» le esigenze esterne (per lo più amministrativo-burocratiche) al nostro modo di lavorare, che da quando esiste un collettivo redazionale – ovvero più o meno dall’inizio



degli anni Duemila (prima era un collettivo di due…) – è rimasto cooperativo e orizzontale. Questo comporta che in linea di principio non ci sono mansioni esclusive ma tutti fanno tutto. In linea pratica, però, la realtà ci ha imposto alcuni adattamenti in quanto le mansioni più tecniche richiedono competenze specialistiche. Dunque, per non creare una struttura a compartimenti stagni, abbiamo accettato che alcune competenze specialistiche siano espletate singolarmente, ma i criteri con cui ogni settore è gestito vengono comunque discussi e decisi a monte da tutti. Superfluo dire che la scelta del programma editoriale, dei temi e degli autori, è evidentemente opera dell’intero collettivo redazionale.
Quindi sì, essere sul mercato impone alcuni adeguamenti, ma l’essenziale del nostro lavoro cooperativo non ne viene intaccato. Anche perché poggia su due pilastri: la continua ed esplicita tensione fra efficacia ed efficienza e la modalità artigianale di produzione che è stata adottata. Molto in sintesi, per scelta e per necessità dobbiamo avere un livello di efficienza piuttosto alto per mantenere costanti i ritmi di pubblicazione e la qualità editoriale. Il timore è che questo efficientismo possa «schiacciare» l’efficacia del lavoro collettivo, che invece richiede condivisione e tempi dilatati. Da qui quella tensione che è parte integrante del nostro lavoro quotidiano: di nuovo, una posizione scomoda che però ci mantiene vigili. Quanto alla modalità artigianale, di proudhoniana memoria, è la dimensione lavorativa che ci appare più congeniale in quanto coniuga lavoro manuale e lavoro intellettuale. Perché, contrariamente a quanto si pensa, il libro non è affatto un prodotto puramente intellettuale, ma è il risultato di molteplici capacità manuali (e persino artistiche): un manufatto che dà all’artigiano che lo ha prodotto una soddisfazione assolutamente tangibile.
Quali sono i criteri con cui selezionate i titoli da pubblicare?
A parte il criterio-base, ovvero proporre in un contesto coerente




le espressioni più innovative e originali della riflessione anarchica e libertaria, siamo molto pragmatici nel selezionare temi e autori. D’altronde, le ragioni per pubblicare un libro sono svariate: l’attualità di un testo, che magari risponde a una diffusa richiesta di approfondimento, per esempio, ma anche l’inattualità di un testo, che al contrario affronta temi non ancora dibattuti, anticipando argomenti che a nostro avviso lo saranno presto (qui spesso ci azzecchiamo, ma il concetto di «presto» è molto aleatorio…). Anche la difficoltà o l’accessibilità di una trattazione sono criteri che teniamo sempre presenti: l’uno non esclude l’altro, ma di certo vanno alternati. Una caratteristica «storica» del nostro catalogo è invece l’interdisciplinarietà, quel meticciamento di saperi diversi che dà adito a sguardi inusuali. Poi ci sono le cosiddette «operazioni culturali», cioè quei titoli che non hanno palesemente alcun appeal commerciale ma che pubblichiamo lo stesso perché all’interno del nostro discorso aggiungono senso e coerenza. Inutile dire che queste «operazioni» le dobbiamo purtroppo centellinare. E infine seguiamo con attenzione non solo quanto di antagonista si muove sul campo (e per ragioni non esclusivamente editoriali), ma anche il lavoro di ricerca, a livello internazionale, che tanti progetti editoriali a noi affini portano avanti nei campi più disparati.
In effetti nel catalogo elèuthera c’è una notevole percentuale di testi tradotti da varie lingue.
Sì, siamo più che convinti che una visione «nazionale» della cultura sia del tutto obsoleta, in particolare per degli internazionalisti incalliti come noi. Certo, l’attenzione al «qui» permane. Si vive e si agisce in un luogo preciso e quello che ti circonda è il tuo habitat sociale. Ma le dinamiche sociali ormai sono ormai globali e dunque è necessario seguire con attenzione ciò che avviene a livello planetario, anche per intercettare quanto di non-occidentale sta emergendo. E dunque sì, tante traduzioni, nonostante l’ulteriore sforzo in termini di editing e budget


che questo comporta.
Ma questo vostro lavoro di ricerca viene generalmente riconosciuto e apprezzato o passa inosservato?
In effetti abbiamo spesso dei riscontri positivi, il che indubbiamente ci aiuta a «tenere botta». E questi apprezzamenti (non esenti da critiche) arrivano sia da parte del milieu libertario sia da parte degli «addetti ai lavori» (librai, docenti, giornalisti, lettori). In genere, non è solo il lavoro di ricerca e la qualità editoriale a essere riconosciuti ma anche il progetto «politico» che c’è dietro: ovvero riportare l’anarchismo nel dibattito culturale, politico, scientifico, etico contemporaneo. È un obiettivo che perseguiamo da tempo, ma di recente è stato inaspettatamente rafforzato dalla rilettura di Emma Goldman (abbiamo appena pubblicato una sua antologia con alcuni testi inediti in italiano). La nostra Emma (e il nostro Errico non era da meno) aveva ben chiaro a chi si rivolgeva quando scriveva articoli o teneva conferenze: lei non si rivolgeva ai fedeli e ai seguaci, ma parlava al mondo intero, e a voce alta. Nel nostro piccolo stiamo cercando di fare la stessa cosa: permettere alle voci anarchiche di risuonare forti e chiare al di fuori delle mura del ghetto (un ghetto in cui peraltro non ci hanno rinchiuso, ma in cui ci siamo rinchiusi). È ora di uscire e di parlare a voce alta come Emma. Non certo per ripetere slogan tardo novecenteschi (quando va bene, perché alcuni sono risorgimentali), ma per riprendere quel posto nell’agorà pubblica che l’anarchismo ha avuto lungamente e che deve tornare ad avere. Certo è pericoloso, si rischia di essere snaturati, travisati, fagocitati, ma è quello il luogo del logos e della praxis, ed è lì che elèuthera sta cercando di riportare l’anarchismo.
Riassumendo, ci sarebbe una doppia finalità nella strategia editoriale che portate avanti. Da un lato, l’obiettivo prefissato (e forse in parte raggiunto) è di rendere meno autoreferenziale il circuito militante permettendogli di ac-




cedere a strumenti e stimoli che vengono da mondi esterni. Dall’altro, è la società nel suo insieme che si arricchisce grazie ai dispositivi libertari che le vengono forniti da questo contesto antiautoritario. C’è dunque un effetto doppio di potenziamento.
Sì, anche se in questo gioco di influenze reciproche non è così facile «tracciare il limite». Chiaramente stiamo citando Paul Goodman e il suo monito ad avere sempre una chiara consapevolezza di dove fissare il proprio limite, ben sapendo che non può essere tracciato una volta per tutte ma va costantemente ridefinito. Posizionarsi per scelta sul limite tra dentro e fuori, tra marginalità e mainstream, richiede un’attenzione costante che ovviamente non mette a riparo da qualche scivolone. Ma l’importante è rialzarsi, darsi una spolverata e riprendere la stessa postura precaria con qualche consapevolezza in più.
Seguendo i titoli editi anno dopo anno, titoli che escono con inflessibile regolarità, si desume la crescente presenza di approcci libertari ai più diversi ambiti disciplinari, e ciò avviene anche in settori scientifici. C’è effettivamente una rinascita del pensiero anarchico o è solo un’illusione prospettica?
Negli ultimi trent’anni – complice la caduta delle principali ideologie novecentesche – l’attenzione per il pensiero anarchico è andata aumentando tante nelle scienze umane quanto nelle scienze «dure», anche se con modalità alquanto particolari. Infatti, questa evidente renaissance si colloca (spesso, non sempre) su una cesura: quella tra pensiero anarchico e movimento politico. Questa cesura ha consentito un uso teorico delle idee anarchiche – per certi versi molto fecondo – senza che questo comporti alcuna ricaduta sociale. In parole povere, critica del dominio ma senza doversi imbarcare in alcuna lotta per abbatterlo. E infatti, per marcare questa separazione tra mondo




delle idee e mondo reale, è stata coniata una nuova definizione: anarchismo filosofico come pensiero estraneo all’anarchismo politico che si incarna nei movimenti sociali. Stiamo per pubblicare il libro di una filosofa francese, Catherine Malabou, che critica con grande acume questo anarchismo depoliticizzato che scinde arbitrariamente i principi e i valori anarchici dai modi dell’agire sociale. Malabou si concentra sulla filosofia contemporanea, ma il medesimo discorso è applicabile a molte altre discipline.
Quindi sì, il pensiero anarchico è diventato più influente, ma in questa versione devitalizzata. Ciò detto, ci sono comunque delle ricadute positive, soprattutto in quei saperi tradizionalmente attenti all’anarchismo come l’antropologia o l’ecologia, ma anche in saperi decisamente sorprendenti come l’economia (fin qui la prateria del pensiero marxista e liberale) o la biologia. Soprattutto in quest’ultimo campo ci sono approcci estremamente innovativi che stanno riconfigurando la conoscenza scientifica con una radicale messa in discussione dei paradigmi dominanti e dell’immaginario gerarchico che li sottende. Basti pensare alla visione scientifica recentemente elaborata dal biologo Jean-Jacques Kupiec e sintetizzabile nella frase: «né dio né genoma».
A proposito di questa appropriazione «indebita» delle idee anarchiche – che in taluni casi vengono completamente stravolte, come nel caso delle pratiche di cooperazione inglobate nelle teorie del management – si può forse concordare con quanto diceva Colin Ward nell’intervista uscita sulla rivista «Libertaria». Colin ipotizzava che nel ventunesimo secolo forse gli anarchici non si chiameranno più così. Ma poco importa, perché la cosa fondamentale è che il corpo delle loro idee continui a tradursi in pratiche concrete, a prescindere da come ci si definisca. E il problema sta appunto qui, perché oggi si produce poca azione anarchica specifica, o per essere più precisi si produce poca azione tout court. È dunque un problema generale, non solo degli anarchici. Il mondo è cambiato troppo



89

velocemente e noi non siamo riusciti ad adeguarci, per cui la società vive ancora basandosi su modelli obsoleti. Il che ci ha portato all’attuale impasse. L’idea anarchica, diciamo, non va più di pari passo con il movimento politico anarchico. È più veloce. Ed è un problema che avvertiamo come urgente ormai da tempo. Forse è un bene che l’idea anarchica vada avanti a prescindere dagli anarchici che si definiscono tali, e tuttavia per certi aspetti sta assumendo una dimensione a-storica. Ma tornando a elèuthera, a vostro avviso che cosa c’è oggi di vitale nel pensiero anarchico? Di cosa vi siete invece liberati? Cosa avete coscientemente scartato della tradizione?
Mettiamola così: noi della tradizione non abbiamo scartato nulla perché non abbiamo nessuna intenzione di cancellare il passato. Però il nostro compito è inventarci il presente, ripensare i modi di agire e di pensare adeguandoli alle circostanze storiche in cui ci troviamo a operare. Dunque non buttiamo niente della tradizione, ma la collochiamo nel posto che le compete: il passato. Un passato di cui siamo orgogliosi, ma che non va replicato, pena l’irrilevanza. Al contrario noi – come ogni nuova generazione di anarchici, direbbe Tomás Ibáñez – dobbiamo continuamente reinventare l’anarchismo che è, per definizione, sempre in divenire.
Passiamo adesso a una domanda più tecnica: quali sono i problemi quotidiani, amministrativi o finanziari, che un progetto editoriale autogestito ed egualitario, un progetto che si pone come un’alternativa concreta al modo di produrre dominante, deve affrontare per farcela? E come può essere sostenuta un’esperienza di questo genere?
Come si è detto prima, stare nel mercato porta vantaggi ma anche svantaggi, soprattutto a livello di gestione economica. Ci si deve confrontare con un mondo, a noi estraneo e urticante, che ha le sue regole e i suoi steccati. E tuttavia ci siamo accorti,



andando avanti negli anni, che per mantenere vivo il progetto bisognava adempiere talune trafile burocratiche, per quanto assurde fossero per una visione libertaria della vita e del lavoro. Detto ciò, noi proviamo, come in tutti gli altri ambiti, di avere una gestione paritaria e di ragionare insieme, condividendo le scelte, soprattutto quelle problematiche. Che sono le più varie, anche perché le cose cambiano velocemente. Negli ultimi anni alcuni attori (potenti) del mercato editoriale lo hanno influenzato pesantemente, ribaltandone le regole. Questo ci ha spinti a parlare con altri editori che hanno un profilo non troppo dissimile dal nostro, e ora si sta cercando di ragionare insieme su forme alternative di gestire il mercato librario (che per inciso in Spagna e Francia esistono). C’è quindi sperimentazione e confronto tra soggetti più o meno affini che avvertono la necessità di cambiare alcuni di questi meccanismi. E la parte più positiva è che si discute a partire dal basso e non dall’alto, per una gestione molto più orizzontale dei rapporti tra i diversi soggetti della filiera del libro.
Da un punto di vista strettamente economico, il ricavo sulla vendita dei libri è appena sufficiente a tenere in piedi la baracca. Nel circuito commerciale i margini sono strettissimi: del prezzo di copertina all’editore arriva solo il 40% circa, e un margine così risicato (sul quale gravano i costi di produzione, i costi di gestione, la retribuzione del lavoro e i diritti d’autore) raramente permette di «investire» in quello che vorremmo: ancora più traduzioni e da lingue «esotiche» che implicano costi più alti, tomi corposi che comporterebbero un prezzo di vendita eccessivo, titoli su argomenti interessanti ma troppo specifici per un mercato asfittico… Come dicevamo prima, elèuthera è un progetto culturale e politico, non un’impresa commerciale, ma i conti con la realtà circostante bisogna farli. Per quanto riguarda il lavoro, nei primi due decenni elèuthera si è basata esclusivamente sul lavoro volontario (o meglio sulla militanza) dei suoi fondatori, ma poi fortunatamente il progetto si è allargato e l’impegno quotidiano è stato retribuito in base alle




disponibilità finanziarie (con l’eccezione della parte anziana e pensionata del collettivo che continua a svolgere gratuitamente la propria opera).
Rispetto alla seconda parte della domanda, cosa si può fare per sostenere un progetto come il nostro, in effetti ci sono vari modi per aiutarci. A parte leggere i nostri libri, è importante parlarne, farli conoscere a chi magari va poco in libreria – il passaparola rimane la modalità più efficace per vendere i libri (bestseller compresi) – o addirittura promuoverli presso le librerie locali che ancora non ci conoscono. Un’altra buona pratica è far conoscere il nostro lavoro culturale e politico nei territori in cui si è attivi, non semplicemente vendendo i libri ma organizzando iniziative culturali che amplifichino i temi da noi trattati, innescando circuiti virtuosi di discussione. Sono tutte finestre sul mondo che sicuramente possono aiutare elèuthera a essere più visibile e presente. Ma c’è anche un altro modo per sostenere il nostro progetto ed è quello di mettere a disposizione le proprie competenze, che di mestiere si faccia l’avvocato o l’idraulico. Una rete solidale basata sulle competenze in realtà è sempre esistita, e forse in passato era più solida. Nondimeno, nella nostra pluridecennale esperienza questo tipo di solidarietà pratica ha resistito alle spallate dell’individualismo neoliberista ed è un aiuto concreto che ci consente di andare avanti.
Chiudiamo parlando del futuro – a quanto pare incerto – del libro. Siamo sicuri che il futuro sarà sempre più digitale e che quindi il tramonto del libro cartaceo sia un destino ineluttabile?
Diciamo che di certezze non ce ne sono, tuttavia si possono fare ipotesi, disegnare scenari più o meno probabili. Una cosa però è certa: il digitale è una realtà che ha ormai occupato molti spazi della comunicazione, delle relazioni, della propaganda, della conoscenza. In effetti, appare come un cambio di paradigma (dal materiale all’immateriale) non dissimile da quello



che cinque secoli fa ha rimpiazzato la trasmissione orale con quella scritta grazie all’invenzione della stampa. Ciò detto, siamo convinti che la carta stampata non ha i giorni contati, perché ha una sua valenza specifica. A dirlo non sono quelli che sulla carta ci campano, ma schiere di educatori, medici e psicologi che si occupano delle tecniche di apprendimento e memorizzazione. Se l’informazione ridotta a news ormai passa per il digitale (e sta facendo le scarpe ai periodici tradizionali), i testi che implicano studio, concentrazione e approfondimento necessitano ancora di un supporto cartaceo. Quindi noi con la nostra saggistica hard non temiamo la concorrenza del digitale. Ma c’è un altro ragionamento da fare, che si ricollega a quanto abbiamo detto prima: noi non siamo una casa editrice e basta, siamo un progetto culturale. E dunque, chi se ne frega se il futuro sarà il cartaceo, il digitale o persino l’orale, comunque vada noi abbiamo un progetto politico e culturale da portare avanti, e se in questa contingenza storica ha assunto una data forma, nulla vieta che possa assumerne un’altra se le condizioni mutano. L’abbiamo detto prima: l’anarchismo è sempre in divenire, e noi pure.
Anzi, a questo proposito vogliamo chiudere la nostra conversazione ricordando la salutare provocazione che Amedeo Bertolo (1941-2016), fondatore di elèuthera, ci lanciava ogni fine anno. Implacabilmente, quando arrivava la stagione dei bilanci, poneva a sé stesso e a noi tutti sempre le stesse domande: vale la pena continuare questa esperienza? Non ha già dato tutto quello che poteva dare e dunque è meglio chiuderla e porsi nuovi obiettivi? Non sta diventando fine a sé stessa, un’istituzione che si riproduce per inerzia? Beh, noi ogni anno continuiamo a porci le stesse domande e a riflettere su quello che stiamo facendo. Il rischio di riprodursi per inerzia, di diventare autoreferenziali, c’è sempre. Ma ci sono anche dei rimedi, e l’autodissoluzione delle avanguardie di cui René Lourau parlava molti anni fa a noi sembra una via d’uscita da tenere sempre presente.










Forme di libertà: il doppio potere nelle Fiji
Glenn Hall
Con il rinnovato interesse in Nord America per la costruzione di un doppio potere e la definizione di strategie per raggiungere questi obiettivi, è importante guardare a modalità esistenti in tutto il mondo di resistenza e costruzione del potere. In tutto il mondo, i popoli indigeni ed ex colonizzati hanno intrapreso la lotta per creare spazi autonomi o, come dice Arturo Escobar, per costruire «un mondo che comprende molti mondi» (Escobar 2012). Questa strategia è ben nota a chiunque segua gli sforzi degli zapatisti (EZLN), dell’Autoamministrazione della Siria del Nord (Rojava), del Bakur e, recentemente, del popolo Mapuche nella regione Wallmapu del Sud America. Queste lotte rinunciano all’obiettivo della creazione o del controllo dello Stato, dando vita invece forme di doppio potere all’interno degli Stati in cui sono collocate. Questo approccio si allinea ampiamente al programma politico del comunalismo sviluppato da Murray Bookchin, sebbene adattato e modificato per contesti specifici.
È in questo quadro che tratto del popolo iTaukei (E-tow-kay) delle Fiji e alla sua lotta per l’autonomia dal governo figiano. Le Fiji hanno sperimentato la debolezza dello Stato attraverso vari golpe nel loro passato, ed è mia opinione che questa debolezza abbia al centro aspetti di doppio potere. Questo testo illustra alcune di queste caratteristiche e ne discute brevemente le origini e le conseguenze. Sostengo che questi esperimenti di doppio potere nelle Fiji ci mostrino l’importanza del controllo delle terre da parte dei comuni e della sottrazione di potere da parte degli organi di governo locali e municipali, e dimostrano come ciò possa contribuire alla debolezza dello Stato auspicata dal comunalismo. Inoltre, credo che se queste strutture siano «forme di




libertà» latenti, spetta alle persone e alle organizzazioni dare loro un contenuto politico. L’esperienza fijiana offre anche un ammonimento: in assenza di una critica più ampia dei sistemi di gerarchia e dominio, la democrazia di base e il doppio potere possono facilmente diventare strumenti di un nazionalismo reazionario. Le Fiji sono state colonizzate per la prima volta dai britannici nel 1875 e fino al 1916 si sono affidate a servitori indigeni importati dall’India. Le Fiji ottennero infine l’indipendenza nel 1970. Come succede spesso in molti Paesi ex colonizzati, ci sono state tensioni tra i discendenti delle popolazioni indiane e i nativi iTaukei, che a volte sono sfociate nella violenza. Il timore che
In assenza di una critica più ampia dei sistemi di gerarchia e dominio, la democrazia di base e il doppio potere possono facilmente diventare strumenti di un nazionalismo reazionario
il controllo indo-figiano potesse distruggere l’autonomia culturale degli iTaukei è stato identificato come uno dei fattori principali dei quattro colpi di stato che le Fiji hanno subito, guidati o favoriti dall’esercito dominato dagli iTaukei. Sebbene esuli dagli scopi di questo testo trattare le origini del razzismo in quest’area e gli altri fattori coinvolti nei colpi di stato, questa storia è adeguatamente riassunta in altre fonti, come ad esempio Race and Politics in Fiji di
Robert Norton (2012) e The Fijian Colonial Experience di Timothy Macnaught (2016); entrambi questi testi sostengono che l’élite politica dei governi coloniali e poi sovrani abbia favorito questa divisione e alimentato la paura di non poter mantenere le proprie posizioni.
Tuttavia, nonostante la storia coloniale e post-coloniale, gli iTaukei hanno sviluppato una forma indigena di democrazia diretta dal basso e di confederazione con sfumature ecologiche. Questo processo è stato facilitato da una serie di fattori storici e sociali. In tutte le Fiji, i villaggi hanno avuto una penetrazione limitata dell’economia del contante e del controllo statale, lasciando alle




comunità ampia libertà di dirigere e decidere le proprie linee di sviluppo. Le questioni importanti vengono sollevate nel corso di una riunione mensile del villaggio chiamata bose va koro, durante la quale le persone partecipano alla pratica indigena del talanoa, o storytelling. La talanoa funziona come una sorta di connubio tra Gli iTaukei hanno sviluppato una forma indigena di democrazia diretta dal basso e di confederazione con sfumature ecologiche
lavoro e gioco: le persone discutono gli avvenimenti del villaggio, espongono le loro lamentele, ridono, scherzano e riportano quanto discusso dalle varie assemblee locali, il tutto bevendo kava e fumando sigarette. In questo modo, la noia tipica delle riunioni viene alleviata con cura, umorismo e interesse gli uni per gli altri. Anche la vita sociale è informata dal concetto iTaukei di vivere vaka vanua, o «con la terra». Il termine vanua ha molteplici connotazioni: può significare semplicemente la terra stessa, oppure l’unità di terra, spirito e popolo. Implica uno stile di vita in armonia con la terra e con la propria comunità, anteponendo il benessere di entrambi al profitto personale (Parke 2014).
Esistono diverse assemblee a cui gli abitanti del villaggio possono partecipare. Queste assemblee tematiche si occupano di questioni come criminalità e mediazione, igiene dell’acqua, salute e sicurezza, finanza e investimenti, sviluppo della comunità e sono anche gruppi di donne e giovani, gruppi ecclesiali e di assistenza agli anziani. Attraverso queste assemblee, vengono definiti e diretti vari aspetti della vita del villaggio. Le assemblee differiscono da villaggio a villaggio, in quanto ognuna di esse è creata e controllata all’interno del bose più grande del villaggio. I bose va koro sono stati codificati nel governo attraverso il Ministero degli Affari iTaukei. Queste riunioni dal basso si collegano a un sistema di riunioni distrettuali e provinciali, composte sia da capi ereditari che da funzionari eletti per decidere gli affari dei villaggi a livello regionale, provinciale e nazionale. In pratica è una confederazione di assemblee comunitarie.




A grandi linee, le Fiji sono suddivise in 14 yasana (province), ogni yasana contiene un numero variabile di tikina (distretti). Il koro, o villaggio, è l’unità amministrativa più piccola. Ognuna di queste unità ha un capo, o tui, che ne è responsabile: il Roko Tui per la provincia, il Buli per il distretto, vari capi locali e il Turaga Ni Koro (capo villaggio) a livello di villaggio (Parke 2014). Ciascuna di queste unità comunali ha un proprio consiglio, che si riunisce per occuparsi dei problemi locali e poi conferisce le problematiche al livello superiore. Questo livello successivo è guidato da una serie di regolamenti di villaggio, che variano da luogo a luogo. Inoltre, i capi villaggio e i capigruppo si incontrano ogni trimestre per confrontarsi sulle questioni distrettuali e per nominare i membri del consiglio provinciale che si tiene due volte l’anno (Rotuivaqali 2012). I consigli provinciali contribuiscono a coordinare le linee di sviluppo dei villaggi, dalle infrastrutture agli investimenti. Hanno inoltre la facoltà di creare e gestire società e/o cooperative pubblico-private per favorire lo sviluppo economico delle aree rurali e generare capitale controllato dagli iTaukei.
Questo sistema, che nella sua forma attuale soffre di corruzione e di frode, potrebbe anche portare verso una struttura economica municipalizzata. Sebbene questi consigli più grandi siano controllati da élite politiche ereditarie, non è sempre stato così. Testimonianze storiche e antropologiche suggeriscono che l’ereditarietà di queste cariche e l’attribuzione di un così ampio controllo sulle assemblee siano il risultato del colonialismo britannico (Macnaught 2016). Prima di allora, i capi di queste assemblee venivano scelti dai loro stessi abitanti in base al valore in guerra, al servizio reso alla comunità o come compromesso tra le varie fazioni; il loro potere sul resto del villaggio era in molti casi trascurabile. Le confederazioni sono emerse in modo fluido, nascendo e scomparendo a seconda delle necessità. Il sistema provinciale era legato alla base e le riunioni di villaggio erano un metodo di governo indiretto da parte degli inglesi (Macnaught 2016).



Un altro aspetto importante di questa struttura è la comunitarizzazione dei diritti fondiari. Oltre l'80% della terra delle Fiji è di proprietà comunitaria di vari clan: è inalienabile e i proventi finanziari delle locazioni e di altri progetti di sviluppo sono distribuiti annualmente ai membri dei clan attraverso l’iTaukei Land Trust Board. Questo ha in gran parte frenato la penetrazione del capitalismo nei villaggi delle Fiji e ha impedito la loro proletarizzazione. Gli iTaukei possono partecipare al commercio come preferiscono e hanno a disposizione terre da coltivare e su cui vivere senza affitti o tasse.
A questo punto è importante spiegare alcuni aspetti del contesto indo-figiano. Gli indo-figiani sono esclusi da questa comunalizzazione della terra e devono acquistare le piccole quantità
di terra libera o affittarla dai clan iTaukei. Per questo motivo, gli indo-fijiani sono esclusi dall’accesso alla terra su base etnica e sono costretti a partecipare all’economia salariale. Questo fa sì che un gran numero di imprenditori e lavoratori siano di etnia indo-fijiana. Si è quindi sviluppata la percezione, alimentata e sostenuta prima dal
governo coloniale britannico e poi dalle élite dei clan iTaukei che hanno preso il loro posto, che gli indo-figiani volessero espandersi, rubare terre e sopprimere lo stile di vita degli iTaukei (Norton 2012). La percezione che gli indo-fijiani avessero conquistato troppo potere politico e minacciato la «supremazia» degli iTaukei è stato il fattore che ha animato tutti e quattro i colpi di Stato nella storia delle Fiji.
Tuttavia, a causa della limitata importanza del governo centrale in tutte le Fiji, questo è in gran parte un dramma che si svolge tra l’élite politica e culturale della capitale Suva. Sebbene ci siano stati disordini e uccisioni a Suva durante i colpi di stato, la loro portata è stata molto limitata rispetto ad altri episodi simili nel




resto del mondo (Norton 2012). Inoltre, vi sono prove di solidarietà tra la comunità indo-fijana e la comunità iTaukei nella vita quotidiana. Un esempio storico importante risale al 1920, quando gli indo-fijiani proclamarono uno sciopero generale per ottenere salari pari a quelli degli europei, che fu brutalmente represso dal governo coloniale. Inizialmente gli iTaukei sostenevano i minatori, gli agricoltori e i braccianti indo-fijiani con cibo, alloggio e sostegno morale. In seguito, però, furono indirizzati dalle loro élite principali – su indicazione del governo coloniale – ad agire come crumiri (Norton 2012).
Questo evento ha contribuito a catalizzare lo «sviluppo» del popolo iTaukei e, non a caso, della sua terra. In primo luogo i colonizzatori britannici e poi le élite iTaukei hanno spinto per portare gli iTaukei verso l’«individualizzazione», in particolare non rinnovando i contratti di affitto dei coltivatori di canna indo-fijiani per dover così lavorare la terra in prima persona (Macnaught 2016). L’operazione fu portata a termine, ma con disappunto della Colonial Sugar Refining Company (CSR); gli iTaukei coltivavano una quantità di canna da zucchero molto inferiore a quella degli indo-fijiani, ma la società non aveva altri gruppi da cui acquistare. Il piano di sviluppo fu presto abbandonato e il governo coloniale centralizzò l’affitto delle terre nel 1940. Questo esempio illustra come le tensioni tra i popoli iTaukei e Indo-Fijiani siano state alimentate dalle élite coloniali e culturali nel tentativo di conciliare la cultura comunitaria degli iTaukei con la spinta al dominio della terra e al profitto insita nel capitalismo. Nel suo libro Earth Democracy, Vandana Shiva descrive con acume come il conflitto etnico mascheri e compenetri il conflitto di classe: «Quando la globalizzazione minaccia i valori, le norme e le pratiche delle diverse culture, si verifica un contraccolpo culturale. Quando la risposta culturale non difende contemporaneamente la democrazia economica e la creazione di economie vive, finisce per assumere la forma di identità e culture negative» (Shiva 2016). Il conflitto tra questi due gruppi etnici nelle isole Fiji conferma il punto di vista di Shiva.



Sebbene il resoconto di cui sopra fornisca solo un abbozzo del complicato contesto storico fijano, possiamo comunque tirare le fila e derivarne delle conclusioni interessanti. La prima è la convinzione che le Fiji siano uno Stato-nazione instabile, pur rimanendo un arcipelago relativamente pacifico. Molti teorici hanno utilizzato le Fiji come caso di studio sulla debolezza dello Stato, tra cui l’attuale Procuratore Generale, Aiyaz Sayed-Khaiyum, nella sua tesi di Master sull’autonomia culturale degli iTaukei (Sayed-Khaiyum 2016). Sayed-Khaiyum indica il Ministero degli Affari iTaukei, l’iTaukei Land Trust Board e l’autonomia dei villaggi come ragioni principali della debolezza dello Stato, che secondo lui incoraggiano campanilismo e razzismo. Se da un lato possiamo certamente riconoscere che c’è del vero in questo, dall’altro possiamo utilizzare la lente dell’ecologica sociale per sottolineare che non dobbiamo accettare la debolezza dello Stato come un risultato negativo e che non è scontato che le forme di decentramento politico siano razziste o campanilistiche.
L’ultimo colpo di Stato del 2006, guidato da Frank Bainimarama, è stato definito un «colpo di Stato per porre fine alla cultura del colpo di Stato». Eppure, come leader in carica del partito Fiji First, ha continuato a mantenere il potere dopo due cicli elettorali e ha lavorato per attuare riforme neoliberali volte a integrare maggiormente le Fiji nel mercato globale. Per questo motivo, ha preso provvedimenti per limitare l’autonomia culturale iTaukei, sciogliendo il Gran Consiglio dei Capi e gli statuti dei singoli villaggi, istituzioni di base ed élite dell’autonomia culturale iTaukei. C’è stata anche una spinta ad affittare la terra a entità aziendali per 99 anni, sovvertendo di fatto i diritti fondiari comunitari. In risposta, c’è stato un aumento del sentimento nazionalistico. Le ultime elezioni del 2018 hanno visto la contesa tra Fiji First e il Partito socialdemocratico (Sodelpa), quest’ultimo candidato con un programma di ripristino della supremazia iTaukei. Ciò rispecchia da vicino il fenomeno più ampio dell’aumento dei movimenti nazionalisti/fascisti in tutto il mondo in risposta alla globalizzazione neoliberista.




Quello attualmente in corso è un tentativo di integrare le Fiji nella modernità capitalistica promessa alle nazioni «in via di sviluppo»
Questo ci riporta al centro della mia argomentazione, ovvero che la debolezza dello stato deriva effettivamente dall’autonomia culturale degli iTaukei, un risultato della nascente struttura a doppio potere incorporata nell’amministrazione coloniale. Porta con sé
la doppia faccia di un’eredità di dominio e di una possibile forma di libertà. C’è il potenziale per espandere questa autonomia culturale in un paradigma confederale che includa gli indo-fijiani e altre minoranze etniche, religiose e culturali dell’arcipelago delle Fiji in un modo che non distrugga la cultura iTaukei, né installi la sua supremazia.
In effetti, essendo le Fiji al centro di flussi migratori sia melanesiani sia polinesiani, la popolazione delle Fiji ha una lunga storia di integrazione inclusiva, con una vasta diversità culturale che è stata omogeneizzata in «fijiano» solo con la colonizzazione. Tuttavia, quello attualmente in corso è un tentativo di integrare le Fiji nella modernità capitalistica promessa alle nazioni «in via di sviluppo», a costo di sacrificare l’autonomia culturale a un individualismo sterilizzato incapsulato nel quadro dello Stato-nazione liberale.
Questa situazione sottolinea l’importanza della politica comunalista o confederalista democratica sostenuta da Murray Bookchin e Abdullah Öcalan. Nelle Fiji possiamo vedere la necessità di costruire un potere duale assumendo e democratizzando le istituzioni del governo locale, ma anche la necessità di una confederazione e di una cultura dell’inclusività per arginare il campanilismo. Anche in forma latente, la struttura a doppio potere della democrazia diretta di base combinata con il controllo comunitario della terra nelle Fiji determina uno stato indebolito sia un sistema alternativo in cui le persone possono investire il loro tempo e i loro sforzi. La sua importanza è evidenziata dalla contesa tra i due principali partiti politici delle



Fiji; uno vuole disinnescare questo sistema per portare le Fiji nella modernità capitalista, l’altro per usarlo come strumento per affermare il dominio iTaukei e l’esclusione di altri gruppi. La falsa scelta che viene offerta alle Fiji è la stessa che si trova oggi in tutto il mondo: o il neoliberismo o il nazionalismo reazionario. Ma attraverso il quadro politico dell’ecologia sociale diventa possibile vedere come potremmo far crescere un nuovo mondo all’interno delle crepe del vecchio, nelle Fiji e altrove, coltivando «forme di libertà» locali e allo stesso tempo estirpando gerarchia e dominio.
Articolo tratto da: «Harbinger. A Journal of Social Ecology», Issue 1, Winter 2019.
Traduzione di Marco
Bibliografia
A. ESCOBAR, Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World, Princeton University Press, Princeton, 2012.
T. MACNAUGHT, The Fijian Colonial Experience: A Study of the Neotraditional Order Under British Colonial Rule Prior to World War II, ANU Press, Acton (Canberra), 2016.
R. NORTON, Race and Politics in Fiji (Second edition, Pacific studies series), University of Queensland Press, St Lucia, Australia, 2012.
A. PARKE, Degei’s Descendants: Spirits, Place and People in Pre-Cession Fiji, ANU Press, Canberra, 2014.
M. ROTUIVAQALI, Accountability in Fiji’s Provisional Councils and Companies: The Case for Lau and Namosi (Unpublished Master’s thesis), University of the South Pacific, Fiji, 2012.
A. SAYED-KHAIYUM, Cultural Autonomy - Its Implications for the Nation-State, Masters’ thesis, University of Hong Kong, 2002.
V. SHIVA, Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace, Zed Books, London, 2016 (prima ed. 2005; trad. it.: Il bene comune della terra, Feltrinelli, Milano, 2011).









Luce Fabbri (1908-2000)
Lorenzo Pezzica
Ancorata alla radice socialista dell’anarchismo malatestiano e del padre Luigi, ma al contempo spinta a svilupparlo e arricchirlo, Luce Fabbri è certamente da considerarsi una tra le figure intellettuali più interessanti e significative dell’anarchismo italiano e internazionale del Novecento.
Testimone degli eventi e delle tragedie che attraversano tutto il XX secolo, Fabbri ha affrontato nel corso della sua esistenza alcuni tra i nodi centrali delle vicende storiche della realtà contemporanea. In lei ha convissuto sia una solida cultura politica, storica e letteraria, che, ad esempio, le permise nel 1949 di accedere in Uruguay all’insegnamento universitario, sia una massima apertura mentale verso i problemi del presente e del futuro. Nonostante ciò il suo pensiero, seppur accolto in numerose riviste del movimento, non venne compreso e dibattuto quanto avrebbe meritato e le sue idee passarono sostanzialmente inosservate. Anche chi, nel movimento anarchico italiano dalla fine degli anni Sessanta, riprese e sviluppò per esempio il tema della tecnoburocrazia, mettendo in evidenza pensatori come Luis Mercier Vega o riscoprendo personaggi come Bruno Rizzi, non si accorse delle pagine scritte da Luce Fabbri sullo stesso tema. Luce Fabbri nasce a Roma il 25 luglio 1908, figlia di Luigi Fabbri e di Bianca Sbriccioli. Nell’ottobre del 1910 nasce a Bologna, dove la famiglia si era nel frattempo trasferita, il fratello Vero. Nell’autunno del 1926, dopo la definitiva affermazione del fascismo in seguito alle leggi «fascistissime» del 1925, il padre Luigi è costretto ad espatriare clandestinamente attraverso la frontiera svizzera, recandosi in Francia dove lo raggiungerà nell’anno successivo la moglie Bianca.
Luce rimane da sola a Bologna per terminare gli studi univer-




sitari, ospite in casa di un amico di famiglia, il socialista Enrico Bassi. Due mesi dopo la laurea, ottenuta nel 1928, anche Luce decide di lasciare clandestinamente l’Italia, raggiungendo la famiglia a Parigi i primi di gennaio del 1929. Nel marzo dello stesso anno il padre Luigi è nuovamente costretto ad attraversare clandestinamente la frontiera con il Belgio, sotto la minaccia di arresto da parte della polizia francese. In aprile Luce e la madre lo raggiungono a Bruxelles e il mese successivo la famiglia parte dal porto di Anversa per l’Uruguay.
Fin dall’inizio del suo arrivo nel nuovo paese Luce si impegna attivamente nel movimento anarchico uruguayano, scrivendo articoli e libri, tenendo conferenze e impegnandosi in svariati ambiti. I primi anni a Montevideo sono difficili per problemi economici e di inserimento, mentre la nostalgia dell’Italia si fa sentire in modo acuto. Per aiutare la famiglia, Luce impartisce lezioni private di italiano e greco, e partecipa alle commissioni annuali d’esame per l’italiano, che era materia curricolare nelle scuole secondarie superiori dell’Uruguay, ottenendo nel 1933 l’incarico di professoressa di storia in molte scuole, che svolgerà fino al 1970. Durante la prima estate nel nuovo paese, per ristabilirsi nella salute compromessa dal lungo viaggio, Luce trascorre un periodo di vacanza sulle montagne di Cordoba, in Argentina, ospite di Diego Abad de Santillán. È l’inizio di una lunga amicizia che durerà tutta la vita. Nel frattempo Luigi Fabbri avvia una nuova importante iniziativa editoriale, la pubblicazione della rivista «Studi Sociali», il cui primo numero esce nel marzo del 1930. Alla redazione collaborano Ugo Fedeli e Torquato Gobbi e Luce, che scrive alcuni articoli firmati con lo pseudonimo Lucia Ferrari.
Il 6 settembre 1930, con il colpo di stato del generale Uriburu in Argentina, si scatena una feroce repressione contro gli anarchici. Quelli che riescono a fuggire riparano a Montevideo, dove vanno a ingrossare la comunità degli esiliati. Tra i profughi c’è anche Ermacora Cressatti, un muratore anarchico di origini friulane, di cui ben presto Luce si innamora e che diventa suo marito nel 1933. Alcuni anni dopo nasce la figlia Luisa.



Il 22 giugno 1935 muore Luigi Fabbri. Luce, gravemente ammalata, non può assistere ai suoi ultimi istanti e neppure prendere parte al funerale. La perdita del padre, che adorava, rappresenta uno dei più grandi dolori della sua vita. Cerca di reagire, continuando l’opera iniziata da Luigi, in particolare «Studi Sociali». Tra il 1936 e il 1939 Luce si impegna nel sostegno agli anarchici spagnoli che lottano sul doppio fronte della guerra contro Franco e della rivoluzione.
Luce Fabbri «nasce» anarchica, favorita certamente dallo speciale ambiente familiare in cui poté crescere. Tutto il suo percorso esistenziale, intellettuale e politico si iscrive all’interno dell’ideale anarchico che non le impedisce di ancorare il suo pensiero a un forte principio di realtà e al contesto sociale e politico di appartenenza. Essere anarchica «da sempre» è ciò che rende Luce Fabbri un personaggio estremamente significativo per la pregnanza con cui ha vissuto e concretizzato la sua weltanschauung libertaria.
Un altro elemento importante che la caratterizza è rappresentato dalla condizione dell’esilio, vissuto con grande sofferenza ma mai quanto quella del padre. Per la Fabbri l’Uruguay diventa il suo nuovo Paese, anche se l’Italia resterà sempre presente nella sua esistenza. Da quel momento questa condizione «binaria» diventa centrale per la sua esistenza e il suo pensiero. Nonostante questa sua scelta esistenziale, il movimento anarchico italiano resta un punto di riferimento fondamentale del suo agire di militante e intellettuale anarchica.
Fin dal 1944 segue con entusiasmo i tentativi di riorganizzazione del movimento nella parte dell’Italia liberata da parte in particolare di Pio Turroni, Giovanna Caleffi e Cesare Zaccaria, tentativi che si concretizzeranno nel settembre del 1945 con il primo Congresso nazionale di Carrara che darà vita alla Federazione anarchica italiana. Luce Fabbri comunica il suo entusiasmo a Caleffi e Zaccaria, aderendo al progetto della rivista «Volontà» che tra il 1946 e il 1962 (anno della morte di Giovanna Caleffi) diviene uno degli spazi più importante del dibattito teorico dell’anarchismo italiano e internazionale, mettendo a contatto il




movimento italiano con le voci più avanzate della cultura occidentale di timbro libertario.
In quegli anni la Fabbri collabora assiduamente alla vita della rivista. Oltre ad affrontare argomenti legati all’attualità politica e sociale italiana e uruguayana, ai temi della pedagogia libertaria, alla ricostruzione storica, alla critica letteraria, si impegna in una riflessione sul fenomeno del totalitarismo, iniziata fin dagli anni Trenta, con diversi articoli. Essa rappresenta il contributo principale che diede a «Volontà». Articoli oggi riuniti e pubblicati nell’antologia Critica dei totalitarismi, uscita nel 2023 per le edizioni elèuthera.
Nell’affrontare il tema del totalitarismo Luce Fabbri attinge alle più diverse e stimolanti correnti del pensiero «critico», dimostrando così la sua particolare apertura mentale e culturale. Al fianco del padre Luce aveva acquisito la conoscenza delle problematiche scaturite dal dibattito sulla rivoluzione russa e l’avvento del regime fascista in Italia; fa proprio e rielabora il pensiero di Errico Malatesta e di Camillo Berneri, ma si dimostra sensibile anche, per esempio, alle suggestioni che emersero dal «laboratorio parigino» degli anni Trenta.
Tra le fonti a cui attinge vi sono anche le opere di Orwell, Il mito dello stato di Cassirer, La rivoluzione dei tecnici di Burnham; La nuova classe di Gilas, solo per fare qualche altro esempio. Molte delle sue intuizioni sul fenomeno del totalitarismo sono vicine a quelle espresse per esempio da Simone Weil o anticipano per alcuni aspetti quelle che furono poi sviluppate da Hannah Arendt, mentre le sue osservazioni sulla tecnoburocrazia presentano delle affinità con quelle formulate da Bruno Rizzi.
Ai dogmatismi e alle certezze manichee di quegli anni Luce Fabbri rispose con un’indagine critica e analitica, insoddisfatta della vulgata corrente, animata da una costante problematicità e da una prospettiva culturale aperta.
Per Luce Fabbri il fenomeno totalitario trova le sue origini storiche nel contesto creato della grande guerra. Comparando poi nazismo e stalinismo, Luce Fabbri dà una definizione riassuntiva del «siste-



ma totalitario» in questi termini: «è l’unificazione dell’oppressione politica e dello sfruttamento economico delle grandi masse umane asservite, nelle mani di uno stato assoluto e fortemente centralizzato, operante attraverso una casta scalonata di funzionari economicamente privilegiati […]. Tale casta comprende tutta la burocrazia governativa nei suoi diversi settori, compresi i tecnici e gli organizzatori della produzione e della distribuzione, la polizia, l’esercito e col tempo, senza dubbio, il clero».
Nel passo citato emerge il fenomeno tecnoburocratico quale elemento che denota il totalitarismo. Luce Fabbri, insieme a Luis Mercier Vega, è stata dunque tra i primi a introdurre nel movimento anarchico di lingua italiana un’indagine particolarmente stimolante, il concetto di tecnoburocrazia. Dopo aver inquadrato il tema tecnoburocratico all’interno del fenomeno totalitario, Luce Fabbri però pone in secondo piano gli aspetti economici del processo totalitario considerati «una delle manifestazioni del rapporto fondamentale tra gli individui e i gruppi sociali, ch’è essenzialmente un rapporto politico, un rapporto di potere».
È quindi verso l’aspetto più genuinamente «politico» e «ideologico» del totalitarismo che Luce decide di concentrare la sua analisi. Proprio in relazione all’ideologia totalitaria, Luce Fabbri individua tre elementi principali che definiscono il regime totalitario: la neolingua, la visione ufficiale della storia, la militarizzazione delle intelligenze. Ma non si limita, nella sua riflessione, ad analizzare il fenomeno totalitario nel solo significato di nuovo regime. Si apre verso una prospettiva ermeneutica, cercando di leggere in ciò che accomuna fascismo, nazismo e stalinismo qualcosa che non riguarda soltanto l’intensità e la struttura dell’oppressione politica ma la sua essenza. Riconoscere l’onnipotenza del potere per Luce Fabbri non deve mai diventare un alibi per dichiarare impossibile l’azione. Soprattutto quando si è anarchici. Contro il potere è possibile gettare in aria le carte, con il coraggio e la forza di una volontà ritrovata, «una “tensione” adeguata».




Nel 1949 ottiene la cattedra di Letteratura Italiana all’Università di Montevideo, che terrà fino al 1991, esclusa la parentesi di dittatura militare (1975-1985). Numerosi sono i suoi saggi pubblicati su Dante, Machiavelli e Leopardi.
Negli anni Cinquanta e Sessanta, accanto all’insegnamento, Luce si dedica alla militanza nel movimento locale, pur non trascurando contatti con gli ambienti italiani e internazionali. In particolare s’impegna in un movimento pedagogico per la riforma autonomistica della scuola secondaria. A partire dal 1985, con l’inizio del processo di democratizzazione dell’Uruguay, riprende la sua attività militante, a partire dalla riapertura di «Opción libertaria». Riprende anche i contatti con l’Italia, diventando per esempio collaboratrice della rivista «A rivista anarchica» di Milano.
Nel 1993 Luce compie il suo ultimo viaggio in Europa, per prendere parte alla Exposiciòn internacional anarquista di Barcellona. L’intervento che legge al convegno, Una utopìa para el siglo XXI, viene pubblicato sul n. 205 di «A rivista anarchica» e può essere inteso come il suo testamento spirituale. Approfittando del viaggio a Barcellona si reca per qualche settimana in Italia: sarà per lei l’ultima volta che rivedrà il paese natale. Negli ultimi anni Luce si dedica alla scrittura della biografia del padre, Luigi Fabbri. Storia di un uomo libero, pubblicato nel 1996 dalla BFS. Attiva sino agli ultimi giorni della sua vita, muore a Montevideo il 19 agosto 2000 nella sua casa, in J.J. Rousseau 3659.




Bibliografia essenziale
Di Luce Fabbri
Gli anarchici e la rivoluzione spagnola (con Diego Abad de Santillán), Carlo Frigerio Editore, Lugano, 1938.
La libertà nelle crisi rivoluzionarie, Edizioni Studi Sociali, Montevideo, 1947. L’anticomunismo, l’antimperialismo e la pace, Edizioni di Studi Sociali, Montevideo, 1949.
La strada, Edizioni Studi Sociali, Montevideo, 1952.
Sotto la minaccia totalitaria, Edizioni RL, Napoli, 1955.
Problemi di ieri e di oggi, Edizioni RL, Napoli, 1958.
Luigi Fabbri. Storia di un uomo libero, BFS, Pisa, 1996.
Una strada concreta verso l’utopia, Samizdat, Pescara, 1998.
La poesia di Leopardi, Instituto Italiano de Cultura, Montevideo, 1971.
Machiavelli descritto, Instituto Italiano de Cultura, Montevideo, 1972.
La Divina Comedia de Dante Alighieri, Universidad de la Republica, Montevideo, 1994.
Critica dei totalitarismi, elèuthera, Milano, 2023.
Su Luce Fabbri
L. Pezzica, Anarchiche. Donne ribelli del Novecento, Shake, Milano, 2013, pp. 159-171.
M. Rago, Tra la storia e la libertà. Luce Fabbri e l’anarchismo contemporaneo, ZiC, Milano, 2008.



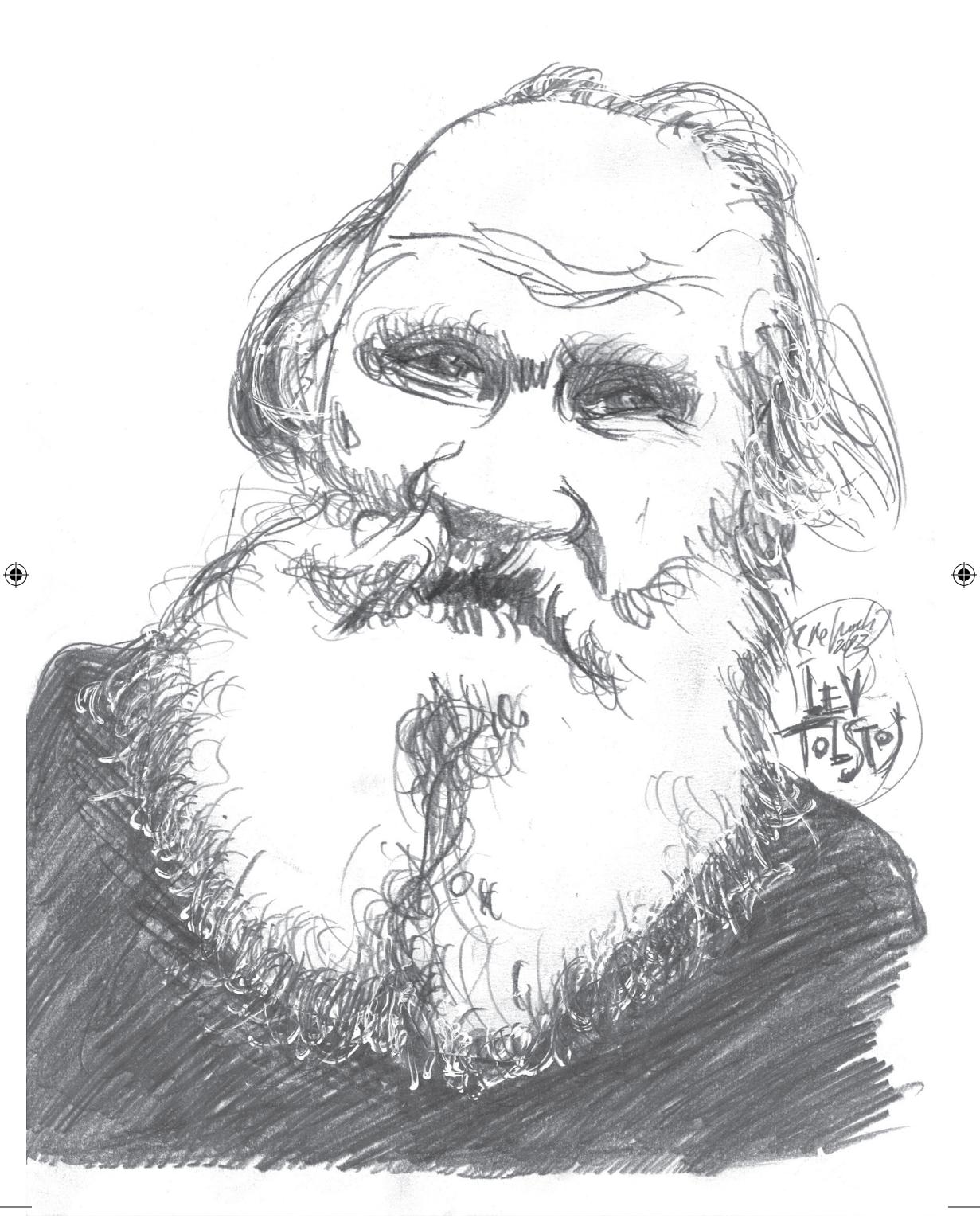



Lev Tolstoj (1828-1910)
Francesco Codello
Tolstoj appuntava nei suoi diari: «Ho letto Kropotkin sul comunismo. Ben scritto e buoni concetti, ma stupefacente per l’intima contraddizione: per far cessare la violenza di alcuni uomini sugli altri, impiegare la violenza. Il punto è questo: come far sì che gli uomini cessino di essere egoisti e violenti? Secondo il loro programma, per il raggiungimento di quest’obiettivo occorre impiegare nuova violenza».
Ecco come Lev Tolstoj il grande scrittore russo, il famoso autore di grandi e intramontabili opere narrative, interrogava l’anarchismo. Eppure, nonostante le critiche forti e risolute che muoveva all’idea anarchica, Tolstoj era, ed è, considerato un pensatore sostanzialmente «anarchico». Sul senso del suo essere anarchico critici letterari, storici o politici, hanno dibattuto a lungo. Una sicura sensibilità libertaria del grande scrittore russo, pur avendo avuto esplicita manifestazione a un certo punto della sua vita, può essere rintracciata, in nuce, già nei suoi due più grandi e famosi romanzi: Guerra e pace e Anna Karenina. Anarchico dunque, ma di un anarchismo specifico, particolare, diverso sicuramente, da quello degli altri pensatori «classici» di questa idea. Infatti, se la critica allo stato e al potere, alla concezione «sviluppista» dell’economia, alla proprietà privata, all’educazione autoritaria e alla scuola istituzionalizzata, alla funzione repressiva della religione ufficiale, al militarismo e a ogni forma di esercito, alla nozione di patria e di patriottismo, al socialismo statalista, all’uso antropocentrico della natura e degli animali, se tutto questo (e altro ancora) può essere riconosciuto come patrimonio comune dell’anarchismo, per altre caratteristiche il suo pensiero si differenzia, in modo anche radicale, da quello tradizionalmente considerato come libertario. Questo aspetto, lungi


dal rappresentare però un limite (anche se può esserlo), costituisce in realtà un utile e quanto mai significativo contributo a un pensiero anarchico non rigidamente rinchiuso in presunte inossidabili certezze.
Nel 1900 a firma «Studenti Socialisti Rivoluzionari Internazionalisti di Parigi» appare un opuscolo dal significativo titolo: Tolstoismo e anarchismo, in cui viene affrontata appunto la questione relativa al possibile rapporto tra il pensiero anarchico e quello che ormai viene chiamato tolstoismo. Così conclude: «In riassunto, noi pensiamo che la propaganda di Tolstoj ha un’utilità teorica incontestabile, soprattutto quando essa attacca con vigore il militarismo e lo Stato. Ma essa presenta anche, a nostro avviso, dei grandi pericoli […] Tolstoj, il quale critica con tanta asprezza e vigore i pregiudizi e le istituzioni, fa una propaganda che devia dal socialismo e dalla rivoluzione. Egli è forse un eccellente cristiano della chiesa primitiva, è certamente un grande scrittore, è un pensatore, ma non è, in nessun caso, un anarchico comunista e rivoluzionario». Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda si troveranno, seppur con accenti diversi e sfumature non omogenee, molti altri pensatori e militanti anarchici italiani come Pietro Gori, Luigi Fabbri, Luigi Galleani, Errico Malatesta, Camillo Berneri e molti altri.
Un approccio differente lo troviamo in altri militanti anarchici come, ad esempio, Pëtr Kropotkin il quale, nel 1905, nell’opera Ideals and Realities in Russian Literature, dedicando un capitolo proprio a Tolstoj, esprimeva le sue opinioni sul Tolstoj letterato ma anche sulla dimensione più complessiva del suo pensiero. La prima osservazione, di estrema attualità, la fa a proposito di due opere giovanili di Tolstoj, Infanzia e Fanciullezza, in cui coglie bene la profondità delle intuizioni tolstoiane rispetto ai temi educativi. Kropotkin mette in risalto come nessuno, fino ad allora, avesse così ben descritto la vita dei ragazzi dall’interno, cioè dal loro punto di vista. Infatti Tolstoj dimostra molto bene il valore dell’empatia nella relazione educativa e lo fa in modo tale che il lettore è costretto a giudicare gli adulti dallo stesso



punto di vista del ragazzo. In effetti, a partire proprio da questi iniziali capolavori letterari, Tolstoj svilupperà con anticipo, secondo solo a William Godwin, quelle che saranno destinate a diventare le idee base, tutt’ora riconosciute e sui cui si sviluppano continuamente esperienze di scuole libertarie, di un approccio antiautoritario all’educazione e alla scuola. Sarà proprio il tema dell’educazione, infatti, che avvicinerà per primo la sensibilità dello scrittore russo alle idee dell’anarchismo.
Kropotkin però coglie, dalle sue opere, anche altri aspetti centrali del pensiero di Tolstoj e li interpreta in chiave libertaria: la denuncia dei mali della cosiddetta civiltà e il bisogno di un ritorno alla natura con l’abbandono di tutte quelle artificiosità che «noi chiamiamo vita civile»; la potente condanna della guerra e la rivalutazione del ruolo delle masse a scapito del singolo eroe nel progresso della storia; il tentativo di liberare il cristianesimo da ogni gnosticismo e misticismo e di descrivere Dio come la vita, o «come l’amore o in generale come l’ideale, di cui l’uomo è cosciente in se stesso»; la lotta contro lo stato e la chiesa, il governo in quanto tale e i dogmi religiosi; le disuguaglianze sociali e il sistema capitalistico. E inoltre: l’incitamento alla disobbedienza civile; il sostegno a una visione non antropocentrica e più rispettosa degli altri esseri viventi; alla costruzione di una società decisamente più semplice e umana. Rispetto alla questione della «non resistenza al male», concetto fondamentale nell’elaborazione di Tolstoj che ispirerà anche la vita di Gandhi, Kropotkin, diversamente da altri anarchici, sottolinea che essa va letta non come un rifiuto di lottare contro le ingiustizie ma, piuttosto, nel senso che le lotte, giuste e sacrosante, non devono contemplare la violenza: si tratta cioè «della non resistenza al male con la violenza».
Anche Max Nettlau evidenzia in modo positivo l’apporto che Tolstoj ha dato arricchendo molto il pensiero anarchico soprattutto in Russia. Ribadisce le stesse sottolineature fatte da Kropotkin rispetto alla teoria della «resistenza al male» come una forma di lotta, di disobbedienza civile, di rifiuto di scelte autoritarie, di condanna della violenza dello Stato e dei governi.




Inoltre, nel pensiero tolstoiano, si trova, secondo il grande storico dell’anarchismo, il riconoscimento della forza che il bene, la bontà, la solidarietà possiedono. Si tratta, in altre parole, di una energia veramente rivoluzionaria che ci appartiene e che deve pertanto essere incoraggiata a esprimersi al posto di malvagità e sopraffazione. L’unica cosa che Nettlau lamenta è l’uso che Tolstoj fa della terminologia religiosa, che inevitabilmente confonde il popolo: «Ha errato perché […] le religioni sono state sempre uno strumento della reazione che perseguita coloro che le combattono a fondo». La maturità del grande romanziere russo è caratterizzata, secondo Gustav Landauer, invece dall’aver acquisito «la saggezza di un profeta e di un santo». La sua implacabile lotta contro i governi e gli stati, le chiese istituzionalizzate, ogni sorta di violenza dell’uomo sull’uomo e su tutti gli esseri viventi, sono esemplari verità che Tolstoj ha annunciato sistematicamente. Ma, sempre secondo Landauer, non bisogna scordare che la robustezza del suo pensiero sta molto nella capacità dimostrata di cogliere l’importanza che mezzi e fini siano coerenti tra loro: «Egli ha chiaramente dimostrato che il fine, la non violenza, è contemporaneamente il mezzo per conseguire questo fine», che ogni forma di dominio esercitato tramite la violenza può venire spazzato via solo quando ciascuno di noi cesserà di esercitare ogni sorta di violenza nei confronti degli altri e di se stessi. L’importanza che Tolstoj riveste tra gli anarchici è dunque ben sottolineata da questi interpreti e attivi militanti dell’ideale anarchico. A essi si può aggiungere anche Rudolf Rocker che non teme di evidenziare come il pensiero tolstoiano, tra le tante intuizioni libertarie che ha espresso, non si sia scordato di denunciare il colonialismo economico e l’imperialismo culturale che l’Europa e l’intero occidente hanno messo in campo nei confronti di altri paesi più poveri. Ma anche come il modello di sviluppo proprio del capitalismo si sia imposto con la forza e la domina-
zione verso l’esterno del continente europeo e come, nei fatti, lo stesso capitalismo e lo sviluppo della tecnica non siano stati in grado di soddisfare le profonde aspirazioni che gli uomini e le



donne hanno alimentato sognando una società più giusta e più libera. Tolstoj, per Rocker, è stato dunque «non un riformista, non rientra tra coloro che vogliono guarire il male con dei piccoli miglioramenti. Il suo pensiero è rivolto contro il fondamento stesso di questa società moderna; combatte l’essenza e non la forma di questa sedicente civiltà».
Nell’Encyclopédie anarchiste del 1924 alla voce Tolstoïsme si può leggere una corposa sintesi dell’evoluzione del pensiero di Tolstoj, delle sue convinzioni in ambito politico, economico, religioso, ecc. e si afferma con decisione che egli debba essere annoverato sicuramente tra i pensatori anarchici. Il teorico e il militante principale dell’individualismo anarchico, E. Armand (pseudonimo di Ernest Lucien Juin) lo annovera tra i suoi principali punti di riferimento assieme a Benjamin Tucker e Henry David Thoreau, soprattutto nel significato da attribuire alla concezione tolstoiana di non resistenza al male con la violenza, sostenendo questa forma di lotta e sottolineandone anche le implicazioni concrete.
Come si può capire esiste dunque un filo rosso che unisce le riflessioni di questi autori anarchici nel giudizio sostanzialmente positivo di Tolstoj, sul suo legittimo anarchismo. Ma altri pensatori e militanti, altrettanto autorevoli nelle file del movimento anarchico internazionale a cavallo tra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento, hanno evidenziato critiche anche molto severe nei confronti dello scrittore russo. Errico Malatesta e Luigi Galleani, in modo particolare anche se con accenti diversi, non hanno esitato a criticare aspramente le implicazioni negative che le teorie tolstoiane sulla non violenza e sulla religione cristiana hanno nel processo di trasformazione rivoluzionaria della società.
Ma è lo stesso Tolstoj che precisa, esplicitamente, il suo rapporto con l’anarchismo in alcuni pensieri tratti dai suoi Diari: «Una volta l’anarchismo era impensabile. Il popolo voleva adorare e star sottomesso e i governanti erano certi della loro vocazione […] Ora invece il popolo non adora più e non solo non vuole



star sottomesso ma vuole essere libero […] I popoli […] non sono più disposti a sopportare il potere, vogliono la libertà, la completa libertà». Ma chiarisce subito che il suo anarchismo è particolare, specifico, personale: «Mi considerano anarchico, ma io non sono anarchico, sono cristiano. Il mio anarchismo è solo l’applicazione del cristianesimo ai rapporti tra gli uomini. Così l’antimilitarismo, il comunismo, il vegetarianesimo».
Il pensiero di Tolstoj ha avuto, e ancora ha, molti seguaci e a esso si sono ispirati veri e propri pionieri di comunità tolstojane alternative alle forme di vita dominante e organizzazioni sociali di stampo libertario.
Tolstoj, dunque, ha in comune con il pensiero anarchico diverse e fondamentali idee che vengono però sostenute attraverso una lettura estremizzata e poco consueta del messaggio contenuto nel vangelo. Gesù e la sua predicazione sono alla base della sua profezia anarchica. Anzi, come lo stesso scrittore russo ha ribadito, il suo pensiero filosofico, religioso, politico non è altro che una traduzione in questi ambiti della predicazione evangelica. La religione di Tolstoj è sostanzialmente un’etica universalizzata: «Questa religione c’è e noi tutti la possiamo conoscere, se soltanto evitiamo di nascondere a noi stessi i suoi imperativi, imperativi che ci sembrano esagerati e impossibili, perché si oppongono direttamente a tutto il nostro sistema di vita e smascherano i vizi e i crimini abituali della nostra vita. Tale religione ci fu sempre e c’è oggi: essa è nei Veda, nel Confucianesimo, nel Taoismo, nell’insegnamento dei sapienti romani e greci, nell’Islam, nel Bahaismo e nel Cristianesimo; è nelle dottrine di Rousseau, Pascal, Kant, Schopenhauer, Emerson, Ruskin, Lamennais, e molti altri e cosa principale, è nel cuore e nella mente di ogni uomo del nostro tempo […] Tutto il credo consiste in questo, come fu detto da Cristo e da tutti i sommi maestri del mondo: nel fatto che per avere coscienza del principio divino in se stessi e riconoscerlo in tutte le persone, bisogna amare tutti e non fare a nessun uomo ciò che non vuoi che sia fatto a te».
Questa fiducia nelle naturali virtù del popolo, dei contadini russi



in particolare, seppur ammantata di un certo ottimismo naturalistico, non gli ha però impedito di denunciare i grandi livelli di corruzione che il potere (nelle sue varie articolazioni) riesce a produrre negli animi e nei costumi delle singole persone. Ma questa sua fede idealistica non gli ha compromesso neanche la volontà di proclamare la necessità della ribellione, in tutti gli ambiti della vita quotidiana, a ogni forma di dominio e di repressione. Lui stesso, in vari momenti della sua tormentata esistenza, non si è sottratto ad azioni e scelte di rifiuto di quei valori e quei comportamenti che caratterizzavano la società dell’epoca. «Non posso tacere!» è forse il «mantra» che riassume bene il suo sguardo obliquo verso il potere. La lotta che Tolstoj conduce contro ogni forma di dominio è sempre caratterizzata da una scelta morale. Per Tolstoj l’autorità, ogni forma di autorità, non è altro che il mezzo per forzare un uomo ad andare contro i suoi desideri e contrasta con l’influenza spirituale, che viene invece salvaguardata dalla critica tolstoiana. La relazione fondata su una gerarchia autoritaria incoraggia l’ipocrisia, intesa non tanto come una mera spinta ad agire contro i propri convincimenti quanto, piuttosto, come il recitare una parte in un teatro nascondendo la propria identità.
Tolstoj pertanto assume e fa proprie le critiche anarchiche al potere, ma lamenta l’inconsistenza di idee e di proposte praticabili che possano suggerire nuove forme di relazioni sociali. Ma l’affondo più radicale Tolstoj lo porta in termini più strettamente filosofici. Per lo scrittore russo, come abbiamo già visto, l’unica possibilità di negare la legge umana e tutti gli apparati istituzionali che ne conseguono risiede nell’abbracciare totalmente un’altra legge, ben più grande e universale, che sarebbe quella divina dell’amore universale. In nome e per conto di questa, e solo in questo modo, è possibile riconoscersi uguali e radicalmente non assoggettati al potere secolare.
La filosofia tolstoiana è una filosofia sostanzialmente morale, kantiana, che basa la sua universalità proprio sulla sua adesione al pensiero del Cristo. Come giustamente rileva Giampietro Ber-




ti, «l’anarchismo di Tolstoj appare molto più radicale di quello “tradizionale”, dal momento che il rifiuto di obbedire all’autorità investe proprio ogni comando umano».
Per Tolstoj l’emancipazione umana è possibile solo a condizione di obbedire alla morale che Gesù ci ha tramandato, e la fede in Dio è assolutamente necessaria per questo scopo: proprio per tutto questo è possibile e legittima la disobbedienza all’autorità umana, perché viene dopo quella divina e la contraddice. Inoltre i comandamenti di Dio sono insiti nella natura umana, sono cioè immanenti, valori cristiani e valori umani coincidono. L’enfasi posta da Tolstoj su un misticismo sapienziale, identificato nei grandi maestri religiosi sia occidentali che orientali, conduce il suo pensiero a valorizzare una tensione continua verso la perfezione. Grazie a questo atteggiamento di perfettibilità costante, l’essere umano si pone in modo critico nei confronti della vita terrena e di ogni forma di dominio, proprio perché aspira a un modello universale e religioso di bontà. Sulla base di un principio universale e naturale, la legge dell’amore, attraverso una continua coerente testimonianza di questa fede nella vita terrena, Tolstoj nega ogni valore a qualsiasi autorità secolare e a ogni istituzione che pretenda di rappresentarla. Il suo tasso di anarchismo è pertanto identificabile nella sua priorità morale: la possibilità di cambiare radicalmente questa società corrotta e autoritaria si risolve prioritariamente nella rivolta morale che ogni individuo deve compiere. La dimensione della rivolta (individuale) è essenziale dunque a quella rivoluzionaria (collettiva). La più grande questione che differenzia il pensiero di Tolstoj da quello espresso dai classici dell’anarchismo è, come abbiamo visto, quella della legittimità dell’uso della violenza, seppur come inevitabile, resistente risposta alla violenza istituzionalizzata. In molte occasioni egli, infatti, denuncia senza esitazione come la violenza perpetuata dalle istituzioni statali sia all’origine, e ben più grave, della violenza delle rivolte, sia individuali che sociali, impiegate per abbatterla. La sua idea (fatta propria poi da tutti i movimenti che si ispirano alla nonviolenza) della non resistenza



al male, esemplifica in maniera chiara i suoi convincimenti etici e morali. Lottare è non solo giusto, ma soprattutto doveroso: è l’imperativo morale per eccellenza per ogni individuo che voglia trasformare il mondo corrotto e degenerato e per edificare un nuovo rapporto tra gli esseri viventi. La legge dell’amore, amare gli altri come vorresti essere amato, è la legge universale che presiede la filosofia morale tolstoiana. Anzi, l’unica forza in grado di sconfiggere la violenza dello stato e della proprietà è proprio questo amore portato alle sue estreme e più radicali conseguenze. La violenza genera violenza, pertanto se il fine è fondare una società fatta di relazioni non violente, è impossibile pervenirci, nonostante qualsiasi sopruso noi subiamo, attraverso l’uso di forme violente. Tolstoj istituisce la sua scelta morale sulla legge dell’amore universale per tutti, ma proprio tutti, gli esseri viventi.

Bibliografia essenziale
Di Lev Tolstoj
Il rifiuto di obbedire, a cura di F. Codello, elèuthera, Milano, 2019.
La schiavitù del nostro tempo, BFS Edizioni, Pisa, 2010.
Quale scuola, Mondadori, Milano, 1978.
Perché la gente si droga?, Mondadori, Milano, 1988.
Guerra e rivoluzione, Feltrinelli, Milano, 2015.
Il regno di Dio è in voi, Manca edizioni, Genova, 2003.
Tolstoj verde, Manca editore, Genova, 1990.
Su Lev Tolstoj
G. BERTI, Il pensiero anarchico. Dal Settecento al Novecento, Lacaita, Manduria, 1998, pp. 667-91.








Letture della prefigurazione
F. C.
Coerentemente con l’idea di fondo che ispira questa rivista proponiamo ancora alcune letture che possono rappresentare stimoli e suggestioni interessanti per i nostri lettori. Lo scorso numero abbiamo suggerito il libro di John Clark (edito da elèuthera) che ci ha presentato una prospettiva sperimentale e una visione libertaria della società. In particolare ricordo ai nostri lettori e a quanti hanno voluto leggerlo che Clark ci ha raccontato di esperienze di democrazia diretta e di relazioni libertarie in India e in Sri Lanka (oltre al Rojava e al Chiapas). Per sviluppare ulteriormente queste conoscenze asiatiche (in particolare dell’India) ecco il libro di Catia Dini, Al servizio del cosmo (EMI, Bologna, 1998), che ci presenta delle esperienze di autogestione nei villaggi indiani secondo lo spirito di Gandhi. Dini ci fa riflettere su come il modello di sviluppo occidentale abbia provocato in pochi decenni danni ambientali irreparabili e vistose lacerazioni sociali in tutto il pianeta. Gandhi aveva invece individuato, già all’inizio del secolo scorso, un modello alternativo fondato su uno sviluppo rurale con epicentro il villaggio indiano, attraverso l’impiego di appropriate tecnologie alternative e un modello particolare di produzione egualitaria, il decentramento economico fondato sulla centralità artigianale, una distribuzione caratteristica di relazioni più consapevoli e autogestite. Ma soprattutto tutto questo legato a una distribuzione condivisa e partecipata della ricchezza in armonia coerente con l’etica, la cultura, la religione, l’educazione e l’amicizia in ambito famigliare e sociale, caratteristiche del contesto indiano. Il libro traccia insomma una panoramica significativa della realtà indiana che non appare nelle descrizioni ufficiali dei governi e degli enti internazionali ma proprio per questo si dimostra veramente interessante e utile.




ONG e società civile implementano e realizzano micro-imprese, associazioni di credito e di risparmio, cooperative, movimenti rurali e urbani, che vanno nella direzione per noi interessante, seppure con le contraddizioni che possiamo immaginare, di creare e sperimentare qui e ora un modo diverso e più autentico di vivere i principi libertari. Nel libro si affrontano anche le problematiche che inevitabilmente emergono quando si opera concretamente in senso antiautoritario e partecipato, all’interno di uno stato che si regge, come tutti gli stati, su altri presupposti e altre relazioni. Interessanti sono inoltre le parti del testo che ci rappresentano la condizione femminile e quella del sistema educativo, l’organizzazione del sistema sanitario e la gestione delle foreste e dell’agricoltura biologica, la funzione delle banche e la gestione del credito in modo diverso da quello ufficiale. Insomma un testo che può aiutarci a capire meglio sia in positivo che nelle contraddizioni ciò che significa agire altrimenti con uno sguardo obliquo rispetto a quello del potere.
Spostandoci decisamente di contesto, ma sostanzialmente rimanendo nel campo delle sperimentazioni, è opportuno leggere il libro di James Horrox, Le mouvement des kibboutz et l’anarchie. Une révolution vivante (éditions de l’éclat, 2018) sfortunatamente non tradotto in italiano (edizione originale: A Living Revolution. Anarchism in the Kibbutz Movement, AK Press, Oakland, 2009). Horrox ci ricorda che il movimento dei Kibbutz prende forma in Palestina sotto la dominazione ottomana a partire dal 1910 per diventare, a suo giudizio, una delle esperienze di vita comunitaria e di progresso sociale più interessanti del XX secolo in contesto occidentale. L’autore ricostruisce l’origine di questo movimento anche nelle sue forme ispiratrici riconducendolo alle idee di Kropotkin e Landauer intorno alle quali si orientò una parte consistente dei pionieri che sono stati i protagonisti di questa sperimentazione di stampo libertario. Il progetto del Kibbutz infatti si lega non solo a una voglia di vivere in modo comunitario la propria vita, ma soprattutto a un’idea più ampia di trasformazione sociale caratterizzata in senso libertario.




Dopo averci raccontato le origini e gli anni d’oro di questo movimento, Horrox ci rappresenta anche il declino dell’aspetto più rivoluzionario, facendolo risalire a partire dagli anni Ottanta, in cui si determina una trasformazione di alcune caratteristiche più innovative sul piano delle relazioni sociali di stampo egualitario in una realtà più marcatamente di stampo capitalistico. L’autore, nell’ultima parte del testo, fa emergere però un vento nuovo che attraversa alcune di queste esperienze. Una nuova alba dell’originale struttura comunitaria sta emergendo, non senza evidenti difficoltà, all’inizio del nuovo secolo a testimonianza, come sostiene Horrox, di una singolare vitalità di questa terra così martoriata dal dolore e dalle contraddizioni. L’autore nell’ultimo capitolo dà conto sia in termini di pensiero che di quantità e qualità di un rinascente, seppur minoritario, movimento di giovani che si identificano in una storia di comunitarismo libertario e dei rapporti che essi intrattengono con il pur flebile movimento anarchico israeliano. Per chi volesse approfondire il rapporto tra anarchismo ed ebraismo suggerisco, tra l’altro, la lettura del bel volume curato da Amedeo Bertolo, L’anarchico e l’ebreo. Storia di un incontro, (elèuthera, Milano, 2001).
Facendo un passo indietro nella storia di un pensiero anarchico prefigurativo, consiglio la lettura del testo di Paul Reclus, Plus loin que la politique, (Héros-Limite, Genève, 2020). Paul, ingegnere e professore, nipote di Elisée Reclus, nasce nel 1858 e muore nel 1941. Nonostante il momento storico, ancora caratterizzato da un anarchismo classico e tradizionale, con acume e lungimiranza affronta l’idea prefigurativa con accorta sensibilità, senza cadere nell’utopismo inconcludente e senza cedere a tentazioni strettamente istituzionali e stataliste. Considerando la Politica come tecnica di gestione del dominio, Paul Reclus si propone, in questi scritti scelti qui raccolti, di suggerire un’organizzazione della vita sociale a livello comunale e federalista caratterizzata in senso libertario. Affronta infatti i diversi aspetti dell’organizzazione comunale – agricoltura, industria, insegnamento, trasporti, giustizia, fiscalità, ecc. – con un approccio alternativo a quello



125

proprio dello Stato. Cerca insomma di suggerire concretamente come si potrebbe realizzare una organizzazione comunale libertaria in una prospettiva federalista e confederalista. Si tratta di creare, a sua convinzione, un nuovo modello di organizzazione fondata su principi come il mutuo appoggio, la solidarietà, la cooperazione in un quadro di riferimento decisamente libertario e condiviso. Si tratta di scritti che ovviamente si riferiscono alle condizioni reali di un’epoca novecentesca e che non possono tener conto di quanto oggi la situazione sia per molti aspetti decisamente cambiata, ma il suo approccio è marcato da un metodo e da una professionalità che evita di scivolare in una prospettiva immaginativa di carattere astrattamente utopico. Questo fatto rende questi articoli, pubblicati nella rivista «Plus loin» tra l’aprile del 1925 e il maggio del 1939, utili e attuali ancora oggi per chi scelga di approfondire e di caratterizzare il suo pensiero libertario in una prospettiva propositiva e prefigurativa.
Questi temi che in questi (e altri) libri hanno trovato spazio dovrebbero essere letti con l’aiuto prezioso di alcune riflessioni decisamente importanti contenute nel volume di Murray Bookchin, Dall’urbanizzazione alle città (elèuthera, Milano, 2023), appena editato in lingua italiana. Testo corposo, documentato, ricco di spunti e di riflessioni: un’opera ricchissima finalmente fruibile ai lettori italiani. Bookchin ricostruisce in modo originale la storia dello sviluppo urbano dimostrando, con esempi e importante documentazione, come le città non siano sempre state quelle che noi viviamo oggi, caratterizzate per la loro funzionalità in termini capitalistici e di consumo individuale. Le città sono nate e state piuttosto lo spazio e il luogo della convivenza, del confronto, dello scambio, insomma della democrazia diretta. Prima dell’avvento delle megalopoli la vita dei cittadini si caratterizzava più nel senso del mutualismo che in quello della competizione, riproducendo uno schema relazionale mutuato dai sistemi ambientali, dagli ecosistemi. Seguendo questa chiave interpretativa, Bookchin rivendica il diritto (dovere etico) per il popolo libero delle



città di riappropriarsi del loro status di uomini e donne libere, vero corpo vivente della democrazia, al fine di contrastare quel concetto di cittadinanza proprio di un sistema burocratico e statalista, capitalista e consumista, che si è invece imposto nel tempo. I cittadini sono stati progressivamente trasformati in elettori e in clienti, venendo così deprivati degli spazi e dei modi che caratterizzano una vera democrazia diretta e solidale. Per intraprendere questa strada di emancipazione e di riscoperta del senso profondo e vero di cittadinanza è necessario, secondo Bookchin, re-inventare un nuovo municipalismo libertario consapevole della sua storia, ricca di esempi e di esperienze significative nel passato e nel presente. Solo questa strada potrà riportare la «politica» alle sue origini nobili e corrette: non più arte di governo (dei pochi sui molti) in mano a professionisti e burocrati del potere, ma effettiva pratica di autodeterminazione quotidiana dei cittadini. Insomma, un libro da leggere e su cui discutere in ambito ampio e condiviso per poter affrontare le sfide odierne in una prospettiva, appunto, propositiva e prefigurativa.





