Numero Completo 05
Semi sotto la neve Rivista libertaria Numero 5 giugno 2023
Reg. trib. di Belluno n. 2 del 2021 (RGNC n. 1412/2021 del registro stampa) Dir. Resp. Antonio Senta Pubblicazione a cura dell’APS Semi sotto la neve
In copertina e all’interno: illustrazioni di Vittorio D’Augusta ritratti di Roberto de Grandis e foto autoprodotte
Prezzo di una copia 7 euro
Chi desidera ricevere una o più copie della rivista scriva a: semisottolaneve@riseup.net Per riceverla regolarmente (tre numeri l’anno) e essere aggiornati sulle attività dell’associazione, chiediamo un contributo di 20, 30, 50 o 100 euro in base alle proprie possibilità
Per versamenti: APS Semi sotto la neve IBAN: IT70 H085 1105 6390 0000 0044 009 BIC: CCRTIT2T95A CAUSALE: contributo
| Esperienze | ||
|---|---|---|
| ·Bauhäusle | A. Franchini e S. Shimizu | 9 |
| Architettura come processo sociale | ||
| ·Hacklabbo | A. Soto e Micorriza | 22 |
| Un esempio di autogestione delle tecnologie informatiche | ||
| ·Tana libera tutti | Thea Venturelli | 31 |
| Scuola libertaria a Parma | ||
| Approfondimenti | ||
| ·Gli ecomusei | Valeria Giacomoni | 41 |
| Una proposta alternativa al turismo di massa | ||
| ·Stratocaster o Balalaika? | Felice Liperi | 51 |
| Per uno sguardo sonoro sul conflitto in Ucraina | ||
| ·L’Iran e l’Islam politico | Amir Khosravi | 59 |
| Una lotta continua per la libertà | ||
| ·Come vuoi essere punito? | Antonello Azzarà | 68 |
| Le alternative al carcere tra disciplina ed esclusione | ||
| Conversazione | ||
| con Pino Cacucci | a cura di Chiara Gazzola | 77 |
| Internazionale | ||
| ·Hippies neoliberisti | Luca Bognanni | 91 |
| Lavorare dai paesi di vacanza | ||
| Radici | ||
| ·Carlo Rosselli | Nicola Del Corno | 97 |
| ·Simone Weil | Flavio Lazzarin | 101 |
| Recensioni | ||
| ·Leggere l’anarchia | F. C. | 109 |
| ·Il camionista e l’anarchia. Un libro e oltre | Franco Melandri | 114 |

Editoriale
In un articolo pubblicato nella rivista «Interrogations» nel lontano 1975, Giampietro (Nico) Berti coniò questa felice espressione per descrivere, in estrema sintesi, la natura e la vocazione più profonda dell’anarchismo: «nella Storia, ma contro la Storia». L’anarchismo, movimento politico volto alla trasformazione rivoluzionaria della società in vista della realizzazione di una società contrassegnata dal socialismo libertario, fondata sull’autogestione dei produttori e la cooperazione volontaria ed egualitaria degli individui e dei gruppi sociali, si è posto fin dal suo costituirsi nella storia a fianco delle classi oppresse e sfruttate, dei movimenti di emancipazione, di rivolta e sovversione dell’ordine costituito, per contribuire al cambiamento politico e sociale auspicato; al contempo, si è sempre manifestato – e sempre si manifesterà – contro la storia, in quanto sua caratteristica precipua è quella di negare sul piano teorico la legittimità morale e politica del principio del dominio e di ogni forma di rapporto gerarchico tra gli esseri umani; di contestare, dunque, ogni manifestazione storica e politica di tale principio: passata, presente e futura.
Ciò che si è determinato, nel corso degli ultimi decenni, è che, per un concorso complesso di circostanze, che non è possibile analizzare in questa sede, l’anarchismo è progressivamente e mestamente scivolato fuori dalla storia. Il tramonto delle ideologie rivoluzionarie, il crollo verticale della capacità utopica e immaginativa della società, la bancarotta del comunismo realizzato, l’impossibilità o incapacità di disegnare un percorso di lotta e di trasformazione sociale complementare e alternativo a quello fatto proprio da gran parte dell’anarchismo storico di matrice socialista a cavallo tra Otto e Novecento, hanno spinto ai margini il movimento anarchico, riducendone la reale capacità di incidere nella storia.
Molte riflessioni sono state spese recentemente su questo fondamentale e dirimente punto. Il nostro contributo, come chi ci segue fin dall’inizio di questa avventura editoriale ben sa, muove appunto da questo quesito: posto che l’anarchia, ossia una società di liberi, uguali, sorelle e fratelli, non può che costituire l’orizzonte regolativo, la stella polare, la bussola necessaria a orientare il cammino del più generoso progetto di emancipazione sociale mai concepito, come è possibile, oggi, restituire attualità all’anarchismo, far sì che esso torni a essere un protagonista credibile ed efficace nella storia, condizione a sua volta ineludibile per chi abbia l’ambizione di porsi con altrettanta efficacia e credibilità contro la storia?
La risposta – alla luce dell’esperienza storica, della riflessione teorica, del buon senso (rivoluzionario), di un approccio sistematicamente non-ideologico e non dogmatico – risiede nel valorizzare, connettere, interrogare i semi di libertà che prefigurano, qui e ora, un mondo nuovo e diverso, per molti aspetti alternativo a quello, in crisi profonda, se non in disfacimento, in cui oggi viviamo, delle democrazie avanzate, dei vecchi e nuovi regimi autoritari, dell’economia capitalista estesa su scala globale.
Ci è sembrato e ci sembra più proficuo raccontare esperienze ed esperimenti di libertà, uguaglianza e solidarietà realizzati, piuttosto che insistere troppo sulla, o limitarsi alla, critica negativa e demolitrice della attuale società e delle sue istituzioni, peraltro sempre più precarie. Per certi versi, abbiamo adottato, e chiediamo ai nostri lettori, un cambiamento di paradigma: la critica della società non deve emergere principalmente da un discorso ideologico, fattosi negli anni troppo spesso incomprensibile e autoreferenziale, ma, esplicitamente o implicitamente, dall’affermazione positiva e in parte realizzata di un modo diverso di vivere, lavorare, socializzare.
Anche in questa quinta uscita della nostra rivista, i lettori vecchi e nuovi – che speriamo sempre più numerosi – sapranno cogliere questo spirito costruttivo nei vari articoli che sono andati a formare il numero. Tale spirito è il vero collante tra contributi che esprimono, inevitabilmente, sensibilità parzialmente difformi: infiniti sono i colori e le sfumature della libertà e il libero pensiero teorizza e pratica la diversità come un valore. Non teme il libero confronto delle idee, ma lo sollecita. Non respinge la concordia discors, ma la ricerca incessantemente.
Crediamo fermamente nel principio della sovranità del lettore: il quale arriverà alla sua «verità» – ci auguriamo – anche grazie agli strumenti, alle informazioni e alle indicazioni che la nostra piccola rivista saprà fornirgli, nella lucida consapevolezza che i temi trattati in ogni numero sono spesso, obiettivamente, molto complessi: si tratta di questioni che necessitano di diversi approfondimenti e riflessioni. Meritano di essere ripresi e analizzati da angolature diverse. Così stiamo facendo e faremo.
In questo numero, nelle Esperienze: Thea Venturelli descrive e interroga Tana libera tutti, scuola libertaria di Parma, appartenente alla Rete per l’Educazione Libertaria. Una scuola che copre l’arco cronologico-educativo che va dalla materna alla primaria, fondata sulla sperimentazione continua, su un rapporto non gerarchico tra docente e discente, sui concetti di genitorialità condivisa e comunità auto-educante, sull’educazione del bambino alla, e nella, autonomia. Alberto Franchini e Shunsuke Shimizu illustrano un interessante esperimento di architettura partecipata e, in un certo senso, di anarchia realizzata: il dormitorio studentesco di Bauhäusle, presso Stoccarda, nato e sviluppatosi negli anni Ottanta del secolo scorso grazie alla collaborazione di oltre 200 studenti con alcuni docenti dell’Istituto per l’edilizia e la progettazione. La «cacofonia visiva» che ne è nata è un esempio emblematico di come l’ordine e l’equilibrio possano sorgere da una combinazione variabile di spontaneità e organizzazione, in un contesto rigorosamente non-gerarchico. A. Soto e Micorriza ci introducono ad Hacklabbo, laboratorio hacker di Bologna, che lotta per la libera circolazione dell’informazione, il diritto alla privacy e all’anonimato ma, contemporaneamente, anche per la condivisione delle conoscenze tramite l’autoproduzione di infrastrutture digitali e comunicazioni autonome fondate sulla partecipazione.
Negli Approfondimenti: Valeria Giacomoni racconta, con particolare riferimento al Trentino, la nascita e lo sviluppo degli ecomusei, esempi di partecipazione popolare alla memoria storica, ambientale, artistica, di un dato luogo, nell’ambito di una pianificazione territoriale dal basso. Felice Liperi ritorna sul tema delle contraddizioni legate al sentimento antiamericano che complica la lettura del perdurante e lacerante conflitto ucraino, che ha assunto sin dall’inizio una importanza mondiale. Amir Khosravi si occupa del caso iraniano, delineando permanenze e mutamenti del rapporto tra religione e potere a partire dall’introduzione dell’islam in terra persiana, trattando la questione della laicità, quella delle donne e descrivendo i caratteri dell’indomito movimento di protesta (ri)iniziato con il barbaro e grottesco assassinio di Mahsa Amini, causato da una ciocca di capelli fuori posto. Antonello Azzarà affronta il tema delle misure alternative al carcere con riferimento al caso italiano, sottolineando i pregi, ma anche i limiti, di questa misura punitiva, della quale non possono beneficiare i detenuti stranieri e i nullatenenti e che si inserisce in un ordinamento di cui auspichiamo la completa depenalizzazione. Invece, forte del sostegno di una opinione pubblica in larga misura orientata in senso forcaiolo, sdoganatasi soprattutto negli ultimi decenni, lo Stato italiano sembra voler andare in tutt’altra direzione.
Nella Conversazione Chiara Gazzola dialoga con Pino Cacucci, scrittore e traduttore di grande reputazione e successo, autore da sempre vicino agli ideali libertari, ribaditi anche in questa sede: al centro della conversazione l’ultima ponderosa fatica dell’autore bolognese, L’elbano errante, romanzo storico che rivela il lato oscuro del Rinascimento, stagione di risorgimento culturale ma anche di massacri e guerre interminabili sotto il segno del fanatismo religioso.
Nell’Internazionale Luca Bognanni denuncia la falsa liberazione promossa e promessa dagli «hippies neoliberisti», nomadi digitali del tutto funzionali al sistema che affermano di contestare, ma dal quale in realtà si preoccupano di trarre il massimo profitto col minimo sforzo.
Nelle Radici il lettore troverà la presentazione di due grandi figure appartenenti, ciascuno a suo modo, a una corrente di pensiero più ampia dell’anarchismo, che non è improprio definire libertaria. Corrente che la rivista intende valorizzare e far conoscere, perché crede nella proficua contaminazione delle idee e vi ritrova una inappagabile aria di famiglia: la filosofa e teologa Simone Weil, miliziana della colonna Durruti durante la guerra civile e rivoluzione spagnola, implacabile critica della statolatria marxista ma anche dell’individualismo liberale e democratico, introdotta da Flavio Lazzarin; l’attivista e scrittore Carlo Rosselli, critico e revisore del marxismo, fautore di un socialismo liberale, democratico e federalista che molti punti in comune presenta con l’anarchismo critico elaborato in quegli anni dall’amico Camillo Berneri: Nicola Del Corno chiarisce l’insopprimibile anelito libertario dell’animatore di «Giustizia e Libertà».
Un gruppo di recensioni, a opera di Francesco Codello e Franco Melandri, invita infine il lettore a trarre utili spunti di analisi e di azione da vecchi e nuovi volumi: Anarchia come organizzazione, di Colin Ward; Anarchia e cooperazione. Alle origini di un rapporto (1861-1914), di Antonio Senta; Dallo Stato alla comunità: il mondo di domani, di John Clark; i Discorsi sull’autogoverno di Matthew Wilson.
Concludiamo rinnovando l’invito a sostenerci, soprattutto tramite abbonamenti, e ad aiutarci a diffondere la rivista, contribuendo, così, alla circolazione delle idee per le quali si batte.

Bauhäusle. Architettura come processo sociale
Alberto Franchini e Shunsuke Shimizu
Bauhäusle non è solo uno dei dormitori studenteschi più popolari del campus suburbano di Vaihingen presso Stoccarda, ma è anche uno di quelli in cui si può riconoscere un forte senso di comunità basato su principi come l’auto-organizzazione, la condivisione del cibo e l’ecologia.
Il recente anniversario dei 40 anni ci offre un’occasione per riflettere su questo luogo non comune in cui l’architettura ha svolto un ruolo centrale nel processo di creazione di questa particolare comunità malgrado il rapido avvicendamento dei suoi abitanti. Gli studenti che vi abitano attualmente hanno organizzato una settimana di festeggiamenti, tra il 3 e l'8 luglio 2022, con l’apertura dello studentato, una mostra con padiglione auto-costruito per spiegare il principio costruttivo, visite guidate, feste, concerti e altri eventi che hanno visto la partecipazione di studenti, visitatori curiosi, vecchi e nuovi abitanti. La presenza di ex abitanti testimonia il forte senso di appartenenza che questo edificio, con il suo processo progettuale condiviso, il suo peculiare metodo di auto-costruzione, auto-manutenzione e la sua particolare organiz-
zazione, è in grado di trasmettere. Lo scopo di questo breve articolo è raccontare le strategie adottate per attivare varie forme di interazione sociale tra gli abitanti, descrivere il modo in cui essi si identificano nello spazio attraverso la sua modificazione e rendere conto del modo in cui l’edificio viene abitato e governato oggi.
Lernen durch selberbauen (imparare costruendo da sé)
Questo dormitorio è il risultato delle idee e del lavoro di circa 220 studenti del corso di Baukonstruktion I (costruzione edile) dei professori Peter Sulzer e Peter Hübner, dell’Institut für Baukonstruktion und Entwerfen (Istituto per l’edilizia e la progettazione). Questi professori avevano deciso all’inizio degli anni ottanta di basare il loro insegnamento sul motto Lernen durch selberbauen (imparare costruendo da sé) e hanno seguito la richiesta di alcuni studenti del primo anno di progettare e costruire il proprio alloggio per far fronte alla difficoltà di trovare delle camere in affitto. Da quel momento in poi agli studenti del loro corso è stato chiesto di progettare una stanza per se stessi, imparando bisogni, dimensioni e movimenti del corpo.
Alla base di questo esperimento architettonico c’è una precisa idea pedagogica: per insegnare l’architettura e la sua costruzione non basta formare gli studenti attraverso disegni e progetti simulati, ma è necessario seguirli nell’adempimento di un compito reale, sia attraverso la progettazione, utilizzando anche modelli in scala, sia con l’autocostruzione. Questo concetto non è lontano da quello di Learning by doing del pedagogista e filosofo americano John Dewey o da quello meno noto di «Università produttiva» dello storico dell’architettura italiano Bruno Zevi. Gli studenti iscritti al corso erano divisi in diversi gruppi, ciascuno supervisionato da un professore o assistente. Ogni gruppo era autonomo nella progettazione e nella realizzazione di una propria tipologia di stanze con i propri materiali costruttivi, tecnica e forma specifici. Tra un gruppo di stanze e l’altro venivano lasciati intenzionalmente degli spazi vuoti, colmati con altre stanze nel corso del cantiere, per evitare discussioni tra i gruppi sul posizionamento dei muri di partizione. Il processo decisionale che porta al risultato finale è quindi tutto all’interno del gruppo ed è soprattutto grazie a questa micro scala sociale che è in gioco la capacità dei singoli di mediare tra posizioni diverse e arrivare a una soluzione condivisa da tutti i membri del gruppo.
Le differenze tra i lavori dei vari gruppi sono ben visibili dall’esterno e ci raccontano come qui gli architetti abbiano rinunciato alla loro autorialità per lasciare spazio a una creatività collettiva di tipo particolare, in cui il risultato finale complessivo è una forma composita fatta di idee e forme diverse non predeterminato da nessuno: non si tratta di un risultato uniforme come nei banali dormitori istituzionali in cui committenti e architetti decidono per gli utenti cosa è meglio per loro, come se avessero tutti le stesse esigenze e stili di vita.
Qui l’intera costruzione è suddivisa in parti controllate dai singoli gruppi e l’esito globale è un lavoro corale in cui le parti, non essendo in perfetto accordo tra loro, creano una sorta di cacofonia visiva. Il risultato complessivo non è risolto in modo tradizionale, dove la forma è conclusa in se stessa e talvolta autoreferenziale, ma le sue parti sono semplicemente giustapposte l’una all’altra in un modo che crea molte tensioni e attriti. Questa strategia può essere vista come vitale per questa antidogmatica comunità di studenti, perché, ad esempio, i molti interstizi hanno stimolato la loro creatività per costruire nuovi spazi intermedi di mediazione tra interno ed esterno, ampliando le possibilità di interazione tra architettura e natura.

La libertà creativa che si può notare in tutte le diverse soluzioni è stata possibile perché il Bauhäusle è stato classificato come edificio sperimentale temporaneo e per questo motivo non è stata richiesta la licenza edilizia che avrebbe imposto limitazioni sull’aspetto degli edifici. Questa condizione non è affatto secondaria e va considerata come un punto di partenza fondamentale per proporre modelli abitativi alternativi come quello in questione. D’altra parte, anche il lavoro degli studenti deve essere considerato una condizione essenziale per la comprensione di quest’opera. Il fattore umano è specifico e caratterizza in modo peculiare questa esperienza. Si pensi, ad esempio, alla loro maggiore capacità immaginativa rispetto a persone che in altre fasi della loro vita sono più soggette ai condizionamenti della società.
La forma architettonica è sempre il risultato di uno specifico processo organizzativo del lavoro, che può essere più o meno sostenibile dal punto di vista etico, sociale ed economico. In questo caso, la forma è espressione diretta di una particolare organizzazione del lavoro che valorizza il contributo creativo dei futuri abitanti e rifugge dalle convenzioni tipiche del settore edilizio, in cui l’architetto, o spesso il committente, ha l’ultima parola e decide il risultato finale. L’artefatto costruito è quindi una critica involontaria ai normali processi e appalti che caratterizzano il settore delle costruzioni, come ricorda lo storico dell’architettura Peter Blundell Jones.
Il ruolo dell’architetto con quest’esempio si sposta da quello tradizionale di autore solitario e individualista, che controlla dall’alto verso il basso il risultato formale (come Howard Roark, protagonista di The Fountainhead, il best seller scritto da
L’artefatto costruito è quindi una critica involontaria ai normali processi e appalti che caratterizzano il settore delle costruzioni
Ayn Rand), a una figura professionale multidisciplinare, a metà tra architettura e scienze sociali, incaricata di supervisionare e organizzare l’intero processo, dalla progettazione all’autocostruzione. Gli abitanti – opportunamente organizzati e diretti – vi hanno un ruolo attivo e creativo, che si può vedere nel risultato finale realizzato, ma anche nel forte senso di comunità che comunicano le persone con il loro stile di vita.
Un aspetto fondamentale, che ci fa capire il lavoro essenziale e sottile di Sulzer e Hübner nel dirigere gli studenti, riguarda la volontà di rendere possibile la percezione delle attività comuni pur mantenendo l’alto grado di privacy desiderato all’interno delle singole stanze. I trenta appartamenti sono completamente separati dagli spazi comuni da due corridoi che corrono su entrambi i lati della cucina, il che garantisce la privacy in ogni stanza. D’altra parte, molte delle stanze sono progettate con piccole finestre che danno sulla cucina, ovvero lo spazio comunitario
più importante. Quando si esce di casa o si va alla toilette, si passa sempre per la cucina, moltiplicando le opportunità di incontri casuali.
Le trenta camere della versione definitiva sono disposte in otto gruppi e, come già osservato, sono collegate da due corridoi paralleli che racchiudono gli spazi comuni: due bagni e due cucine. Questa struttura è stata progettaQuando si esce di casa o si va alla toilette, si passa sempre per la cucina, moltiplicando le opportunità di incontri casuali
ta dal personale dell’Istituto ed è stata realizzata con il metodo costruttivo di Walter Segal. Un metodo di autocostruzione che utilizza una struttura in legno concepita per essere abbastanza semplice da permettere alla gente comune di costruire la propria casa, anche senza precedenti esperienze nel campo dell’edilizia. Questa parte è stata la prima a essere costruita nell’estate del 1981 e, nonostante l’adozione del metodo Segal, è stata l’unica a essere eretta dagli appaltatori per risparmiare tempo e fornire una prima base di lavoro. Le altre parti eseguite dagli appaltatori sono state l’impianto idraulico e l’impianto elettrico, mentre tutto il resto, come le fondazioni, la carpenteria, la muratura, l’intonaco, l’isolamento, la piastrellatura, è stato eseguito dal personale e dagli studenti. I lavori di costruzione sono stati completati nel 1983.
Auto-manutenzione e personalizzazione
Lo spazio interno è ancora più complesso di quello esterno perché esprime l’individualità degli studenti coinvolti nella sua ideazione e realizzazione, ma anche lo stile di vita degli attuali abitanti che nel corso del tempo hanno apportato numerose modifiche, per adattare le stanze alle loro esigenze. Le camere da 15 a 28 metri quadrati sono delle specie di maisonette (duplex) con terrazze annesse, che offrono un ambiente di vita molto ricco e particolare se confrontato con altri dormitori per studenti dello stesso campus, in cui gli spazi interni sono molto più distaccati dagli esterni. In questo progetto gli esterni devono essere visti come una naturale continuazione degli interni, se non addirittura un loro completamento, sia per quanto riguarda le terrazze di pertinenza delle singole camere sia per gli spazi comuni situati in tutte le direzioni.
Per questi motivi è difficile immaginare che il «Bauhäusle» sia una delle residenze per studenti meno costose dell’area di Stoccarda, con soli 300 euro al mese nel 2022. Inoltre, è importante sottolineare che gli studenti possono persino ottenere uno sconto sul prezzo di affitto se mantengono il loro dormitorio da soli. Tuttavia, non dobbiamo vedere la pratica della manutenzione solo da un punto di vista economico, ma come un prendersi cura dell’edificio che avvicina le persone al luogo e che le avvicina tra loro, ad esempio nelle operazioni più complesse o per le parti comuni.
Per ridurre drasticamente i costi, i materiali utilizzati nella costruzione originale provengono principalmente da prodotti di massa standardizzati, utilizzati direttamente «dallo scaffale» senza tagli, e in minima parte da articoli di scarto, in esubero e di seconda mano. Gli stessi prodotti standard possono essere facilmente acquistati nei negozi di bricolage ancora oggi e di solito sono anche immagazzinati e direttamente accessibili ai residenti in un capanno degli attrezzi, costruito nelle immediate vicinanze dell’edificio originale nel 1993.

Grazie al metodo di costruzione semplificato, gli studenti possono provvedere da soli alla manutenzione dell’edificio. In altre parole, se un edificio si rompe, gli studenti sono in grado di riconoscerne la causa e di ripararlo immediatamente. Ad esempio, una volta al mese si tiene il Bausonntag (la domenica della costruzione), il giorno in cui gli studenti lavorano insieme per riparare l’edificio. Anche se gli studenti che studiano architettura in questo dormitorio sono pochi, imparano il fai-da-te grazie a queste opportunità di riparazioni quotidiane e accrescono il proprio senso di appartenenza al dormitorio.
Molti degli spazi unici degli studenti sono il risultato della personalizzazione attraverso la costruzione di mobili fai-da-te. Uno studente di economia dell’informazione afferma: «L’importante per il bricolage spontaneo è avere a disposizione materiali e strumenti nel capanno degli attrezzi, improvvisare e testare l’assemblaggio, piuttosto che pianificare e poi ordinare i materiali». Durante la sua residenza quinquennale, ha realizzato qualsiasi tipo di bricolage, dagli scaffali ai tavoli per la visione delle piante, dalle scrivanie per lo studio alle terrazze sul tetto.
Uno studente di ingegneria aerospaziale, residente da un solo anno, ha realizzato una semplice struttura espositiva fai-da-te per conservare ed esporre il suo hobby: le biciclette. A volte ha anche contribuito a progetti relativamente grandi per la ristrutturazione di questo dormitorio.
I grandi progetti come la terrazza, il giardino d’inverno, la cucina e il rifacimento del tetto vengono realizzati insieme; nel 2019, il giardino d’inverno è stato ricostruito in collaborazione con un falegname professionista. Gli studenti si sono riuniti per progettare il nuovo giardino d’inverno e la costruzione è proseguita mentre i professionisti supervisionavano l’uso degli attrezzi e il montaggio.
Questo modo di prendersi cura dei propri spazi abitativi e delle loro strutture è raro in una società consumistica dominata dal capitalismo
Uno studente che studia economia sociale dice: «Se trascorri un totale di 50 ore al Bauhäusle lavorando al progetto di ristrutturazione, puoi prolungare il tuo contratto per sei mesi». Questo è un altro meccanismo intelligente per incoraggiare gli studenti a partecipare al lavoro manuale e per mantenere vivo lo spirito originario dei primi abitanti che avevano costruito il proprio dormitorio, nell’idea implicita che il lavoro manuale è un potente veicolo
per la creazione di un profondo senso di appartenenza.
Pertanto, gli studenti vivono insieme in una vera e propria comunità sostenendosi a vicenda. Questo modo di prendersi cura dei propri spazi abitativi e delle loro strutture è raro in una società consumistica dominata dal capitalismo, dove si assiste a una dispersione di conoscenze e competenze, oltre che a un’iper-specializzazione che concorre alla creazione di non-luoghi. Questo esempio, al contrario, è un modello di crescita alternativo per le città, basato sulla vita comunitaria e su un grande senso di appartenenza.
Auto-organizzazione
Questo edificio, di proprietà dell’università, è gestito autonomamente dagli studenti che vi abitano. Undici Ämter (incaricati) sono responsabili dei progetti di costruzione e dell’acquisto dei materiali. All’inizio di ogni semestre vengono eletti in media due studenti per ogni incarico.
Il Wohnheimssprecher (portavoce del dormitorio) è l’Ämter più importante, perché è responsabile dell’intero funzionamento del Bauhäusle, dalla presidenza delle riunioni periodiche (almeno due volte a semestre) alla contabilità, fino alla gestione della comunicazione stampa. Qui vengono discusse tutte le questioni più scottanti, come la selezione del nuovo «Ämter» e le questioni che riguardano i residenti votati. Le grandi responsabilità di questo «Ämter» consentono agli studenti di prolungare di un anno il loro soggiorno.
Il Wohnheimsreferent (referente del dormitorio) gestisce le informazioni degli studenti, come le informazioni di contatto, il nome, la specializzazione, l’anno accademico e così via, i traslochi, ma anche tutti i subaffitti e gli spostamenti all’interno dello studentato. Questa figura funge da collegamento tra gli studenti e lo Studierendenwerk responsabile.

Lo Studierendenwerk è l’associazione studentesca che gestisce i dormitori e che in ultima analisi firma il contratto di locazione. Il referente di questo Wohnheim (dormitorio) deve anche organizzare visite guidate per presentare il dormitorio ai futuri studenti. Anche questa posizione dà diritto al prolungamento del soggiorno di un anno.
Il Materialamt (addetto ai materiali) e il Baututor (tutor edile) svolgono un ruolo importante per rendere possibili i progetti di bricolage nel Bauhäusle. I loro compiti sono la manutenzione e l’acquisto degli attrezzi, l’insegnamento del loro utilizzo, la cura dell’intero dormitorio, l’organizzazione del Bausonntag (domenica della costruzione) e l’incoraggiamento degli studenti a partecipare ai lavori di ristrutturazione. I Baututor conoscono come è costruito il Bauhäusle e sanno come ripararlo in caso di necessità. Anche se la maggior parte degli studenti di questo Ämter non ha mai studiato architettura, si diverte con i lavori e acquisisce familiarità con l’architettura, trasmettendo questo sapere alle generazioni future. Come abbiamo potuto capire parlando con alcuni di loro questo processo è ben consolidato e ben funzionante.
Nel Bauhäusle gli studenti residenti acquisiscono un senso di responsabilità per la loro casa, partecipando alla gestione del loro dormitorio con compiti suddivisi. Questo permette loro di gestire la casa senza problemi, evitando i conflitti. Inoltre, eventi come i progetti di riparazione del dormitorio e le riunioni regolari offrono agli studenti l’opportunità di pensare e discutere insieme riguardo al dormitorio, contribuendo a creare un senso di comunità tra i residenti.
Consapevolezza ecologica
Uno studente che ha soggiornato in questo dormitorio per più di cinque anni e ha studiato Sviluppo energetico si definisce un «vegano del food sharing». In pratica si rifornisce di cibo solo con il food sharing (movimento di ridistribuzione del cibo in eccedenza, ndr), poiché Bauhäusle è membro di foodsharing.de. Ci sono diversi studenti che partecipano attivamente a questo movimento e di solito vanno in giro per la città in bicicletta a raccogliere le eccedenze. Le grandi quantità di cibo raccolto vengono messe vicino all’ingresso del dormitorio e distribuite agli studenti del Bauhäusle e ai vicini. Pane, verdure, insalate e carne, che altrimenti sarebbero sprecati, sono messi a disposizione gratuitamente. Questa attività ha rafforzato il pensiero ecologico degli studenti del dormitorio.
Gli studenti del «Bauhäusle» insistono anche sul consumo di verdure coltivate localmente. Molti di loro sono membri di So-LaWi (Solidarische Landwirtschaft, Agricoltura solidale). Aderendo a SoLaWi, si assumono la responsabilità comune della

produzione delle aziende agricole locali affiliate all’organizzazione. Ortaggi, cereali, carne, latte e altri prodotti coltivati e allevati con metodi biologici da aziende agricole locali vengono forniti agli investitori. Il Bauhäusle riceve quindi regolarmente prodotti regionali dalle aziende agricole partner e funge anche da punto di distribuzione.
La maggior parte degli abitanti del Bauhäusle acquisisce o rinforza la propria consapevolezza ecologica durante la sua permanenza in questa struttura poiché passa gran parte della propria vita a contatto con gli altri inquilini, specialmente negli spazi delle cucine al centro del dormitorio, dove la questione del rifornimento di cibo è essenziale ed è decisa in comune. Una studentessa di ingegneria aerospaziale, che vive qui da più di cinque anni, ha raccontato di dover passare attraverso la cucina per uscire all’aperto e che quindi capita spesso di incontrare altre persone per caso nella vita quotidiana. Ha anche detto che questa struttura è un po’ diversa dal precedente dormitorio in cui ha vissuto, perché lì doveva entrare in cucina intenzionalmente e quindi c’erano pochi incontri casuali.
D’altra parte, un’altra studentessa ha detto di essersi interessata allo stile di vita ecologico, come quello vegano, la condivisione del cibo, il «Solawi» e così via, dopo essere entrata in questo dormitorio, perché cucinava sempre insieme agli altri studenti. Quindi, il progetto di questo dormitorio favorisce l’interazione incidentale tra gli studenti e questo porta a diffondere la consapevolezza ecologica nel Bauhäusle.
L’identità del Bauhäusle non si basa solo sulle sue caratteristiche architettoniche e sulle pratiche di bricolage ma anche sulla sua filosofia ecologica.
Considerazioni finali
L’esperimento del Bauhäusle ha avuto un grande impatto sia in Germania, dove possiamo trovare altri alloggi per studenti basati su principi simili, come l’ESA di Kaiserslautern (1981-1987), sia nel Regno Unito grazie al lavoro di Blundell Jones, pioniere nello studio degli edifici come parte e veicolo di processi sociali. Si tratta di un approccio minoritario, che presuppone lo studio degli edifici attraverso la loro realizzazione, cercando di spiegare il funzionamento delle reti sociali che hanno informato l’oggetto fisico. Solo così si può accedere alla comprensione di forme architettoniche che altrimenti apparirebbero, specialmente ai non addetti ai lavori, strane e lontane. Questo approccio, unito alle interviste agli abitanti, offre al lettore l’opportunità di riflettere sull’attualità di una esperienza innovativa, in cui la pedagogia si intreccia con la partecipazione degli utenti alle fasi di progettazione e autocostruzione. Se da un lato la partecipazione è uno strumento utile per creare una comunità, l’autocostruzione può essere vista come un veicolo per radicare questa comunità in uno specifico spazio, che solo grazie a questo processo può diventare un vero e proprio luogo antropologico. L’auto-organizzazione, invece, può essere considerata uno strumento per mantenere viva la comunità; nonostante il breve turn over dei suoi abitanti, l’insieme dei processi legati all’auto-manutenzione, alla personalizzazione e al fai-da-te hanno avuto l’effetto di mantenere i nuovi arrivati legati a questo luogo e di rinnovare lo spirito originario della prima generazione.
Bibliografia
https://www.instagram.com/bauhaeusle_stuttgart/
P. BLUNDELL JONES, P. HÜBNER. Bauen all eine soziale Prozeß - Building as a social process, Axel Menges, Fellbach, 2007, pp. 8-23.
A. FRANCHINI, L’Istituto Universitario di Architettura di Venezia come università produttiva, in Ostilio Rossi P. (a cura di), Bruno Zevi e la didattica dell’architettura, Quodlibet, Macerata, 2019, pp. 143–153.
J. MC KEAN e A. GRAHAME, W. SEGAL: Self-Built Architect, Lund Humphries, London, 2021.

Hacklabbo Un esempio di autogestione delle tecnologie informatiche
A. Soto e Micorriza
Introduzione
Le tecnologie invasive, l’imposizione di una socialità digitale predigerita da parte dei colossi dell’informatica e dei media, la profilazione pervasiva a scopo commerciale e di controllo sociale, la censura governativa e aziendale e la commercializzazione di massa di prodotti hardware e software che utilizzano licenze limitanti e brevetti intellettuali come armi legali e dogane virtuali sono gabbie sociali in cui l’utente viene rinchiuso.
Hacklabbo, il laboratorio hacker di Bologna, analizza, smonta e scardina le meccaniche in cui ci siamo fatti inscatolare rivendicando la libera circolazione (analogica e digitale) dell’informazione, il diritto alla privacy, all’anonimato, alla libertà di espressione e di invenzione, condividendo conoscenza attraverso l’autoproduzione dal basso di strumenti alternativi, di infrastrutture digitali e di comunicazione autonome che consentano una partecipazione politica consapevole.
Storia
Hacklabbo è innanzitutto un luogo fisico, nato e cresciuto a XM24, spazio pubblico autogestito che per circa vent’anni ha caratterizzato il quartiere della Bolognina.
A inizio degli anni Duemila tre studenti, di cui uno di informatica, che frequentavano XM24, cominciano a lavorare con alcuni pc in una saletta del centro sociale. Strumento non comune e costoso, all’epoca, il personal computer. Averne libero accesso era entusiasmante per loro. Ancor di più installarci linux e creare l’accesso a internet. Una stanza, una connessione e alcune macchine, che paiono giocattoli. Così è nato hacklabbo, cresciuto insieme a XM24 in anni di condivisione politica e di metodo autogestito quotidiano per concretizzare interessi comuni. Hacklabbo è stato dentro XM24 fino allo scriteriato e doloroso sgombero di quest’ultimo, nell’agosto del 2019, da allora è nomade, e ultimamente ha trovato ospitalità in un altro spazio autogestito cittadino, VAG61.
Descrizione
Hacklabbo è un gruppo libertario numeroso, che ha al suo interno la percentuale più alta di non maschi tra i vari hacklab italiani. A legare le sue e i suoi partecipanti c’è un’affinità comune, che è l’autogestione, sia come pratica politica che come approccio alla tecnologia. Il collettivo si incontra ogni mercoledì perché pensa che relegarsi in spazi esclusivamente virtuali sia solo d’aiuto a chi cerca di sgretolare il tessuto sociale.
L’idea è di sperimentare, smontare, studiare e implementare servizi digitali affinché siano replicati e far sì che le azioni di riappropriazione della tecnologia si moltiplichino e si diffondano. Hacklabbo crea coscienza e condivisione della conoscenza, diffonde l’uso di tecnologie e software liberi.
Questo è ciò che i suoi partecipanti intendono per attitudine hacker. Hacker ha un significato ben diverso da quello che in-
tende la vulgata: non è rubare dati e denaro o ‘bucare’ facebook. Hacker è l’attitudine curiosa ad aprire la scatola e guardarci dentro, a smontare e rimontare hardware e software; è, cioè, un uso critico della tecnologia, una critica attiva a quanto la tecnologia ufficiale impone con piattaforme e software proprietari.
Contesto
Fin da quando è nato, Hacklabbo ha promosso l’uso del software libero, cioè software che garantisce:
-
- Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo.
-
- Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità.
-
- Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare gli altri.
-
- Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti apportati, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html). Il software proprietario è, appunto, di proprietà di determinati
I governi, più o meno democratici, in genere sono molto interessati a conoscere in dettaglio i dati ritenuti sensibili della propria popolazione, per poter esercitare meglio controllo e repressione .
individui o organizzazioni e le licenze ne consentono determinati usi solo sotto particolari condizioni, impedendone altri (ad esempio, la personalizzazione e il miglioramento del software stesso). Vivendo nell’era in cui le informazioni hanno un enorme valore, non ci si meraviglia se i grandi attori in gioco possiedono gli strumenti e le infrastrutture tecnologiche.
Dai dati ricavati dalla profilazione degli utenti e da ogni singola inte-
razione compiuta con gli strumenti tecnologici le corporations traggono profitto: o direttamente, attraverso il marketing, o con la vendita diretta dei dati ad altri attori. I governi, più o meno democratici, in genere sono molto interessati a conoscere in dettaglio i dati ritenuti sensibili della propria popolazione, per poter esercitare meglio controllo e repressione.
Centrale è quindi la questione della proprietà dei dati. Quando utilizziamo piattaforme commerciali cediamo gratuitamente i nostri dati, ma non solo. La piattaforma commerciale può ma-

nipolare o cancellare da un momento all’altro i contenuti, i dati, che ognuno di noi le ha concesso. Per esempio, negli ultimi anni diversi account di collettivi e gruppi politici sono stati cancellati dai social network commerciali per aver pubblicato contenuti sulla resistenza in Kurdistan, “in violazione della policy”.
Per contro facendo uso di servizi autogestiti ognuno può avere il controllo dei propri dati e renderli più sicuri.
Gli attivisti per una tecnologia autogestita sanno che le grandi corporations creano artificialmente dei bisogni e li sfruttano per farne profitto. Di conseguenza pensano sia necessario smettere di alimentare questo meccanismo in cui si è solo dei numeri e grazie a cui grandi multinazionali incrementano i propri profitti e li investono per aumentare i bisogni o per influenzare il comportamento sociale e politico degli utenti.
È quello che è accaduto, per esempio, con Cambridge Analytica (CA). Questa società di consulenza britannica ha influenzato le campagne elettorali negli Stati Uniti nel 2016 (pro Trump) e in Inghilterra in occasione del referendum sulla Brexit per mezzo di una comunicazione strategica che si serviva dei dati che gli stessi utenti offrivano alle grandi piattaforme mainstream.
È quindi necessario assumere maggiore consapevolezza sul fatto che tali meccanismi ci influenzano profondamente: essere profilati non è qualcosa di neutrale; vuol dire anche rischiare di diventare dipendenti dal mezzo ed essere indotti a compiere alcune azioni, dall’acquistare un prodotto online fino a esprimere una preferenza elettorale.
Come funziona
Durante gli incontri del mercoledì, che possono durare anche fino a tarda notte, singoli individui e membri di vari collettivi partecipano alla convivialità di Hacklabbo. Periodicamente si svolgono assemblee le cui decisioni riguardano le attività che riguardano l’intero collettivo. Da conversazioni e ciappini (in bolognese: lavoretti pratici) si sviluppano riflessioni che contribuiscono all’autoformazione e alla crescita collettiva.
Queste discussioni sono alla base dell’organizzazione di nuovi servizi e nuove infrastrutture.
Servizi
I servizi autogestisti sono servizi alternativi rispetto a quelli delle corporations, sono gestiti in modo assembleare da collettivi che condividono gli stessi principi libertari. Gli strumenti messi a disposizione, sempre gratuitamente, sono i più disparati; da quelli per la comunicazione, email e mailinglist, a quelli di videoconferenza o messaggistica istantanea. Ci sono strumenti per collaborazione collettiva per produzione di contenuti, come pad, wiki o più specialistici per la produzione di software. Imprescindibili sono i servizi di trasferimento, conservazione, condivisione, sincronizzazione di file tra persone o gruppi. Tra i servizi a disposizione ci sono anche veri e propri social network, come Mastodon, la piattaforma di microblogging simile a Twitter che recentemente ha ricevuto molte attenzioni. La prima istanza in lingua italiana tra tutte quelle attive oggi è nata proprio nei sotterranei di XM24 nel 2018. Inoltre esistono veri e propri archivi digitali come “arkiwi” e “grafton9”, e agende condivise per la pubblicazione di eventi che si tengono in città (“balotta.org”, nato sulla scia e sul codice del progetto dell’hacklab torinese “gancio.org”).
Ogni collettivo è autonomo e vive del continuo confronto con gli altri partecipanti di Hacklabbo, dando concretezza all’idea di mutuo aiuto. I vari servizi effettivamente si danno supporto reciproco e si contaminano, sono interconnessi nella consapevolezza che la molteplicità ne aumenta i benefici per ognuno.
Fondamentale è inoltre il rapporto umano, la condivisione fisica. C’è un rapporto umano tra chi coltiva la tecnologia autogestita, chi costruisce l’infrastruttura informatica e chi la utilizza: si instaura così una catena di fiducia. L’idea alla base dell’attitudine hacker è quella di minare la delega del
linguaggio informatico alle multinazionali, ai governi o a altre istituzioni statali, cioè di mantenere aperto un ambiente che si tende a chiudere sempre più secondo logiche proprietarie. I servizi autogestiti vogliono mantenere vivo lo spirito iniziale del World Wide Web, cioè garantire un utilizzo democratico perché condiviso delle tecnologie informatiche. Storicamente sia l’informatica applicata che internet nascono come tecnologie militari! Erano altri mezzi per mantenere il primato tecnologico e militare degli USA durante la guerra fredda. Queste tecnologie stanno diventando possesso esclusivo di oligopoli o monopoli, come nel caso delle Big Tech (Google ora Alphabet, Amazon, Facebook ora Meta, Apple, Microsoft) che dominano il mercato. L’autogestione dei servizi digitali si oppone alla prassi capitalista che ha trasformato la rete - nata come «rete tra pari» - in qualcosa di gerarchico volto al profitto di pochi.

Divulgazione
Hacklabbo vive di una continua autoformazione sia nel momento di confronto settimanale, sia nel lavoro quotidiano dei singoli collettivi che si concentrano su determinati servizi e che su quello continuano a formarsi, a formare altri e a fare divulgazione. Una volta all’anno Hacklabbo organizza due giornate di seminari e di presentazioni aperte al pubblico in cui sono affrontati temi riguardanti la riappropriazione, lo studio, la critica degli strumenti tecnologici. L’evento che si è sempre svolto in spazi autogestiti si chiama Hack or Di(Y|e), nome che richiama alla programmazione ma anche al Do It Yourself. La prossima sarà la nona edizione, e pur essendo un evento di nicchia attira oramai moltissime persone da ogni parte d’Italia.
Altri esempi di divulgazione sono il programma radio Hack or Dye che da sette anni viene trasmesso dall’emittente locale Radio città Fujiko, oppure i due volumi del libro Soberania tecnologica, una raccolta di saggi che raccoglie esperienze su diverse tecnologie autogestite, scritta originariamente in spagnolo e che Hacklabbo ha contribuito a tradurre in italiano.
Sostentamento
Dal punto di vista economico Hacklabbo e i vari collettivi vivono grazie a una costante compressione dei costi, che si concretizza nell’utilizzo di hardware riciclati o nella condivisione di connettività casalinghe. C’è un’ottica del risparmio molto forte e anche un’attenzione a limitare l’impatto ambientale, utilizzando per quanto possibile energia da fonti rinnovabili e hardware destinato allo smaltimento. Fonti di sostentamento per le proprie attività sono gli eventi pubblici, come l’appuntamento annuale descritto in precedenza, la vendita di magliette, felpe, adesivi, presine autoprodotte ma soprattutto le donazioni di singoli, collettivi, spazi sociali e gli hackmeeting nazionali in cui è richiesta una sottoscrizione all’ingresso che viene poi divisa tra lo spazio ospitante e i vari servizi.
Rete
Hacklabbo e gli altri hacklab sparsi sul territorio italiano (e non solo) si incontrano ogni anno durante Hackmeeting, un evento che si svolge in Italia dal 1998 e che coinvolge una grande comunità di appassionati di tecnologia, attivisti e hacker. Hackmeeting si svolge solitamente in uno spazio autogestito, dura tre giorni e prevede almeno tre talk in contemporanea, da mattina a notte, oltre a diverse attività, organizzate o spontanee, come workshop, laboratori, tavole rotonde, assemblee e altri momenti di condivisione. I partecipanti sono principalmente appassionati di tecnologia, ma l’evento è aperto a chiunque sia interessato a partecipare e a contribuire alla comunità.
Inoltre, Hackmeeting è un evento autogestito, ovvero organizzato e gestito interamente dai partecipanti stessi, che si organizzano in gruppi di lavoro e collaborano per organizzare le diverse attività e la logistica dell’evento.
Hackmeeting a sua volta è parte di una federazione più ampia. Non formale, ma di fatto. Anche fuori dall’Italia si svolgono hackmeeting: ciò accade in Spagna e in altre parti d’Europa, in Messico, in Bolivia e in Nord America. Questi eventi locali sono anche occasioni di incontro e coordinamento tra attivisti provenienti da diverse parti del mondo.
Conclusione
L’azione hacker ha trovato un terreno fertile a Bologna, soprattutto dopo gli hackmeeting del 2014 e 2021 che si sono svolti in città. Ogni evento è stato un punto di svolta contribuendo a dare vita a un movimento molto trasversale e sostanzialmente immune a quelle divisioni per aree politiche tipiche dei movimenti sociali. Questo perché si concentra sulle pratiche più che sull’ideologia.
Diffondere pratiche di base, come l’installazione di sistemi operativi linux in sostituzione a windows, all’inizio non è stato per niente semplice. Ora, dopo anni di lavoro, vi è maggiore sensibilità nei confronti di un uso consapevole e critico delle tecnologie e sul fatto che normalmente non utilizziamo tecnologie sicure. Nel tempo alcune pratiche volte ad autogestire la tecnologia si sono allargate nei movimenti e all’interno degli spazi sociali e la curiosità e la consapevolezza sull’utilizzo critico delle tecnologie risulta sempre più in aumento.

Contatti Link interessanti
hacklabbo@posta.indivia.net https://hacklabbo.indivia.net/ http://it.hackmeeting.org/ https://hacklabbo.indivia.net/book/sobtec2/it/ [https://www.indivia.net](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/) [https://www.esiliati.org/](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/) [https://bida.im](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/) [https://www.lattuga.net](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/) [http://ofpcina.net/](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/) [https://www.autistici.org/](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/) [https://hackordie.gattini.ninja/](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/) [https://balotta.org/](https://www.indivia.net https://www.esiliati.org/ https://bida.im https://www.lattuga.net http:/)

Tana libera tutti Scuola libertaria a Parma Es p e
Thea Venturelli
La Rete per l’Educazione Libertaria collega una serie di realtà, presenti sul territorio italiano, attive nella sperimentazione con bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di pratiche creatrici di comunità scolastiche autogestite. Tra queste Tana Libera Tutti, con sede a Mamiano, in provincia di Parma, è tra le prime nate in Italia: è attiva infatti dal 2007. La struttura che ospita quest’esperienza è la tipica casa rurale emiliana, un edificio largo e solido, diviso in diverse stanze ampie e luminose; il giardino che la circonda è vasto e alberato, attrezzato con uno spazio dedicato ai momenti assembleari oltre alle altalene e agli altri giochi. Una barchessa arricchisce ulteriormente l’area disponibile. Muovendomi nelle stanze posso apprezzare la cura riservata agli spazi dedicati alle varie attività e anche al relax. Posso osservare i diversi materiali a disposizione e alcune opere e creazioni. Sono angoli allegri, vivi, colorati. La cucina è ben organizzata con un movimento di persone che sistemano lo spazio prima di tornare a casa. Carlotta mi racconta di come, negli anni, l’organizzazione dei pasti abbia subito diversi aggiustamenti: un tempo era responsabilità di ogni famiglia cucinare secondo i turni organizzati, ora invece è
presente una cuoca. Questa presenza ha rafforzato il legame tra i bimbi che, un paio di volte al mese, cucinano e fanno il pane. Tana Libera Tutti è il primo progetto di educazione libertaria che ho conosciuto, diversi anni addietro, quando ancora abitavano un’altra sede. La pratica che sento più attiva in questa realtà è la sperimentazione, una sperimentazione comples-
La pratica che sento più attiva in questa realtà è la sperimentazione, una sperimentazione complessiva che riguarda il progetto in tutte le sue articolazioni
siva che riguarda il progetto in tutte le sue articolazioni. Le figure adulte coinvolte nell’accompagnamento hanno visto, fin dalle origini, il gruppo «scuolina» come una comunità autoeducante come nel suo complesso ed è per questo che, all’iniziale presenza nel quotidiano dei soli genitori, dopo circa sei mesi si è affiancata la figura di Manu, accompagnatrice ancora oggi presente. Ascoltare il suo racconto, e quello di Angela e delle altre accompagnatrici e mamme (sì, eravamo tutte donne) che, al termine della giornata scolastica, hanno accolto la mia proposta di un incontro per poter scrivere questo articolo, mi immerge nell’esperienza della comunità permettendomi, ancora una volta, di viverne la ricchezza. Partecipare alla ricostruzione dello sviluppo di questo percorso, dai momenti fondativi al consolidamento di una struttura comunque aperta e in perenne evoluzione, è coinvolgente ed emozionante. L’entusiasmo, la fatica, i contrasti, i tentativi, il confronto, le soddisfazioni, sono raccontate non solo con le parole ma anche con le espressioni e i gesti che le accompagnano. Ripercorriamo insieme il desiderio delle famiglie fondatrici di creare un contesto a misura di bambino (piccolissimi i primi, da uno a tre anni) in cui i genitori non delegassero in toto la crescita

dei loro figli a un’istituzione terza ma potessero essere compartecipi di una genitorialità condivisa. Poi la successiva apertura a un’accompagnatrice inesperta, ma determinata a esserci, per interagire e crescere portando uno sguardo differente, infine la decisione di darsi una struttura riconoscibile dopo un periodo di spontaneismo pionieristico. E ancora, il racconto di un progetto che diventa interessante anche per altre famiglie e quindi la crisi di crescita. Aprirsi significa allargare le possibilità, intrecciare altri intenti, desideri, modi; significa arricchire la rete di relazio-
ni e contatti e la capacità di azione assumendosi però il rischio di perdere fluidità, di smarrire le sfumature dell’altro, di diluire il contatto e la relazione. Sorge così la volontà di caratterizzarsi e, per farlo, si cerca l’accompagnamento di persone competenti, con esperienza nelle dinamiche di gruppo o che stanno affrontando un percorso educativo affine. Il gruppo educante continua a essere composto dalle educatrici e dai genitori che partecipano agli incontri della Rete per l’Educazione Libertaria e ai percorsi di autofor-
Il desiderio delle famiglie fondatrici di creare un contesto a misura di bambino in cui i genitori non delegassero in toto la crescita dei loro figli a un’istituzione terza ma potessero essere compartecipi di una genitorialità condivisa
mazione interni. Nel frattempo le piccole e i piccoli crescono e si avvia il percorso della primaria, la sede si sposta e si inserisce anche Angie. Con questa nuova fascia di età si aprono nuove esigenze e quindi nuove domande… La dimensione relazionale diviene ancora più fondante, la profonda ricerca di autenticità è l’impegno di ogni giorno. Chi partecipa al progetto porta se stesso, le sue attitudini, la competenza derivante dagli interessi e dalle esperienze individuali. L’impegno è accompagnare bambine e bambini nell’esplorazione in libertà delle proprie capacità, favorendo l’autonomia di ogni singola persona piccola o grande che sia. Le lezioni sono libere, non esiste l’obbligo di frequenza, gli

approfondimenti sono individuali e legati agli interessi specifici di ciascuno in modo che possa realizzare il suo progetto da solo o in gruppo. L’accompagnatrice è presente per sostenere, supportare, mettere a disposizione la sua esperienza in una relazione orizzontale e aperta. È un coro quello delle accompagnatrici mentre raccontano quanto hanno imparato, quanto hanno scoperto stimolate dagli interessi, dalle domande, dalle curiosità e dal sapere di bambine e bambini competenti e informati. La libertà di essere è fondamentale nello sviluppare la propria capacità creativa. Il gruppo adulti è ben consapevole delle opportunità disponibili e si attiva per potenziarle. Anche l’autonomia del progetto ha bisogno di svilupparsi, di garantire la sostenibilità attraverso la condivisione delle risorse e delle necessità presenti. La ricerca è costante, la sperimentazione continua: lunghi scambi, incontri, riunioni della comunità educante, apertura a nuovi inserimenti creano una base condivisa, sempre in definizione e adattabile. L’impegno dedicato è tanto e faticoso ma la complessità del crescere insieme richiede la disponibilità a resettarsi continuamente attraverso un ascolto attivo e partecipe nella valorizzazione della molteplicità degli sguardi, tanti sguardi.
Questo confronto permette alla comunità di camminare insieme: al di là di programmi scolastici e didattica i genitori sanno che figlie e figli apprendono molto altro, un «altro» che definisce la qualità delle relazioni, dell’apprendimento, del crescere.
Posso percepire il grande travaglio vissuto dagli adulti coinvolti nell’emanciparsi dalle richieste introiettate dal contesto sociale, dall’educazione ricevuta, dai parametri richiesti da un’istituzione che raramente agisce per permettere a chi si affaccia al mondo di osservarlo con occhi liberi e puliti: al contrario, lavora nella direzione opposta. Nel confronto confermiamo quanto il lavoro dell’adulto rispettoso della consapevole crescita del bambino sia un’attività funambolica che nessuno ci ha insegnato: una ricerca costante di equilibrio tra esserci senza sopraffare e lasciare senza abbandonare.
Una tale ricerca richiede una sintonia tra il gruppo accompagnatrici che si crea, come racconta Angela, attraverso lo scambio ma soprattutto grazie al quotidiano condiviso. L’insicurezza degli esordi, ricordata da Manu, ben consapevole della sua inesperienza iniziale, lascia il posto a una danza i cui passi si muovono naturali perché incarnati nella sicurezza della pratica di ogni giorno. La curiosità è grande intorno allo svolgimento della vita quotidiana nella comunità autoeducante. Spesso viene chiesto che cosa suc-
cede: difficile raccontare cosa accade in una giornata scolastica fatta di piccoli e di grandi movimenti. La relazione instaurata nel gruppo in presenza, accompagnatrici e bambini, si muove anche in un gioco di sguardi che si comprendono. La fiducia alla base di questo percorso è costruita anche sull’onestà di condividere che cosa posso dare o accogliere: da qui nasce l’immediatezza di sapere cosa chiedere a chi in quel momento, di fronte a quel bisogno o curiosità. La giornata è scandita da un ritmo
riconoscibile attraverso tre cerchi (tempo dedicato all’incontro collettivo) che segnano il passaggio delle varie fasi: il cerchio di buongiorno dove ci si ritrova salutandosi individualmente per incominciare la giornata insieme; il cerchio che precede il pranzo, utile a decomprimere e arrivare a tavola pronti per mangiare; il cerchio del saluto di fine giornata in cui ci si prepara a separarsi dandosi appuntamento per il giorno successivo. Questa pratica, che coinvolge solo bambine e bambini della primaria, pur rimanendo liberamente aperta anche alla fascia dell’infanzia, è stata introdotta grazie all’accompagnamento di una psicomotricista e ha rafforzato la fluidità del percorso quotidiano.

Nel tempo la «scuolina» ha modificato l’organizzazione interna in base alle necessità che si sono manifestate. Attualmente è in presenza dal lunedì al venerdì: due giorni fino alle 13.30, gli altri tre fino alle 15.30. I motivi che hanno portato a questa scelta sono legati al bisogno di dedicare uno spazio per vivere anche altri contesti che non siano solo la scuola, recuperando tempo da vivere in famiglia o in altri situazioni utili ad avere momenti dedicati a sé, tra giornate intensissime che richiedono grande energia e impegno. In uno dei tre pomeriggi a scuola si svolge l’assemblea: partecipano solo bambine e bambini della primaria, l’infanzia solo se convocata, ferma restando, come
La fiducia nelle capacità di bambini e bambine è totale e la loro risposta straordinaria
per il cerchio, la possibilità di partecipare qualora sia desiderio dei più piccoli esserci. Le decisioni vengono prese attraverso il metodo del consenso: in caso di stallo su differenti possibilità si sperimentano diverse soluzioni che verranno successivamente valutate. L’assemblea è anche il luogo in cui affrontare eventuali conflitti che non hanno trovato soluzione in momenti informali. Bambine e bambini sono molto autonomi in questo e raramente richiedono il supporto delle accompagnatrici; anche l’assemblea è ampiamente gestita da loro che assumono il ruolo di mediatori e tengono il turno di parola. In caso di necessità sono supportate dalle adulte che hanno anche il compito di redigere il verbale. Nel corso degli anni nel percorso di Tana Libera Tutti sono passati almeno cento bambine e bambini: ognuno ha toccato, e tocca, delle corde, ha portato bellezza e fatica, donando una grande maturità e consapevolezza al progetto. Manu e Angie, dopo tanti anni di presenza, sono depositarie della storia della «scuolina» ma sono bambini e bambine a tramandarne l’essenza, a renderla luogo vivo, creativo, a loro misura, interesse e desiderio. Hanno acquisito la sicurezza di muoversi nel loro contesto, con i modi e le regole da loro stabilite e rielaborate secondo la necessità e praticando una qualità relazionale altissima. La fiducia nelle capacità di bambini e bambine è totale e la loro risposta straordinaria. Lo stesso avviene con il gruppo genitori: grazie al percorso intrapreso fin dalla fondazione chi decide di partecipare al progetto è consapevole di inserirsi in un contesto educativo rivolto non solo ai figli. La vitalità del luogo, infatti, è nutrita anche dalla volontà dei genitori di «imparare a stare insieme» ricercando, anche attraverso il già nominato accompagnamento esterno, le pratiche più efficaci. Il gruppo scuola prevede attualmente la presenza di 33 bambini con un gruppo adulti di circa 60 persone tra accompagnatrici e genitori. Un numero così significativo ha bisogno di strumenti sociali utili a facilitare le necessità organizzative e gestionali. La MAG 6 di Reggio Emilia, di cui è già stato scritto su questa rivista, è stata e rimane un riferimento fondamentale. Accanto alla possibilità dei genitori di fermarsi a scuola e stare nel flusso della giornata, esiste una struttura estremamente articolata utile a condividere le necessità organizzative e le responsabilità generali che non ricadono sulle accompagnatrici ma vengono condivise nel gruppo tutto.
Ogni mese sono previsti incontri e riunioni che vanno dall’assemblea plenaria, in cui le decisioni vengono stabilite anche qui attraverso il metodo del consenso, a vari gruppi di lavoro che operano in autonomia: gruppo pedagogico, gruppo economico, gruppo comunicazione, gruppo promozione, gruppo turni, gruppo tutoraggio per i nuovi ingressi, con un gruppo coordinamento che mantiene il collegamento tra tutti. Trovo significativo mettere in evidenza due aspetti che mi hanno colpito in questa organizzazione. Il primo è l’esistenza di un gruppo memoria creato per il desiderio di mantenere il filo del progetto e dei suoi lunghi anni di storia, la sua evoluzione, il cammino compiuto, i suoi sviluppi, conservarne i documenti e i ricordi. L’altro aspetto è la volontà di bambine e bambini di partecipare attivamente ai gruppi di lavoro: un’ulteriore conferma di come ciascuna e ciascuno si senta parte di un contesto cui può contribuire, partecipando attivamente con le proprie capacità, attitudini, risorse. La stessa conferma ho avuto durante una recente iniziativa pubblica ascoltando la testimonianza di giovani donne e giovani uomini, studenti universitari ora, ma destinatari originari dell’idea di Tana Libera Tutti, che puntualmente sono presenti a supportare il progetto e usufruiscono dello spazio che hanno vissuto da piccoli per attività e iniziative promosse da loro stessi. La spontaneità nel mettersi a disposizione, seduti a terra in diverse aree del giardino, per raccontare la loro esperienza ormai lontana mi ha colpito per la naturalezza: la luce negli occhi era intensa quanto quella dei bambini che frequentano oggi, perché il progetto è ancora loro.
Considero la comunità autoeducante di Tana Libera Tutti una testimonianza davvero felice, un laboratorio di possibilità, incontri, crescita individuale e comune straordinario, frutto della disponibilità a mettersi in discussione, di non sentirsi mai arrivati, di una flessibilità fondamentale per osservare da differenti angolazioni. Nonostante la fatica e la stanchezza, nonostante l’impegno richiesto, i dubbi, i contrasti, a emergere nel loro raccontarsi è comunque quella voglia di esserci, di stare. C’è la volontà di trasformare le potenziali difficoltà in risorse ritenendo le nuove famiglie, che spesso arrivano con motivazioni e consapevolezze molto differenti da quelle che hanno mosso il progetto originario, un’opportunità per guardare come si sono trasformate e come si confermano le proprie motivazioni. C’è, anche, la volontà di non smettere di guardare i limiti e le opportunità impliciti nelle scelte fatte; di constatare come una struttura consolidata snellisca l’organizzazione ma risulti poi essere anche vincolante; di osservare che in un numero allargato di bambini ogni temperamento trova il suo spazio ma porta anche a realizzare a fine giornata che, di alcuni di loro, non hai incrociato lo sguardo. Ringrazio molto la generosa disponibilità che trovo sempre nella tana animata dai liberi tutti. Perché, a imparare a essere liberi, si impegnano insieme.
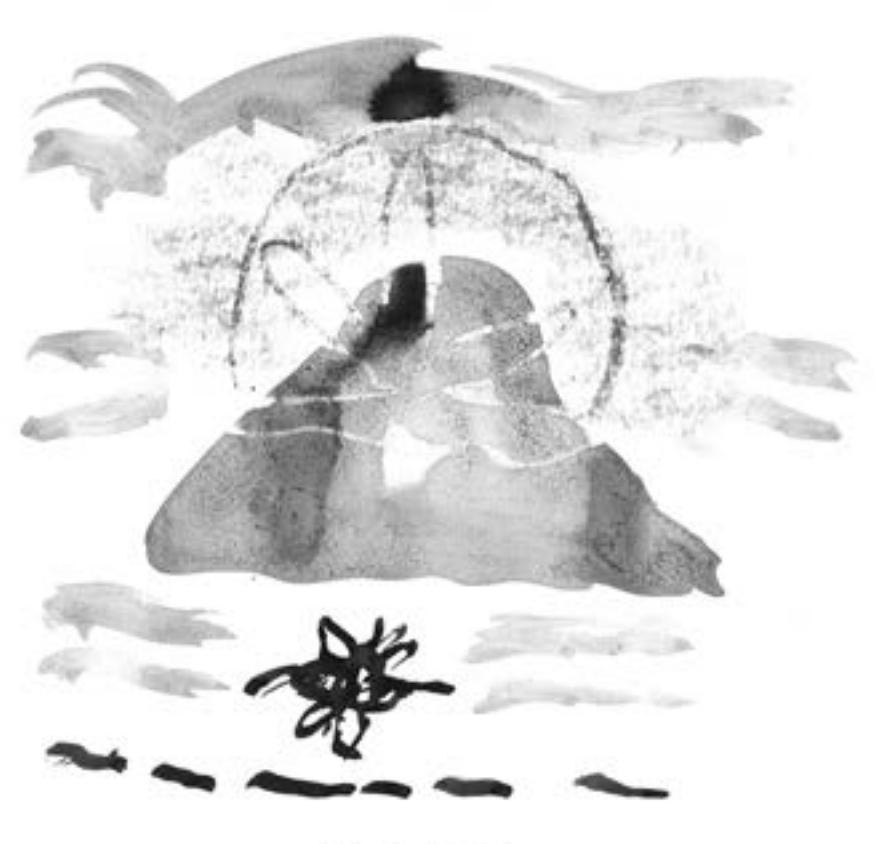

Gli ecomusei. Una proposta alternativa al turismo di massa
Valeria Giacomoni
Il concetto di ecomuseo nasce in Francia nei primi anni Settanta sull’onda dei movimenti di contestazione con l’obiettivo di superare schemi e definizioni di vecchio stampo anche nel mondo della cultura: «i teorici francesi volevano delineare una nuova formula museale in grado di oltrepassare i confini accademici, mettendo al centro dell’attenzione un approccio olistico del “fare cultura”, una provocazione intellettuale che solo nei decenni successivi è giunta a una declinazione operativa»1 . La proposta scardina quindi l’idea di un museo statico e costituito da oggetti e apre l’orizzonte a un’osmosi con il territorio: in primo luogo l’ecomuseo non ha pareti e inoltre si configura indissolubilmente legato all’ambiente, come espressione del territorio da conservare. Il neologismo ecomuseo è stato coniato da Hugues de Varine, archeologo, storico e museologo, che nel 1971 ha dato questa definizione: «L’ecomuseo è un’istituzione che gestisce, studia, utilizza per scopi scientifici, educativi e in generale culturali, il patrimonio globale di una comunità che comprende la totalità dell’ambiente naturale e culturale di questa comunità. L’ecomuseo è quindi uno strumento di partecipazione popolare alla pianificazione territoriale e allo sviluppo comunitario». Interessante è notare come negli anni successivi de Varine aggiungerà una precisazione a questa definizione: «Rimpiango di aver usato la parola istituzione, alla quale preferirei oggi progetto, ma non avevo ancora scoperto che l’ecomuseo è prima di tutto un processo»2 .
1 A. Stefani, coordinatrice della Rete degli Ecomusei del Trentino, Gli ecomusei del Trentino e il “fare rete”, in «UCT. Rivista di cultura, ambiente, società del Trentino», n. 551, novembre 2021.
De Varine con i suoi 87 anni è ancora oggi un grande sostenitore di questo concetto in continuo divenire: più passano gli anni più gli si attribuisce l’invenzione degli ecomusei, ma lui tiene a sottolineare che ha inventato solo la parola, e che ogni ecomuseo è stato inventato dai suoi fondatori, e ogni museo è diverso dagli altri. De Varine per spiegare la complessità racchiusa nella parola ecomuseo, la paragona alla definizione di pipistrello, animale che costituisce un’eccezione alle classiche catalogazioni e non corrisponde a nessuna categoria: è un mammifero ma vola, vola ma allatta i suoi piccoli, ecc3 .
Diffusione, obiettivi e riconoscimento legale
Diffusi dapprima in Francia (dove esiste una federazione degli ecomusei) e in altri paesi francofoni come il Canada, sperimentati poi in molti altri paesi europei e in situazioni territoriali diverse, quali zone limitrofe o comprendenti parchi naturali, aree paleoindustriali dismesse, valli rimaste emarginate dallo sviluppo turistico di massa, a partire dagli anni Novanta si affacciano sulla scena italiana come una delle forme più innovative nella difficile coniugazione di conservazione e sviluppo, cultura e ambiente, identità locale e turismo.
Per avere un’idea precisa dei primi riconoscimenti ufficiali degli ecomusei in Italia, le prime leggi che li citano sono del 1999 in Piemonte e nel 2000 in Trentino. Il riconoscimento dello status di ecomuseo prevede un iter di 3 anni di lavoro di un’associazione: questo significa che deve esserci un nucleo civile che spinge e che porta avanti il progetto, non può essere una semplice idea calata dall’alto delle amministrazioni locali. È da sottolineare quindi che essi nascano come movimenti spontanei dal basso, con l’obiettivo di tutelare e prendersi cura collettivamente del territorio circostante, delle sue peculiarità e delle sue tradizioni.
3 Parole tratte dalla presentazione del libro L’ecomuseo singolare e plurale del 10 febbraio 2022 https://www.youtube.com/watch?v=2z5QJKHhhk0
Il forte legame con l’ambiente di ogni nucleo associativo fondante porta inevitabilmente a diverse interpretazioni del termine ecomuseo: ogni territorio ha la sue esigenze, le sue risorse e le sue difficoltà, e l’ecomuseo si propone quindi di far fronte alle più svariate necessità locali.
Ci sono quindi zone che riescono a valorizzare delle risorse naturali organizzando visite guidate, in altre si preparano sentieri per poter approfondire la conoscenza del territorio camminando, spesso si fa un lavoro di recupero del patrimonio locale di arti e mestieri attraverso la conservazione/ristrutturazione di edifici e attrezzature in disuso. La valorizzazione delle peculiarità di ogni territorio sono legate generalmente alle forme di
sostentamento dei suoi abitanti che nell’ultimo secolo si sono inevitabilmente modificate. Lo spopolamento di certe zone è legato anche a questo processo di evoluzione del sistema produttivo e alla concentrazione del lavoro nei centri industriali. La globalizzazione ha spazzato via la capacità di autosostentamento di molte popolazioni, soprattutto nelle
Ogni territorio ha la sue esigenze, le sue risorse e le sue difficoltà, e l’ecomuseo si propone quindi di far fronte alle più svariate necessità locali
zone marginali, che riuscivano a produrre ciò di cui avevano bisogno sfruttando le risorse del territorio e a limitare il commercio a prodotti che non potevano coltivare/creare. Quei territori che non hanno puntato sul turismo di massa, sfruttando e spesso sacrificando le loro risorse naturali, trovano in questo tipo di associazioni la possibilità di recuperare e valorizzare una memoria non troppo lontana, di un’altra generazione, di un altro modo di vivere. Le persone che rimangono a vivere in zone marginali spesso sono anziane e sono testimoni di questi processi di graduale abbandono delle attività tradizionali. Attraverso l’utilizzo della storia orale si ricostruisce l’identità di un territorio per aiutarci a capire meglio chi siamo e da dove veniamo.
Valorizzare la vocazione non commerciale
Il lavoro degli ecomusei quindi coinvolge certamente la popolazione locale, e oltre ad essere focalizzato sull’ambiente aspira a estrapolare e trasmettere la cultura intrinseca di un territorio. E a chi si vorrebbe trasmettere questo sapere? Per capire l’orientamento che possono prendere questo tipo di associazioni è importante capire a chi si punta come fruitori. Innanzitutto possiamo dire che a guadagnarne è sicuramente la popolazione locale, che oltre ad arricchirsi a livello associativo, si impegna nel recupero di un patrimonio culturale collettivo spesso a rischio di scivolare nell’oblio in nome del progresso e della tecnologia. Inoltre anche le attività proposte dagli ecomusei hanno un target locale
Partendo da noi e dall’ambiente circostante possiamo capire meglio le altre culture e tradizioni
e non orientato a captare i grandi flussi turistici: la gran parte di attività organizzate sono formative, pensate per le scuole o per avvicinare gli abitanti ad approfondire la conoscenza del proprio territorio. Queste proposte permettono anche di ripensare il concetto di turismo, senza necessità di compiere grandi spostamenti (nell’ottica sempre della
sostenibilità): si offrono proposte di qualità per approfondire le nostre radici, i panorami, gli edifici e le tradizioni che ci circondano. È un cambio di impostazione notevole rispetto alla frenesia del mondo contemporaneo e all’ottica della globalizzazione e dei viaggi low cost. Non serve andare lontano per scoprire il mondo, anzi: forse proprio partendo da noi e dall’ambiente circostante possiamo capire meglio le altre culture e tradizioni.
Il lavoro di ogni piccola associazione viene quindi poi valorizzato con la creazione di una rete a livello regionale, strategica per creare una connessione culturale stabile tra gli ecomusei. Non è facile gestire una rete con così tante differenze, dato che tutti i territori rispondono alle esigenze peculiari del proprio territorio, ma il comune denominatore è l’interazione con la comunità.
Fare rete significa mettersi in gioco
La rete offre supporto ai singoli ecomusei (per quanto riguarda la riforma del terzo settore, le collaborazioni con le biblioteche, il servizio civile) e fa delle proposte di progetti a maglie larghe, che ogni ecomuseo poi declina a modo suo, facendo riferimento alla propria amministrazione locale, in base anche alla disponibilità economica di ogni comune.
Credo sia da apprezzare questa organizzazione orizzontale e non gerarchica: la scelta della rete offre una forma di aggregazione leggera, non burocratica, stabile, vicina al territorio, con una propria personalità giuridica ma che non costituisce una sovrastruttura.
La rete si propone di incrementare lo spirito di «cittadinanza attiva» da parte delle comunità locali attraverso pratiche innovative e partecipate e sviluppa le relazioni tra i diversi enti in maniera egualitaria. Queste le parole della coordinatrice della Rete degli Ecomusei del Trentino: «Gli ecomusei hanno messo a sistema il “lavorare in rete”, scelta non sempre facile. Partecipare a un percorso “di rete” significa innanzitutto mettersi in gioco, ammettere le proprie incompetenze e imparare dagli altri, d’altro canto e al pari ogni azione di apprendimento; lavorare in rete permette al singolo come al gruppo di evolversi e crescere. Può sembrare una banalità dire che l’unione fa la forza, ma il caso delle reti informali degli ecomusei, sia quelle a carattere locale costruite dai singoli ecomusei, sia la rete provinciale, ne sono una conferma»4 . Ogni ecomuseo si prende la responsabilità di fare la propria parte nell’ambito di questa rete e partecipare alle attività per il perseguimento di un obiettivo comune. La Rete si avvale di un servizio di segreteria per il coordinamento della attività comuni e per garantire la circolazione delle informazioni a tutti gli aderenti.
4 A. Stefani, Gli ecomusei del Trentino e il “fare rete”, cit., pp.13-14.
Per riuscire ad entrare nel dettaglio sul funzionamento dei progetti per questo articolo abbiamo analizzato la Rete degli Ecomusei Trentini, ma esiste una rete a livello nazionale e internazionale per le quali valgono la maggior parte dei concetti qui esposti. La poca presenza degli ecomusei su internet e sui social riflette la vocazione di legame fisico con il territorio che possiamo considerare solo positivamente e ha richiesto un approfondimento su piccola scala grazie a lettura di documenti e interviste per arrivare a spiegare il progetto.
Sinergie, valori e finanziamenti
Il concetto e le caratteristiche degli ecomusei e la loro organizzazione in rete mi sembrano assolutamente condivisibili da un punto di vista libertario, ma interessante è anche capire fino a che punto si appoggiano o sono appoggiate dalle istituzioni. Se da una parte c’è un riconoscimento dell’importante lavoro degli ecomusei, i finanziamenti pubblici comunque sono I finanziamenti pubblici comunque sono minimi e le basi su cui poggiano sono associazioni e volontariato
minimi e le basi su cui poggiano sono associazioni e volontariato. A volte indicati dalle istituzioni come brand per una crescita turistica sostenibile, gli ecomusei si sentono abbastanza lontani da questa definizione soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi commerciali, dato che non puntano ad intercettare i grandi flussi turistici. Non fanno parte quindi della strategia di marketing a livello regionale, anche se viene riconosciuto che potrebbero essere un punto di forza.
D’altro canto spesso le amministrazioni, soprattutto nei piccoli comuni, sono i più grandi sostenitori di questi progetti che vengono portati avanti a livello quasi istituzionale. Le sinergie che si creano nelle valli portano a ottimizzare le risorse disponibili e ad esempio nell’occasione di organizzare eventi si delega la parte più culturale all’ecomuseo, e magari la parte più pratica agli alpini o ai vigili del fuoco. È inevitabile nelle piccole comunità l’interazione con le istituzioni e gli altri enti presenti, e credo che la presenza degli ecomusei possa fare la differenza ad esempio sui valori e i principi che si vogliono trasmettere nelle attività organizzate. L’attenzione all’ambiente e all’instaurazione di rapporti orizzontali possono contaminare in senso positivo le proposte sul territorio. Ad esempio l’essenza degli ecomusei è quanto più lontana o contraria alle classiche operazioni di marketing che prevedono le grandi kermesse tanto di moda negli ultimi anni, e non condivide azioni che mettano in secondo piano il territorio, come le gare o i raduni di veicoli.
Attorno al concetto di paesaggio gli ecomusei hanno costruito la loro identità, al paesaggio come definizione di spazio di vita, spazio quotidiano; gli ecomusei si impegnano a preservarlo e tutelarlo per le nuove generazioni, non come immutato e intoccabile, ma ragionando con la comunità sul suo migliore sviluppo. In molti dei territori soggetti allo spopolamento queste azioni portano ad una nuova consapevolezza, e magari offrono qualche posto di lavoro e qualche opportunità in più per gli esercizi della zona.
L’impegno della popolazione per il territorio
Per avere un’idea dei numeri, tra gli ecomusei trentini (nove in tutto a oggi) la maggior parte ha solo una persona fissa stipendiata tutto l’anno, alcuni addirittura a tempo ridotto. Si avvalgono poi di collaboratori e operatori didattici per le scuole, ma per quanto riguarda il funzionamento quotidiano si basano sul volontariato: in un anno si parla di circa 800 persone coinvolte e 176 associazioni. Il volontariato e l’impegno della comunità sono quindi una risorsa fondamentale.
La strada da percorrere per il futuro è quindi sempre di più l’autofinanziamento per poter sopravvivere come associazioni culturali. Gli ecomusei non avendo mai avuto grandi finanziamenti ed essendo nati come associazioni dal basso, sono già allenati a basarsi soprattutto sull’impegno gratuito dei propri sostenitori. Ma tenendo in conto che il bilancio per le attività culturali cala ogni anno e quindi il finanziamento pubblico per quanto esiguo, sarà sempre minore, la programmazione risulterà fondamentale per la sopravvivenza di questi enti. Oltre alle questioni economiche per la sopravvivenza si cerca di guardare al futuro per capire in che modo possano radicarsi nella nostra società nonostante la vocazione non commerciale. Queste le parole del presidente della Rete Ecomusei del Trentino «Il futuro degli ecomusei è pertanto legato alla loro stessa esistenza in quanto l’ecomuseo rappresenta ciò che un territorio è e ciò che sono i suoi abitanti. Rappresenta la cultura viva delle persone, il loro ambiente, ciò che hanno ereditato dal passato, ciò che amano e desiderano[…] Ogni ecomuseo rappresenta situazioni territoriali diverse, ma tutti svolgono una delle forme più innovative nella difficile coniugazione di conservazione e sviluppo, cultura e ambiente, identità locale e turismo […]. Suggestiva è la definizione che ne ha dato Hugues de Varine, ancora nel lontano 1970: l’Ecomuseo è “Il futuro del passato”»5 .
Un nuovo modo di fare turismo e di vivere l’ambiente circostante basato sul rispetto
In conclusione possiamo affermare che i punti di forza di questa visione siano un nuovo modo di fare turismo e di vivere l’ambiente circostante basato sul rispetto. La presenza capillare sul territorio e la struttura orizzontale di queste associazioni permette di sperare in un’influenza positiva anche sulla gestione politica, culturale e ambientale soprattutto nelle piccole comunità, vista la forte interconnessione con le istituzioni.
5 G. Gorfer, presidente della Rete degli Ecomusei trentini, in «Rivista UCT», n.551, novembre 2021.
Bibliografia
Intervista a Adriana Stefani, coordinatrice della rete degli Ecomusei del Trentino in data 18 gennaio 2023.
L’ecomuseo singolare e plurale di Hugues de Varine | 10 feb 22, Talk con Daniele Jalla e Maurizio Tondolo, curatori dell’edizione italiana organizzata da ICOM (International Council of Museums) Italia, https://www. youtube.com/watch?v=2z5QJKHhhk0.
«Rivista UCT. Rivista di cultura, ambiente e società del Trentino», n. 551, novembre 2021, numero speciale uscito in occasione del ventennale degli ecomusei trentini.
Gli ecomusei nella Provincia Autonoma di Trento, a cura del Servizio attività culturali, Provincia Autonoma di Trento, 2004.
https://www.ecomusei.trentino.it/approfondimenti/cose-un-ecomuseo/
https://www.formazioneturismo.com/litalia-e-pronta-per-gli-ecomusei/
Riflessione sulla bellezza
Il paesaggio alpino è il risultato di una lenta e sofferta trasformazione del territorio – una sorta di adattamento delle condizioni naturali del luogo alle esigenze delle popolazioni locali – nel corso di millenni. Lo spazio verticale della montagna, segnato dalle diverse funzioni necessarie alla sopravvivenza – la campagna e il prato stabile, il bosco ceduo, le aree e le strutture per la transumanza, la cà da mont*, il bosco di materiale d’opera, la malga e l’alpeggio – con tutto il portato di competenze, saperi, professionalità, racconti, leggende eccetera è un capolavoro dell’uomo che, paradossalmente, l’uomo moderno tende a scordare. O che sta diventando incapace di leggere e interpretare. Perché l’uomo moderno va di fretta ed è sempre più abituato al brutto, alla sciatteria, all’improvvisazione. Mentre il processo cognitivo di percezione della bellezza necessita della lentezza, del movimento fisico che consente l’allineamento tra cuore e cervello. Ma necessita anche dell’educazione al bello, per poterlo riconoscere, apprezzare, condividere con gli altri. Secondo Confucio la bellezza sarebbe ovunque, ma non tutti la saprebbero cogliere. Qualche secolo più tardi Shakespeare affermava che la bellezza, da sola, è in grado di pervadere gli occhi senza bisogno di un oratore. Vero. Di fronte a una successione di vette dolomitiche al tramonto non si può che restare estasiati, per la magnificenza di uno spettacolo al di fuori delle nostre capacità, non riproducibile con mezzi «umani» e per questo «sovra-umano» e per alcuni divino. È forse quella che Edward Wilson definiva «biofilia», una capacità iscritta nel nostro Dna di connettersi con la natura. Ma per comprendere un bosco in autunno, un alpeggio o la montagna nel suo complesso servono l’esperienza in ambiente, la lentezza del passo, la conoscenza trasmessa da qualcuno, un educatore, un amico, il nonno o il boscaiolo. Serve la presenza di un maestro, di un mentore. Ecco, forse gli ecomusei possono svolgere, in quest’epoca, il ruolo di mentori per le popolazioni locali e in particolare per i giovani. Possono prenderli per mano e accompagnarli, con il passo lento e sicuro del montanaro, a scoprire l’anima dei luoghi, che è diversa da una valle ad un’altra6 .*
6 R. Bombarda, fondatore e primo presidente dell’Associazione Pro Ecomuseo della Judicaria, in «Rivista UCT», cit.

Stratocaster o Balalaika? Per uno sguardo sonoro sul conflitto in Ucraina
Felice Liperi
Nel muro di fronte a Giolitti, una delle migliori gelaterie romane, compare ancora, scolorita e quasi invisibile, la scritta Van Thieu vattene. Già ma chi è Van Thieu? Lo spiega Wikipedia: «generale e politico vietnamita, presidente e dittatore del Vietnam del Sud dal 1965 al 1975» cioè un uomo al potere fino alla disfatta americana e alla liberazione del paese. Proprio il periodo che ha sconvolto il sud-est asiatico e contemporaneamente ha visto emergere in intere generazioni una coscienza pacifista antimperialista e nell’area della sinistra italiana un sentimento antiamericano che sembra permanere a distanza di oltre cinquant’anni anche nel modo di schierarsi sulla guerra in Ucraina. Un sentimento rappresentato da numerosi osservatori fra i quali la studiosa di scienze sociali Oksana Dutchak1 e Andrea Papi su «Semi sotto la neve» con questa considerazione «la partigianeria di una parte consistente della sinistra, intesa come complesso culturalmente identificabile, contro le visioni politiche e sociali del blocco occidentale, di cui pure storicamente e culturalmente è parte»2 . Da dove nasce questo sentimento antiamericano che complica la lettura del conflitto ucraino? Se ne può trovare origine nelle manifestazioni contro la guerra in Vietnam che si moltiplicano negli anni Sessanta in Francia e in Italia dietro il ricordato slogan «Van Thieu vattene!», e poi nelle mobilitazioni recenti per le guerre in Iraq e Afghanistan. Nella fase pre-sessantotto la sinistra italiana si schierava decisamente contro gli USA respon-
1 10 terribili asserzioni della sinistra contro la resistenza ucraina, dal sito Ytali.com, 21 luglio 2022.
2 Le ipocrisie di un antimperialismo parziale, in «Semi sotto la neve», n. 4, p. 48.
sabili dell’attacco al Vietnam anche attraverso interventi di suoi importanti intellettuali nel settimanale Rinascita come Enrica Collotti Pischel sotto lo pseudonimo di Silvia Ridolfi:
«Nel corso dell’ultimo anno (1963, ndr) il Vietnam meridionale è diventato il terreno di sperimentazione di quelle tecniche della “guerra speciale” (cioè degli strumenti e dei sistemi di repressione della guerriglia rurale) che da anni strateghi e psicologi del Pentagono stanno elaborando»3 .
Una posizione ribadita, come ricorda Francesco Montessoro, anche da dirigenti del PCI come Gian Carlo Pajetta in un editoriale sempre su «Rinascita»: «Il problema del Vietnam» scriveva l’esponente comunista, diventato direttore di «Rinascita» dopo la morte di Togliatti nell’agosto del 1964, «cessa di essere un problema locale anche acuto, acquista un valore universale; diventa un banco di prova per le forze che minacciano la pace in ogni parte del mondo e per le forze che, in ogni parte del mondo, vogliono respingere il pericolo di guerra»4 . Negli stessi giorni si organizzava alla Basilica di Massenzio, a Roma, una «marcia della pace» fra le prime in Italia a favore della resistenza vietnamita. La mobilitazione proseguiva nel corso del 1965 con una serie di manifestazioni compresa una «veglia per il Vietnam» fra il 27 e il 28 novembre al Teatro Adriano con la partecipazione di intellettuali e politici sempre dell’area di sinistra che si mostrava in prima linea anche con l’«appello dei quarantasei», firmato da artisti e intellettuali europei e pubblicato sul New York Times alla fine del 19655 .
In realtà l’antiamericanismo nell’area della sinistra non solo giovanile si è andato alimentando attraverso le critiche all’imperialismo statunitense anche sulla spinta di un appassionato terzomondismo ispirato ai processi rivoluzionari in corso a Cuba, in Algeria, in alcuni paesi africani subsahariani oltre che
3 F. Montessoro, Il mito del Vietnam nella cultura italiana degli anni ‘60, dal sito www. sissco.it.
4 Ibid
5 Ibid., p. 6.
al pensiero visionario di Mao Zedong. Invece l’invasione della Cecoslovacchia, avvenuta pochi anni dopo, nell’agosto 1968, se provocava l’uscita dal PCI di alcuni militanti e intellettuali, fondatori del quotidiano Il Manifesto, in realtà non vedeva una forte mobilitazione di pacifisti e militanti di sinistra nei confronti dell’Unione Sovietica.
Il PCI diventò, in tutte le sue sezioni, il teatro di una battaglia durissima tra filosovietici «carristi» e difensori del nuovo. Quella durezza segnava la strada per chi si affacciava dentro il PCI in quei giorni6 .
Un tema ripreso in un recente intervento su «Reset» da Giancarlo Bosetti:
È vero che il PCI mantenne un atteggiamento incerto e continuò a lasciar credere che il legame «antimperialista» con il PCUS andasse preservato, nonostante tutto, ed è vero che il suo appoggio convinto al «nuovo corso» cecoslovacco era in contraddizione con quel legame7 .
Tornando al Vietnam la mobilitazione negli anni Sessanta proseguiva in occidente con una delegazione del tribunale Russell che documentava le devastazioni provocate dai bombardamenti americani e anche il mensile «Il Ponte», sotto la direzione di Enzo Enriques Agnoletti, si attivava per contrastare la politica estera del presidente Lyndon Johnson. Fra gli studiosi più acuti, la sinologa Edoarda Masi nel 1965 con il saggio Rivoluzione nel Vietnam e movimento operaio occidentale accendeva il dibattito sul significato della rivoluzione vietnamita, interpretata come un segno della crisi del sistema capitalistico. Posizione condizionata forse dal fatto che in Italia la sinistra, e il PCI in particolare, già allora non sembravano in grado di operare una decisa azione
6 In: L. Scoppola Iacopini, F. Anghelone, Praga 1968. La “Primavera” e la sinistra italiana, Bordeaux, Roma, 2014.
7 G. Bosetti, Quella primavera del ‘68 che cambiò anche la storia della sinistra italiana, in «Reset», 26 febbraio 2015.
rivoluzionaria – ma forse neanche riformista – per cui quel sogno impossibile andava trovato in altro contesto, come ad esempio la resistenza vietnamita strettamente connessa al crescente ribellismo giovanile e all’utopia rivoluzionaria di Che Guevara, Mao e Fidel Castro. Già ma perché è stato sempre così facile e spontaneo mobilitarsi a sostegno delle battaglie antiamericane mentre l’azione dell’imperialismo russo non ha provocato nell’area progressista altrettanta indignazione e mobilitazione sociale? Forse perché, come scrivono oggi molti esperti di politica este-
Perché è stato sempre così facile e spontaneo mobilitarsi a sostegno delle battaglie antiamericane mentre l’azione dell’imperialismo russo non ha provocato nell’area progressista altrettanta indignazione e mobilitazione sociale? ra, quell’imperialismo dell’est è stato sempre visto come meno pericoloso e invadente di quello dell’ovest? Anzi sono in molti a sostenere che una delle ragioni di questa ambivalenza sta nel fatto che si sente la Russia più lontana e meno pericolosa degli Stati Uniti rimasti invece inchiodati alle loro responsabilità per le bombe sul Giappone nel 1945, le atrocità in Vietnam, il collegamento ai golpe in Sud America negli anni ‘70 e l’azione nelle guerre del Golfo e in Afghanistan. Mentre le invasioni sovietiche dell’Ungheria e della Cecoslovacchia, e poi in particolare quella in Afghanistan, l’azione in Siria e in
Africa e ora l’invasione dell’Ucraina, non hanno provocato critiche particolarmente accese alla Russia, né grandi mobilitazioni di pacifisti e del popolo della sinistra. Nonostante alla guida della Russia ci sia da molto tempo Putin, un autocrate responsabile di crimini e azioni sanguinarie, ora incriminato dalla Corte internazionale di giustizia anche per il rapimento di bambini dall’Ucraina. Sta di fatto che il popolo progressista è da sempre, non solo ora con la guerra in Ucraina, esitante a mobilitarsi contro quel paese, come mostra anche l’invasione dell’Afghanistan.
Non può essere solo una questione di distanza, in realtà geograficamente molto inferiore rispetto a quella con gli Stati Uniti, è soprattutto un fatto ideologico e culturale, basta pensare a quanto poco sia conosciuto il messaggio delle poesie cantate di un oppositore solitario come l’artista russo Vladimir Vitsosky, premio Tenco nel 1993, ma figura conosciuta in un ambito molto ristretto di appassionati. Mentre sono celeberrime le canzoni pacifiste di folk singer e rocker come Pete Seeger, Bob Dylan, John Lennon, Joan Baez, Neil Young, Bob Marley, Bruce Springsteen ecc. così come anche i loro strumenti iconici quali le Fender Stratocaster, mentre al contrario la balalaika è un cordofono russo sconosciuto ai più. Paradossalmente è proprio questo folto gruppo di artisti e la denuncia pacifista proposta da film come Hair, Jesus Christ Superstar, Comma 22, La lunga linea rossa, Apocalipse Now e Il cacciatore ad aver coagulato la mobilitazione delle coscienze di numerose generazioni contro gli Yankee mentre non c’è – tranne che in rari documentari – una sola pellicola che racconti la carneficina in Cecenia o la campagna sovietica in Afghanistan. Anzi all’uscita de Il cacciatore nel 1979 furono forti le polemiche per come il regista Michael Cimino aveva deciso di rappresentare i vietcong, quali sadici criminali e non come patrioti in guerra con gli invasori americani. Quindi l’altra domanda che sorge è com’è possibile che le stesse persone che si alimentano di rock, film, letteratura proveniente dagli Stati Uniti poi non esitano nel terreno della politica internazionale a scagliarsi contro il mondo che li ha prodotti? Mentre non c’è un artista russo, eccetto il ricordato Vitsosky, che rappresenti un modello per le nuove generazioni o autori di teatro, cinema, musica che possono contare su un seguito in Occidente? Perché in realtà a parte il collettivo punk delle Pussy Riot, costretto ad organizzare proteste per lo sviluppo della democrazia in Russia sotto rigoroso anonimato, non esistono importanti esponenti in grado di opporsi a Putin e alla sua politica dispotica e stalinista. Anzi spesso si assiste a una sottovalutazione delle azioni criminali dell’autocrate russo perché considerate baluardo all’imperialismo NATO. Un sentimento che, nonostante il lungo tempo trascorso dalle aggressioni dell’«Occidente», nasconde una mai sopita e forte critica nei suoi confronti che spesso porta ad un giudizio negativo verso il popolo ucraino di cui si accreditano molte delle dicerie più negative: corrotto, nazista, reazionario, filo occidentale. Allora, come accennato sopra, il sentimento di fratellanza e solidarietà che unisce il mondo della sinistra, soprattutto quella più radicale, trova le sue ragioni profonde nel rimanere legato al mito di una nazione come la Russia erede della rivoluzione d’ottobre, mentre gli Stati Uniti rappresentano ancora il mito capitalista alleato all’imperialismo militare della NATO. Oppure può accadere, nella versione più moderata, che ampi settori dell’opinione pubblica di area progressista mantengano un’equidistanza fra aggressori e aggrediti non solo riguardo al riarmo dell’Ucraina ma più in generale sul sostegno alla causa dei resistenti. Un sentimento che osservatori come il giornalista britannico Paul Mason provano a spiegare tornando ancora più indietro nel tempo, alla guerra civile spagnola. Un’epoca utile, a suo dire, per affrontare le contraddizioni che toccano l’ala progressista del Partito democratico americano e trovare le ragioni per cui, invece, dovrebbe sostenere il diritto all’autodifesa dell’Ucraina. «Immaginate» scrive, «una storia alternativa della Guerra civile spagnola dove, dopo alcuni capovolgimenti iniziali, la fazione antifascista inizia a vincere. Ricacciano indietro le armate di Franco soprattutto perché Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti rifiutano il “non intervento” e inviano armi pesanti, compensando così il sostegno fornito da Hitler e Mussolini. In questo scenario, qualcuno pensa seriamente che la sinistra mondiale avrebbe tolto il suo sostegno alla parte repubblicana a causa della cosiddetta “aggressione imperialista”? Avrebbe denunciato il conflitto spagnolo come una “guerra per procura”? Avrebbero convocato una conferenza internazionale per chiedere la fine di tutte le forniture di armi agli antifascisti in nome della “pace”? Avrebbero chiesto di negoziare con Franco, sostenendo una soluzione ‘accettabile per tutti’? [invece] quando si tratta dell’invasione russa dell’Ucraina, una parte dell’estrema sinistra internazionale ha fatto tutte queste cose e anche di più»8 .
Un ragionamento che, per tornare al Vietnam, potremmo estendere a quando i più appassionati sostenitori della causa vietcong non avessero dubbi sul sostegno armato della Cina ai combattenti antiamericani. Anche perché, come aggiunge ancora Dutchak nel suo intervento, «Un’altra variazione di questa affermazione riguarda la discussione sulle armi della NATO … viviamo in un mondo in cui non c’è uno stato progressista di dimensioni necessarie per fornire sostegno materiale a una lotta di questa portata e trarre vantaggio dalla sua vittoria» come accadeva all’Unione Sovietica e alla Cina quando aiutavano la liberazione del Sud Vietnam. A nessuno è mai venuto in mente di dire ai vietnamiti di rinunciare ad un pezzo del loro territorio, così come non lo si è chiesto persino ai talebani mentre si continua a farlo, ad esempio, nei confronti dei palestinesi e dei curdi che vedono ogni giorno scomparire pezzi della propria terra. Invece spesso in ambienti «progressisti», pur non esplicitamente, sono in molti a pensare che l’Ucraina dovrebbe capitolare e rinunciare ai territori appena conquistati dai Russi e dar seguito alle richieste politiche di Putin, abbandonando la causa per un’indipendenza completa del paese e l’autodeterminazione del suo popolo.
Allora in conclusione, queste riflessioni ci pongono di fronte al dilemma fra una democrazia che permette odio e amore accompagnate da grandi canzoni e il ricordo di Stalingrado e del mito dell’Armata Rossa che impediscono la critica ad un’autocrazia che annienta pensieri e passioni. In definitiva un dilemma che ci ripropone simbolicamente di scegliere fra le svisate di una Stratocaster o le suggestioni di una balalaika.
8 P. Mason, Come fermare il nuovo fascismo. Storia, ideologia, resistenza, Il Saggiatore, Milano, 2021.
LO SPECCHIO
Sì, mi ricordo quella parete nella nostra città rasa al suolo. Si ergeva fin quasi al sesto piano. Al quarto c’era uno specchio, uno specchio assurdo perché intatto, saldamente fissato. Non rifletteva più nessuna faccia nessuna mano a ravviare chiome, nessuna porta dirimpetto, nulla cui possa darsi il nome «luogo».
Era come durante le vacanze vi si rispecchiava il cielo vivo, nubi in corsa nell’aria impetuosa, polvere di macerie lavata dalla pioggia lucente, e uccelli in volo, le stelle, il sole all’alba. E così, come ogni oggetto fatto bene, funzionava in modo inappuntabile, con professionale assenza di stupore.
Wislawa Szymborska, Basta così, (trad. di Silvano De Fanti), Adelphi 2012

L’Iran e l’Islam politico. Una lotta continua per la libertà
Amir Khosravi
Sfogliando le pagine della storia moderna iraniana, si comprende come negli ultimi secoli in questo antico paese la religione e il clero sciita abbiano sempre avuto un ruolo attivo nella politica. La religione, rappresentata dall’apparato clericale sciita, è stata l’alleata principale dell’istituzione monarchica iraniana per secoli (dal XVI secolo fino al 1921), una fonte legittimante per le dinastie governanti e una valvola di sfogo nei momenti in cui il furore della società scrollava le basi del potere dell’ancien régime iraniano. Tuttavia, la Repubblica islamica, fondata nel 1979 da Khomeini con il contributo di gruppi marxisti, ha costituito una novità storica: la religione, come istituzione, è divenuta da allora unico riferimento e detentore del potere politico.
L’Iran odierno è l’eredità diretta dell’Impero Safavide, dinastia sciita che governò la Persia tra il 1501 ed il 1736. Dopo l’invasione degli arabi musulmani, fu lo Scià Ismāīl, fondatore dell’Impero Safavide, a unire sotto un’unica giurisdizione gran parte dei territori dell’antica Persia. Con i Safavidi l’Iran rinacque come Stato-nazione dotato di un governo nazionale e finì un lungo periodo di frammentazioni, guerre civili e occupazioni straniere. La storiografia iraniana non è stata in grado di chiarire se la transizione verso lo sciismo sia stata soltanto una maledizione o abbia avuto anche qualche impatto positivo. I Safavidi imposero con la forza la loro versione dell’Islam, che sotto molti punti di vista era in contrasto con l’Islam ortodosso professato dagli arabi. Lo sciismo diventò un elemento distintivo dei Persiani dal resto del mondo islamico, all’epoca quasi unanimemente rappresentato dall’Impero ottomano.
Lo sciismo nacque in Iran già come parte integrante della politica. Dall’epoca safavide i mullah vennero volutamente coinvolti nella politica e nella gestione del potere temporale. Questa collaborazione costituì, con una breve interruzione nell’era di Nādir Scià (1736-1747), la base della politica iraniana fino all’inizio del XX secolo. Sotto i Safavidi e sotto i Qajar l’Iran aveva avuto pochissimi elementi di uno Stato laico, ma non era neanche uno Stato islamico, come invece è, a tutti gli effetti, l’odierna Repubblica islamica.
Durante il regno della dinastia Qajar (1794-1925) la collaborazione tra le istituzioni politiche e la religione diventò sempre più vitale per la classe governante da un lato e sempre più lu-
crativa per il clero dall’altro. I Qajar governarono l’Iran come un loro patrimonio familiare. La religione offriva il sedativo più efficace per un popolo che vedeva i progressi del mondo e dei suoi vicini, mentre in patria soffriva per l’estrema povertà e per un’arretratezza che ogni giorno diventava più marcata. Nell’impedire la modernizzazione e nel sedare le rivendicazioni del popolo iraniano le due istituzioni, la monarchia e la religione, si ritrovarono fortemente unite fino al 1906, anno di un’importante frattura tra le classi dominanti.
La religione offriva il sedativo più efficace per un popolo che vedeva i progressi del mondo e dei suoi vicini, mentre in patria soffriva per l’estrema povertà e per un’arretratezza che ogni giorno diventava più marcata
I costituzionalisti iraniani, inizialmente formati da una ristretta cerchia di intellettuali ma divenuti successivamente uno dei movimenti più rilevanti nella storia persiana, attingendo contemporaneamente a valori dell’antica Persia pre-islamica e a quelli della Rivoluzione francese e dell’Illuminismo europeo presero a «venerare» ardentemente la sovranità popolare invece che l’autorità religiosa, i diritti naturali e universali dell’uomo e lo Stato di diritto al posto dell’ombra di Dio sulla terra (come veniva chiamato il re Qajar), la legge umana, concepita come uno strumento astratto, uniforme e uguale per tutti, al posto della sharia, la mellat, ovvero la nazione, invece che la ommat (comunità musulmana).
Per il clero sciita l’alleanza con la vecchia monarchia aveva costituito un rapporto estremamente vantaggioso. Oltre agli aspetti materiali, i mullah erano detentori di imponenti poteri all’interno della società iraniana: due pilastri dello Stato, ovvero la giustizia e l’istruzione, erano monopolio dei mullah. Nell’Iran dei Qajar non esistevano tribunali civili o statali, né un codice civile scritto e uniforme, ed erano i mullah ad occuparsi direttamente e arbitrariamente della gestione della giustizia e ad arbitrare tra le persone sulla base della legge islamica.
Per quanto concerne l’istruzione, non c’erano le scuole moderne, ma i maktab gestiti dagli stessi mullah, in cui venivano insegnate esclusivamente le materie religiose e coraniche. Questo permetteva al clero di garantirsi la perpetuazione del proprio potere, dal momento che erano loro a educare le persone nel percorso di alfabetizzazione e socializzazione e a giudicarle quando agivano contrariamente alla sharia.
Nell’ancien régime iraniano mentre i cittadini erano fiscalmente sudditi del re, psicologicamente e culturalmente erano schiavi del clero sciita. Questo rapporto di schiavitù culturale si interruppe con la Rivoluzione costituzionale del 1906 e successivamente con l’ascesa al potere di Reza Pahlavi nel 1921.
Nel febbraio del 1921 mentre l’Iran era sommerso dalle crisi
Nell’ancien régime iraniano mentre i cittadini erano fiscalmente sudditi del re, psicologicamente e culturalmente erano schiavi del clero sciita sociali e politiche, un generale del corpo militare dei Cosacchi (l’esercito dei Qajar) con i suoi tremila uomini entrò a Teheran con l’obiettivo di rovesciare il governo Qajar, ritenuto incapace di gestire le crisi di cui soffriva la popolazione, e di istituire un governo in grado di difendere gli interessi della nazione, all’epoca minacciati considerevolmente dal colonialismo britannico. Quel generale era Reza Pahlavi, padre fondatore dell’Iran moderno. Per circa quattro anni occupò le cariche di Ministro della guerra e poi di Primo ministro. Nell’ottobre del 1925 un’assemblea costituente votò la destituzione della dinastia Qajar dal potere e lo scelse come il nuovo Scià d’Iran. Così cambiò il destino della Corona del Pavone.
Con le riforme di Reza Scià il clero sciita perse la quasi totalità del potere politico-istituzionale e il suo ruolo sociale fu limitato alla gestione delle moschee e delle preghiere, lo stesso processo che contemporaneamente ebbe luogo anche nella Turchia di Mustafa Kemal.
Con la Rivoluzione costituzionale e poi con i Pahlavi la natura e la posizione dell’istituzione monarchica iraniana cambiarono radicalmente e tale istituzione diventò motore della modernizzazione e laicizzazione dello Stato iraniano. In tutto questo i Pahlavi ebbero un ruolo rilevante, ma non erano da soli. Le riforme erano ideate e messe in atto da un gruppo di intellettuali e pensatori iraniani che provenivano dal movimento costituzionalista. La nuova classe politica iraniana era assai diversa da quelle precedenti ed era capeggiata da uno Scià e da una monarchia che a loro volta erano considerevolmente diversi dal passato.
Più la monarchia attirava i laici, più venivano respinti i religiosi. Venne fondato il Ministero dell’Istruzione insieme a un’ampia rete di scuole moderne e a un sistema scolastico centralizzato, laico e uguale per maschi e femmine, con insegnanti che non venivano più dalla moschea o dal mondo religioso ma dalle università europee. Nel 1934 venne fondata la prima università iraniana: l’Università di Teheran, ancor oggi la più prestigiosa del Paese. Essa fornì l’opportunità, anche per le donne, di studiare una varietà di discipline, dalla medicina all’ingegneria e alle materie umanistiche. Oltre alla costruzione dell’Università e di diversi centri scolastici, migliaia di giovani iraniani vennero inviati in Europa per continuare il loro percorso formativo grazie a borse di studio.
La gestione della giustizia venne assegnata a una neonata magistratura uniforme, laica e sotto diretto controllo dello Stato. Per la prima volta l’Iran fu dotato di un codice civile moderno e laico. Le radici della ripugnanza del clero sciita verso l’istituzione monarchica iraniana vanno cercate in queste riforme che hanno spazzato i monopoli che il clero manteneva da secoli. Il periodo tra il 1921 ed il 1979 fu per l’Iran una finestra sulla modernità, un’apertura verso il mondo, un’epoca di grandi cambiamenti e soprattutto la fase in cui la vecchia Persia, grazie anche a diversi boom economici, riuscì a recuperare il divario con il mondo occidentale.
Un’altra cesura importante nella storia politica iraniana avvenne nel 1962, quando Mohammad Reza Pahlavi, figlio di Reza Scià e re dell’Iran dal 1941, decise di mettere in atto una vasta serie di riforme culturali ed economiche volte a intensificare e consolidare il processo di modernizzazione della società iraniana.
Nel gennaio del 1963 con un referendum popolare che ottenne una maggioranza schiacciante iniziò la stagione delle riforme, conosciuta come Rivoluzione bianca, destinata a cambiare la struttura socio-economica dell’Iran. Il programma prevedeva sei principi fondamentali: 1. Riforma agraria, abolizione del sistema feudale vassallatico e distribuzione della terra ai contadini; 2. Nazionalizzazione delle foreste, dei pascoli e delle fonti idriche; 3. Privatizzazione delle aziende controllate dallo Stato per ottenere fondi necessari per la riforma agraria; 4. Compartecipazione degli operai ai profitti delle aziende; 5. Riforma della legge elettorale per dare alle donne il diritto di voto e gli stessi diritti politici dei maschi; 6. Creazione di un sistema scolastico universale, gratuito e obbligatorio e dell’esercito del sapere (Sepāh-e Dānesh), composto dai volontari che in alternativa al servizio militare si recavano nei villaggi rurali e meno sviluppati per fare gli insegnanti.
La Rivoluzione bianca del 1963 è una delle chiavi di lettura della storia contemporanea iraniana. Le donne iraniane, che con una legge del gennaio 1936 sull’abolizione dell’hijab obbligatorio si erano emancipate dalla gabbia del tradizionalismo islamico e con le riforme scolastiche avevano ottenuto il diritto allo studio, con il 1963 ottennero i medesimi diritti politici degli uomini. Nel 1979, quando Khomeini e i suoi uomini erano sul punto di imporre il loro codice di abbigliamento islamico alle donne iraniane e di ingabbiare le ragazze, l’Iran aveva il tasso d’istruzione femminile tra i più alti al mondo.
Fu proprio nell’occasione di proteste delle forze reazionarie contro i principi della Rivoluzione bianca che per la prima volta il nome di Ruhollah Khomeini apparve nella scena politica iraniana. In una lettera indirizzata allo Scià egli protestò contro il dirit-
to di voto delle donne, definendolo contrario ai principi del Corano e dell’Islam. Successivamente, in diversi discorsi pubblici tenuti nelle moschee, attaccò il programma di riforme.
Le riforme avevano creato molte aperture, soprattutto sociali, culturali ed economiche, ma anche dei gruppi sociali che si sentivano esclusi, tra i quali trovò sostegno Khomeini: i grandi proprietari terrieri che avevano perso i loro possedimenti con le riforme del
‘63, i bazari (mercanti tradizionali), che con le aperture economiche vedevano a rischio i propri monopoli economici, i gruppi marxisti che nell’assetto istituzionale monarchico non trovavano posto, e i lavoratori non specializzati che a causa di una rapida industrializzazione erano emigrati nei grandi centri urbani.
Durante il periodo che definiamo come «Iran liberale» (1921- 1979) lo sviluppo politico del Paese rimase indietro e, sotto alcuni punti di vista, venne trascurato. Anche a causa del clima internazionale della guerra fredda, lo Stato iraniano si dimostrò incapace di integrare tutti gli orientamenti politici al suo interno e, di conseguenza, alcune fazioni della società estremizzarono le loro posizioni, confluendo in partiti o sette anti-sistema. Questi cleavages socio-politici costituirono poi la base del consenso di Khomeini e altre forze rivoluzionarie.
La Rivoluzione islamica del 1979 è stato un movimento totalmente illiberale. Valori come democrazia o libertà non erano tra gli obiettivi dei leader della Rivoluzione. Gli islamisti e i marxisti iraniani hanno trovato un punto comune in quello che chiamavano «lotta contro l’occidentalizzazione», ma in realtà ciò che loro contrastavano era la modernità in quanto tale.
Ora una nuova generazione di iraniani cerca di riprendersi ciò che gli islamisti tolsero loro nel 1979. La Rivoluzione in corso in Iran dal settembre 2022 può essere definita un movimento per la libertà e per la laicità delle istituzioni. Il movimento Donna, vita e libertà è il dichiarato antidoto della Rivoluzione islamica del 1979. Le donne che bruciano il velo obbligatorio nelle strade del Paese non bruciano un pezzo di stoffa, ma l’ideologia teocratica e totalitaria di un regime che da quasi mezzo secolo si intromette negli aspetti più privati della vita delle persone.
Per questi giovani costruire un paese laico non sarà un compito facile. Lo sciismo in Iran è nato e si è evoluto come religione politica. Però l’Islam politico appare oggi a repentaglio anche nella fascia di
Le donne che bruciano il velo obbligatorio nelle strade del Paese non bruciano un pezzo di stoffa, ma l’ideologia teocratica e totalitaria di un regime che da quasi mezzo secolo si intromette negli aspetti più privati della vita delle persone
popolazione che aveva costituito il suo punto di forza, ovvero nelle classi sociali economicamente più deboli. Come abbiamo detto, nella storia iraniana dal 1925 in poi, la monarchia ha rappresentato il principale contropotere nei confronti delle forze religiose e reazionarie. Oggi tale ruolo spetta invece ai giovani iraniani, che dovranno costruirsi un solido ancoraggio politico per evitare che si ripetano esperienze negative come quella del 1979.
La rivoluzione in corso in Iran sorge dal basso e nonostante la mancanza di una leadership dichiarata unisce tutta la nazione. Tutte le città iraniane partecipano alla Rivoluzione con le stesse rivendicazioni e gli stessi slogan e questo dimostra la forte unità nazionale degli Iraniani nonostante la convivenza di una molteplicità di etnie e di minoranze dentro i confini del Paese.
Il movimento ha radici nella storia iraniana e si ispira dalle idee per le quali combattevano un secolo fa i costituzionalisti iraniani. Nell’Iran di oggi l’Islam politico e il terzomondismo hanno perso la battaglia davanti ai giovani che trovano sempre il modo per aggirare la censura applicata dalla Repubblica islamica per scoprire la realtà, soprattutto sul loro passato. Il movimento,
quindi, può essere definito un movimento per il ritorno ai valori che stavano alla base dell’Iran liberale. La tattica della Repubblica islamica per reprimere le rivolte popolari è sempre stata etichettarle come «dirette dall’esterno», dagli Stati Uniti o dall’Occidente. Ma la rivoluzione Donna, vita e libertà è un movimento spontaneo che prende forza da una rivoluzione culturale e intellet-
La Repubblica islamica sin dall’inizio della sua fondazione ha utilizzato il corpo delle donne per imporre alla società la sua ideologia totalitaria
tuale già avvenuta e consolidata tra le nuove generazioni iraniane. La nuova rivoluzione iraniana sorge per contrastare la povertà economica, l’autoritarismo politico e la discriminazione per questioni di religione e soprattutto per questioni di genere. Come è ben chiaro dallo slogan principale dei rivoluzionari iraniani, il pilastro del movimento sono le donne. La Repubblica islamica sin dall’inizio della sua fondazione ha utilizzato il corpo delle donne per imporre alla società la sua ideologia totalitaria. Quando si entra in Iran la prima differenza che si nota è proprio l’hijab delle donne, ovvero la mancanza del diritto di scegliere il proprio vestiario. Questa discriminazione si estende a tutte le sfere della vita sociale delle donne iraniane.
Non è banale che il simbolo della rivoluzione sia una ragazza, Mahsa Amini, e che siano le ragazze a guidare le lotte in strada e a combattere in prima linea contro le forze pro-regime. Questo è un indicatore del fatto che, nonostante i quarantaquattro anni di Repubblica islamica, il totalitarismo religioso non è riuscito a eliminare le donne iraniane dalla società.
Non è facile prevedere il futuro politico dell’Iran. Ma una cosa è certa: la fine dell’Islam politico è più vicina di sempre e possiamo sperare che l’Iran abbia una nuova classe dirigente guidata dagli stessi giovani che oggi stanno portando avanti una lotta che non è animata dalle obsolete ideologie otto o novecentesche, ma dall’ardore per la libertà e la prosperità. Un cambiamento radicale è atteso in Iran.
Bibliografia
P. ABDOLMOHAMMADI, La Repubblica Islamica dell’Iran: il pensiero politico dell’Ayatollah Khomeini, De Ferrari, Genova, 2009.
M.R. PAHLAVI, Risposta alla storia, a cura di M. Gallone, A. Crespi Bortolini, A. Traversi, Editoriale Nuova, Milano, 1980.
F. SABAHI, Storia dell’Iran, Mondadori, Milano, 2003.
A.A. SHAMIM, Iran dar dore-ye saltanat-e Qajar, Entesharat Behzad, Teheran, 2008.

Come vuoi essere punito? Le alternative al carcere tra disciplina ed esclusione
Antonello Azzarà
La violenza del carcere e le alternative coerenti con la sua funzione
Quando a Michel Foucault venne chiesto di parlare di alternative al carcere in occasione di un convegno a Montreal nel 1976, lui non nascose un certo imbarazzo. In quell’occasione provò a spiegare il suo disagio con un esempio. Parlare di alternative al carcere significa parlare di alternative tra diverse punizioni. Sarebbe come chiedere a un bambino di sette anni: «Senti, visto che tanto sarai punito, cosa preferisci: la frusta o saltare il dolce?». Ecco, questa osservazione racchiude il nocciolo del problema. La risposta a questa domanda sarebbe pressoché unanime e sembra avere una portata più evocativa che euristica. Ma se evitiamo di concentrarci sulla probabile risposta e ci soffermiamo piuttosto sul semplice fatto che la domanda è stata posta, riusciamo a cogliere un aspetto profondo, forse essenziale, delle misure alternative (nello specifico) e di un’alternativa al carcere (in generale). A connotare l’alternativa al carcere è proprio la possibilità di scegliere tra il carcere e qualsiasi altra cosa che, almeno in teoria, dovrebbe essergli sempre preferibile.
Senza andare troppo lontani, è dalla prima metà del Novecento che si parla del carcere come luogo di sofferenza per eccellenza, rispetto al quale è e deve essere preferibile ogni situazione di degrado materiale e morale all’esterno di esso.
Parlare di alternative al carcere significa parlare di alternative tra diverse punizioni
È il principio della less eligibility, termine con cui sono state chiamate oltremanica alcune teorie di politica economica della pena elaborate da Georg Rusche e Otto Kirchheimer nel loro Pena e struttura sociale (1939). Un lavoro pioneristico per quei tempi, con cui per la prima volta si adottava nelle scienze sociali una prospettiva marxista per un’analisi economica dell’evoluzione del sistema penale in maniera almeno in parte indipendente rispetto alla criminalità. In sostanza, il carcere deve essere meno preferibile rispetto a qualsiasi altra condizione protratta di sofferenza all’esterno. La sola privazione della libertà personale non basterebbe a renderlo un luogo disprezzabile. A vedere lo stato delle prigioni si direbbe che questo principio sia quantomai rispettato. Alla perdita della libertà personale, intesa per lo più come libertà di spostamento, si accompagna sovente la perdita di una pluralità di diritti che va da quello all’affettività, alla sessualità, alla salute, alla libertà di manifestazione del proprio pensiero e di autodeterminazione. Inoltre, non è affatto trascurabile l’elemento della violenza che rende il carcere un posto certamente più tormentato rispetto a qualsiasi altra condizione di miseria esterna. Si tratta di una violenza perenne, di cui sono impregnati tanto i rapporti orizzontali quanto quelli verticali. Per dirla con Max Weber è il monopolio dell’esercizio legale della forza che emerge e si esprime nella sua forma più cruda e originaria. Di rado questa violenza buca le pareti del carcere e si manifesta al pubblico esterno. Basta richiamare da ultimo quanto accaduto, in termini macroscopici, con la rappresaglia di Santa Maria Capua Vetere. Ma la violenza che fuoriesce dal carcere non è che la punta di un iceberg a cui si deve aggiungere il sommerso, la cosiddetta cifra oscura, che rappresenta sempre la parte più cospicua in ambito criminologico.
L’altro motivo di imbarazzo per Foucault, invece, aveva a che fare con il fallimento del carcere. Che il carcere abbia sempre tradito la sua promessa rieducativa e risocializzante era cosa già nota almeno da quando Filippo Turati, il 18 marzo 1904, resocontava alla Camera dei deputati lo stato delle carceri italiane in questi termini: «Noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli, e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti, o scuole di perfezionamento dei malfattori». Le pene alternative al carcere, dunque, si proponevano e si propongono ancora oggi come alternativa a quella fabbrica di delinquenza e, presa coscienza del fallimento del carcere, ambiscono a segnare un cambiamento di rotta.
È piuttosto intuitivo, dunque, che nessuno voglia andare in carcere. La pena carceraria è eteronoma, sempre subita al di fuori della propria sfera volitiva. La condanna viene emessa da un giudice, eseguita da un pubblico ministero che ne ordina l’esecuzione alla forza pubblica la quale obbedirà anche muscolarmente se necessario. Al procedimento che porta alla condanna prende
parte, come si suol dire, il popolo attraverso i giudici e le giurie popolari da una parte e la collettività dall’altra, mediante l’obbligo di esplicitare le motivazioni che sorreggono il dispositivo della sentenza. Mai l’imputato diventa partecipe della propria condanna, a lui spetta il diritto di difendersi. Le misure alternative invertono que-
Mai l’imputato diventa partecipe della propria condanna, a lui spetta il diritto di difendersi. Le misure alternative invertono questo paradigma
sto paradigma. Il reo, per la prima volta, è chiamato a richiedere la propria pena. Si tratta di un processo che Foucault descrive come di interiorizzazione della punizione e ne individua parte della sua genealogia nella cogestione tra detenuti e amministrazione di alcuni istituti d’avanguardia, come era sul finire degli anni ‘60 quello di Kemela in Svezia. Una struttura che si proponeva di essere un’alternativa al carcere, in cui gli stessi detenuti, riuniti in consigli insieme all’amministrazione, venivano coinvolti nelle decisioni che riguardavano il programma penitenziario, diventando parte attiva nell’espiazione della propria pena. C’è un altro aspetto che risulta fondamentale: l’implementazio-
ne delle misure di espiazione esterna della pena determina la
fuoriuscita della pena dalla prigione. Una volta fuori, questa si espande a macchia d’olio per diffondersi nella società attraverso meccanismi di disciplinamento che investono gli aspetti più pregnanti della vita sociale. Il modello totalizzante del carcere viene traslato all’esterno per tramutarsi in una serie di prescrizioni altrettanto specifiche che disciplinano in modo estremamente dettagliato ogni aspetto della vita sociale: il tipo di lavoro da svolgere, l’uso che si fa della derivante remunerazione, l’uso della tecnologia, l’ambito familiare e le frequentazioni esterne a esso. Insomma, quella che viene rappresentata come un’alternativa alla prigione, che nasce dalla consapevolezza del suo fallimento, si rivela essere in questa prospettiva perfettamente coerente con i suoi obiettivi.
L’espansione delle alternative al carcere in Italia
In Italia, come nel resto del mondo occidentale, è in corso una tendenziale espansione delle misure alternative al carcere. Il Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione 16/1992 e con la 22/2003, ha auspicato l’ampliamento del novero delle community sanctions, ovvero di provvedimenti che «mantengono il reo nella società con l’imposizione di obblighi e condizioni» con una supervisione in funzione ausiliaria e di controllo. In Italia, che resta uno dei paesi più carcerocentrici di Europa con 56.605 detenuti a fronte di 51.261 posti disponibili (fonte DAP – dati del 31 marzo 2023) e quindi con un tasso di sovraffollamento del 110,43%, le persone prese in carico dall’Ufficio Esecuzioni Penale Esterno
In Italia, come nel resto del mondo occidentale, è in corso una tendenziale espansione delle misure alternative al carcere
sono ben 130.637 (il numero comprende anche la messa alla prova, le misure di sicurezza, le sanzioni e le misure di comunità, dunque le misure alternative al carcere sono intese in senso ampio – dati del 31 marzo 2023, fonte DGMC, Dipartimento Sezione Statistica) – più del doppio rispetto alle presenze in carcere. Questi numeri sembrano confermare la tendenziale fuoriuscita della pena delle maglie del penitenziario, seppure il principale strumento di repressione, la pena regina, resti la detenzione carceraria. Si conta infatti che il 55% dei condannati in Italia passi dal carcere, contro il 28 % dei casi in Germania, il 30% in Francia e il 36% in Inghilterra e Galles.
La tendenza sembra rispecchiare ancora una volta il panorama penale statunitense il quale, già forte di una tradizione correzionale «in libertà» attraverso gli istituti di probation e parole, conta un numero di condannati che è più del doppio rispetto a quello dei detenuti e che ha registrato un forte aumento dei «bianchi poveri», a testimonianza che il controllo penalistico sia in continua espansione a dispetto di altre forme di controllo sociale tipiche del welfare state (Gottschalk 2020).
In definitiva, un numero così elevato di soggetti sottoposti a una misura penale testimonia anche un generale aumento delle persone coinvolte nei processi di criminalizzazione. Il sistema dell’esecuzione penale esterna e interna al carcere abbraccia ben 187.242 persone tra detenuti e soggetti in vario modo coinvolti nell’esecuzione esterna di una pena, ovvero un numero pari alla popolazione di un capoluogo di regione di medie dimensioni.
L’esclusione delle misure alternative
Per cogliere un altro aspetto fondamentale delle misure alternative al carcere bisogna guardare dove il sistema si piega su sé stesso, contraddicendo lo scopo e la natura di quella scelta scontata tra un male maggiore e uno minore. Tra le misure alternative al carcere è particolarmente esplicativa di questa contraddizione quella dell’espulsio-
Tra le misure alternative al carcere è particolarmente esplicativa di questa contraddizione quella dell’espulsione dello straniero irregolare prevista nel Testo Unico sull’immigrazione
ne dello straniero irregolare prevista nel Testo Unico sull’immigrazione, D.Lgs. 286/1998. Si tratta di una misura atipica che, seppure annoverata tra quelle alternative al carcere, ha una ratio legis difficilmente compatibile con quella propria delle alternative al carcere. È apertamente in contrasto con lo schema di scelta volontaria dell’alternativa tra due opzioni delineata da Foucault. Non c’è alcuna scelta rimessa al detenuto e, ancor più grave, nemmeno al giudice. A differenza delle altre misure alternative al carcere, l’art. 16, comma 5, del T.U. sull’immigrazione non prevede che la misura possa essere richiesta dall’interessato, ma questa viene disposta autoritativamente da parte del magistrato di sor-
Nessuna possibilità di rieducazione per lo straniero irregolare detenuto, visto che il reinserimento a fine pena, di fatto, non ci sarà
veglianza quando la pena residua da scontare è pari o inferiore a due anni. Il giudice è altresì obbligato a dover disporre l’espulsione dello straniero a prescindere dalla condotta da lui tenuta durante la detenzione. Dunque, nessuna possibilità di rieducazione per lo
straniero irregolare detenuto, visto che il reinserimento a fine pena, di fatto, non ci sarà. Si cela così l’irrogazione di un’ulteriore misura afflittiva dietro la concessione di una misura alternativa. Un’ulteriore condanna a una pena percepita come il triste epilogo di un percorso migratorio terminato nel peggiore dei modi. L’esempio è paradigmatico, ma a ben vedere il discorso poco cambia anche quando a restare fuori dai benefici penitenziari sono gli immigrati regolari e tutti i soggetti che si collocano negli strati più bassi della piramide sociale. Restano esclusi di fatto i senza fissa dimora che in assenza di un qualsivoglia capitale economico e sociale esterno al carcere non possono uscirne perché giudicati inidonei all’espiazione della parte residua di pena all’esterno (fatta eccezione per i pochi fortunati che vengono accolti nelle varie comunità). Per loro il carcere desocializzante e violento resta l’unica modalità di esecuzione fino all’ultimo giorno di pena.
Conclusioni
regolari e irregolari, nullatenenti, mendicanti, senza fissa dimora di ogni genere e provenienza, rientra a pieno titolo in quella che Alessandro De Giorgi (De Giorgi 2002) ha definito come una tendenza omogenea verso una politica penale escludente e severa a livello globale, che varca i confini regionali e nazionali, come risultato di convergenti mutazioni del capitalismo contemporaneo (Melossi 2022). Il fenomeno può essere allora ricondotto a quella violenza originaria dell’accumulazione primitiva che ha determinato la liberazione di forza-lavoro strumentale allo sviluppo del dominio di fabbrica. Laddove invece quest’ultima non arriva, il carcere diventa luogo privilegiato per la sua continua riproduzione. C’è però una parte di popolazione che ne resta fuori e, in quanto non-soggetti di diritto, restano esclusi anche dalla penalità moderna e da ogni sua pretesa disciplinante. Questi andranno semmai a rigonfiare le fila del lavoro servile non salariato, tra i campi nelle mani del caporalato, sulle strade o nelle piazze quando non rimandati nelle terre di origine. Allora quando parliamo di alternative al carcere dobbiamo porci almeno due domande: alternative per chi? E rispetto a cosa? Perché fin quando resterà esclusa dalla fruizione delle misure alternative una fetta considerevole di popolazione penitenziaria completamente priva di risorse materiali, economiche e sociali, il carcere come sistema punitivo resterà sempre funzionale rispetto alla sua riproduzione. Per gli immigrati irregolari e gli emarginati, invece, questa possibilità resta esclusa a priori e, per loro, non resta che la violenza del carcere o l’espulsione. Per quanto riguarda la seconda questione, invece, l’espansione crescente delle misure alternative sembra ben lontana dal configurare la realizzazione di qualcosa di meglio del diritto penale, come auspicato da Gustav Radbruch, ma più vicina, quasi certamente, a un diritto penale migliore. Ma ciò non basta, perché al proliferare di misure alternative al carcere dovrebbe per lo meno corrispondere un forte ridimensionamento delle fattispecie delittuose, andando così verso un diritto penale che possa davvero dirsi minimo.
La dinamica escludente a cui vanno incontro i detenuti stranieri,
Bibliografia
- A. DE GIORGI, Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine, ombre corte, Verona, 2022.
- M. FOUCAULT, Alternative alla prigione, Neri Pozza, Vicenza 2022
- M. GOTTSCHALK, Deplorable or Disposable? The Carceral State and “Braking Bad” in Rural America, in N. LACEY et al. (a cura di), Tracing the Relationship between Inequality, Crime and Punishment: Space, Time and Politics, British Academy, London, 2021, pp. 94-132.
- D. MELOSSI, Economia politica della pena, in T. Pitch (a cura di), Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive, Carocci, Roma, 2022, pp. 23-43.
- G. RUSCHE, O. KIRCHHEIMER, Pena e struttura sociale (1939), il Mulino, Bologna, 1978.


Conversazione con Pino Cacucci
A cura di Chiara Gazzola
Ciao Pino, la mia prima curiosità è rivolta alla tua ultima pubblicazione, L’elbano errante*, un romanzo storico ambientato nel ‘500 nel quale i temi del viaggio, della precarietà esistenziale e del senso di infinito appaiono predominanti. Ti sembra corretta questa sintetica interpretazione?*
E che cosa ti ha spinto ad ambientare il romanzo in questo secolo dopo esserti occupato del ‘900 sapendo coglierne aspetti differenti e, forse, contraddittori?
Non solo l’interpretazione mi sembra corretta, ma racchiude i sentimenti essenziali che spingono il protagonista del romanzo – che definirei sia storico che di avventure – a diventare «errante», continuamente alla ricerca di risposte a un’esistenza votata alla vendetta. Alla base di un’idea che ho coltivato per una decina d’anni – con lunghe ricerche e innumerevoli letture – c’era la voglia di narrare cosa sia stato il cosiddetto Rinascimento, un secolo di massacri e guerre interminabili, scontri sanguinosi con i Turchi che hanno compiuto veri genocidi e costretto alla schiavitù innumerevoli giovani donne sequestrate ovunque e, per contro, una civiltà cristiana che era in piena Inquisizione, con altrettante guerre tra cattolici e protestanti, con le persecuzioni di ugonotti, valdesi, eretici di ogni sorta, streghe da bruciare sul rogo, e così via… Forse è stata per me una sorta di istigazione, questo odierno uso della parola «rinascimento» sempre a sproposito: volevo raccontare cosa fu veramente quell’epoca.
Dunque, dopo tanti anni di elucubrazioni, ho iniziato a scrivere questo librone di circa mille pagine nel primo periodo di cosiddetto lockdown, arrivando al secondo, senza smettere di scrivere per un anno, senza escludere un solo giorno, quasi fossi posseduto da questa storia e le sue innumerevoli vicende… Insomma, un romanzo figlio della peste, mi verrebbe da dire. L’idea di partenza è l’isola d’Elba, che frequento da almeno quarant’anni, un amore che si è consolidato di pari passo con quello per il Messico. C’è una spiaggia, forse non memorabile, semplicemente un arco di sabbia grossa e ghiaia poco prima della baia di Porto Azzurro, un tempo Longone. E fin dalle prime volte mi chiedevo perché l’avessero chiamata spiaggia del Barbarossa. Nulla a che fare con l’imperatore Federico, né con un ufficiale barbuto di Napoleone (poiché all’Elba tutto o quasi ruota attorno a quei dieci mesi del Bonaparte). Una curiosità che non era difficile da soddisfare e approfondire, visto che gli Elbani amano la storia della propria terra montagnosa circondata dal mare: Barbarossa era il soprannome che i cristiani affibbiarono al temuto Khayr al-Din, ammiraglio turco di Solimano il Magnifico, e il nome dato alla spiaggia non era certo un omaggio, bensì il ricordo di eventi nefasti. In questa insenatura a poche miglia dal porto di Longone, sbarcò più volte con i suoi corsari turcheschi e i famigerati giannizzeri, mettendo a ferro e fuoco buona parte dei centri abitati limitrofi, depredando e distruggendo e incendiando e, soprattutto, sequestrando giovani da mettere ai remi delle galee e giovinette da vendere all’asta degli schiavi di Algeri. Ancor più ambite se erano vergini, per cui, rapivano spesso anche le bambine.
Da allora, ho rimuginato per decenni qualche idea su come raccontare quell’epoca. La stessa che ci piace chiamare Rinascimento, ma che all’Elba, come del resto in tutte le coste del Mediterraneo e non solo, fu sanguinaria e devastata da guerre, invasioni, massacri spaventosi, nonché crudeltà spesso gratuite, inflitte con sadismo terrificante. Ammetto che anche la smania di gettare tutto questo sangue sull’edulcorata facciata del Rinascimento mi ha intrigato fin dall’inizio.
E mentre raccoglievo storie e leggende, un giorno a Portoferra-
io ho visto quella targa di marmo sul muro esterno del vecchio mercato, dove nel XVI secolo si costruivano le grandi galee da battaglia:
«Da questo arsenale scesero nelle onde del Mediterraneo quei vascelli da guerra che offrirono alle coste toscane protezione e difesa dagli attacchi turcheschi. A Gloria del Principato Mediceo e dell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano».
In quegli anni Portoferraio era stata ribattezzata Cosmopoli, in onore di Cosimo de’ Medici che fece costruire bastioni e fortezze, rendendo l’Elba inespugnabile, scelta strategica poiché l’isola, fin dai tempi degli antichi Romani era talmente ricca di ferro da suscitare le mire di tanti. Ferro per daghe, spade, alabarde, corazze, e poi archibugi, e palle di cannone… E a un certo punto Cosimo proprio qui, a poche centinaia di metri sopra l’arsenale, volle fondare il Sacro Militare Ordine di Santo Stefano, nell’edificio allora convento adibito a caserma, dove oggi sorge, su una piazza lastricata che domina il suggestivo scenario del centro storico e della baia, il Centro Culturale De Laugier (un altro ufficiale di Napoleone, Cesare De Laugier, di origini elbane).
Cominciava a esserci tanto materiale per la mia fantasia unita alla ricostruzione storica. Non restava che tener conto dell’amore, che in un’epopea di battaglie, insorgeva ancor più forte a dispetto delle violenze: un affetto spezzato tra una sorella e un fratello su quella spiaggia, gli amori disperati di lui diventato spadaccino e soldato di ventura, le relazioni di lei che darà un figlio al Pascià di Algeri, e l’amore di giovane madre disposta a tutto pur di salvarlo e renderlo libero… E collegare il fatto che in quegli anni Miguel de Cervantes era un ventenne soldato a Napoli nonché spadaccino sfuggito alla giustizia per un duello in Spagna. Occorreva far quadrare i conti di luoghi e date degli eventi storici per farlo incontrare con il mio protagonista, Lucero l’Elbano.
Un’altra confessione: la spinta a narrare gli eccidi e le sopraffazioni messe in atto dai Turchi è dovuta alla mia vicinanza pluridecennale alle popolazioni curde – a Bologna la comunità già vent’anni fa mi invitava alle loro manifestazioni e alla festa del Nowruz, l’avvento della primavera che segna l’inizio del calendario curdo, festa proibita e repressa in Turchia – e ricordare a chi leggerà questo libro – romanzo d’avventure, certo, «di cappa e spada», ma anche accurata ricostruzione storica di ogni evento, arrivando alla battaglia di Lepanto – quale storia passata e presente abbia la Turchia.
Ebbene, era una rivalsa che mi ha animato non poco a scriverne. Ma anche ad approfondire le motivazioni che spinsero migliaia di cristiani catturati a convertirsi e a scalare le gerarchie militari fino a diventare ammiragli del Sultano – esempio supremo fu il calabrese Uccialì, che a Lepanto inflisse gravi perdite alla Lega Santa – e sicuramente lo fece non da mercenario ma da musulmano convinto. Senza però dimenticare che se l’Islam si è macchiato di simili crimini contro l’umanità, il Cattolicesimo con l’Inquisizione ha fatto altrettanto, e all’Inquisizione di Siviglia – e non solo – sono dedicati non pochi capitoli. Non è per pareggiare i conti, è per rammentare cosa fu il Rinascimento.
L’idea di narrare le vicissitudini di Cervantes quando era ancora soltanto uno spadaccino e un soldato dei Tercios de Infanteria a Napoli – dove era riparato dalla Spagna arruolandosi come in una sorta di Legione Straniera per sfuggire alla condanna del taglio della mano destra per aver gravemente ferito un uomo influente in un duello – è stato il punto a cui volevo arrivare in questo romanzo: sapere che aveva combattuto nella «battaglia delle battaglie», Lepanto, mi affascinava non poco, volevo farne un protagonista di azioni e dialoghi, quindi la vita di Lucero l’Elbano era da me predestinata a questo incontro tra uomini d’arme, con una differenza d’età di circa vent’anni. Sono entrambi appassionati di letture epiche, cavalleresche, picaresche, e questo suggella subito il rapporto di amicizia. Cervantes diventerà il cantore dell’avventura utopica camuffata da follia, Lucero l’ha vissuta fin da ragazzino e continua a viverla, pur sentendo che gli anni e le amarezze stanno erodendo le motivazioni per andare avanti: «Loro sono la barbarie, ma noi non siamo certo la civiltà».
Insomma, i soliti disastri della storia, dalla quale non impariamo mai. Con l’aggravante delle menzogne della propaganda bellica. Se c’è una differenza con il passato, e quindi con il ‘500, è che allora ricorrevano meno all’ipocrisia, combattevano e basta. Oggi, gli ipocriti prevalgono e falsano tutto. Arrivando alla macabra favoletta di un’Europa che è in pace dal 1945: intanto, ha partecipato e armato e anche provocato innumerevoli guerre. L’Europa è il continente dell’ipocrisia. Ha usato i Curdi come carne da macello quando le città europee erano flagellate dai sanguinosi attentati dell’Isis, per poi fregarsene quando i Turchi e le loro schiere di tagliagole jihadisti li hanno attaccati alle spalle: per l’Europa la Turchia è un ottimo partner commerciale, a cui vende armi e anche quei carri armati che invadono i territori dei Curdi e ne travolgono la resistenza. Oltre che ipocriti, anche cinici e codardi.
Il romanzo si sviluppa su due contesti paralleli: la realtà di Lucero spadaccino e soldato di ventura, e la realtà di Angiolina rapita e venduta all’asta di Algeri, e così via. Angiolina-Aisha è l’altra protagonista, in alcune fasi è persino predominante come figura narrativa. E nel corso delle avventure e disavventure, emergono sempre donne non soltanto come comparse o amanti di Lucero, ma figure emblematiche delle vicende dell’epoca (Raquel l’ebrea di Siviglia perseguitata dall’Inquisizione, la strega del Beneventano, la prostituta di Firenze o quella di Napoli, entrambe simboli di una certa realtà da “soldataglia”, o anche la giovinetta Eréndira sul lago di Pátzcuaro… fino a personaggi come Zahira “l’Ape Regina” dell’harem di Algeri o la convertita Amina).
E a un certo punto… faccio arrivare Lucero l’avventuriero fino in Messico, l’allora Nueva España dei Conquistadores. Dopo un’intera vita di frequentazioni, appassionate letture e ricerche sulla storia dell’America Latina e in particolare del Messico, a cui ho dedicato non pochi libri e innumerevoli articoli, ho creduto di poter ricreare quelle atmosfere in base alle conoscenze maturate in quarant’anni di vagabondaggi sia geografici che letterari. Il tentativo, che spero sia riuscito, era trasmettere quella stessa meraviglia che provò Bernal Díaz del Castillo, il cronista di Hernán Cortés, quando vide spalancarsi davanti agli occhi la capitale degli Aztechi – anche se in realtà loro si chiamavano Mexíca – la Gran Tenochtitlán. Con l’aggravante che davanti alla vista di Lucero e del suo manipolo di armigeri ex galeotti, si estende la distesa di macerie provocate dalla conquista e un’umanità assoggettata e vilipesa.
Da lettrice ho sempre colto nella tua prosa il filo conduttore di una traccia libertaria: sia nei tuoi romanzi che nelle ricostruzioni storiche; sia nei racconti autobiografici che nei ritratti di artiste che hanno saputo esprimere - attraverso opere e scelte esistenziali pagate spesso duramente - la loro opposizione nei confronti di una cultura maschile e oppressiva. Ci puoi dire qualcosa di più a riguardo? Quali sono per te gli aspetti essenziali del pensiero e dell’etica libertaria sui quali dovremmo insistere in una società sempre più complessa e strutturata?
Ecco il termine giusto: etica. Mi sono sentito anarchico fin dall’adolescenza: nato e cresciuto in una famiglia di comunisti sfegatati ma libertari nei comportamenti quotidiani, l’attrazione per l’anarchismo storico fu molto precoce. Ben presto, del comunismo togliattiano e poi via via a seconda dei leader, mi colpiva la mancanza di etica: mi sembrava che per loro il fine giustificasse i mezzi, avanzando imperterriti (e scelleratamente) verso un baratro che puntava alla spartizione del potere soffocando strada facendo proprio l’etica. Per me il pensiero libertario è proprio questo: non separare mai l’ideale dal vivere di ogni giorno. E iniziando a scrivere, a narrare storie, ho sempre seguito questo filo, prediligendo la ricostruzione di esistenze ed eventi improntati a tale etica (per esempio, scusate l’autocitazione, le vicende umane e tragiche di Jules Bonnot nel romanzo In ogni caso nessun rimorso, che continuo a considerare uno dei migliori che abbia scritto).
Nei tuoi libri, soprattutto in quelli che prima ho definito «ritratti», hai scelto principalmente di scrutare l’universo femminile. Puoi spiegarci che cosa ti ha spinto in questa direzione?
Nei primi anni ‘80 arrivai in Messico con una curiosità – tra le innumerevoli – su chi fosse stata una certa Tina Modotti; di lei avevo visto negli anni 70 alcuni ritratti fotografici eseguiti da Edward Weston in una mostra a Venezia: le scarse notizie nelle didascalie mi intrigarono… e poi, quello sguardo intriso di malinconia, che lasciava presagire tante cose, per un raccontatore di storie. E a Città del Messico mi resi conto che lì la memoria di Tina Modotti era viva, addirittura gli intellettuali ne discutevano animatamente e così mi misi a cercarne le tracce, che allora (quarant’anni fa) mi permisero persino di conoscere qualcuno ormai ottuagenario che l’aveva frequentata, in quell’epoca di intense passioni politiche e cannibalismo tra stalinisti e antistalinisti; passo dopo passo, conobbi innanzi tutto Paco Taibo II (la nostra amicizia iniziò nel 1982) che mi presentò a Elena Poniatowska (allora stava scrivendo il suo romanzo Tinissima) che a sua volta mi diede il telefono di Octavio Paz, dicendomi però di non dirgli che lo avevo avuto da lei: avevano appena rotto i rapporti proprio per “colpa” di Tina, dopo un articolo sulla rivista di Paz dal titolo Tina stalinissima, che in realtà poneva dubbi su quanto Tina fosse stata all’oscuro delle trame staliniane che portarono all’assassinio di Trockij o quanto ne fosse tacitamente complice. Octavio Paz, da ventenne, era andato volontario alla guerra di Spagna e lì aveva conosciuto Tina Modotti: quel giorno trascorso a casa sua, parlando di mille cose del passato e del presente, resta per me indimenticabile. Allora non sapevo bene che farne, non avevo in mente un libro ma tutt’al più un articolo per una rivista, ma dopo tante ricerche e persone intervistate, nel 1988 scrissi il primo libro su Tina Modotti, I fuochi le ombre il silenzio, pubblicato dalla cooperativa editrice Agalev, a cui ne sarebbero seguiti altri tre… Perdonatemi se me ne vanto, ma nel 1988 nessuno o quasi in Italia sapeva chi diamine fosse stata Tina Modotti, sebbene in Messico venisse considerata un pilastro della fotografia con motivazioni sociali, e comunque tra i maestri della fotografia mondiale. A onor del vero, la memoria di Tina veniva tenuta in vita solo a Pordenone, dagli amici di Cinema Zero, e a Udine dal Comitato Tina Modotti, ma erano di fatto gli unici.
Poi indagando su quell’epoca, emergevano, tramite le frequentazioni di Tina, personaggi memorabili della storia del Messico (dell’arte e della Revolución), come Frida Kahlo (credo che il primo libro in Italia che citasse una certa Frida Kahlo fosse il mio, anche se negli anni ‘80 uscì negli Stati Uniti la biografia di Hayden Herrera, allora non ancora pubblicata nella nostra lingua). E così, cominciai ad approfondire quel periodo che considero il più appassionante nella storia della cultura (e della politica) del Novecento, gli anni Venti e Trenta in Messico, in particolare nella capitale, dove furono le donne a fare la vera rivoluzione, sovvertendo schemi fino ad allora improntati a tradizioni oscurantiste. Il Messico di quell’epoca anticipò le istanze di liberazione che Europa e Stati Uniti avrebbero visto solo a partire dagli anni Settanta, basti pensare che il termine «femminismo» fu usato per la prima volta da quelle donne messicane (come, purtroppo, sono state sempre donne messicane a coniare in tempi recenti il doloroso termine «femminicidio», diffusosi anche da noi).
Nahui Olín, Antonieta Rivas Mercado, Elvia Carrillo Puerto, Nellie Campobello e innumerevoli altre. Sono state per me una fonte inesauribile di storie da narrare, inquadrandole in quel periodo di straordinaria creatività. Certo, in altri miei libri ho raccontato la storia di donne ribelli e indomite, cercando nel passato di questo disgraziato paese in cui sono nato e cresciuto, giusto per ricordare che non c’era solo il Messico, e quindi, nel mio piccolo, ho riportato in vita la memoria di partigiane come Edera, Iris e Mimma non pretendo di essere stato l’unico, ma il fatto che quando nel 2001 pubblicai Ribelli! con il capitolo che ricostruiva la vita di Irma Bandiera detta Mimma, allora nessuno la ricordava, e se oggi, almeno a Bologna, tante iniziative (compreso un affresco su una scuola) ne celebra l’immagine, beh, è per me un orgoglio averlo propiziato con quel libro, del quale il capitolo su Mimma è stato letto pubblicamente in innumerevoli occasioni.
Questa conversazione risulterebbe monca se non parlassimo dell’attualità del Messico e della cultura ispanica. Dal nostro punto di osservazione emergono più facilmente le realtà violente e poco si conosce di esperienze di autogestione (con l’eccezione del Chiapas e del neozapatismo), proprio quelle realtà alle quali «Semi sotto la neve» vuol dedicare maggior attenzione. A che punto di maturazione sono questi semi nell’America centrale?
Molti semi hanno messo radici e sono germogliati, purtroppo a noi arrivano solo echi di tragedie, massacri, narcotraffico e così via. L’esempio del Chiapas è fondamentale: gli zapatisti hanno ottenuto il notevole risultato di creare una nuova sensibilità nella società civile messicana, che prima non si poneva granché la questione del razzismo intrinseco o strisciante nel Messico moderno nei confronti delle popolazioni indigene. Hanno gettato le basi di una nuova concezione della realtà circostante, varcando i confini del Messico e spargendosi un po’ ovunque. E molti movimenti successivi in America Latina ne hanno tratto spunti e ispirazione. Ovviamente l’Impero continua a commettere ogni sorta di crimini per soffocare questi germogli, un tempo ricorreva ai colpi di stato (senza rinunciarvi del tutto, i più recenti in Honduras e in Perù, intanto in Venezuela ci ha provato con risultati fallimentari, come pure, parzialmente, in Bolivia), mentre adesso usa immani risorse per finanziare le oligarchie e sobillarle e istigarle in varie maniere. Temo però che non si possa essere ottimisti al riguardo: se è vero che le radici di quei semi sono tenaci, è altrettanto vero che viviamo in un’epoca di strapoteri finanziari che impongono qualsiasi cosa (a partire dal cosiddetto «estrattivismo», il saccheggio sistematico delle risorse del loro sottosuolo). Di fatto, parlando di Centroamerica, le etnie indigene di ceppo maya (prevalenti in Chiapas e Guatemala) hanno diffuso una coscienza sociale di straordinario valore, a partire dai rapporti con la Madre Terra, concetti che minoranze agenti nel continente americano e in Europa (e non solo) hanno fatto proprie.
Tu svolgi anche la professione di traduttore. Come descriveresti quest’arte, che presuppone un’ampia conoscenza della cultura di un autore ma il cui impegno principale penso sia, attraverso l’utilizzo di una lingua diversa, quello di rendere comprensibile la sensibilità originaria, con tutte le sfaccettature che questo comporta?
Direi che da tempo, ormai, l’attività di traduttore è quella principale, considerando i circa 120 titoli di letteratura spagnola e latinoamericana in oltre 35 anni. Volendoci scherzare su, in pratica scrivo libri nel tempo libero dalle traduzioni. È un mestiere che mi affascina e appassiona. E mi ha permesso di conoscere scrittrici e scrittori con i quali ho rapporti di amicizia, in alcuni casi soltanto epistolare, in molti altri c’è una frequentazione ovunque si presenti l’occasione. La consuetudine di contattare l’autore del libro da tradurre aiuta enormemente a ottimizzare il lavoro: lo spagnolo è la lingua di 21 paesi, praticamente impossibile conoscere il gergo di tutti, spesso un testo scritto – per esempio – da un messicano, risulta per molti termini incomprensibile a un abitante di Madrid o di Buenos Aires. Ovviamente, per la mia frequentazione del Messico, sono avvantaggiato con autori di quell’immenso paese, tenendo conto però che da uno stato all’altro esistono modi di dire completamente diversi (tra parole e frasi gergali del Chihuahua, per esempio, e quelle del Chiapas, esistono differenze notevoli). Sta proprio qui il fascino del tradurre quella che è sì una lingua comune, ma che varia costantemente non solo da un Paese all’altro ma anche da una regione all’altra. Certo, dopo circa 120 libri tradotti, ormai conosco molte varianti anche dei luoghi dove non sono mai stato, comunque è fondamentale il rapporto con gli autori che traduco. Per mia fortuna ho sempre trovato un’amichevole disponibilità, perché esistono anche scrittori poco accorti che, se il traduttore chiede loro aiuto per alcuni dubbi, pensano che il traduttore non sia abbastanza bravo. Oggi con la posta elettronica questi rapporti epistolari sono facili e rapidi. Ricordo che prima (come dicevo, i miei 35 anni di “carriera” sono iniziati quando a malapena cominciavano a usarsi i computer) scrivevo lettere cartacee, e in casi come quello di Francisco Coloane, del quale ho tradotto l’intera opera, le mie domande ci mettevano settimane ad arrivare in Cile e altre settimane ci volevano per ricevere le sue risposte. Oggi mi sembra di raccontare qualcosa di preistorico, eppure, allora usavamo la posta aerea.
È una bella cosa sentir definire «un’arte» il mestiere silente e appartato del tradurre, anche se preferirei chiamarlo artigianato: un appassionato e attento lavorio alla ricerca del termine giusto, del sinonimo appropriato, cercando di restituire l’anima di un testo in un altro linguaggio, interpretando le intenzioni e le intuizioni di chi lo ha scritto, e tenendo sempre presente che si tratta di traduzione letteraria e non letterale: su questo punto, occorre prendersi alcune libertà per rendere non solo il senso ma anche le sensazioni che l’autore voleva trasmettere ai lettori. Tornando ai rapporti diretti, ovviamente non ho potuto avviarli quando mi hanno affidato testi di autori scomparsi da tempo, come nel caso di vari testi di Ernesto Che Guevara, primo tra tutti i cosiddetti Diari della motocicletta. Di quella esperienza straordinaria ricordo soprattutto la sensazione di conoscere, pagina dopo pagina, frase dopo frase, un ragazzo che in sella a una sgangherata moto – condivisa con l’amico per la pelle Alberto Granado – percorreva le strade della sua Mayuscula América, come la chiamava lui, e al termine, un profondo senso di rimpianto per non averlo mai conosciuto. Perché tradurre comporta anche questo: illudersi di capire il motivo per cui l’autore ha scelto quella certa parola anziché un’altra, una costruzione della frase, un concetto in cui a un certo punto ha provato dubbi, ripensamenti. Insomma, la magia della traduzione è questa: la relazione intima con chi ha scritto l’originale.
Hai detto di aver avuto l’opportunità di conoscere profondamente alcuni autori, penso a Luis Sepúlveda o a Paco Ignacio Taibo in particolare. Quale ricchezza ti ha lasciato l’averli frequentati?
Una ricchezza innanzi tutto umana: il rapporto di amicizia e complicità mi ha sempre dato moltissimo, le nostre interminabili chiacchierate (su ogni argomento possibile e immaginabile, spaziando dai libri alle vicissitudini personali, dalla politica internazionale alla vita quotidiana di ciascuno) sono sempre state memorabili occasioni conviviali, tra ironia, risate, momenti di tristezza per le assenze e di passione per gli ideali in comune. La perdita di Lucho, come chiamavamo Sepúlveda tra noi amici, mi ha privato di un punto di riferimento, umano, culturale, politico. Con Paco tutto questo continua, fortunatamente, ed entrambi sono sempre stati due straordinari catalizzatori di rapporti e conoscenze, organizzatori di festival e saloni del libro e ogni sorta di iniziativa culturale di livello internazionale. Intorno a Paco e a Lucho si è creata una “banda” di scrittori e scrittrici, giornalisti ed editori, e ogni incontro con il pretesto di presentare libri e incrociare esperienze ha consolidato rapporti arricchenti che mi hanno sempre scaldato il cuore e stimolato i pensieri. Vorrei concludere ricordando un altro «imprescindibile», come definì Brecht gli uomini dei quali non si può fare a meno: Eduardo Galeano. C’eravamo conosciuti in Nicaragua, quando il sandinismo rappresentava un esempio, un’alternativa che attirava tante persone da tutti gli angoli del mondo. In una delle ultime volte che ci siamo visti a cena, qui in Italia, abbiamo condiviso l’amarezza per come era finita quell’esperienza… ma sempre avendo ben chiaro che le nostre utopie potevano essere incrinate da errori e delusioni e persino “tradimenti”, ma ciò non significa affatto che siano sbagliate o che i devastatori del pianeta avessero ragione. Fu proprio Eduardo, del resto, a coniare quella frase che oggi circola nel mondo: «L’utopia è come l’orizzonte: muovi un passo e si allontana di un passo, cammini per chilometri, e si allontana di chilometri. Ma allora a cosa serve l’utopia? Proprio a questo: ad andare avanti». Verso l’orizzonte: sconfitti mille volte ma mai arresi.
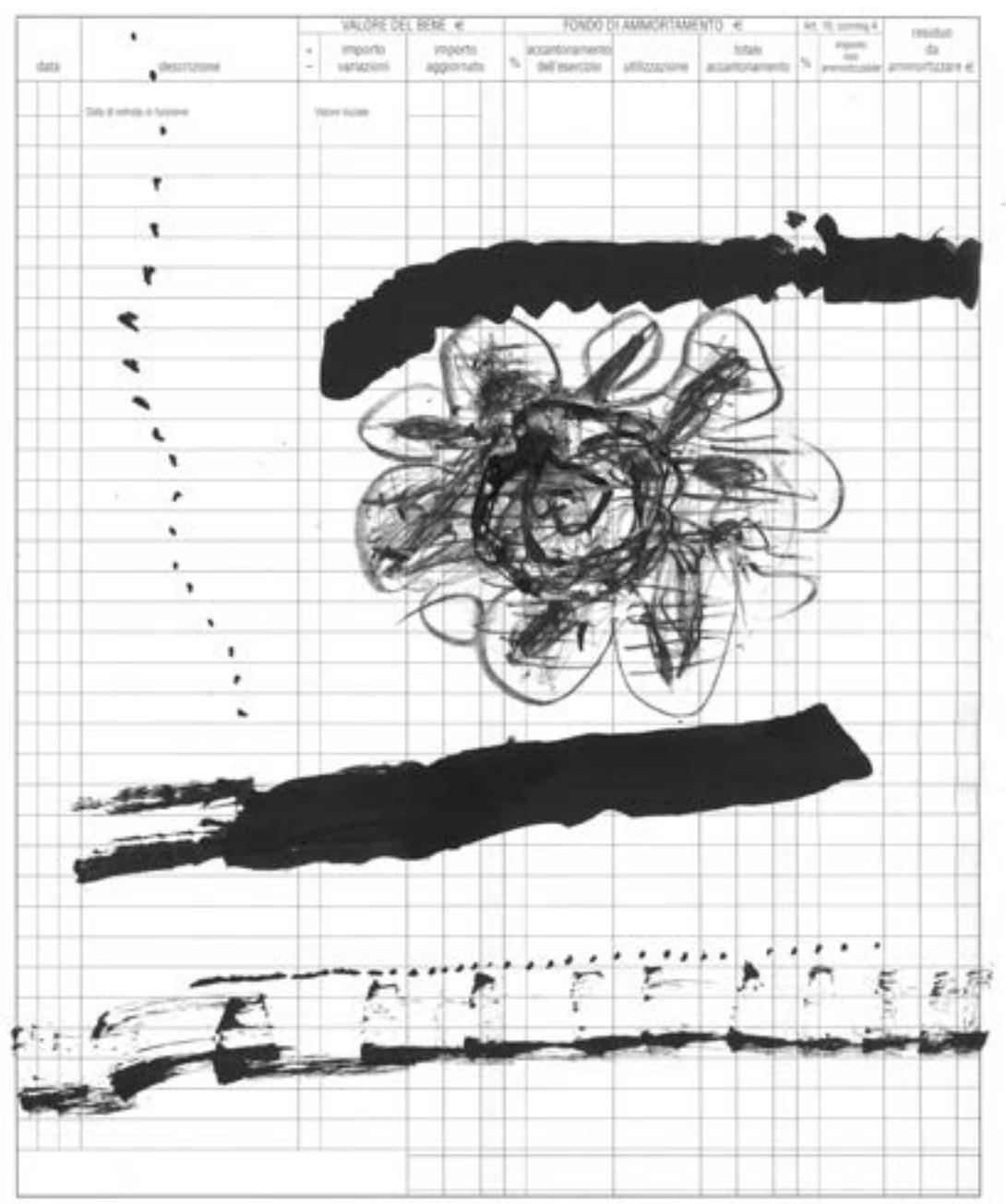

Hippies neoliberisti. Lavorare dai paesi di vacanza
Luca Bognanni
I nomadi digitali si considerano spesso l’avanguardia della globalizzazione, tuttavia, essi incarnano l’opposto di un movimento alternativo
Fino a ieri contavano la casa, l’auto e le otto ore di lavoro, oggi invece il motto è: vivi secondo le tue regole, trova il tema che ti sta a cuore, lavora in modo flessibile e in qualsiasi parte del mondo.
Sempre più persone in Germania vogliono seguire questo imperativo da millennial, di indipendenza, ricerca di significato e avventura. Secondo un sondaggio Bitkom, il 35% degli intervistati in età da lavoro lo farebbe prevalentemente dall’estero, se ne avesse la possibilità. In testa a questa tendenza ci sono i cosiddetti nomadi digitali. Come tali si definiscono coloro che non solo lavorano prevalentemente all’estero, ma che si spostano nelle zone calde senza una residenza fissa e non hanno bisogno di altro per guadagnare se non di un computer portatile e di una connessione internet stabile.
Una parte cospicua di questa comunità, molto presente in rete, mette in scena il proprio stile di vita come alternativa hippie a una vita noiosa e alienata da colletti bianchi. «Voglio finalmente realizzare i miei sogni, invece di lavorare tutta la vita per i sogni di qualcun altro», è un aforisma spesso condiviso nei gruppi Facebook della community. Ma il fenomeno mostra anche i vuoti e i paradossi delle società tardo-capitaliste: essere liberi e non vincolati significa buttarsi a capofitto nel libero mercato.
Come ha scritto l’autrice del «New Work» Christine Thiel nella sua dissertazione Der mobile Alltag Digitaler Nomaden zwischen Hype und Selbstverwirklichung (La quotidianità mobile dei nomadi digitali tra hype e auto-realizzazione), pubblicata nel 2021, il trend dei nomadi digitali è stato scatenato dall’uscita di un bestseller internazionale Die 4-Stunden-Woche: Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben (La settimana di 4 ore: più tempo, più denaro, più vita), scritto da Timothy Ferriss nel 2007. In esso la ricchezza non viene più definita dal possesso di beni materiali, ma dal tempo libero a disposizione, dalla
Ferriss ha diffuso il principio del cosiddetto «geoarbitraggio»: si tratta di sfruttare la diversità dei livelli salariali e del costo della vita nel mondo. In concreto: anche con uno stipendio piuttosto basso in Germania è possibile vivere bene nei paesi del sud del mondo
mobilità. Valori post-materialistici come lo sviluppo di sé e l’autorealizzazione, che i bohémien hanno da sempre rivendicato, sono quindi ora etichettati come la «nuova ricchezza», impregnata di capitalismo e trasferita nel mondo degli high performers e dei carrieristi.
Ma un tale concetto di vita deve essere finanziato. Ferriss suggerisce di creare un reddito passivo, che vuol dire fare una prestazione lavora-
tiva una tantum che generi reddito senza ulteriori azioni. Ad esempio, un seminario sul web che, una volta online, può essere consultato e venduto più volte. Dall’altra parte Ferriss ha diffuso il principio del cosiddetto «geoarbitraggio»: si tratta di sfruttare la diversità dei livelli salariali e del costo della vita nel mondo. In concreto: anche con uno stipendio piuttosto basso in Germania è possibile vivere bene nei paesi del sud del mondo. Queste due strategie caratterizzano anche lo stile di vita di molti nomadi digitali.
Guidati dal mercato
Tuttavia i presunti modelli di successo portano solo poche persone alla vita di lusso e agi tanto propagandata. Lo dimostra lo studio sul campo di Christine Thiel, che tra il 2015 e il 2019 ha trascorso diversi mesi negli hotsposts del webworking mondiale e ha condotto interviste significative con i nomadi. Molti nomadi digitali vivono in modo precario come freelance, nonostante il geoarbitraggio.
Lavorano nella vendita diretta di Amazon, offrono servizi di life e business coaching, gestiscono una sorta di segreteria online come assistenti virtuali o scrivono testi pubblicitari ottimizzati per i motori di ricerca. Pochi nomadi rimangono a lungo nello stesso lavoro; sono guidati dalle mode in rapida evoluzione del mercato digitale. Un attimo fa tenevano corsi su come ottenere voli in business class grazie a intelligenti raccolte punti e ora prendono in affitto immobili a basso costo nei paesi del sud del mondo, per subaffittarli ai turisti a caro prezzo.
La maggior parte dei servizi digitali segue le tendenze del momento, viene riprodotta in massa, fino a quando non prende piede una nuova moda. Inoltre i prodotti sono spesso rivolti alla community stessa e mirano a reclutare nuove «persone che la pensano allo stesso modo». I loro programmi, riversati in e-book, podcast, blog e corsi online, si chiamano «Scelgo la libertà», «Fuga dall’ufficio» o «Breakout! Esci dal sistema ed entra nella vita libera (dalle tasse)». In molti casi la situazione sembra un grande sistema a effetto palla di neve, in cui i membri si vendono l’un l’altro il loro coaching. Sempre in controtendenza però: l’immagine del dipendente nine-to-five controllato dall’esterno è considerato il tipico esempio di vittima da «ruota del criceto», mentre i nomadi sembrano essere i soli in grado di raggiungere la libertà totale.
Lo studio dettagliato di Thiel non solo mette a nudo le ovvie incongruenze della propagandata realizzazione di sé, che dovrebbe avvenire tramite l’acquisto di un grezzo vademecum online, ma fa anche luce su altre contraddizioni tra lo stile di vita commercializzato e la realtà della vita dei nomadi digitali. Forse il più grande paradosso emerge quando si dà un’occhiata ai loro discorsi di liberazione. Nei gruppi Facebook di questa comunità, si propone una visione del mondo che rifiuta le reti di sicurezza e la regolamentazione statale.
La Germania, con le sue misure adottate in seguito alla pandemia, la tassazione e l’istruzione obbligatoria, viene non di rado definita nei commenti come una «repubblica delle banane» iperburocratica ed economicamente pianificata. Sebbene questa visione non sia rappresentativa dell’intera comunità, la sua frequenza nei commenti non sembra insignificante nell’analisi dell’ideologia della liberazione. La glorificazione dell’autoresponsabilità, della libertà individuale e dell’assunzione di rischi è insita in questa ideologia. Per ironia della sorte, però, sono proprio le tanto demonizzate «reti di sicurezza» che rendono possibile a molti il passaggio alla vita nomade.
I costi del capitalismo globalizzato
La certezza di «cadere sul morbido» in caso di fallimento è soprattutto ciò che rende il vagabondare digitale un’opzione possibile. Non ci sono neanche riflessioni approfondite su quella «mobilità» a cui i nomadi si sottopongono volontariamente. La maggior parte di loro viaggia con visti turistici e deve lasciare molti paesi al massimo dopo tre mesi. Poiché viaggiano senza permesso di lavoro, spesso si muovono in zone grigie dal punto di vista legale. Con il loro mito kitsch della auto-realizzazione sbandierato sui social media, i nomadi digitali nascondono i costi del capitalismo globalizzato con tutti i suoi vincoli e le sue incertezze. Molti hanno trasformato il marketing del loro stile di vita in un modello di business, anche se le immagini patinate che si trovano su Istagram non hanno molto a che fare con la realtà; nel migliore dei casi sono reali solo per pochi. E persino il moto di critica al capitalismo, che denuncia l’alienazione nel rapporto di lavoro, si rivela una finta lotta: l’obiettivo non è infatti colpire il «capitalismo nemico» con un colpo mirato, ma promuovere il nuovo modello di lavoro freelance contro quello del posto fisso nell’economia sociale di mercato.
I nomadi digitali non mettono in discussione i meccanismi che portano al rapporto col libero mercato. Al contrario, li naturalizzano e li reinterpretano come opportunità: la perdita delle reti di sicurezza sociale e lavorativa? Un’uscita solenne dalla propria immaturità. Dover affermarsi come singola «EGO-ditta» nella libera concorrenza globalizzata? Un’occasione per la definitiva realizzazione di sé. Il fondamento ideologico si basa su una fede quasi spirituale nei poteri liberatori e di realizzazione di un mercato non regolamentato. Il sociologo Ulrich Bröckling ha coniato il termine «io imprenditoriale» per questa categoria tardo-moderna, all’inizio degli anni 2000.
Nello stile di Google, Facebook e Co.
In questo senso i nomadi digitali sono l’opposto di un movimento alternativo: invece di attaccare le strutture attuali e sperimentare modelli alternativi all’interno di collettivi, officine o cooperative, come negli anni ‘70, gli hippy neoliberali chiedono di portare all’estremo il mainstream economico.
I nomadi digitali operano come aziende internazionali quando esternalizzano i loro costi di vita in paesi del sud globalizzato. Molti cancellano la loro residenza in Germania e utilizzano modelli di risparmio fiscale nello stile di Google, Facebook e Co. Il grande vuoto, come riassume anche Christine Thiel nella sua analisi, è la valutazione morale di questa «desolidarizzazione sociale». Tutto sembra legittimo semplicemente perché è possibile.
Traduzione di Anna Lisa Bertolo pubblicato il 12 gennaio 2023 su Tageszeitung (Taz), quotidiano della sinistra radicale fondato a Berlino nel 1978*.*


Carlo Rosselli (1899-1937)
Nicola Del Corno
È nota quella pagina del sesto capitolo di Socialismo liberale nella quale Carlo Rosselli esaltava il metodo liberale quale miglior mezzo di autogoverno per una società; un metodo che aspirava a che le comunità politiche potessero amministrarsi da sé «con le loro forze, senza interventi coercitivi o paternalistici». Tale metodologia, spiegava l’autore, consisteva nel principio che la libera persuasione individuale fosse l’unica via praticabile per arrivare alle decisioni riguardanti la polis nel suo insieme. Da un punto di vista più strettamente istituzionale, tale metodo poteva esemplificarsi in un insieme di regole del gioco, tese a contenere le inevitabili, e anzi auspicabili, discordie sempre risorgenti nella società entro una pacifica convivenza, capace di assicurare una feconda dialettica fra partiti, movimenti e individui.
Risulta pertanto indubitabile l’appartenenza di Rosselli alla migliore tradizione del socialismo democratico, liberale, e più complessivamente libertario nel suo costante impegno a contrastare ogni soluzione dittatoriale, fascista o comunista che fosse. La passione democratica di Rosselli si sostanziava per essere prescrittiva, ossia in prima istanza si batteva per il pieno riconoscimento dei diritti individuali, per la promozione di una maggiore uguaglianza pur nel rispetto delle differenze, per la ricerca di una nuova forma di partecipazione politica che partendo dal basso non si risolvesse in una indistinta massificazione della società, ma garantisse cooperazione, così come autonomia e pluralismo. Rosselli cercò costantemente un sottile equilibrio fra democrazia formale e democrazia sostanziale; se infatti era vero che la democrazia aveva sue proprie regole procedurali che non andavano stravolte, d’altro canto però doveva soprattutto coinvolgere nella gestione della cosa pubblica il maggior numero di cittadini, fungendo da elevazione morale e politica per i ceti subalterni. Compito pertanto dei socialisti e dei libertari era quello di comprendere finalmente come il problema di una società libera fosse quello di fornire ai cittadini una coscienza politica che li coinvolgesse in pratiche concrete di autogoverno. Non sorprende allora come la preoccupazione di rendere pienamente partecipativa l’Italia, una volta uscita dalla dittatura fascista, fosse uno dei temi portanti della riflessione e dell’azione politica rosselliana: la libertà, che sino a quel momento aveva riguardato solo alcune minoranze privilegiate, doveva ora divenire per la prima volta nella storia una pratica del vivere civile condivisa da tutta la popolazione. Ma perché ciò si concretizzasse, era necessario che la democrazia non risultasse una mera forma di governo rappresentativo, ma divenisse sostanziale nelle più diverse manifestazioni della collettività; «uomini vogliamo, non schede, non numeri, non tessere», questo era l’appello di Rosselli nel rimarcare la differenza fra la democrazia considerata come sola forma e quella invece come efficace sostanza; il risultato nel primo caso era stato, lo ricordava una volta di più, il fascismo. Trasformati in meri elettori, i cittadini rimanevano infatti in una condizione di subalternità, come ribadiva nel famoso articolo Contro lo Stato: «in poco più di un secolo i cittadini, trasformati in elettori, sono stati retrocessi a sudditi». In un articolo di commento al plebiscito del 13 gennaio 1935 riguardante il territorio del bacino della Saar Rosselli invitava a diffidare di una democrazia puramente quantitativa, di una sorta di «tocquevilliana» tirannia della maggioranza, dove gli elettori fossero ridotti alla stregua di massa, e non considerati cittadini consapevoli, dotati ciascuno di una propria autonomia intellettuale in grado di fargli assumere decisioni meditate secondo il proprio sentire, senza timore per questo di risultare in minoranza.
Far diventare sostanziale la prassi democratica significava allora per Rosselli in prima battuta rendere effettivamente vivi gli «organi di vita civile», strappandoli alla sclerotizzazione burocratica e ad ogni pretesa di guida coattiva; pertanto i comuni, i consigli di fabbrica e di azienda agricola, le camere del lavoro, i partiti, i giornali, la scuola, le associazioni dovevano essere trasformati in dispositivi in grado di assicurare la partecipazione diretta e il controllo effettivo degli individui che ne facevano parte. Ampliare le possibilità dell’agire politico, anche in vista di una prossima uscita dall’autoritarismo fascista, presupponeva superare schemi meramente classisti, per dare il giusto valore alla scelta personale in un contesto sociale comunque solidale. Un esempio di tale società libertaria era individuato da Rosselli nel famoso discorso pronunciato da Radio Barcellona il 13 novembre 1936, allorché avvertiva come in Catalogna «un ordine nuovo è nato, basato sulla libertà e sulla giustizia», una dimostrazione pratica di come «le più audaci conquiste sociali si fanno rispettando la personalità dell’uomo e l’autonomia dei gruppi umani» a scapito della «statolatria».
La democrazia rivoluzionaria che Carlo aveva in mente a metà degli anni Trenta, con fascismo e nazismo ormai saldamente al potere, risultava inoltre un progetto con ambizioni transnazionali, e quindi non limitato al solo orizzonte post-mussoliniano del nostro paese. Per rendere concreti i benefici dell’agire democratico, e per superare definitivamente le «barbarie» dello Stato «mostro» coevo, Rosselli pensava alla creazione di nuove istituzioni europee, legittimate da una assemblea eletta da tutti i popoli del continente; bisognava pertanto pensare, come abbozzava in modo non ancora pienamente formulato nel maggio 1935, a una futura costituzione federale europea che avesse quale compito primario quello di svalorizzare frontiere, dogane, e più in generale ogni forma di nazionalismo.
Bibliografia
Alcuni scritti di Carlo Rosselli
Oggi in Spagna, domani in Italia, a cura di A. Garosci, Einaudi, Torino, 1967.
Socialismo liberale (1930), a cura di J. Rosselli, introduzione di N. Bobbio, Einaudi, Torino, 1997.
Scritti dall’esilio, a cura di C. Casucci, Einaudi, Torino, 1988-1992, 2 voll. Scritti politici, a cura di Z. Ciuffoletti e P. Bagnoli, Guida, Napoli, 1988.
Alcuni scritti su Carlo Rosselli
- P. BAGNOLI, Carlo Rosselli tra pensiero politico e azione, Passigli, Firenze, 1985.
- N. DEL CORNO (a cura di), Carlo Rosselli: gli anni della formazione e Milano, Biblion, Milano, 2010.
- Z. CIUFFOLETTI, Contro lo statalismo. Il “socialismo federalista liberale” di Carlo Rosselli, Lacaita, Manduria, 1999.
- E.R. PAPA, Rileggendo Carlo Rosselli. Dal socialismo liberale al federalismo europeo, Guerini e Associati, Milano, 1999.
- S. G. PUGLIESE, Carlo Rosselli. Socialista eretico ed esule antifascista 1899- 1937, Bollati Boringhieri, Torino, 2001.
- N. TRANFAGLIA, Carlo Rosselli dall’interventismo a Giustizia e Libertà, Laterza, Bari, 1968.

Simone Weil (1909-1943)
Flavio Lazzarin
Non si può non essere d’accordo con Albert Camus, che definì la Weil «l’unico grande spirito del nostro tempo». Farne memoria è, allora, un invito a chi ancora si interroga sul senso della vita a leggerla e rileggerla, perché le sue parole sono come lampi che illuminano per un istante la notte del mondo in cui viviamo e sono pensieri che possono trasformarsi in attrezzi indispensabili per affrontare i pericoli dell’attualità.
Weil ha mantenuto nelle diverse stagioni della sua breve vita una coerenza radicale e ha guadagnato come conseguenza il ritrovarsi fuori dagli schemi e dalle convenzioni sociali, politiche e religiose, sempre impietosamente smascherate.
Non è assolutamente ipotizzabile dividere, né distinguere, in due momenti la biografia della Weil: il periodo militante, che è esplicito nelle Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale (1934) e il periodo mistico, dopo l’incontro con il cristianesimo, che appare con chiarezza in numerosi altri scritti. Sembra di vedere un’estrema coerenza tra la battaglia per la destituzione e morte dell’«io» – unica condizione perché possa, come dono e non come conquista ascetica, rivelarsi il divino – e la battaglia, altrettanto dura, antiautoritaria e antitotalitaria, per non accettare l’identificazione con qualsiasi gregge, tradizionale o moderno.
Nata a Parigi nel 1909 e morta a Londra, a 34 anni, nel 1943 – una breve vita in cui fu filosofa, teologa, insegnante, operaia, anarchica rivoluzionaria, matematica, mistica – Weil non si identificò con le sue origini ebraiche e fu greca per opzione filosofica, al punto di essere ritenuta antisemita. A tal proposito, tuttavia, pare invece che, in contraddizione con il dichiarato platonismo, la sua spiritualità si fondi nel dualismo teologico e monismo antropologico tipicamente giudaici e non nel monismo teologico e dualismo antropologico tipicamente greci. Benché frequentasse gli ambienti comunisti, sindacalisti e rivoluzionari, non si identificò mai con nessun partito e, fin dall’inizio, fu critica dello statalismo sovietico. Nonostante la sua conversione a Gesù, non volle identificarsi nemmeno con la Chiesa cattolica, considerata il peccato originale e l’ispirazione di tutti i totalitarismi. Non poteva accettare che l’universalità, la cattolicità, fosse resa vana dagli anathema sit. Anarchica, fu in Catalogna a combattere con Durruti, ma dopo un incidente nelle cucine, ritornò a casa, con sentimenti non violenti, sorti dopo avere constatato la violenza anche dei repubblicani.
Sul piano filosofico, se con Nietzsche l’opposizione fu prettamente esistenziale, per via della grecità del pensatore tedesco e della sua interpretazione del cristianesimo come religione degli schiavi, con Marx e i marxismi, invece, il litigio critico fu esplicito. Non si tratta solamente del suo incontro, nel 1932, con l’esule Trotskij, che pure ospitò nella sua casa a Parigi, ma che accusò di essere stato con Lenin carnefice di uno stato autoritario e oppressivo che rivelò il suo vero volto nella spietata repressione della Macnovicina e dei marinai di Kronstadt fatta dall’Armata Rossa.
Weil studiò davvero Il Capitale e la sua critica di Marx e dei marxismi appare originale e forse unica: la classe dominante riceve la missione storica di accelerare senza soluzione di continuità le forze produttive, ma in questo processo sopraggiunge il momento in cui le strutture di potere non riescono più a favorire e accompagnare lo sviluppo. Allora è la rivoluzione e il «soggetto» rivoluzionario sono le forze produttive, che propiziano il sorgere di una nuova classe egemone. Non c’è quindi assolutamente la condanna etica e politica del sistema capitalista e dei suoi orrori, ma semplicemente la constatazione che quando la borghesia non è più funzionale allo sviluppo delle forze produttive deve essere sostituita dalla classe che saprà far funzionare il sistema. Questo incessante rinnovarsi delle forze produttive non è che un mito, un assioma inconsistente e impermeabile a una lettura scientifica. Mito come il realizzarsi hegeliano dello spirito nella dialettica della storia. Mito che non sfugge all’illusione hegeliana e sostituisce le astuzie dello spirito con la materialistica misteriosa provvidenza delle forze produttive. Tutto ciò si trasformò inevitabilmente nella tragedia dell’oppressione totalitaria dei bolscevichi. Mito, perché Marx non riesce a spiegare la sua fede ingenua nello sviluppo ininterrotto e virtuoso delle forze produttive. E sono queste, per Marx, e non i diseredati e gli oppressi, l’unico vero motore della storia.
Inoltre, per Weil, è evidente la disfatta della Rivoluzione russa e della stessa idea di rivoluzione quando il potere del capitale sul lavoro, che si realizza pienamente nella grande industria con le sue macchine, è incorporato acriticamente nel sistema socialista. È nella fabbrica che sistemicamente si struttura la disuguaglianza tra specialisti e lavoratori manuali, che si riproduce poi nel rapporto diseguale e oppressivo tra gli intellettuali del partito e le masse popolari. E nella riproduzione, senza soluzione di continuità degli apparati giuridici, burocratici, militari e polizieschi dello stato zarista. Si rivela con chiarezza, ancora una volta la differenza tra chi scientificamente crea, decide e comanda e chi ha accesso solo ai risultati, senza capire nulla del metodo, relegato al ruolo di chi accetta tutto fideisticamente.
In questa lettura critica, Weil è estremamente attenta a non buttare via il bambino con l’acqua sporca, perché «la grande idea di Marx è che nella società, come nella natura, tutto si svolge mediante trasformazioni materiali» (Weil 1983: 22-23).
Non ha assolutamente senso sognare e desiderare il futuro, perché tutto dipende dalle condizioni materiali, che devono essere conosciute e analizzate per poter creare possibilità umane di vita sociale e politica. Ma, alla fine, deve constatare che il metodo materialista, l’unica idea preziosa di Marx, è sempre stato dimenticato dai marxisti e «non bisogna allora stupirsi che i movimenti sociali nati dal marxismo siano tutti falliti».
E sono fallite tutte le rivoluzioni cominciando dalla Rivoluzione francese, che, vittoriosa contro l’oppressione, ha inaugurato una nuova oppressione. Sembra impossibile emanciparsi da questo imbroglio, che, sostanzialmente, è determinato dall’esistenza dello Stato. Chi vuole resistere sembra condannato a due uniche possibilità: o la capitolazione o l’avventura; o il riformismo, più o meno cinico, di chi realisticamente non vede cammini di vittoria definitiva contro l’oppressione o il sogno avventuriero di chi opta per un’opposizione radicale al sistema. Weil insiste che Marx, con il suo metodo dimenticato, ha trovato il modo di superare questa falsa alternativa, che era egemonica negli anni Trenta e che continua paradigmatica nelle sinistre del nostro tempo.
Alla fine della sua analisi radicalmente realista dell’oppressione come costitutivo paradigma della politica, difenderà, via metodo materialista, la tesi che gli oppressi possano esercitare la volontà di non arrendersi e di approfittare di ogni breccia dimenticata dall’onnipresente potere per lottare e non rinunciare alla libertà e alla possibilità di costruire cammini di umanità, eliminando la grande industria, il capitale finanziario, la divisione tra lavoro intellettuale e lavoro manuale, la diastasi tra scienza e lavoro, sostituendo lo Stato centralizzatore, con il suo apparato burocratico e militare, con lo Stato come potere obbediente. Weil, però, non dimenticò che «è solo nell’uomo preso come individuo che si trovano la chiaroveggenza e la buona volontà, uniche fonti dell’azione efficace. Ma gli individui possono associare i loro sforzi senza rinunciare alla loro indipendenza». E, preoccupata per il contributo caratteriale di chi lotta, ci ricorda «la vanità delle etichette politiche. Ci si può lanciare nel movimento rivoluzionario con uno spirito da capo desideroso di manipolare le masse e di avere un ruolo eminente sulla scena della storia, oppure da soldato fanatico; e si trovano nei ranghi dei conservatori uomini di buona volontà naturalmente disposti a far concorrere le forze di cui dispongono per il maggior bene di tutti. È per il carattere che gli uomini sono fratelli o estranei tra di loro» (Weil 1983: 136-137).
L’antropologia che Weil propone va oltre la persona, oltre la maschera, oltre il teatro sociopolitico, oltre l’amministrazione del mondo fatta dai partiti politici, oltre la democrazia, oltre il diritto, oltre lo Stato. La critica del concetto di persona la pone ancora una volta ai margini della teologia cristiana, che fonda fin dal IV secolo l’interpretazione della Trinità utilizzando il termine «persona», πρόσωπον, prosopon. Sceglie istintivamente il monismo antropologico giudaico ed eminentemente biblico, che opta per una visione unitaria dell’essere umano, lontana dal dualismo greco – oggi ancora egemonico – che lo divide in anima e corpo. Infatti, l’anima per la Bibbia è nefesh, parola legata alla respirazione e alla vita concreta che, con l’aria, passa per la gola, le corde vocali, le vie aree, fino ai polmoni. In Genesi 2,7 troviamo la fonte della vita come respiro: «allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente». Tutto quello che respira vive e Simone è indignata perché attraverso questa gola sembra non passare il grido di chi soffre privazione, umiliazione e ingiustizia. Oppure siamo noi che rimaniamo sordi a queste grida, che non hanno parole. E senz’altro viviamo in un sistema che è vaccinato per non udire questo grido, realtà costitutiva di ogni essere umano. Ogni essere umano è allora sacro per la sofferenza cristologica causata da altri esseri umani e non per essere persona, con peculiari e diversificate funzioni nel teatro sociopolitico. L’individuo non è sacro per ciò che egli è e rappresenta. Risulta sacro perché potenzialmente – e a volte di fatto – può aprirsi all’irruzione della Verità, della Giustizia, della Bellezza. Questo duplice approccio antropologico è la porta d’ingresso della critica radicale del diritto.
I Greci non avevano il concetto di diritto e si limitavano alla nozione di giustizia, principio questo che è anche supremamente evangelico, cristiano, benché da sempre dimenticato dalle Chiese. Furono infatti i Romani che inventano il diritto, concetto inseparabile da quello dell’impero, realtà «pagana, non battezzabile» in cui il diritto di proprietà, esteso alle cose e agli esseri umani, è il fulcro ispiratore di tutte le leggi. Solo la giustizia apre lo spazio all’agape, agli eccessi estremisti dell’amore. Costitutivamente, il diritto non ha alcun legame con l’etica e con la politica come costruzione dell’umanità.
A mò di una impossibile conclusione, data l’ampiezza e la profondità del pensiero weiliano, la critica del diritto forse ci offre lo stimolo per ridiscutere la politica della difesa e rivendicazione dei diritti umani, che continua egemonica e inoppugnabile sia tra le sinistre, sia nelle Chiese. Un appello per verificare la sua pertinenza ed efficacia, sia come ispirazione della vocazione politica, sia come pratica di accompagnamento degli ultimi e come fattore di trasformazione sociale.
Bibliografia
Alcuni scritti di Simone Weil
Incontri libertari, a cura di M. Zani, elèuthera, Milano 2021.
L’attesa di Dio, a cura di M.C. Sala, Rusconi, Milano, 1984.
L’ombra e la grazia, a cura di G. Hourdin e F. Fortini, Rusconi, Milano, 1985.
La persona e il sacro, a cura di M.C. Sala, Adelphi, Milano, 2012.
Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano, 1983.
Sulla guerra. Scritti 1933-1943, a cura di D. Zazzi, il Saggiatore, Milano, 2013.
Una costituente per l’Europa. Scritti londinesi, a cura di D. Canciani e M.A. Vito, Castelvecchi, Roma, 2013.
Alcuni scritti su Simone Weil
G. FIORI, Simone Weil, Biografia di un pensiero, Garzanti, Milano, 1997.
D. CANCIANI, Simone Weil. Le courage de penser, Beauchesne, Paris, 2011 (edizione più breve in lingua italiana: Il coraggio di pensare. Impegno e riflessione politica tra le due guerre, Edizioni Lavoro, Roma, 1996).
R. FULCO, T. GRECO (a cura di), L’Europa di Simone Weil. Filosofia e nuove istituzioni, Quodlibet, Macerata, 2019.
L.A. MANFREDA, F. NEGRI, A. MECCARIELLO (a cura di), Esistenza e storia in Simone Weil, Asterios Editore, Trieste, 2016.



Leggere l’anarchia
F. C.
Sono esattamente cinquant’anni che il libro più diffuso e forse il più importante scritto da Colin Ward, Anarchia come organizzazione, è stato editato per la prima volta in italiano (Edizioni Antistato, Milano, 1976). Il testo, che ha avuto in questi anni diverse riedizioni (elèuthera, Milano), rappresenta sicuramente una sorta di manifesto programmatico della rivista che avete in mano. Colin Ward con questo libro ha capovolto radicalmente la prospettiva dell’anarchismo tradizionale. Infatti, le tesi sostenute e sviluppate nelle pagine del volume modificano letteralmente e concettualmente la concezione anarchica secondo la quale è solo attraverso un «evento» rivoluzionario che può pensarsi una società libertaria. Secondo Ward l’anarchismo nelle sue espressioni spontanee e autonome esiste già in queste nostre società e si manifesta in tutte quelle forme organizzative che uomini e donne si danno autonomamente e senza l’intervento dello Stato, quando devono risolvere i problemi del vivere quotidiano. L’organizzazione antiautoritaria, in alternativa a quella autoritaria, è quindi una realtà che già esiste, seppure sotto una coltre di neve che ne oscura la visibilità, e che deve essere ampliata, sostenuta, protetta dalle ingerenze dello Stato e che, moltiplicandosi, può rappresentare una alternativa reale al processo di cambiamento tradizionalmente rivoluzionario. Sulla scia infatti delle tesi che sono sviluppate nel libro, i redattori di «Semi sotto la neve» cercano di muoversi coerentemente con queste idee di un anarchismo sperimentale, pragmatico, propositivo. Ma, soprattutto, di dare voce e visibilità a tante iniziative ed esperienze libertarie che, come semi sotto la neve, rappresentano in concreto una soluzione antiautoritaria ai tanti problemi che una società libera inevitabilmente deve affrontare.
La tradizione mutualista e di autogestione che ha caratterizzato le idee e le prassi libertarie ha una storia ormai consolidata e importante. Ne dà conto il bel lavoro di Antonio Senta (Anarchia e cooperazione, Edizioni Malamente, Urbino, 2023) che racconta questa tradizione e i legami intercorsi tra essa e il pensiero anarchico. Si tratta di un socialismo libertario nei fatti, che si nutre delle idee anarchiche e dà vita a una serie di esperienze cooperative e di mutuo aiuto che hanno caratterizzato l’azione di tanti militanti libertari. La cultura politica anarchica ha dato infatti un apporto importante alle esperienze di cooperazione in Italia tra il XIX e il XX secolo. Il testo di Senta indaga questa relazione, tra pensiero libertario ed esperienze concrete, in Italia dal 1861 al 1914. Seppure in un libro agile e non lungo l’autore da conto del lavoro cooperativo a partire dalle prime espressioni del socialismo utopistico, la prima internazionale e delle pratiche mutualistiche che sono evidenti fin agli albori del movimento operaio italiano. Si concentra poi sull’associazione generale dei braccianti nel Ravennate e in generale sulle istanze cooperative nelle campagne romagnole. Infine sintetizza i vari approcci che il movimento anarchico ha avuto nei confronti di queste pratiche ritenute comunque rivoluzionarie. Senta si concentra infine sull’idea che le teorie libertarie e anarchiche possano aver caratterizzato una parte del più generale movimento cooperativo che invece viene rappresentato dalla storiografia tradizionale come espressione solo delle concezioni marxiste e cattoliche. Portare alla luce anche questa tradizione libertaria è importante per testimoniare che l’anarchismo (in questo caso italiano ma sappiamo anche europeo) non è costituito solo da una visione rivoluzionaria tradizionalmente intesa, ma anche da azioni dirette, esperienze concrete, sperimentazioni, che in qualche maniera costituiscono un aspetto propositivo e positivo della teoria anarchica.
Questa sensibilità libertaria, volta a creare fin da subito le condizioni concrete per un mutamento sociale coerente con un socialismo libertario, si esprime nelle tante società di mutuo soccorso, università popolari, cooperative di lavoro e di scambio, ecc. Queste trovano espressione concreta nelle storie di operai e contadini, e costituiscono un patrimonio storico di rilevante attualità. Il libro di Antonio Senta documenta con dovizia alcune di queste esperienze, valorizzandone proprio la portata autenticamente antiautoritaria e ne evidenzia gli aspetti tipici di un socialismo sperimentale fondato sul mutuo appoggio come prassi politica e sociale.
Sulla stessa linea, seppure con approccio più teorico e utilizzando esperienze più attuali, si snoda il bel lavoro di John P. Clark (Dallo Stato alla comunità. Il mondo di domani, elèuthera, Milano, 2023). Clark parte dal presupposto che il mondo attuale si trovi di fronte a un bivio: proseguire indifferenti sulla strada dell’atomizzazione individuale esasperata e sulla conseguente disgregazione sociale sempre più evidente, oppure interrompere questo cammino deviando verso un modello diverso di convivenza sociale in grado di proporre una vita comunitaria più consona alla solidarietà e all’altruismo. Tutto ciò rappresenta, secondo Clark, non un semplice progetto politico ma piuttosto un’idea di trasformazione sociale e culturale che riconosca il valore imprescindibile della comunità salvaguardando, al contempo, le differenze e le caratteristiche individuali. Queste «comunità» non rappresentano però solo un auspicio ma esistono già in alcune esperienze particolarmente significative e di dimensioni importanti. Clark infatti ci introduce, con le dovute differenze e sensibilità culturali, nelle comunità indigene del Chiapas descrivendoci le forme organizzative proprie di una tradizione messicana di autogoverno comunitario (in particolare i Caracol e i Municipios autonomos y Rebeldes Zapatistas) e si sofferma in particolare sulle modalità organizzative autogestionarie della vita sociale delle singole comunità federate. Poi ci porta dentro le problematiche sociali e politiche che attraversano l’esperienza autogestionaria nel Rojava curdo e ci descrive l’organizzazione sociale qui applicata del confederalismo libertario. Ma, con una sensibilità davvero aperta, ci offre una lettura libertaria del movimento e della rivoluzione gandhiana (Sarvōdaya, letteralmente «il benessere di tutti»). In India questo movimento ha prodotto un’esperienza enorme di autorganizzazione fondandosi sul recupero di tradizioni autoctone e valorizzando un’idea di socialismo comunitarista. Differenziandosi da un anarchismo tradizionalmente a-religioso e assumendo una prospettiva decisamente spirituale e persino ascetica, il Sarvōdaya comprende però molte istanze più decisamente simili alle teorie e alle pratiche libertarie occidentali. Tra i punti in comune vi sono il rifiuto della proprietà privata, la validità e la dignità conferita a tutte le forme di lavoro, la sintesi tra libertà e uguaglianza, il decentramento economico e politico, il rifiuto della politica parlamentare sostituita dalla centralità della democrazia diretta. Infine Clark ci accompagna dentro un’altra straordinaria esperienza che ha coinvolto centinaia di villaggi dello Sri Lanka (Sarvōdaya Shramadana, «Il dono della speranza»). Questo movimento si è sviluppato dal basso a partire dal 1958 con lo scopo di sostenere le iniziative autonome di aiuto nei villaggi poveri e al fine di provvedere alle varie necessità di sostentamento. La particolarità di questo movimento è quella di proporre e di attuare una politica di trasformazione materiale, una politica comunitaria, e una politica spirituale. Ahangamage T. Ariyaratne (il fondatore) ha ridefinito il concetto gandhiano di Sarvōdaya come «benessere di tutti» per sottolinearne il carattere di «unità nel risveglio» o «risveglio di tutti». In questo modo ha implementato la concezione gandhiana con la spiritualità buddista. Infatti è stato aggiunto il termine shramadana (Shrama significa energia o lavoro e dana significa dare o condividere). Il movimento di estese dimensioni rifiuta il modello di sviluppo dominante e l’organizzazione gerarchica della comunità. Il suo scopo è quello di convertire la politica dello Sri Lanka in un commonwealth di villaggi o repubbliche comunitarie in cui ogni villaggio possa esprimere il massimo di autogoverno possibile. Questo obiettivo però viene declinato con la specifica volontà di mantenere le caratteristiche di ogni villaggio e quindi di perseguire l’unità attraverso la diversità. Ovviamente tutto questo presenta modalità e specificità organizzative e procedurali che Clark ben riassume nel testo. Concludendo vale la pena di riportare le parole dell’autore che ben sintetizzano la portata innovativa di un approccio sperimentale e innovativo delle idee libertarie. Scrive Clark: «Landauer era consapevole che l’impulso comunitario può diffondersi nella società (potremmo dire “come un’epidemia di guarigione”) solo attraverso la potente forza dell’esempio offerta dall’esistenza di pratiche realizzate. Aveva capito che la rivoluzione sociale non è possibile se il sistema di dominio ha una presa ferrea sull’ethos sociale. E tempo dunque di passare dalla prefigurazione alla figurazione e alla trasfigurazione. Dobbiamo poter vedere concretamente il nuovo volto del reale» (p. 226).
La nostra rivista sta dentro questa strada.

Il camionista e l’anarchia Un libro e oltre
Franco Melandri
Il libro Discorso sull’autogoverno di Matthew Wilson, pubblicato da elèuthera a fine 2022, traduce bene il senso del titolo inglese: Rules Without Rulers: The possibilities and Limits of Anarchism, un testo dai molti pregi, che efficacemente mette a tema il nocciolo dell’invettiva che un camionista scagliò, nel 2005, in Scozia, contro i manifestanti anti-G8: «Maledetti anarchici, siamo rimasti bloccati negli ingorghi tutta la mattina grazie a voi. Pensavo credeste nella libertà! E la mia libertà, allora?» (Wilson 2022: 21).
Come dice l’autore, quell’invettiva pone infatti un problema: se è vero che «l’anarchismo, o forse più correttamente gli anarchici, partono spesso dal presupposto di una concezione assoluta della libertà», ne consegue che proprio questa concezione renda ineludibile un nodo pratico perché teorico: «Quanto è legittima l’istanza di una libertà assoluta? Cosa significa davvero una tale rivendicazione?» (Wilson 2022: 22) e ciò soprattutto se si vuole che l’«anarchismo (…) sia preparato a costruire davvero un nuovo mondo, e non semplicemente a fare una prova generale incentrata sulla protesta» (Wilson 2022:10).
Questi grimaldelli ermeneutici portano all’impostazione teorica che regge tutto il testo: «l’anarchismo è un’ideologia profondamente problematica, e se deve essere in grado di offrire una visione praticabile di un mondo alternativo, ha bisogno di un costante riesame critico» (Wilson 2022: 23) ed è alla luce di ciò che viene intrapreso un percorso in cui via via ci si occupa delle «ragioni dell’anarchia», dell’«anarchismo e i limiti della libertà», di «etica e altri limiti della libertà», delle «inevitabili conseguenze del potere», del «conflitto» e del senso e della praticabilità del «processo decisionale del consenso».
Al termine del viaggio Wilson pone un’ulteriore domanda: «perché (…) l’anarchismo continua a essere presentato come un insieme di istanze morali assolute?», alla quale risponde con due tesi più che condivisibili: «l’anarchia è un’interazione sempre mutevole tra i propri valori libertari e gli innumerevoli altri valori che esistono e modellano il mondo» e perciò «una visione praticabile dell’anarchismo non è utopica: è un mondo in cui ci si governa senza governanti» (Wilson 2022: 269-270).
Gli argomenti sviluppati da Wilson muovono dalla concezione che, sulla scorta di Colin Ward, vede l’anarchismo principalmente come «anarchia in azione» e come «prefigurazione sociale» a partire da qui che vengono valutati significato e senso delle tesi di teorici del post-anarchismo quali Saul Newman e Todd May o di autori quali David Graeber, Uri Gordon o Murray Bookchin, così come delle pratiche del Lifestyle Anarchism, cioè di quell’anarchismo che, abbandonata ogni concezione incentrata sulla rivoluzione o su un evento dirimente e fondante, si incentra su scelte di vita e sulla costruzione di realtà al di fuori, o ai margini, degli ambiti della politica e di quelli in cui le relazioni di potere appaiono stringenti.
Come è abbastanza noto, contro il Lifestyle Anarchism si scagliò proprio Bookchin nei suoi ultimi anni di vita (giungendo infine ad abbandonare l’anarchismo e a teorizzare il «confederalismo democratico» che ispira l’esperienza attuata dai guerriglieri curdi in Rojava) ed è proprio mostrando come le critiche bookchiniane si concentrino spesso non tanto su precise idee e pratiche, ma su una maschera di comodo appiccicata all’avversario, che Wilson ha comunque modo di rimarcare che l’anarchismo non riesca a rispondere convincentemente a questioni centrali e non superabili come il sorgere e il costituirsi di rapporti di potere, il sempre incipiente conflitto esistente tanto fra diverse impostazioni etico-morali che fra diverse ideologie e/o sistemi politico-sociali e così via.
Come dimostrano anche i vari richiami alle teorizzazioni di John Rawls, tutto il discorso wilsoniano è chiaramente imperniato sui paradigmi teoretici del liberalismo; giustamente e opportunamente, sottolinea la costitutiva consonanza fra alcuni aspetti delle teorie politiche e dei fondamenti di liberalismo e anarchismo, in tal modo, però, rende evidente l’elemento problematico che attraversa l’intero libro, cioè appunto l’estrema discutibilità di detti presupposti.
Wilson, infatti, intende libertà, uguaglianza, solidarietà essenzialmente come «valori», cioè come frutto di una scelta, kantianamente razionale, fra opzioni differenti o divergenti, mentre il loro essere «idee» viene di fatto ridotto unicamente alla loro costituzione logico-razionale (che è, del resto, il solo modo per cui sia poi possibile concepirle come «assolute»). Lo stesso vale per le concezioni della politica e del potere, in cui la prima è essenzialmente vista come il modo e luogo in cui le diverse opzioni etico-morali e le volontà da esse derivanti si confrontano e si misurano (si ricordi il camionista), cosicché il potere politico viene inteso principalmente come la capacità di imposizione potestatica che dirime le contese e fissa i limiti invalicabili che ogni opzione non può superare.
Essendo tutt’altro che superficiale, Wilson non si nasconde che il potere è anche «capacità di fare» o che la libertà non è solo esecuzione di una volontà ma anche autonomia ed auto-governo, ma questo non toglie che non riesca a tenere insieme in modo convincente queste diverse acquisizioni, cosicché tutte finiscono per essere niente più che manifestazioni di una «ideologia», rispetto alla quale è del tutto legittimo chiedersi se «sia rimasto qualcosa da salvare» (Wilson 2022: 270).
A detta domanda, egli risponde affermando di essere «assolutamente convinto che ci sia, ma solo se gli stessi anarchici sono pronti a riconoscere i limiti della loro ideologia» (Wilson 2022: 270) e su ciò non si può che concordare, soprattutto se si comprende che il problema, prima che nei contenuti, sta nella «ideologia» in quanto tale.
L’oltre. Come lo stesso Wison ricorda, Bakunin affermava di essere «un amante fanatico della libertà» e alla luce di questo «fanatismo» sottolineava che la libertà di tutti e di ognuno non è tanto, o solo, quella che, kantianamente, si ferma dove comincia l’uguale libertà degli altri, ma quella che, hegelianamente, si completa nella libertà altrui. Detta dichiarazione può sicuramente essere intesa come un generoso e irenico desiderio o come un concetto del tutto idealistico e astratto, ma questo non toglie che, così facendo, non si colga il motivo per cui, per Bakunin come per molto anarchismo, la triade della Rivoluzione francese – libertà, uguaglianza, fraternità/solidarietà – alla fin fine sia un po’ come la Trinità dei cristiani: diversi aspetti/modi di un unico elemento.
Lasciando dio a chi lo prega, quel che va pienamente compreso, infatti, è che detto «elemento» non è tanto un’idea o un valore razionalmente costruito, quanto il riconoscimento di un «dato», che proprio per questo è tanto «empirico» che «simbolico» e che, in questa sede, non è azzardato indicare come fondatività della politica in quanto tale, cioè esattamente quanto Wilson non riesce che a intravedere proprio a causa dei presupposti da cui muove (a sua scusante, va anche detto che essi sono la «moneta corrente» nella gran parte del mondo filosofico anglosassone, come tale data per scontata, quasi sempre inconsapevolmente). La politica, infatti, è certo scontro di interessi e quindi lotta per il potere, ma è innanzitutto quel modo d’essere del mondo di cui parlava Hannah Arendt, specificando (Vita activa, cap. 1, par. 7) che esso «non si identifica con la terra o con la natura», ma «è connesso, piuttosto, con l’elemento artificiale (…), come pure con i rapporti tra coloro che abitano insieme il mondo fatto dall’uomo» e che quindi «come ogni in-fra, mette in relazione e separa gli uomini allo stesso tempo».
Questo «mondo comune/in-fra», che allo stesso modo unisce e separa (e che forse sarebbe meglio definire «politico», così sottolineando il differenziale che fa essere un certo mondo e non un altro, per esempio quello per cui vi è una «società civile» e non una tribù o un branco) è certamente attraversato dagli «umori» di cui parlava Machiavelli – cioè da diversi e spesso contrastanti visioni del mondo, interessi, valori – ed è da sperare che lo sia sempre, visto che l’alternativa sarebbe la fine della società in quanto insieme di esseri umani che si sanno e si vogliono tali, cioè il presupposto su cui sorge il potere politico.
Questo, a sua volta, lo si capisca o no, è alquanto diverso dagli altri poteri perché non è necessariamente e unicamente comando e autorità imposta, cioè potestà e quindi dominio, e non lo è proprio perché è la politica stessa che, nel suo essere relazione (cioè un accadere che fa essere), dà forma e consistenza a specifiche, cioè storiche e culturali, differenze nel momento stesso in cui le fa essere come quelle differenze che sono.
Le relazioni, in altri termini, non sono creazioni, cioè realizzazioni empiriche di un qualcosa in qualche modo già progettato o attuazioni di una «potenza» data a-priori, ma il farsi stesso del mondo, il suo divenire, che accade anche attraverso il fare degli esseri umani ed è precisamente in questo contesto che si comprende come il potere-Stato, il suo essere ente e istituzione, emerga dal, e si regga sul, potere-capacità di azione (cioè fare sapendo, quindi volendo, quel fare medesimo) dei cittadini e degli individui. È in questo e per questo che l’agire degli esseri umani diventa anche il potere «potestatico» che pone limiti e contrasti al potere-capacità che altre ideologie e interessi riescono a realizzare, dal che deriva, del tutto ovviamente e conseguentemente, che il potere potestatico non possa mai essere o divenire quell’arbitro «neutro» che utopisticamente ipotizza il liberalismo, mentre è sempre per questo che esso è sempre «congiunturale» e non ha altra fonte, forza e capacità se non quella che gli viene attribuita, consapevolmente o meno. In questo contesto, l’autonomia – cioè l’azione in quanto capacità/decisione di darsi norme – altro non è che la libertà come autogoverno, mentre l’anarchia, più che una specifica organizzazione sociale, si rivela essere niente più e niente meno che la condizione stessa per cui tutto questo può accadere proprio perché si impedisce ogni ipostatizzazione o ogni elemento che sovrintenda l’accadere della politica come tale.
Insomma, se l’anarchismo non vuole essere solo l’etichetta di etiche individuali, deve riconoscersi innanzitutto come pratica della politica perché è solo in tale contesto che, come dice Wilson, ci si governa senza governanti.
https://semisottolaneve.net/ semisottolaneve@riseup.net
Facebook: Semi-Sotto-la-Neve-Rivista-Libertaria Instagram: semisottolaneverivista
Collettivo di redazione Marco Antonioli, Francesco Berti, Anna Lisa Bertolo, Francesco Codello, Valeria Giacomoni, Maurizio Giannangeli, Luciano Giugno, Gloria Lanza, Francesco Mosca, Antonio Senta, Fiorenzo Urso
Progetto grafico: Marianna Rovere Logo e logotipo: Nicolas Lepel
Finito di stampare nel maggio 2023
Semi di libertà che prefigurano, qui e ora, un mondo nuovo e diverso.

ISSN 2974-5632 7 euro