Numero Completo 04
Semi sotto la neve Rivista libertaria Numero 4 febbraio 2023
Reg. trib. di Belluno n. 2 del 2021 (RGNC n. 1412/2021 del registro stampa) Dir. Resp. Antonio Senta Pubblicazione a cura dell’APS Semi sotto la neve
In copertina e all’interno: illustrazioni di Roberto Spaccarelli ritratti di Roberto de Grandis e foto autoprodotte
Prezzo di una copia 7 euro
Chi desidera ricevere una o più copie della rivista scriva a: semisottolaneve@riseup.net Per riceverla regolarmente (tre numeri l’anno) e essere aggiornati sulle attività dell’associazione, chiediamo un contributo di 20, 30, 50 o 100 euro in base alle proprie possibilità
Per versamenti: APS Semi sotto la neve IBAN: IT70 H085 1105 6390 0000 0044 009 BIC: CCRTIT2T95A CAUSALE: contributo
INDICE
| Editoriale | 3 | |
|---|---|---|
| Esperienze | ||
| ·Un giorno in mare | Riccardo Gatti | 9 |
| ·La Comune Pachamama: | Mario Rui Pinto | 22 |
| vivere l’utopia a Rio Grande do Sul | ||
| Approfondimenti | ||
| ·Il senso della bioetica per la sopravvivenza e la salute dell’umanità | Pamela Boldrin | 29 |
| · Il punto di vista dei visoni | Giorgio Fontana | 36 |
| ·Percorsi di guerra e violenze | Andrea Papi | 46 |
| ·«Politics» e i suoi autori nelle pieghe della storia | Pietro Adamo | 54 |
| Conversazione | ||
| con Loriano Macchiavelli | a cura di Marco Antonioli e A. Soto | 73 |
| Internazionale | ||
| ·Castigare, pacificare o de-criminalizzare le «bande latine»? | Begoña Aramayona | 91 |
| Esperienze in Spagna, Ecuador e El Salvador | ||
| Radici | ||
| ·Gustav Landauer | Gianfranco Ragona | 103 |
| In appendice: Fiacchi statisti, debolissimo popolo! | 108 | |
| ·Clara Wichmann | ||
| Edy Zarro | 111 | |

Editoriale
Dalle acque del Mediterraneo al cuore del Rio Grande do Sul, nel senso della vita e della morte, nel complesso rapporto tra uomo e natura, nella società e nella cultura, continuiamo, con i molti limiti di cui siamo consapevoli, ma con una passione e perseveranza che ci auguriamo possa in qualche modo trascenderli, a cercare semi concreti di libertà, solidarietà e speranza. Storie piccole e grandi di donne e uomini che sfidano barriere e pregiudizi, violenze e miserie. Che indicano, spesso inconsapevolmente, una direzione verso un mondo più libero e giusto. Che meritano di essere raccontate, condivise e interrogate.
Più di un lettore ci ha comunicato il suo sostegno al nostro modo di affrontare criticamente i temi proposti. Come Badabing, che ci scrive di aver trovato un effetto un po’ terapeutico in questo nostro illustrare immaginari e pratiche di libertà, che permettano di riacquistare fiducia e speranza in un momento storico di «depressione» delle lotte. Abbiamo bisogno del vostro appoggio, ma anche delle vostre critiche e proposte. Vi invitiamo a essere sempre più partecipi alla vita della rivista.
In questo numero, nelle esperienze: il diario di bordo di Riccardo Gatti, a cura di UrLa, la vita quotidiana di un gruppo di marinai e professionisti coraggiosi impegnati nel salvataggio di vite umane che hanno diritto a un destino diverso da quello di finire inghiottite dal mare, senza nessuno che le pianga, senza avere un’altra occasione; la comune libertaria brasiliana Pachamama raccontata da Mario Rui Pinto, un gruppo di adulti e bambini che cerca di vivere insieme applicando i principi della solidarietà e dell’autogestione, sperimentando l’agricoltura biologica e una pedagogia della libertà, nell’incantevole cornice della Foresta Atlantica e del Bioma Pampa.
Negli approfondimenti: una riflessione a tutto tondo di Pamela Bodrin sulla bioetica, sulle enormi potenzialità della medicina e della scienza e sui necessari limiti che occorre porsi e imporsi nell’applicarle; una interrogazione di Giorgio Fontana sul rapporto tra il mondo umano e animale, che ci chiama ad abbandonare una visione che pone tra l’uno e l’altro un invalicabile muro; la critica mordace di Andrea Papi a vetusti ideologismi fondati su un antiamericanismo e antioccidentalismo manicheo e preconcetto, con un invito a esercitare uno spirito critico che valorizzi la parte migliore della nostra storia; infine, un viaggio a ritroso nel tempo proposto da Pietro Adamo, nell’America pre-maccartista che ha vissuto l’esperienza di una rivista di intellettuali liberi e libertari, raccolti intorno a Dwight MacDonald, intenti a riflettere sulle aporie del marxismo e del pensiero rivoluzionario e a proporre un progetto fondato sulla pratica del comunitarismo e dell’autogestione all’interno di microcosmi culturali e sociali.
Loriano Machiavelli è il protagonista della nostra conversazione, a cura di A. Soto e Marco Antonioli: che muove da un discorso sul genere noir e sulla rievocazione del Gruppo 13, per spaziare di seguito lungo la storia politica italiana recente e passata, sfatando i miti di isole felici, per interrogarsi sul ruolo dell’arte e della scrittura.
Nell’internazionale, Begoña Aramayona propone un approccio controcorrente al problema della violenza di strada, con particolare riferimento alle cosiddette «bande latine» attive in Spagna, Ecuador ed El Salvador. L’applicazione concreta del paradigma della decriminalizzazione si dimostra un’utile alternativa alle politiche repressive, evidenziando che esistono strade diverse, basate sul dialogo e la non-violenza, per rispondere a pur fondate paure e legittime richieste di sicurezza.
La figura di Gustav Landauer, presentata da Gianfranco Ragona (con un prezioso inedito in lingua italiana), e quella di Clara Wichmann, delineata da Edy Zarro, sono al centro delle nostre radici: esempi di intellettuali militanti, di libertari protagonisti delle lotte culturali e politiche del loro tempo ma ancora capaci di trasmetterci insegnamenti, di farci comprendere che non solo il dominio, ma anche la libertà ha la sua tradizione, che affonda nel passato prossimo e remoto. Ed è a questa che dobbiamo soprattutto guardare. Perché, come scriveva Vasilij Grossman, la storia più bella dell’umanità «è la storia della sua libertà. La crescita della potenza dell’uomo si esprime innanzi tutto nella crescita della libertà. La libertà non è necessità diventata coscienza, come pensava Engels. La libertà è diametralmente opposta alla necessità, la libertà è la necessità superata. Il progresso è essenzialmente progresso della libertà umana. Giacché la vita stessa è libertà, l’evoluzione della vita è evoluzione della libertà».
Da ultimo, uno scorcio dei prossimi numeri. Molti sono gli ambiti che intendiamo affrontare e approfondire, concernenti temi quali il lavoro, l’ecologia, la scuola. Uno spazio adeguato sarà in particolare dedicato al problema penale: al carcere e alla sua discutibile efficacia, alla sproporzione ancora spesso manifesta tra i reati e le pene. Argomenti ai quali siamo ricondotti da casi recenti e passati. Se, come scriveva Montesquieu, è dalla bontà delle leggi penali che dipende soprattutto la libertà del cittadino, occorre desolatamente osservare che la libertà nel nostro paese non gode affatto di buona salute. Occorre tornare a ripensare il grande tema della misure alternative al carcere, è necessario ridare vigore alla concezione riparatrice, anziché punitiva, della pena, bisogna insistere sulla depenalizzazione dei reati. Soprattutto, è fondamentale presentare le esperienze che offrono ai condannati una vera riabilitazione, che indicano un percorso alternativo a quello della pratica istituzionalizzata della violenza che troppe volte trasforma, per un perverso paradosso, l’autore di un reato in una vittima del sistema giudiziario-penale.
Altro argomento che troverà spazio nella rivista sarà la lotta del popolo iraniano, e in particolare delle donne, contro il regime dispotico e teocratico degli ayatollah. Da oltre quarant’anni una parte sempre più numerosa della società civile iraniana si oppone alle misure liberticide, all’oppressione e alla repressione sanguinaria di uno Stato che ha voluto imporre una camicia di forza fatta di fanatismo religioso, misoginia e indottrinamento ideologico a una popolazione che, prima della «rivoluzione» khomeinista, era tra le più avanzate di quell’area geopolitica in tema di modernizzazione, progresso e libertà individuale. In Occidente, interessi economici e cortocircuiti ideologici hanno contribuito ad alimentare una sorta di congiura del silenzio nei confronti delle lotte del popolo iraniano: è ora di uscire da queste ipocrisie e ambiguità e lavorare per un rovesciamento immediato del regime.
La condizione delle donne – in Iran, Afghanistan ma in generale in ogni società –, così come quella delle minoranze, sarà sempre più al centro del nostro progetto e della nostra attenzione.
Le illustrazioni di questo numero sono di Roberto Spaccarelli (1955-2019) e sono state scelte dalla famiglia insieme a Roberto De Grandis e Paolo Del Bianco. I due ritratti della rubrica radici sono come sempre di De Grandis.
Dedichiamo questo numero all’amico fraterno e al caro compagno Claudio Venza, recentemente scomparso, tra i nostri primi entusiasti sostenitori: figura notevole di studioso appassionato, anarchico coerente e tenace, così legato alla sua Trieste, così capace di respiro internazionale. Che il suo esempio possa continuare a innervare il pensiero e ad alimentare l’azione dei seminatori di libertà!
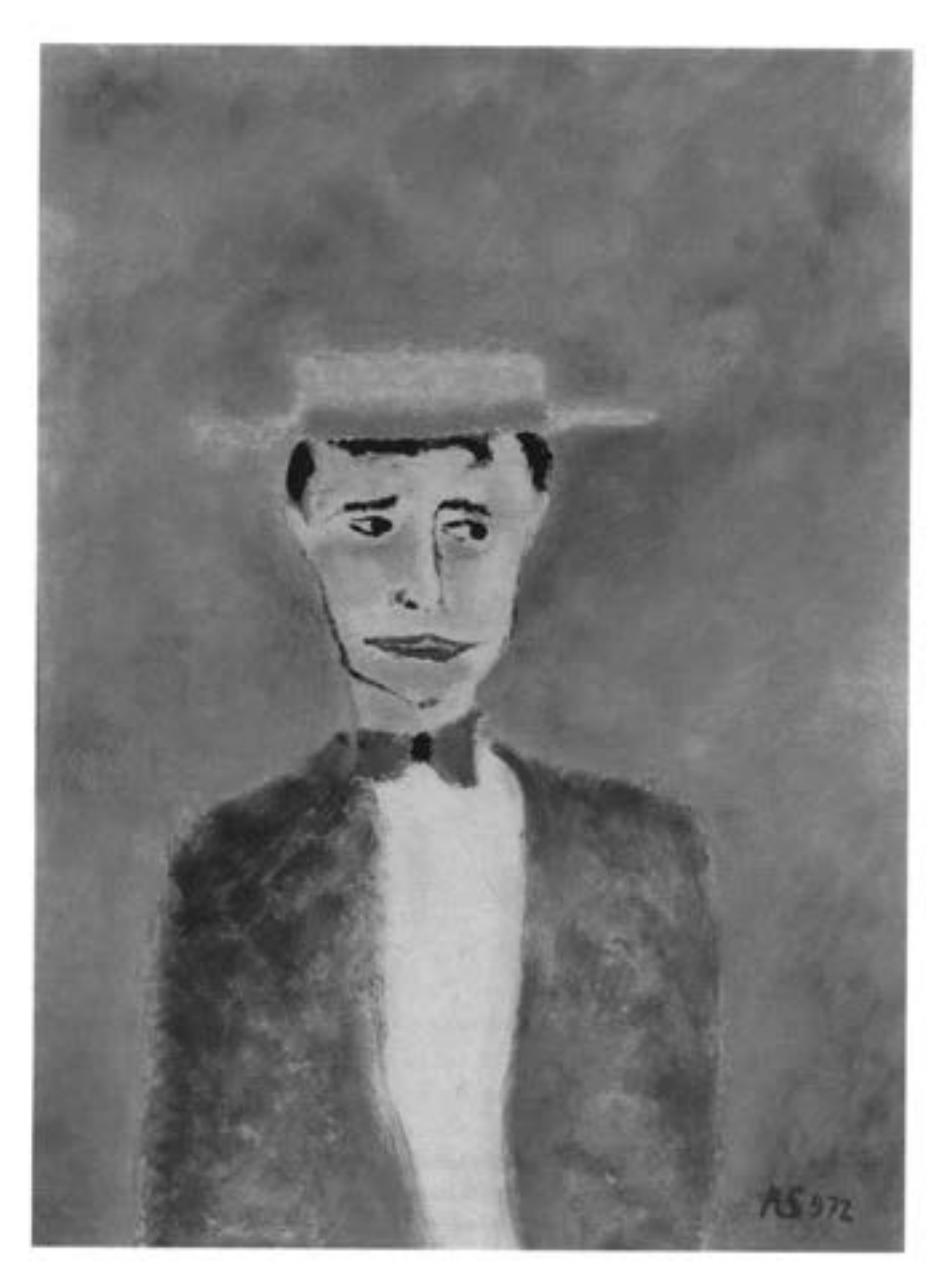

Diario di bordo
Riccardo Gatti (a cura di UrLa) *
Giorno 1
Come normalmente succede all’inizio di una missione, salendo a bordo ci si ritrova sulla porta d’imbarco della nave, alcuni entrano mentre altri escono. Ci si saluta e ci si abbraccia tra chi è già stato assieme a bordo. Quelli che vanno via hanno spesso le facce smunte, dimagrite, i capelli incolti, si nota la stanchezza ma anche la gioia di avere fatto la cosa giusta.
Spesso ci si scambia qualche parola, chi arriva di solito si limita a fare i complimenti a chi sbarca, sia nel caso di successo della missione, sia quando le cose sono andate male. Poche sono le parole da dire, solo gli sguardi parlano.
Ecco, un gruppo di persone lascia la nave e un altro entra. Alcuni rimangono a bordo e continuano anche in questa missione. I nuovi arrivati vengono accompagnati da chi ha già qualche esperienza e devono prima di tutto lasciare i bagagli nella cabina. Inizierà un periodo di addestramento che durerà qualche giorno e inoltre si dovranno ambientare in questa nave così grossa, come un edificio di 6 piani, dove ci si perde spesso.
Facciamo la prima riunione di presentazione e si scopre che vi sono tantissimi ruoli a bordo: personale medico, tecnico umanitario, logistico, personale delle squadre di soccorso e per ogni dipartimento vi sono le persone responsabili del coordinamento.
* Riccardo Gatti è attualmente consulente SAR-Search and Rescue responsabile dei soccorsi a bordo della nave Geo Barents (MSF). Dopo la conversazione pubblicata nel n. 3 gli abbiamo chiesto di scrivere un piccolo diario di bordo di una ordinaria operazione di soccorso.
Iniziano intense giornate, che prevedono almeno quattro ore di lezioni teoriche e pratiche sui rifornimenti e stoccaggio di materiali, del cibo e bevande, e gli allenamenti pratici. L’obbiettivo è riuscire ad arrivare nella zona dei soccorsi, la zona SAR (Search And Rescue) il prima possibile. Si parte.
Giorno 5
Appena fatto rifornimento si parte, si esce dal porto.
Come spesso accade, le autorità non permettono di calare in mare le lance di soccorso (RHIB Rigid Hull Inflatable Boat) per fare pratiche, allenamenti e simulazioni. Perciò appena possibile, quando si è in navigazione, si iniziano gli addestramenti in mare. Realizzare operazioni di soccorso senza avere la perfetta padronanza dei mezzi, delle tecniche e l’adeguato affiatamento delle squadre sia in mare che a bordo, che garantiscano una risposta all’emergenza pronta ed efficace, non solo sarebbe una irresponsabilità ma, in questo contesto, una dimostrazione di un atteggiamento classista e razzista.
A volte, come spesso purtroppo accade nei contesti di volontariato o di aiuto umanitario, si crede sia sufficiente la buona volontà per far bene le cose ma l’esperienza ci dimostra che non basta. Perciò ci si allena molto, i continui addestramenti sono molto stancanti, ma la conseguenza di ciò è di ottenere una preparazione ottimale.
Giorno 6
Oggi purtroppo durante uno degli allenamenti in mare si è verificato un incidente. Marina, che dirige le operazioni di soccorso a bordo di una delle due RHIB, si è rotta una gamba. Chiediamo aiuto via radio «medical emergency, medical emergency» e, mentre a bordo si attiva il team medico, io scendo sul ponte per coadiuvare.
Poco dopo la responsabile medico mi conferma che bisogna richiedere un’evacuazione medica il prima possibile. Chiediamo immediatamente soccorso. Per fortuna siamo ancora vicini alle coste siciliane, facciamo rotta verso la costa e in meno di due ore incrociamo una motovedetta della Guardia Costiera venuta in soccorso, trasferiamo Marina a bordo della motovedetta per il ricovero all’ospedale. Ora la situazione diventa più difficile. Il team perde chi coordina le RHIB dal mare, perciò bisogna riscrivere le formazioni delle due squadre di soccorso e delle squadre sul ponte per far sì che la mancanza di Marina comporti le minori conseguenze negative possibili. A me tocca il compito di far sì che le squadre di soccorso riescano comunque a funzionare in modo adeguato. Ricoprirò il ruolo dalla plancia di comando della nave, oltre al mio (SAR team leader, coordinatore dei soccorsi), sono pronto perciò a imbarcare sulle RHIBS quando ve ne sia il bisogno.
Domani si fa un altro allenamento in mare, appena pronti bisogna fare rotta verso la zona SAR, le zone dove avvengono i soccorsi, visto che non vi sono altre navi ONG e ci saranno presto delle condizioni meteo favorevoli a potenziali partenze dalla Libia o dalla Tunisia.

Giorno 7
Ci si sveglia presto, continuano gli ultimi training teorici e subito dopo mangiato le lance vengono calate in mare, iniziano gli allenamenti in acqua. Staranno in mare fino a quando arriva notte, così da potersi esercitare nelle due condizioni di luce diurna e notturna. Non c’è la pausa per la cena, si scende a turno senza fermare gli allenamenti.
Si finisce ormai a sera inoltrata, si è stanchi e spossati, ma pronti. Si parte, mettiamo la rotta a Sud. Domattina iniziano i turni di guardia sul ponte di comando, si dovrà rimanere attenti alle radio, ai radar e con in mano i binocoli si dovrà scrutare permanentemente l’orizzonte.
Giorno 8
Dopo la consueta riunione generale dove si fa il punto della situazione e si condividono, con tutto il team, le informazioni salienti riguardo a possibili casi SAR aperti (imbarcazioni in distress, in pericolo, che sono alla deriva). Si controlla la situazione in Libia, in Italia e in Europa, così come informazioni e istruzioni riguardanti la nave, si dà il via ai diversi compiti da svolgere durante la giornata. Chi non è di guardia in plancia di comando, dovrà preoccuparsi di svolgere mansioni di messa a
Ormai tra poche ore ci si ritroverà nel bel mezzo delle zone «calde», dove spesso avvengono i soccorsi e dove tante, troppe persone che non vengono soccorse muoiono
punto di tutto ciò che sarà necessario per il soccorso e la cura delle persone soccorse, dovrà ripassare attentamente quanto appreso nei giorni scorsi, riposare ed alimentarsi.
Ormai tra poche ore ci si ritroverà nel bel mezzo delle zone «calde», dove spesso avvengono i soccorsi e dove tante, troppe persone che non vengono soccorse muoiono. Sono le stesse zone dove alcune volte si incrociano pattugliatori delle guardie costiere libiche che, pagate dall’Italia e dall’Unione Europea, hanno il compito di intercettare le imbarcazioni in difficoltà e riportarle nelle carceri libiche contro ogni convenzione internazionale, legge del mare, diritto umanitario e contro ogni etica. Riconsegnandole di nuovo in mano ai trafficanti di esseri umani, di armi, droga, idrocarburi; personaggi questi molto conosciuti a livello internazionale e che in passato si sono seduti al tavolo delle trattative con esponenti del governo italiano a Roma. Le violenze che queste guardie perpetrano contro le persone che intercettano in mare sono largamente documentate. Chi sta al potere in Europa e in Italia continua ad appoggiarle, affinché
portino a termine ciò per cui vengono pagate e cioè far sì che non arrivino persone scomode in Europa, potenziali aventi diritto di asilo e protezione internazionale, potenziali lavoratori e lavoratrici che dovrebbero essere inseriti in un mondo di lavoro che sia in regola, potenziali madri, padri, famigliari, studenti. E comunque tutti e tutte, scomodi testimoni degli scempi di politiche scellerate che vengono messe in atto in Africa e nel Medio Oriente e non solo.
Giorno 9
Ormai siamo nelle zone dei soccorsi, l’attività sulla nave rallenta il ritmo in quanto fondamentalmente d’ora in avanti ci si concentrerà nella fase di guardia in plancia di comando. Oltre a ciò, bisogna riposarsi e alimentarsi, per essere pronti per le improvvise fasi successive: l’attivazione della ricerca attiva e della fase di soccorso. Anche se l’attività in nave ha un ritmo calmo e vi è per lo più silenzio, a bordo si respira un’aria carica di tensione.
Giorno 10
Sono le tre della mattina e arriva una segnalazione da parte dell’organizzazione Alarm Phone: segnala una imbarcazione in difficoltà. In questa fase solo la persona responsabile di coordinare i soccorsi (io) si sveglia, controlla la distanza dall’ultima posizione conosciuta della imbarcazione, prepara la strategia di navigazione e delle ormai imminenti fasi di soccorso.
Siamo a 16 miglia dall’imbarcazione, circa 2 ore di navigazione. ll mare è abbastanza mosso e ci sono circa 20 nodi di vento, non c’è luna e tutto ciò renderà il soccorso potenzialmente abbastanza difficile.
Questa volta decido di chiamare in plancia di comando i due responsabili delle RHIB (Juancruz e Gerald) prima di dare l’allarme che sveglierà tutte le squadre di bordo, quelle di soccorso, quelle mediche e di accoglienza. Ho già chiamato la responsabile del progetto. Mentre arrivano Juancruz e Gerald chiedo al primo ufficiale di accendere il secondo motore della nave, porterà la velocità di un terzo maggiore di quella attuale. Siamo ormai a 50 minuti dall’ultima posizione conosciuta dell’imbarcazione in pericolo.
Spiego ai due responsabili la situazione mentre arriva un aggiornamento da parte di Alarm Phone: comunicano che sembra si tratti di un gommone nero con circa 75 persone a bordo. Dalla posizione aggiornata si evince che siamo più vicini, siamo ormai a 35 minuti. Dopo aver dato ai responsabili delle RHIB le ultime indicazioni e ripassato assieme le potenziali criticità che affronteranno una volta calate le lance da soccorso in mare, chiedo a Juancruz e Gerald di svegliare le squadre di soccorso con calma, per far sì che respirino un momento prima di entrare in azione. Tra 10 minuti darò l’allarme generale.
Siamo ormai a 25 minuti dalla posizione, è il momento, chiamo via radio l’allerta: «MSF team, let’s get ready for rescue. Let’s get ready for rescue. MSF team ready for rescue».
In meno di 4 minuti le lance di soccorso sono pronte a essere calate, dalla plancia di comando avvistiamo una lieve luce intermittente all’orizzonte.

Uso i fari di ricerca della nave orientandoli in direzione della luce. Le persone a bordo, appena capiscono che stiamo cercando di illuminarle, usano quella luce intermittente (una piccola torcia) puntandola verso di noi, adesso si vede molto più chiaramente. In altri 4 minuti le due lance sono in acqua, si dirigono verso la luce e seguendo la scia luminosa della nave, oltre alle mie indicazioni via VHF. Portano a bordo diverse sacche di giubbetti salvagente e molti dispositivi di galleggiamento individuale e collettivo, per poterli usare qualora ci dovesse essere un naufragio. Fino al loro arrivo non sapremo quale è la situazione del gommone, se vi sono persone in acqua o meno.
Ci siamo, le lance sono in posizione e hanno il gommone in vista, confermano che è un gommone nero sovraccarico, le persone sono in panico, si sente un forte odore di benzina, brutto segno in quanto significa che si sono rovesciate le taniche che normalmente hanno a bordo e con ciò che vi saranno persone ustionate e probabilmente anche intossicate. Mentre ci avviciniamo con la nave, mettendola di traverso alle onde e al vento, riusciamo a dare un po’ di copertura e protezione alle RHIB che stanno cercando di avere il controllo della situazione, per far sì che diminuisca il rischio di perdita di vite umane.
Iniziano le fasi di soccorso: i soccorritori e le soccorritrici passano i giubbetti salvagente e iniziano a trasferire con difficoltà le persone dal gommone a bordo delle RHIB. Confermano che vi è la presenza di almeno un bebè, ma non riescono a vederlo. Il mare grosso e il vento fanno sì che il soccorso sia difficile. Se le persone dovessero cadere in acqua, con queste condizioni sarebbe facile perderle di vista. Viene avvistato il bebè e riescono a soccorrerlo.
Inizia il primo trasferimento delle persone verso la nave, la seconda RHIB riprende il soccorso. Mentre da una parte man mano che il gommone si svuota diminuisce il problema relativo
Il soccorso continua fino a che a bordo non vi è più nessuno, si controlla che non sia rimasto qualcuno privo di sensi sul gommone. Si spera che nessuno sia morto
al peso ma aumenta la difficoltà di mantenersi vicini con le RHIB in quanto il gommone deriva di più e si sposta velocemente sotto l’effetto del vento, delle onde o anche delle lance.
Intanto a bordo della nave le persone tratte in salvo vengono ricevute dal personale medico che, in coordinamento con il personale addetto al ponte, deve urgentemente riuscire a distinguere e dividere chi
ha bisogno di immediate cure mediche, mentre gli altri vengono spostati in una zona dove possano attendere la fine del soccorso. Arrivano tutti fradici e molti sono intrisi di benzina, dovranno quindi subito fare una doccia per evitare gravi ustioni. Viene dato loro uno zainetto piccolo con una coperta, una salvietta, spazzolino e dentifricio, una tuta, una maglietta, mutande e calze.
Il soccorso continua fino a che a bordo non vi è più nessuno, si controlla che non sia rimasto qualcuno privo di sensi sul gommone. Si spera che nessuno sia morto.
Le RHIB vengono rimesse a bordo e da subito risistemate e pronte per un eventuale altro soccorso. Intanto a bordo le squadre sul ponte continuano il duro lavoro di prima accoglienza, controllo medico e prima gestione di 76 persone (numero confermato). Alcune sono in situazioni critiche per via dell’intossicazione da benzina. Altre sono in ipotermia. Ci vuole circa un’ora per avere la situazione sotto controllo, sono ormai quasi le 6 di mattina. Questa volta tutti e tutte su questa nave siamo (e sono) stati fortunati. Non vi sono dispersi, non vi sono morti. Meno male. Da questo momento in poi si entra in fase di ricerca attiva con sopravvissuti a bordo. Ci saranno ancora due giorni di buon tempo e potenziali altre imbarcazioni in pericolo. Dalla plancia di comando chiediamo da subito il porto di sbarco, il Place of Safety alla Libia, sapendo che anche se dovessero rispondere (cosa che non fanno mai) lo rifiuteremo chiedendone un altro. La Libia non è un Place of Safety, un luogo sicuro. Ma la strategia dell’UE è stata quella di creare la guardia costiera e la zona SAR libica, dando così una parvenza di formale legittimità a questa tragica farsa che si traduce nella pratica in un sistema di respingimento per delega. La parvenza di formalità fa sì che si sia obbligati a chiedere un porto all’autorità competente della zona dove si è realizzato il soccorso, questa volta la Libia. Evidentemente sia Malta che Italia, che invece sono Place of Safety, sono in copia nelle richieste e comunicazioni con le autorità libiche, e sono formalmente responsabili del benessere, dell’incolumità e della protezione delle persone soccorse, anche di quelle soccorse al di fuori della propria zona SAR.
Giorno 11 e 12
Le persone a bordo passano il primo giorno sfinite e disorientate, poi a poco a poco iniziano a recuperare le forze. Da parte nostra si cerca di dare loro il miglior supporto possibile viste le circostanze, non abbiamo molte certezze da dare loro, ma una cosa è sicura e la ripetiamo spesso: non le riporteremo in Libia. Mentre sul ponte la gestione delle decine di persone che abbiamo soccorso prende il suo ritmo, riceviamo un altro avviso da parte di Alarm Phone. Una imbarcazione in pericolo, questa volta molto lontana da noi, quasi 300 miglia. Non vi sono altre navi da soccorso, non vi sono altri avvisi di imbarcazioni in pericolo e tra poco il mare diventerà grosso. Dirigiamo la rotta verso l’ultima posizione conosciuta, sappiamo già che dovremo affrontare una tormenta e speriamo che questa stessa tormenta non travolga quell’imbarcazione, non avrebbe possibilità di rimanere a galla. Siamo coscienti di essere molto lontani, ma ciò non toglie che dobbiamo far qualcosa sin da subito. L’imbarcazione è in zona SAR maltese, nella stessa zona passano molti mercantili, visto che si trova propria sulla rotta commerciale del Mediterraneo centrale. Perciò iniziamo ad individuare i mercantili presenti in quella posizione e cerchiamo di metterci in contatto con loro, sperando in una risposta. Chiamiamo e mandiamo e-mail anche alle autorità Maltesi che non rispondono, non danno informazioni e non mandano pattugliatori da soccorso. Non è una novità. Non è neppure una novità che le navi mercantili non rispondano. Passa così la notte.
Giorno 13
Sin dalle prime ore del mattino ci mettiamo alla ricerca dei numeri di telefono dei ponti di comando delle navi mercantili che durante la notte abbiamo individuato. Contattiamo le compagnie di navigazione di mezzo mondo, dalla Grecia al Giappone, informando di ciò che sta succedendo: una imbarcazione è alla deriva e le loro navi sono vicine, le leggi internazionali impongono l’obbligo di soccorrere.
Riusciamo a parlare con alcuni comandanti, le informazioni non sono chiare, si capisce che non vogliono condividere ciò che sanno. Poi la dichiarazione di uno dei comandanti: le persone sono state soccorse da un’altra nave, ma le autorità maltesi hanno imposto che non si dica di quale nave si tratti.
Noi immaginiamo qualcosa di già visto prima: un respingimento collettivo orchestrato e ordinato dalle autorità maltesi.
Purtroppo, intanto sul ponte la situazione è critica, il mare gros-
so e la tempesta stanno rendendo la nostra navigazione estremamente difficile, addirittura le onde rompono una parte dell’eliporto in prora. Dobbiamo abbandonare l’operazione di ricerca e cambiare rotta per una navigazione meno pericolosa.
Nei giorni successivi riusciremo a scoprire che, come ci aspettavamo, le persone sono stare respinte e portate questa volta non in Libia, ma in Egitto.
II mare grosso continuerà per alcuni giorni, non sembrano esserci altre imbarcazioni in pericolo, noi intanto abbiamo la responsabilità di portare le persone che sono a bordo in un luogo sicuro nel più breve tempo possibile. Dirigiamo verso nord.
Giorno 17
Da giorni a bordo il ritmo viene cadenzato dalle attività che i vari dipartimenti realizzano, a livello di gestione delle persone, di controllo e cure mediche, di analisi dei casi più gravi a livello umanitario. Purtroppo tutti e tutte hanno un passato molto traumatico. Ciò che possiamo fare per loro è dare il massimo possibile del nostro appoggio, della nostra comprensione.
Questa volta, visto il numero ridotto di persone soccorse che abbiamo a bordo (parlare di «poche» persone quando sono molte decine sembra strano) riusciamo a rimanere molto tempo con loro e a organizzare attività che aiutano a reggere la frustrazione dell’attesa.
Sono ormai diversi giorni che aspettiamo che le autorità italiane indichino un luogo sicuro, un porto dove poter sbarcare queste persone e permettere loro, come sarebbe previsto, il pieno accesso a cure e ai loro diritti. Abbiamo chiesto già 12 volte il porto alle autorità italiane che tacciono. Prima dell’Italia abbiamo inoltrato le nostre richieste a Malta, non ottenendo nessuna risposta. Intanto la sofferenza a bordo aumenta lo stress già elevato, conseguente alle violenze e ai rischi corsi in mare e che ha già creato profonde ferite interne alle persone; questa prolungata attesa ne aumenta le conseguenze.
Il lavoro fondamentale dei dipartimenti di bordo è anche orientato alla raccolta di informazioni importanti e che, purtroppo
ancora una volta, rivelano l’inferno vissuto durante i viaggi e il buco nero della Libia, dove sono stati sottoposti a torture da parte dei trafficanti, dalle milizie ed anche dalla guardia costiera.
Per quanto si possano sentire determinate testimonianze, non si riesce ad abituarsi alle estreme depravazioni e violenze cui vengono sottoposte queste persone. Il motivo è sempre e ancora lo stesso: i soldi. Vengono trattate come merce di scambio, di sfruttamento.
Giorno 18
Verso mezzogiorno riceviamo la comunicazione dalle autorità italiane del porto di sbarco. Finalmente!
Ma è a più di un giorno di navigazione dalla nostra posizione. A volte non si capisce come mai i porti disponibili siano sempre i più lontani, sembra proprio una strana coincidenza.
Comunichiamo la notizia alle persone sopravvissute, vi è un’esplosione di gioia.
Giorno 19
Arrivati in porto alle prime ore del mattino, sul ponte si respira un’aria completamente diversa, le persone sopravvissute sono silenziose, ma il loro sguardo racconta più delle parole. Abbiamo spiegato cosa succederà allo sbarco, come saranno le diverse gestioni poliziesche e burocratiche una volta scesi, quali siano i loro diritti e come farli valere, cercando di far si che almeno, una volta a terra, abbiano qualche conoscenza in più riguardo a ciò che li aspetta.
L’arrivo in questo luogo sicuro è una nuova fase ignota riguardo a ciò che succederà loro e questo crea un evidente stato di grande ansia per il loro futuro.
Vi sono anche molti sorrisi e molta curiosità, ma per lo più tra le persone aleggia una seria attesa.
Dopo le pratiche mediche, la nave riceve la «libera pratica», le persone soccorse possono essere sbarcate, per primi i casi medici, poi le persone minorenni non accompagnate, poi le famiglie e via via tutte le altre. È il momento dei saluti, abbiamo condiviso momenti molto difficili della loro vita e anche della nostra, vivendo anche momenti di gioia e tanta apprensione.
Ecco, adesso è sbarcato l’ultimo ragazzo.
Li salutiamo ancora mentre si allontanano a bordo dei bus scortati dai cellulari e dalle macchine della polizia. Chissà cosa ne sarà di loro.
Torniamo a bordo, la nave è stranamente silenziosa. Siamo silenziosi anche noi.
C’è sempre un mix di sensazioni confuse nel ripensare a quanto accaduto e c’è la speranza che, per queste donne e questi uomini, ciò che sono stati costretti a vivere in questa drammatica fase della loro vita – la Libia, le violenze, il viaggio, il mare – sia terminato per sempre. Speriamo che la vita sia più generosa con loro.
Anche questa nuova fase che inizia per queste persone probabilmente sarà difficile, ma sarà una fase dove almeno – come risposi alla domanda che mi fece una ragazza che avevamo soccorso – nessuno le ammazzerà.
Questa volta, superato il mare, ce l’hanno fatta… hanno vinto la morte.

La Comune Pachamama: vivere l’utopia nel Rio Grande do Sul Espe
Mário Rui Pinto*
Dopo la Fiera del libro anarchico di Porto Alegre e un tentativo fallito di entrare in Uruguay, decisi di partire alla volta della Comune Pachamama, proprio nel cuore del Rio Grande do Sul. E siccome in Brasile tutto è lontano… da Porto Alegre, capitale di quello Stato, a São Gabriel, piccolo centro rurale dell’interno, ci vogliono circa cinque ore di pullmann espresso. Poi, altro pullmann, che circola solo nei giorni dispari, e che, per più di quattro ore, percorre una strada sterrata fino a un posto chiamato Pavão. Qui c’era ad aspettarmi Daiane, una dei membri della Comune
che avevo conosciuto durante la Fiera, e ci facemmo altri tredici chilometri su una strada piena di buche. E finalmente, mentre il sole tramontava, eccomi nella Comune Pachamama, un’oasi di anarchia in una regione di grandi proprietari.
Le origini
La Comune fa parte dell’insediamento Assentamento Madre Terra, un’occupazione di 1.700 ettari di terreni lasciati incolti da un’enorme proprietà, la Fazenda Santa Rita. L’occupazione fu promossa dal Movimento dei Lavoratori Agricoli Senza Terra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-MST)
* Mário Rui Pinto è il responsabile della Casa editrice anarchica portoghese Barricada de Livros.
all’inizio di questo secolo. Nel 2009, l’Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), un’organizzazione dello Stato brasiliano la cui funzione principale è quella di assegnare le terre alle famiglie povere, ha iniziato il relativo processo di legalizzazione dell’insediamento, coinvolgendo circa 90 famiglie. In Brasile, la terre lasciate incolte possono, in teoria e a seconda della maggiore o minore volontà del potere politico, essere espropriate «per necessità o utilità pubblica, o per interesse sociale» e consegnate a coloro che vogliono coltivarle.
Da dove viene questa terra? Di solito da grandi latifondi che non rispettano quanto stabilito nella Costituzione sulla «funzione sociale della proprietà». Con l’avvento al potere del Partito dei Lavoratori e di Lula, il MST è stato cooptato nell’area di governo e alcuni dei suoi leader sono stati nominati nelle strutture dirigenziali dell’INCRA. Poiché il MST non voleva causare problemi al governo, la lotta per la proprietà terriera si indebolì e ad alcuni militanti, considerati più radicali per non aver accettato questa nuova posizione politica, fu dato l’appellativo di «anarchici» e vennero persino espulsi. Fu questo il caso dei fondatori della Comune che appartenevano al Frente de Massa del MST. Dice Daiane: «Ci siamo sentiti chiamare così tante volte anarchici che alla fine abbiamo deciso di sapere di cosa si trattasse… e siamo arrivati alla conclusione che anarchici lo eravamo per davvero. Da quel momento, abbiamo assunto l’anarchismo come un obiettivo nostro e della Comune».
La Comune
La Comune Pachamama ha circa 100 ettari e attualmente fanno parte del progetto 16 adulti e 4 bambini, ma non tutti gli adulti vivono in modo permanente nella Comune. Durante la mia permanenza, i membri residenti erano 6 adulti e 4 bambini. Dei 100 ettari menzionati, ogni membro residente ha diritto a 1 ettaro dove può piantare ciò che vuole. I restanti sono destinati alle infrastrutture, alle coltivazioni, al pascolo e alle pianure alluvionali per la produzione di riso, oltre ad una zona protetta di foresta originaria, in cui la Foresta Atlantica convive col Bioma Pampa. Le principali infrastrutture sono tre case per i residenti, una casa collettiva – che funge da cucina e luogo per pasti e riunioni –, e la Casa del Miele, dove avviene la lavorazione e il raffinamento questo prodotto. Miele e riso biologico – senza veleni e senza padroni – sono i due prodotti che la Comune destina alla vendita, sia diretta nei mercati biologici che su ordinazione attraverso i social networks. Oltre a questi, c’è tutta una produzione agricola, anch’essa biologica, per l’autoconsumo – varie specie di ortaggi, piante aromatiche, frutta, latte e formaggio, raccolte di semi, ecc. –, portata avanti individualmente o collettivamente, che rende la Comune assai poco dipendente dall’esterno. L’accesso diretto a una vasta laguna le fornisce l’acqua di cui ha bisogno.
I princìpi
La Comune e i suoi membri si proclamano anarchici, ma non nei termini dell’anarchismo classico, che ritengono abbia radici eurocentriche, scollegate della realtà in cui vivono. Intendono l’anarchismo come una sperimentazione quotidiana, un’esperienza giorno per giorno di utopia, intesa come creazione e sviluppo di pratiche di vita basate su modelli di comportamento che mettono in discussione il capitalismo, lo Stato e altre forme di dominio, come il machismo, il patriarcato, la discriminazione. Una visione dell’anarchismo che privilegia il naturismo, l’agroecologia, una sana relazione con la Pachamama (Madre-Terra), molto vicina alla visione del mondo indigena. Nelle parole di Lisiane, con la quale ho trascorso praticamente un’intera giornata preparando la risaia per la semina che stava arrivando: «Qui guardo molto di più il cielo, le stelle, la Luna, ma non solo la bellezza; la conoscenza dei cicli della natura diventa fondamentale per la sussistenza».
La Comune cerca anche di incoraggiare, nell’Assentamento, pratiche libertarie di organizzazione della comunità, basate sulla solidarietà, l’autogestione, l’autonomia e l’agricoltura biologica. Se, rispetto alle prime due, i progressi sono notevoli, rispetto alle ultime due, il messaggio non viene accolto. Infatti, in tutto l’Assentamento, solo la Comune di Pachamama pratica agricoltura biologica e diversificata. Tutte le altre famiglie non solo disboscano per avere più terra, ma usano pesticidi e dipendono dalla monocoltura – riso o, in molti casi, soia transgenica – in nome di una presunta «maggiore produttività». Purtroppo, la furia produttivista del MST ha lasciato il segno e la visione agroecologica della Comune è completamente isolata.
Per quanto riguarda il mondo esterno, la Comune dà priorità alla creazione di reti di cooperazione e di mutuo appoggio con altri gruppi e organizzazioni simili, come la Teia dos Povos (la Rete dei Popoli), alla ricerca di due obiettivi: da un lato, ampliare il ventaglio della lotta anticapitalista; dall’altro, rafforzare l’autonomia di questi collettivi a partire da reti alternative al sistema che consentano lo scambio di prodotti, servizi, saperi ed esperienze.
Un confronto inevitabile
Per me il confronto con la Comune pugliese di Urupia (Rui Pinto 2021) è stato inevitabile e immediato. La stessa fraternità, la stessa solidarietà, la stessa volontà di creare un nuovo modo di produrre, consumare e vivere, caratterizzato dall’autonomia, l’autogestione, l’orizzontalità, la lotta contro il capitalismo e lo Stato. Così
come Urupia, anche Pachamama ha organizzato diverse attività rivolte all’esterno, come le Primavere libertarie – se ne sono tenute già sette, di cui l’ultima nel 2019 –, in cui si riuniscono collettivi e individui anarchici, con l’obiettivo di conoscersi meglio, favorire nuovi contatti e progetti, e una Contro-Scuola Estiva Anarchica, tenutasi nel 2016, che ha promosso lo scambio di conoscenze in settori concreti dell’attività della Comune: bioedilizia, permacultura, contro-scolarizzazione.
Il processo decisionale è diverso: qui, a maggioranza dei membri residenti, quando il consenso non è possibile; a Urupia, sempre per consenso. Anche la distribuzione del ricavato proveniente dalle vendite all’esterno è diversa: poiché i due principali settori di produzione – il riso e l’apicoltura –, sebbene organizzati dall’intera collettività, sono di competenza di due gruppi diversi, la Comune ha deciso che i proventi derivanti dalla vendita del riso vadano al gruppo che lo produce, mentre i proventi derivanti dalla vendita del miele vadano all’altro gruppo; a Urupia, poiché non esistono gruppi produttivi differenziati, tutti i ricavi sono collettivizzati.
Ciò che più mi ha colpito
Ma l’aspetto della vita quotidiana nella Comune che più mi ha colpito è stato il rapporto degli adulti con i bambini. La loro educazione è assicurata da tutti a rotazione, in base alla disponibilità

derivante dall’attività agricola e da alcuni viaggi all’esterno. Tutti gli adulti sono contemporaneamente padri e madri. Tutti gli adulti sono insegnanti; qualsiasi aspetto o attività della Comune è materia di insegnamento; tutte le competenze degli adulti sono trasmesse ai bambini – dalla musica all’apicoltura, dalla mungitura delle mucche all’agricoltura al disegno, al portoghese, alle scienze naturali o alla geografia. In breve, un’autentica educazione integrale. Questa attività può certamente essere considerata la più importante della Comune. Per usare le parole di Felipe: «Qui cerchiamo di superare il concetto di famiglia nucleare tradizionale e sviluppare nuove forme di relazioni affettive e emozionali. Relazioni aperte, ogni qual volta ci sia la volontà delle persone». E ha aggiunto, sorridendo: «Cerchiamo di imparare dagli errori commessi dalla Colonia Cecilia sulla questione dell’amore libero»1 . Rifiutando l’istituzione familiare tradizionale e patriarcale, i membri della Comune rifiutano anche l’organizzazione sociale basata sui legami familiari consanguinei e cercano di sviluppare l’educazione collettiva dei bambini. Una vera paternità/materni-
tà collettiva. In conclusione, nella Comune di Pachamama si pratica e si vive l’utopia. È un’ulteriore isola di un vasto arcipelago.
(traduzione dal portoghese di Pietro Masiello)
Bibliografia
M. RUI PINTO, Viver a utopia: cinco ilhas de um arquipélago disperso, Barricada de Livros, Lisboa, 2021.
1 La Colonia Cecilia fu un esperimento di comunità agricola anarchica che venne realizzato in Brasile nell’ultima decade del secolo XIX dal medico veterinario di Pisa Giovanni Rossi insieme a un gruppo di anarchici toscani e lombardi. Da questa vicenda il regista francese Jean-Louis Comolli trasse il film Cecilia – Storia di una comune anarchica del 1976.


Il senso della bioetica per la sopravvivenza e la salute dell’umanità
Pamela Boldrin
Scienza e filosofia sono discipline molto antiche, cresciute assieme per lungo tempo stimolandosi a vicenda. Se pensiamo a un prototipo di scienziato filosofo, chiunque può facilmente richiamare alla memoria il greco Ippocrate, vissuto nell’isola di Kos nel V e il IV secolo a.C. Egli affiancava rigorose procedure logiche (pur con tutti i limiti della sua conoscenza dell’epoca) a profonde riflessioni filosofiche. Era attento osservatore dell’ambiente, nel quale cercava elementi, che annotava scrupolosamente, per spiegare le cause dei sintomi dei malati che visitava, senza discriminazioni in base al ceto sociale, tra l’altro. Non solo, ma la prima grande scuola di medicina, a Kos, è stata anche un ospedale concepito con un approccio globale alla salute dei malati: l’Asklepieion. In quel luogo, le cui rovine sono ancora visitabili, erano presenti le stanze per le visite mediche, quelle per le degenze, gli spazi sacri per la preghiera, un magnifico e confortante panorama sul mare con la costa di fronte (oggi Turchia) e in seguito furono aggiunte anche le terme, dai Romani. Un vero e proprio approccio complesso alla salute! Peccato che, dopo i positivi esordi nell’antichità, la storia umana abbia portato a sviluppi diversi: la scienza si è progressivamente sviluppata separandosi sempre più dalla filosofia e dall’etica. La rivoluzione scientifica e i suoi principali pensatori hanno insistito sul concetto di uomo-macchina, sull’esplorazione sempre più dettagliata dei meccanismi di funzionamento (si pensi anche al ruolo della dissezione dei cadaveri nel costruire la scienza medica), con sempre minor interesse a mantenere collegati in una rete di interazioni i vari percorsi della conoscenza. In effetti,
tra gli approcci conoscitivi, sappiamo bene che è stato il riduzionismo ad avere la meglio. L’infinitamente piccolo, il termine minimo di ogni scomposizione è stato troppo spesso considerato il successo finale di ogni esplorazione, in totale cecità di cosa è la complessità, di come tutto è strettamente collegato e di come molti fenomeni emergano solo nell’interrelazione.
A proposito di fenomeni apparentemente lontani tra loro, con la pandemia attuale abbiamo forse un po’ capito che la deforestazione spregiudicata per fare spazio a città, monocolture agricole o allevamenti
intensivi può urtare delicati equilibri e scatenare la fuoriuscita di virus a noi sconosciuti. Quando tocchiamo l’ecosistema, tocchiamo la nostra salute.
Questo problema era stato colto molto bene negli anni ‘70 da un biochimico oncologo, Van Rensselaer Potter, che nel Winsconsin pubblicò il primo libro dedicato alla bioetica, intitolandolo Bioethics: Bridge to the Future, nel 1971. È proprio la metafora del ponte a essere l’intuizione di cui vi era bisogno, perché Potter pensa questa nuova disciplina come terreno di dialogo tra saperi tenuti troppo a lungo separati, nell’ottica di mantenere il delicato equilibrio sulla Terra minacciato dalla nostra presenza. La prospettiva di Potter, insomma, era ecologica, globale e complessa. Tuttavia, nello stesso periodo, qualche migliaio di chilometri più a est, un medico di nome André Hellegers promuoveva la necessità della bioetica come disciplina capace di discutere le delicate questioni che scaturiscono dal continuo progresso scientifico in campo medico. Questa seconda visione ha avuto maggiormente fortuna e ancora oggi per bioetica si intende perlopiù una forma di sapere che tenta di riflettere e fornire concetti guida negli scenari impensati che la scienza medica pone.
Molti attenzioni della bioetica oggi convergono sulle questioni del fine vita: accanimento terapeutico, eutanasia e suicidio assistito sono temi di grande urgenza e attualità, che interpellano ormai disperatamente il nostro sistema legislativo al fine di fornire strumenti regolativi per aiutare i malati, da un lato. Dall’altro lato, le regole aiutano anche tutto l’apparato delle professioni sanitarie a organizzare al meglio il proprio lavoro, vedendo maggiormente tutelati diversi ruoli e spazi di manovra nelle cure del fine vita.
Leggermente meno altisonante a livello mediatico italiano è tutta la questione dell’inizio vita con gli aspetti legati alla procreazione medicalmente assistita (PMA) che consentono di manipolare sempre di più qualcosa che è stato per lunghissimo tempo fuori dalla portata umana: la creazione di una nuova vita. Fecondazione assistita, eterologa o omologa, selezione e conservazione degli embrioni, maternità surrogata e tecniche di modifica del DNA sono questioni che rivelano aspetti molto inquietanti, ma da esplorare mediante riflessioni condivise, soprattutto perché nel mondo le regole di accesso a queste pratiche sono diverse e mettono in essere flussi verso il miglior offerente. In questo ultimo ambito la riflessione chiama in causa anche questioni economiche, perché quello della PMA è un settore di mercato molto fiorente e, tra le varie problematiche, si presta anche ad abusi nei confronti di chi, per disagio economico-sociale, deve anteporre il denaro all’etica.
Inoltre, la bioetica considera molti altri ambiti nel campo della salute e del benessere. Un occhio sospettoso lo dà alla ricerca nel campo del cosiddetto transumanesimo: longevità estrema (i principali magnati del mondo hi-tech devolvono somme enormi per sovvenzionare laboratori del potenziamento umano), potenziamento cognitivo, ibridazione umani-macchine… tutti campi di ricerca che muovono inizialmente dalla ricerca di cure per situazioni patologiche, quindi in contesti più che legittimi, per poi slittare facilmente in scenari di potenziamento estremo. Ad esempio, se per ovviare alle gravi conseguenze di una paralisi degli arti di una persona in seguito a trauma possiamo installare dei chip nel suo corpo e nella sua testa per ripristinare il movimento, dunque l’autonomia, probabilmente nessuno ha da ridire. Ma, una volta consolidato questo successo, perché non sfruttare la conoscenza per potenziare situazioni di normalità? Perché non installare un motore di ricerca Google direttamente nelle nostre aree cerebrali? Basta ascoltare qualche intervento pubblico di Elon Musk per capire quali sono le mire. La bioetica arriva sempre troppo in ritardo, per lei la potenza della tecnica è concorrenza sleale.
Tornando un po’ più alla quotidianità, la bioetica si occupa anche di elaborare considerazioni sul rapporto medico-paziente. Il consenso informato, regolato per legge, rappresenta un chiaro esempio di come la riflessione sul diritto all’autonomia del paziente sulle proprie scelte sia un risultato ormai insindacabile, il quale ha spazzato via millenni di paternalismo medico. Chiaramente, il consenso informato è solo la superficie formale di un rapporto che in realtà è molto complesso: la
relazione con la persona malata e i suoi famigliari è un processo molto arduo e pieno di imprevisti. L’alleanza terapeutica, auspicata anche dalla recente legge n. 219 del 2017 sulle DAT (dichiarazioni anticipate di trattamento, importanti soprattutto per gestire il fine vita), è un lavoro che richiede tempo, pazienza, abilità comunicative, esperienza e, magari, anche un po’ di formazione specifica, che va oltre le specifiche conoscenze di biologia o medicina, o di diritto. Il personale medico, sostanzialmente, deve avere un minimo di attenzione all’etica, di conoscenza dei suoi principi generali e dei meccanismi di funzionamento della mente umana. Etica vuol dire un po’ di filosofia, un po’ di psicologia, un po’ di cultura generale del mondo, tante cose insomma. È una conoscenza che emerge quando si impara a interfacciare diversi ambiti della conoscenza e dell’esperienza di vita, dunque ognuno creerà una propria etica personale, mai identica a quella di qualcun altro. Fortunatamente abbiamo la possibilità di insegnare un po’ di bioetica, disciplina che, avendo intrecciato la sua fortuna con le vicissitudini della scienza medica, può vantare almeno un sodalizio con questa dimensione importante della nostra vita. Quindi, oltre alla miscela che si manifesterà in
forma variabile nel personale medico, infermieristico e tecnico di elementi personali che concorrono alla formazione di un’etica individuale, la bioetica potrà dare i suoi frutti facendo da ponte tra il sapere scientifico e quello filosofico, elargendo i suoi preziosi appigli nelle difficoltà di tutti i giorni.
Peccato che la bioetica non sia tra le materie di studio nel corso di medicina, nemmeno in quello di molte figure tecniche sanitarie e lo sia per un numero irrisorio di ore nel programma di laurea che forma il personale infermieristico. Nonostante la versione della bioetica come ancella della scienza medica abbia soppiantato la visione globale della bioetica come paladina di tutti gli equilibri legati all’ecosistema, non ci abbiamo guadagnato una classe di professionisti sanitari eruditi in questo campo, perché non c’è posto per tale materia nei fitti programmi universitari. Esistono sì, per chi vuole continuare nel post lauream, master e corsi di perfezionamento universitari in bioetica e, se andiamo a guardare i curricula dei membri dei comitati etici per la pratica clinica (presenti negli ospedali, ma non obbligatori in tutte le regioni italiane), troveremo certamente certificazione di questi percorsi, ma a un livello troppo poco diffuso per i numeri della sanità.
Le pratiche sanitarie non possono vedere la vocazione etica relegata esclusivamente alla predisposizione soggettiva dei vari esponenti del panorama medico-sanitario. La formazione curriculare è fondamentale, così come la promozione di conoscenze non troppo parcellizzate, o non esclusivamente settoriali. Una visione etica non può prescindere da una conoscenza il più vasta possibile, da un piglio curioso verso il sapere e l’esperienza. Come possiamo accertarci che questi requisiti siano presenti nel personale che studia per diventare competente nella cura del-
la salute? Non possiamo saperlo ma possiamo sospettare che sarà sempre meno verosimile, visto che il test di ingresso a Medicina in Italia è stato cambiato a partire dall’anno accademico 2022-2023. Infatti, è stata modificata la ripartizione degli ambiti delle domande: meno cultura generale, più quiz di competenze scientifiche. Sembra che vogliamo formare personale medico che cominci il percorso sapendo già il più possibile di biologia e medicina e
Una visione etica non può prescindere da una conoscenza il più vasta possibile, da un piglio curioso verso il sapere e l’esperienza
poco niente del mondo. Come possiamo agevolare delle menti abili a operare tra i vari campi della conoscenza in questo modo? Come possiamo sostenere una visione complessa in un mondo sempre troppo complesso per le nostre capacità, se non riconosciamo il ruolo che una conoscenza più vasta possibile ha nell’agevolare una visione critica e multidisciplinare?
Con la pandemia abbiamo visto medici, e non solo, rifiutare le evidenze scientifiche sul SARS-CoV-2 e sui vaccini; una piccola parte, per fortuna, ma cosa sono se non un segno che la formazione specialistica può non essere efficace a instillare la capacità di gestire la complessità? La visione complessa richiede pazienza e molta umiltà, non possiamo comprendere sempre tutto, a volte dobbiamo attendere nuovi dati, collegare tutto minuziosamente, confrontare e continuare a ragionare in modo cooperativo, facendoci coraggio a vicenda.
Le teorie complottiste sono la risposta di chi non sa gestire la complessità e preferisce creare o, più spesso semplicemente aderire, a confezionamenti deliranti di spiegazioni che vanno contro le evidenze presenti. Visto il dilagare di questo fenomeno, in qualità di docente a contratto presso il Corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università di Padova mi sono resa conto che era urgente inserire nel mio programma di bioetica (già stipato in 10 ore) una parte dedicata a spiegare cos’è la scienza, cos’è un’opinione e come difendersi dai complottismi o dalle fake news.
La bioetica, meglio se intesa come approccio globale all’ecosistema, ma anche come ancella del progresso medico-scientifico, è comunque una «disciplina ponte», che non può prescindere dall’esplorare diverse forme di conoscenza e tentare di connetterle. Insomma, la bioetica è promotrice di visioni complesse, non è possibile escluderla dalla formazione degli individui, in tutti i campi in cui essi svolgeranno la loro opera professionale o di vita. Ne va della nostra salvezza! Ippocrate sarebbe certamente d’accordo.

Il punto di vista dei visoni
Giorgio Fontana
Al Congresso di Lotta Continua nell’autunno 1976 avvenne uno scambio che nasce dal dibattito portato avanti dalle femministe, ma dice qualcosa anche sugli animali. Ciro della Spa Stura affermò che solo gli operai, «in quanto operai», esprimono il punto di vista del proletariato; la donna, «in quanto donna», può anche essere borghese e reazionaria. «Se una donna ponesse come obiettivo di avere tutte le pelliccia di visone», aggiunse, «sarebbe un obiettivo che riconoscerebbe nelle donne l’effettiva esigenza
«Già. Perché i visoni non dovrebbero avere un punto di vista?». Fu uno dei primi vagiti del mio risveglio antispecista
di avere tutte la pelliccia di visone, ma non sarebbe un obiettivo consono agli obiettivi degli operai». Donatella Barazzetti replicò: «A proposito della questione delle pellicce, volevo dire che il punto di vista della sinistra, in questo caso il punto di vista rivoluzionario, ce l’hanno i visoni» (Cazzullo 2015).
Quando lessi questo passo, molti anni fa, pensai con convinzione: «Già. Perché i visoni non dovrebbero avere un punto di vista?». Fu uno dei primi vagiti del mio risveglio antispecista, ovvero la convinzione che l’essere umano non detenga particolari diritti sulle altre specie animali e non possa pertanto violarne gli interessi. Non voglio cominciare con goffi antropomorfismi, attribuendo ai visoni (o alle martore, o alle lumache) pensieri compiuti: mi limito a suggerire un’ovvietà per gran parte elusa, cioè che gli animali hanno volizioni, preferenze, desideri, simpatie, antipatie. Tale ovvietà è tenuta in massima considerazione quando si tratta di cani e gatti, ma quasi tutte le altre specie sono espropriate di tali libertà elementari e considerate una sorta di massa inerte, infinitamente replicabile e disponibile a diventare cibo o prodotti di ogni sorta. Per scelta del sovrano assoluto — l’essere umano — il mondo animale è diviso in nobili e plebei; e come nelle nostre società, i primi sono pochissimi mentre i secondi molti e sfruttati.
Nel celebre Discorso sulla servitù volontaria Étienne de La Boétie scrisse che «è del tutto vano chiedersi se la libertà sia naturale, poiché non si può asservire nessuno senza fargli torto; nulla è più contrario alla natura — interamente ragionevole — dell’ingiustizia. […] Gli animali se gli uomini li ascoltano, gridano: ‘Viva la libertà!’» (De La Boétie 2008). Era la metà del Cinquecento, e non è affatto retorica. Le azioni di fuga e protesta da parte di elefanti, orche e scimmie costretti alla prigionia — soprattutto in zoo e circhi — sono ampiamente documentate; ed è interessante notare come gli animali sappiano dirigere la violenza con la dovuta discriminazione, concentrandola sui propri aguzzini e ignorando il resto dei presenti (Hribal 2021).
Ovviamente la reazione umana è costruire gabbie sempre più solide e processi di sfruttamento sempre più efficienti, accompagnati da immagini di mucche felici che celano la sofferenza di bovini trasportati per migliaia di chilometri ricoperti da escrementi, maiali costretti a vivere immobili per tutta la vita, pulcini maschi tritati vivi perché inutili alla produzione di uova, polli imbottiti di antibiotici (cfr. Safran Foer 2010 e il recente Mance 2021 fra i tanti).
Ma gli animali non aspirano affatto a essere torturati, imprigionati o uccisi; aspirano a una vita degna tanto quanto noi. Dunque perché negargliela?
Sono vegetariano da cinque anni e mezzo. Nel tempo ho stabilito una dieta in cui sui tre pasti principali due sono vegani e uno vegetariano (dove comunque cerco di porre la massima attenzione alla provenienza di uova e latticini). Non ho problemi di godimento culinario, che ritengo fondamentale per una buona vita e spesso resta un po’ in secondo piano quando si parla di alimentazioni non onnivore: per intenderci, non mi nutro soltanto di tofu e finocchi crudi. Del resto, perché mai il compenso di una dieta più retta dovrebbe essere una diminuzione del piacere? Certo, questo regime resta insufficiente: per quanto ci si rivolga
ad allevamenti qualificati, la nuda verità è che le mucche da latte soffrono comunque — non foss’altro perché inseminate artificialmente e separate a forza dai loro vitelli. La sola scelta rispettosa e con un forte impatto in termini di sostenibilità ambientale è il veganesimo: nutrirsi unicamente di piante e derivati ed eliminare i prodotti animali anche dal resto della nostra vita — ad esempio nell’abbigliamento. Ci sto lavorando su e conto di portare a termine la mia rivoluzione.
Ma a questo punto, nei discorsi occasionali, salta fuori quello che potremmo chiamare il moralista inerte. Di fronte agli sforzi di chi tenta di migliorarsi facendo i conti con difficoltà (o innegabili pigrizie) di vario tipo, il moralista inerte gode nel sottolineare l’imperfezione senza tuttavia impegnarsi in alcun modo. Quando confessai che anni fa mangiai alcuni frutti di mare, uno strappo una tantum, vidi disegnarsi sul volto di un conoscente il tipico sorriso feroce: come potevo dichiararmi vegetariano? Non mi vergognavo della mia incoerenza? Come osavo pensarmi migliore? Risposi che non mi pensavo affatto «migliore»; a differenza di lui — che intanto si sbafava allegramente una bistecca — non applicavo standard morali troppo ardui: perché so che incoerenza e imprecisione fanno parte dell’essere umano, e l’idea che sia meglio essere coerenti nei propri difetti mi sembra alquanto balzana. Questo beninteso non significa cercare scuse o impegnarsi a intermittenza; ma se l’obiettivo è, con Camus, di «diminuire aritmeticamente il dolore del mondo», ritengo sia meglio proporsi degli obiettivi seri ma non punitivi, in luogo di cercare pagliuzze negli occhi altrui.
Allo stesso modo non bisogna cadere in un altro equivoco tipico, per cui occuparsi del dolore animale rischia di soppiantare la lotta alla diseguaglianza fra esseri umani. Certo, vegetarianesimo e veganesimo possono essere praticati in forme liberali, individualistiche o modaiole, senza trarne la dovuta radicalità. Una persona può mangiare solo verdura senza valutarne in alcun modo la provenienza (lo sfruttamento dei braccianti agricoli, le tante storture della filiera), il sostrato economico (la grande distribuzione) o la sostenibilità ambientale (cibi estremamente processati, con molto packaging). Leonardo Caffo si domanda con serietà in Vegan: «non è forse più vegano un pesce pescato in un lago vicino a un villaggio nei pressi di Bagan che un hamburger di tofu mangiato nei dintorni di Koh Samui e arrivato lì con alle spalle chissà quale tour di sfruttamento umano, animale e ambientale?» (Caffo 2018).
La difficoltà qui sta nel contentarsi di aderire a un’unica forma di impegno, concentrando tutte le proprie energie in quella battaglia e dimenticando il resto — a volte anzi criticando aspramente chi combatte altre diseguaglianze, perché ritenute meno importanti. L’antispecismo dovrebbe invece essere uno spunto ad allargare la lotta per maggiore libertà ed equità in qualsiasi cerchia sociale e valorizzare il sostegno a chi è più debole, proprio perché gli animali sono i più deboli fra i deboli. E quindi, ad esempio, impegnarsi materialmente per una società in cui nessuno debba uccidere sottopagato dei polli: si comprende in fretta «l’intima connessione tra sfruttamento umano e sfruttamento animale» su cui si fonda il capitalismo; e non stupisce che Ford abbia preso spunto dai metodi dei mattatoi di Chicago per creare
la sua catena di montaggio a Detroit (Filippi — Trasatti 2022).
Insomma: quando si parla di liberazione animale a volte ci si dimentica che siamo animali anche noi; e che liberando possiamo liberarci a nostra volta producendo effetti politici diretti, ad esempio, verso una migliore distribuzione delle risorse o una risposta concreta alla fame globale. In questo il pensiero libertario è particolarmente prezioso, perché riconosce con energia la varietà dei modi in cui il potere viene articolato, e tenta di combatterli tutti con le forme più opportune.
Durante la prigionia, Rosa Luxemburg assistete alla tortura di un bufalo e se ne commosse al punto da scrivere una lettera famosa, Un po’ di compassione (Luxemburg 2007). Una vicenda simile — lo sputo di un carrettiere sul muso del suo cavallo sfinito — colpì la piccola Anna Maria Ortese, che ricordò la vicenda molti anni dopo in un magnifico saggio dal titolo Bambini della creazione: «Enumerare tutti i peccati dell’uomo contro il Cavallo, l’Aquila, il Passero, lo stesso Serpente, e tutti i figli del cielo e della terra, della notte, dell’alba e l’aurora (Essi apparvero e furono subito adoperati e uccisi, e poi ingiuriati) non si può, non ha tanti numeri il cielo, che pure è infinita scaturigine di numeri, né tanti grani di sabbia il mare, dall’inizio di tutti i mari, da consentire un calcolo anche approssimativo, una somma anche incerta degli strazi subiti dai Popoli muti per mano dell’Uomo. No; un conto siffatto è oltre la misura di tutti i confronti pensabili; e la porta di questo inaudito Campo dei Martiri, che è il passato e il presente dei Popoli muti, giorno e notte, con le sue bifore dorate, sotto il pugno del Potere umano si attorce e arde. Per essi, questi Popoli muti, il cielo è pieno di sangue, e la terra — che a noi può essere delizia — fucina di lamenti» (Ortese 1987).
Tale esercizio di potere è reso possibile proprio dal preteso «mutismo» degli animali: la loro protesta non può articolarsi in parole. Molte persone sono disinformate sul massacro quotidiano che le nostre società perpetrano e difendono; molte persone scelgono di non informarsi affatto; e altre ancora sanno ma decidono di non agire. Perché? Credo a causa di un pregiudizio antropocentrico che accompagna quasi ogni ideologia, religione o espressione culturale: in un quadro del genere, il dolore animale è secondario quando non irrilevante. Di fronte a tale negazione è difficile contro-argomentare; forse si può soltanto ricorrere all’ostensione dell’esempio. Gli animali non parlano ma sanno esprimersi in molti modi, e di certo sono in grado di comunicare il terrore o il male subito: oggi abbiamo molti documenti sull’opera di devastazione che l’umanità ha perpetrato nei confronti degli animali, con un progressivo incremento di violenza e penetrazione che lascia allibiti.
Si può ritenere che in un impegno politico ad ampio raggio la priorità assoluta vada al dolore umano, fino a ignorare le altre forme di sofferenza: finché anche solo una persona sarà in catene, non vale la pena mettersi al lavoro per un maiale. Ma l’argomento è zoppicante: a meno di non cadere in forme caricaturali di impegno animalista,
le due lotte non sono affatto in contraddizione. Nessuno ci obbliga a scegliere tra un maiale e un essere umano; possiamo aiutare entrambi, in modi diversi e congruenti (e per quanto mi riguarda, da quando ho smesso di mangiare animali mi sento più empatico e attento anche verso i miei compagni di specie).
Tale esercizio di potere è reso possibile proprio dal preteso «mutismo» degli animali : la loro protesta non può articolarsi in parole
4.
Dunque come dovrebbe comportarsi un attivista libertario di fronte alla fabbrica di sofferenza animale? Ci sono moltissimi modi di impegnarsi, e non vorrei mai limitare questa ricchezza ipotizzando prescrizioni di qualunque sorta; mi limiterò a suggerire qualche appunto che, spero, possa arricchire il dibattito. Penso innanzitutto che si dovrebbe evitare un’altra forma di moralismo, stavolta non inerte ma non meno deleterio. Foca-
lizzandosi unicamente sul singolo, ci si dimentica che l’atto di mangiare dipende da una varietà di fattori: tradizioni, famiglia, religioni, costumi. Prima di predicare ai convertiti è insomma utile ricordare che non si mangia da soli: anzi, porre il tema in questi termini ricorda paradossalmente l’antropologia del liberismo — l’individuo quale consumatore del tutto isolato, che può e deve cambiare idea in uno schiocco di dita. Così
non è: ogni mutamento è un processo che coinvolge altri membri della propria comunità, e in certi casi — se abbandoniamo uno sguardo urbanocentrico, dove le diete non onnivore sono meglio accette — può anche rivelarsi fonte di emarginazione: ad esempio, si potrebbe parlare a lungo del consumo di carne come attestazione di machismo.
Chiudersi in una bolla elitaria e disprezzare gli onnivori non porta da nessuna parte. Ricordo al proposito una breve conversazione con Paolo Finzi, che mi manca tanto: Paolo sosteneva l’importanza di non «imporre» il veganesimo se non con buone argomentazioni; fedele alla sua dimensione fortemente etica dell’anarchismo, si preoccupava che i mezzi — anche quando si trattava di parole scritte — non divenissero coercitivi e non inquinassero i fini.
Non solo. Anche se cambiamo dieta, siamo spesso abituati a considerare il cosmo animale in modo estremamente riduttivo, ridotto alle pochissime specie con cui interagiamo: piccioni, merli, gatti, cani, mosche, zanzare, magari qualche mucca o capra ogni tanto. Il resto è un mistero selvaggio, osservabile nei documentari, o una fetta di vita sulla quale cade il più totale disinteresse. Eppure non serve andare molto lontano; basterebbe recarsi un po’ più spesso nei boschi e fare esperienza diretta di quello che stiamo minacciando o distruggendo su scala mondiale. La sottile bellezza di una cincia mora, il manto di un coniglio selvatico, il tranquillo lavorio di un formicaio: ma anche un asino anziano che vive libero in un rifugio per animali. Ritrovare la natura nella sua cruda bellezza, senza infingimenti di sorta, è importante anche per ricostruire un rapporto reale con essa, per non sovrapporvi lo schermo avvilente della produzione — in cui le bestie sono soltanto materia prima — e poi ogni tanto il filtro consolatorio del romanticismo.
Il biologo Richard Prum ha insistito sulla necessità di apprezzare la ricchezza estetica della natura, cercando di forzare i nostri schemi di giudizio per comprendere quanto nel mondo animale il bello esista e sia apprezzato dagli animali stessi (Prum 2021). Non si tratta di emozionarsi retoricamente davanti al volo di una rondine, benché male non faccia: si tratta di riconoscere, rispettare e valorizzare la complessità delle altre forme di vita, il cui peggior predatore resta l’essere umano.
Ancora, è fondamentale rammentare che le decisioni individuali hanno un valore assai limitato, e non devono condurre al quietismo di chi si ritiene assolto: affinché la lotta contro lo sfruttamento animale, così come ogni altra lotta, abbia possibilità concrete di successo, deve coinvolgere il più ampio numero di persone. E qui chi crede in mezzi diversi dalla politica partitica dovrà sforzarsi di sostenere quei mezzi già esistenti, e di elaborarne altri, efficaci per le masse sul lungo periodo: un problema tutt’altro che secondario. Con una precisazione: chi obietta che allora «tanto vale mangiare carne», perché in ogni caso il cambiamento è fuori dalla nostra portata e il capitalismo soffoca chiunque, dimentica il potenziale sovversivo della scelta. Leonardo Caffo argomenta che il veganesimo «mostra oggi, con un gesto di anticipazione del futuro nel presente, come vorremmo che l’umanità si nutrisse, vestisse e comportasse una volta capito che il danno che causiamo agli animali e all’ambiente non è mai moralmente e giustificabile. Si mostra oggi, a scapito di molte comodità e attraverso forme di disobbedienza civile e pacifica, come sia possibile vivere in un mondo senza violenza e con un diverso rapporto con l’ambiente». (Caffo 2018).
Per finire, anche in ricordo di Paolo Finzi sono andato a rileggermi il Dossier vegan pubblicato su «A Rivista anarchica» nel maggio 2010, dove ho trovato un paio di osservazioni importanti. La prima è di Adriano Fragano, che insiste sull’importanza di non rimediare allo sfruttamento degli animali concedendo a essi, dall’alto in basso, alcuni presunti «diritti» (ad esempio, aggiungo, il diritto a una morte indolore o a una gabbia più grande). La scelta antispecista è fondata invece sul dovere morale: un’etica che sovverta definitivamente il rapporto umano-animale scalzandone l’antropocentrismo di fondo.
La seconda osservazione è di Filippi e Trasatti, e si ricollega al tema dell’utopia: «Quando si parla di una visione radicalmente differente ci si riferisce spesso sprezzantemente a un supposto utopismo interpretato come impotente aspirazione all’impossibile. Noi invece quando parliamo di utopia, parliamo di un immaginario utopico che si introduce nella realtà e cambia il nostro modo di vedere i limiti tra il possibile e l’impossibile. Il mondo del possibile si dilata» (AA. VV. 2010).
La domanda di Bentham da cui inizia gran parte dell’antispecismo — «Il problema degli animali non è, possono ragionare? né, possono parlare? ma, possono soffrire?» — è senz’altro fondamentale, ma copre soltanto la metà negativa della questione. Gli animali possono soffrire e il dolore e la morte che noi infliggiamo loro non ha giustificazioni: del resto gli animali possono anche giocare, comunicare, fare sesso, apprezzarsi o disprezzarsi, aggredirsi, aiutarsi, esprimere la loro multiforme varietà. Il punto di vista dei visoni non si lascia ridurre alla riduzione del male: chiede di più. Chiede appunto libertà, ovvero la chance di dirigere a piacimento il corso della propria vita.
Bibliografia
AA VV, Dossier vegan, «A Rivista Anarchica», n. 353, maggio 2010.
S. BEST, Liberazione totale. La Rivoluzione per il 21° secolo, Ortica Editrice, Aprilia, 2017.
L. CAFFO, Vegan. Un manifesto filosofico, Einaudi, Torino, 2018.
A. CAZZULLO, I ragazzi che volevano fare la rivoluzione, 1968-1978: storia di Lotta continua, Mondadori, Milano, 2015.
É. DE LA BOÉTIE, Discorso sulla servitù volontaria, La Vita Felice, Milano, 1998.
M. FILIPPI — F. TRASATTI, Crimini in tempo di pace, elèuthera, Milano, 2022.
J. HRIBAL, Paura del mondo animale, Ortica Editrice, Aprilia, 2021.
R. LUXEMBURG, Amare. Un po’ di compassione, Adelphi, Milano, 2007.
H. MANCE, Amare gli animali, Blackie Edizioni, Milano, 2022.
A. M. ORTESE, I bambini della creazione, in In sonno e in veglia, Adelphi, Milano, 1987.
R. PRUM, L’evoluzione della bellezza, Adelphi, Milano, 2020.
J. SAFRAN FOER, Se niente importa, Guanda, Milano, 2010.

Percorsi di guerra e violenze Le ipocrisie di un antimperialismo parziale
Andrea Papi
I dubbi assalgono mentre i fatti, con tutta la loro tremenda tragicità, inducono la mente ad ascoltare i suggerimenti del cuore.
Lo scatenarsi della guerra contro l’Ucraina da parte della Federazione Russa ha portato in evidenza un aspetto di cui poco si parla, che personalmente ritengo inquietante. Riassumendone il senso, si potrebbe dire che si tratta della palese partigianeria di una parte consistente della sinistra, intesa come complesso culturalmente identificabile, contro le visioni politiche e sociali del blocco occidentale, di cui pure storicamente e culturalmente è parte. Non mi riferisco tanto agli schieramenti istituzionali, che ormai ben poco hanno a che fare con i fondamenti teorici ed etici che a noi interessano, ma a un’area di opinione pubblica e di pensiero, ampia e variegata, convinta di far parte del patrimonio di scelte politiche e di idee tradizionalmente considerate di sinistra.
Nonostante l’evidenza degli avvenimenti infatti, dopo aver condannato l’aggressione militare da parte della Russia quasi in modo frettoloso e per dovere, il primo elemento subito emerso in modo preponderante è stata l’affermazione decisa e accusatoria che la responsabilità di un simile attacco bellico non è addebitabile solo al «nuovo zar». Anzi, è maturata in breve la convinzione che in un certo senso Putin sarebbe stato costretto a scatenare la guerra dalle continue e sistematiche invadenze territoriali della NATO, tendenti per calcolo ad accerchiarlo e indebolirlo.
Putin e Biden dunque narrati come corresponsabili di una guerra di annessione voluta dalla Russia per specifici interessi geopolitici suoi. Parte della sinistra, su questo piano ha affermato fin da subito che in realtà sia Biden il vero responsabile dell’attacco russo, in quanto avrebbe subdolamente messo all’angolo la Russia, per costringerla a difendersi da sistematiche minacce attraverso la politica nazista del governo ucraino, non a caso armato di tutto punto dagli americani. Guerra dunque per procura, voluta dall’imperialismo occidentale per il proprio esclusivo interesse.
Non c’è che dire, ci troviamo di fronte a un sorprendente stravolgimento della realtà, che rimanda irresistibilmente alle ingannevoli simbologie da «ministero della Verità» di orwelliana memoria. Ciò che m’è apparso subito sconcertante è che nella sostanza si tratta delle stesse ragioni addotte da Putin per giustificare la propria aggressione territoriale. Una parte consistente della sinistra si è dunque consapevolmente schierata, culturalmente e politicamente, con le motivazioni dell’aggressore, dichiaratamente antidemocratico e antioccidenta-
Una parte consistente della sinistra si è dunque consapevolmente schierata, culturalmente e politicamente, con le motivazioni dell’aggressore, dichiaratamente antidemocratico e antioccidentale?
le? Ciò di cui in realtà sono convinto è qualcosa di più sottile e complesso, che cioè non si tratti tanto di voler stare dalla parte «del nemico» (come direbbe qualcuno), ma di voler contrastare a ogni livello, sempre e comunque, le politiche ritenute tendenzialmente guerrafondaie dell’Occidente guidato dall’America, additata, non senza qualche ragione, come il nemico principale da contrastare.
Anche in questo caso qualche chiarimento s’impone. Per quanto riguarda l’accusa per cui la NATO svolgerebbe sistematicamente una politica di annessioni imperialistiche in Europa, affermo con grande convinzione che non sia necessario spendere molte parole sulla palese evidenza che questa guerra sia voluta soprattutto per ragioni di espansione imperialistica da parte della Federazione Russa a guida Putin. Non è velleitaria l’impressione che, se in Europa non ci fosse l’«argine» dei confini dei paesi aderenti NATO, la Russia putiniana avrebbe da tempo cercato di riprendersi quegli Stati che si erano sciolti dal giogo delle dipendenze dall’URSS in seguito alla dissoluzione dell’ex-impero sovietico.
A monte di una simile visione da «guerra fredda» diventa importante sottolineare come ridurre lo scontro tra potenze mondiali secondo il vecchio schema post-Jalta non permetta di comprendere a fondo i sommovimenti globali in atto. Riproporre infatti oggi la situazione dello scontro bipolare America contro Unione Sovietica, che lo si voglia o no, significa rituffarsi in un passato definitivamente estinto, di cui semmai stiamo vivendo alcuni strascichi. Bisogna prender atto che a pieno titolo siamo entrati in una dimensione geopolitica completamente nuova, in cui si sta ridefinendo un mondo totalmente altro. Siamo definitivamente entrati in una fase non stabilizzata bensì di passaggio, in cui l’equilibrio egemonico delle superpotenze non è più bipolare, ma perlomeno tripolare (USA/Russia/Cina), in tendenza senz’altro multipolare (l’India, per esempio, è senza dubbio in attesa di emergere in modo adeguato).
In questa nuova multipolarità imperialistica in fibrillazione i vecchi schemi bipolari sono saltati
In questa nuova multipolarità imperialistica in fibrillazione i vecchi schemi bipolari sono saltati. Le alleanze vi si ridefiniscono di volta in volta e non in modo permanente, senza riuscire a congelarsi in uno status definitivo, come per esempio appariva nella competizione USA/URSS. Il patto momentaneo Putin/Xi Gin Ping, per esempio, a tratti mostra crepe e titubanze probabilmente perché gli interessi dell’uno e dell’altro non sono completamente coincidenti. Uno dei motivi per cui al momento si trovano dalla stessa parte della barricata, non a caso, è la considerazione opportunistica che li accomuna secondo cui l’Occidente sarebbe un “malato terminale”, le cui democrazie non debbano essere considerate altro che qualcosa da eliminare, dal momento che dal loro punto di vista sono ingovernabili, imperfette e troppo problematiche.
Sono convinto che ogni imperialismo vada contrastato con forza oltre che rifiutato. Indipendentemente dalla forma egemonica che li possa contraddistinguere, o economica o politica o finanziaria o quant’altro, tutti gli imperialismi rappresentano sempre il punto massimo di esercizio del dominio con conseguente sottomissione di popoli e genti. Non ho perciò dubbi che vadano tutti contrastati e criticati aspramente, per quello che sono e per quello che fanno, senza cercar mai in alcun modo improbabili attenuanti di sorta.
È per questo che provo un profondo disagio, e anche un po’ di rabbia, quando constato che invece, per esempio, c’è una differente qualità di valutazione nei confronti dell’America e della Russia: condanna totale e indiscussa per l’America, condanna quasi solo d’obbligo per la Russia, accompagnata da comprensione e frequentemente giustificazioni. Secondo una narrazione molto in auge nell’area di sinistra, gli USA non hanno mai attenuanti di sorta, mentre per la Russia si riesce a trovare sempre diverse giustificazioni storico-politiche che riducono di molto le sue reali responsabilità, nel caso più recente l’aggressione bellica contro l’Ucraina.
Nel 1968 il tema pregnante era la contestazione alla guerra imperiale che gli USA stavano conducendo in Vietnam. Giustamente e fortunatamente da parte di tutti la condanna era unanime e totale. Contestazioni, manifestazioni imponenti, scontri con le forze dell’ordine, azioni di propaganda da parte di tutte le componenti della sinistra, compresi gli anarchici, erano frequenti e continue contro la politica imperialista americana. Allora a nessuno, né anarchico né comunista né di qualsiasi altra formazione di sinistra, è mai venuto in mente che gli americani potessero avere l’attenuante di tentare di arginare la pressione sovietica, che in quella zona del mondo stava allargando la propria area d’influenza.
Come anarchico e libertario esigo di criticare l’America come merita con grande fermezza, ma al tempo stesso lo esigo con la tessa determinazione per ogni altro impero
Fu subito lampante una differenza di valutazione quando, per esempio, l’URSS aggredì l’Afghanistan nel dicembre del 1979. Se non da parte di qualche sparuto gruppo libertario, non ci sono state né manifestazioni né vere prese di posizione contro quest’aggressione pur essa imperialista, evidentemente considerata «diversa» da quella americana. Lo stesso atteggiamento, amplificato al punto che a volte
sembra addirittura raggiungere punte di partigianeria putiniana, si ripropone ora con la guerra contro l’Ucraina. Evidentemente, il rifiuto dell’imperialismo per certuni non è contro le logiche imperiali, tutte, ma esclusivamente contro quelle capitalistiche occidentali. Il problema allora non è il contrasto anti/ imperialistico, ma avversare l’Occidente e le sue democrazie, le quali fra l’altro stanno vivendo ovunque una crisi profonda d’identità e di senso.
Come anarchico e libertario esigo criticare l’America come merita con grande fermezza, ma al tempo stesso lo esigo con la stessa determinazione per ogni altro impero. Si deve al pari contrastare il vecchio imperialismo russo come anch’esso merita, come pure quello emergente cinese, senza provare mai a giustificare nessuna delle loro nefandezze, magari adducendo che sono conseguenza della pressione americana. In proposito, sento fortissima l’esigenza di riuscire a liberarsi di questo antiamericanismo aprioristico, che eleva gli USA a unico colpevole di ogni malefatta. Per comprendere l’importanza ineliminabile di tali aspetti, bisogna entrare nell’ordine d’idee per cui, al di là delle molte incongruenze e contraddizioni, l’Occidente continua ad essere il referente simbolico dell’Illuminismo settecentesco, magnifica rivolta intellettuale e valoriale che, oltre a estirpare dai cuori dei popoli la soffocante imposizione aristocratica, fu in grado di far emergere i sogni e le pratiche sociali universali delle libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà estese a tutte e tutti. Ancor oggi l’Occidente rappresenta saldamente questo insieme di valori e di scelte politiche e sociali. Per tutto ciò non possiamo non riconoscerci in esso, soprattutto se il nostro orizzonte politico è convinto di volgersi a sinistra.
A livello genetico, in fondo, «destra» e «sinistra» hanno molto a che fare con l’illuminismo, ispiratore fondamentale della Rivoluzione francese. La destra e la sinistra politica ebbero infatti origine proprio in quel primo storico parlamento quando, il 17 giugno del 1789, i rappresentanti del popolo si auto-proclamarono e si auto-legittimarono Assemblea nazionale. A destra si piazzarono i nobili e i prelati assolutisti, blocco irriducibile degli aristocratici che auspicavano la restaurazione dell’antico regime. Al centro i liberali, conservatori o monarchici che, pur pendendo dalla parte della destra, volevano mediare in modo da adattare il nuovo avanzante alle esigenze del vecchio. A sinistra i patrioti, ancora sostenitori della monarchia ma timorosi della controrivoluzione, dalla parte del progresso contro la conservazione e la restaurazione. All’estrema sinistra il gruppo dei democratici, tra cui Robespierre, intransigenti sui due punti della sovranità nazionale e dell’eguaglianza civile, per la cui vittoria erano anche disposti all’uso della violenza rivoluzionaria.
Quella disposizione di seggi è diventata simbolo delle tendenze e delle tensioni politiche. Per esser tale la sinistra deve in qualche modo propendere per un tipo di società fondata fattivamente su uguaglianza e solidarietà. La destra invece, pur in forme aggiornate, ripropone la restaurazione dei valori tradizionali, comandi centralizzati in nome di dio patria famiglia, derivazione dei diritti di casta fondamento dei poteri dell’ancien régime.
Paradossalmente è ciò che, in maniera neanche tanto sfumata, si sta riproponendo con forza nelle dinamiche geopolitiche che questa guerra contro l’Ucraina mette in evidenza. Lo dichiarano espressamente ogni volta che si esprimono in proposito Putin, Xi Jin Ping e tutti i componenti di quel blocco anti-occidentale che sta prendendo forma, il quale si propone espressamente di sostituire l’egemonia imperiale americana con egemonie imperiali antidemocratiche, autocratiche e dittatoriali. Considerano l’Occidente un malato terminale, con le sue forme politiche democratiche che simbolicamente significano libertà di esprimersi e criticare al di fuori delle imposizioni autoritarie. Per loro si tratta di una degenerazione delle possibilità di dirigere i popoli, per cui ripropongono in varie maniere la restaurazione dei valori tradizionali, gerarchici, omofobi e patriarcali. Il loro orizzonte alternativo offre regimi politici fondati su strutture oligarchico-dittatoriali spietate e repressive, capaci di assicurare tipi di comandi centralizzati ben saldi.
Una visione a tutti gli effetti assimilabile nel senso e nei contenuti a un tentativo di riscossa dell’ancien régime, sconfitto a suo tempo dalle rivoluzioni americana e francese. Metaforicamente è in definitiva un aggiornamento della reimposizione del vecchio «tallone aristocratico» negatore del principio di libertà, fondato sull’imposizione dall’alto secondo l’ordine di dinastie «superiori» e sulla sottomissione delle classi sociali più deboli.
Di fronte a tali pulsioni reazionarie cosa dovrebbero fare anarchici e libertari, le cui origini e le cui tensioni utopiche hanno le radici nell’universo culturale e immaginativo derivato dall’illuminismo? Non possono che schierarsi contro il «nuovo» blocco imperialista che sta cercando prepotentemente di sotterrarle. Ma non ci si può limitare a schierarsi dalla parte dell’Occidente che c’è. Questo effettivamente da tempo vive una crisi profonda di senso e di valori, tale che nel suo realizzarsi fattuale frequentemente rischia di rinnegare i propri fondamenti. Da tempo, per Le nostre critiche radicali e rivoluzionarie alle scelte dell’occidente sono indispensabili, ma non nel nome di un suo rinnegamento
esempio, i suoi «regimi politici» più che democrazie realizzate sono assimilabili a non-democrazie, vere democrazie mancate sottoforma di “votifici”, dove la partecipazione popolare è nulla e il voto esprime di fatto solo deleghe di potere senza nessun controllo dal basso.
Così dobbiamo usare con forza il diritto e l’esercizio della critica radicale al sistema di cose presente, a tratti anche spietata quando le contingenze lo richiedono. Le nostre critiche radicali e rivoluzionarie alle scelte dell’Occidente sono indispensabili, ma non nel nome di un suo rinnegamento. Anzi, dovrebbero assumere la caratteristica evidenza di sottolineare con grande forza le sue manchevolezze e le mancanze di realizzazione dei suoi principi e dei suoi presupposti, sottolineando che è stato volutamente stravolto sia ciò che prometteva, sia il senso genetico che lo definì.
Contemporaneamente anarchici e libertari dovrebbero essere di stimolo a rivivificare senso e valori originari che presero piede e forma con l’Illuminismo, riattualizzandoli con proposte e pratiche innovative e rivoluzionarie, spinti dal fine di renderli di nuovo una luce del cammino.

«Politics» e i suoi autori nelle pieghe della storia
Pietro Adamo
«La prima Nuova sinistra era composta da radicali degli anni 1930-1945 che non ruppero solo con lo stalinismo ma anche con il leninismo, e non solo con il leninismo ma anche con il trotskysmo, e non solo con il trotskysmo ma in buona parte con il marxismo stesso. Negli Stati Uniti molti di quelli che dovrebbero essere considerati membri della prima Nuova sinistra erano associati con la rivista politics (Lynd 1997: 67).
Così scriveva nel 1981 Staughton Lynd, l’inossidabile veterano della sinistra americana che ha tentato di costruire una genealogia del radicalismo che da un lato giustificasse la resistenza ai poteri forti dell’Amerika autoritaria, multicorporata e imperialista e dall’altro costituisse veicolo identitario di una cultura egualitaria, libertaria e antistatalista. In questi percorsi l’esperienza di «politics», la rivista diretta da Dwight Macdonald tra 1944 e 1949, si presenta come una specie di laboratorio in cui le correnti più audaci dell’esperienza statunitense si incontrano, si discutono e si criticano in nuove combinazioni, alla ricerca di una praticabile american way al radicalismo. Dalla rivista emerge infine un modello per un approccio al politico che, passando per i termini dell’impolitica e dell’antistatalismo libertario, valorizza un approccio in primo luogo etico ai problemi e ai temi della società di massa, proponendo la costruzione di comunità informali situate in sfere extrastatuali, ovvero controsocietà o controcomunità che si chiamino fuori dal funzionamento usuale della politica istituzionale (per rappresentanza, parlamenti, consigli comunali, e via dicendo) e si autofondino sul primato della morale e dell’individuo, proponendosi nella sfera pubblica come esercizio critico, astensione, obiezione di coscienza, boicottaggio, eccetera. «Politics» si ritrova insomma, insieme alle altre riviste anarchiche newyorchesi del periodo («Retort» e «Resistance»), al centro di quel processo di ripensamento globale dell’anarchismo che spesso definiamo «momento post-classico», in cui le principali categorie politiche del «classico» – rivoluzione, classe, politica, storia, progresso – sono riconcettualizzate in termini nuovi. In questo senso, la rivista costituisce davvero, assieme alle «colleghe» sopra citate, una sorta di ponte storico tra la disobbedienza civile di Thoreau, il secessionismo sociale della «Liberty» di Benjamin Tucker, il pacifismo anarchico di «Mother Earth» e l’anarchismo «senza aggettivi» di Voltairine de Cleyre dal lato ottocentesco e l’esplosione anarchica degli anni Sessanta,
con gli hippies e la controcultura, la teoria delle «strutture parallele» proposte dalla Nuova sinistra, le lezioni di Goodman, Bookchin, Ward e via dicendo, sino ad arrivare alle strategie di resistenza messe in atto dal subunderground e dai post-punks dei decenni successivi e alla stessa Occupy Wall Street (Adamo 2016).
«Politics» si ritrova al centro di quel processo di ripensamento globale dell’anarchismo che spesso definiamo «momento post-classico»
La direzione che prende «politics» è quindi quella di un «forte pacifismo e anarchismo», ha scritto, molti anni prima di Lynd, la più nota delle collaboratrici «silenti» della rivista, Hannah Arendt, notando per così dire in diretta (cioè nel fatidico 1968) che «l’umore di alcuni scrittori isolati di sinistra di vent’anni fa è oggi divenuto l’umore dominante di un’intera generazione fermamente convinta, con parola e azione, che “tutti i problemi genuini siano di natura morale”» (Arendt 1968: 33). Anche per Arendt, che non aveva mai firmato alcunché nella rivista di Macdonald ma che sin dal 1945 aveva partecipato alle riunioni redazionali, controllando al caso bozze e traduzioni, «politics» è un modello di radicalismo intellettuale e pratico che affonda le radici da un lato nell’esperienza americana e dall’altro nei dissidi e nelle lacerazioni della sinistra tra anni Venti e Trenta.
«politics», dunque, […] era radicale nel senso che guardava indietro e dava nuova vita a molto che appartiene proprio alle radici della tradizione americana quanto a molto che appartiene alle radici della tradizione radicale ovunque: la tradizione del dire-no e dell’indipendenza, dell’allegro «negativismo» che si confronta con la tentazione della Real-politik, e della fiducia in sé stessi: ovvero la fiducia e l’orgoglio che si provano quando ci affida al proprio giudizio (Arendt 1968: 33).
La descrizione ci porta all’interno del colorato mondo culturale di «politics», dove si incontrano esperienze e tradizioni abbastanza differenti, sebbene unite da una comune avversione per il comunismo reale. La rivista è sì, lo nota anche Arendt, una one man magazine (Arendt 1968: 32) ma può contare su un’ampia e variegata cerchia di collaboratori: «I principali», racconterà qualche anno dopo la chiusura della rivista Macdonald disponendoli in ordine alfabetico, sono «Andrea Caffi (“European”), Nicola Chiaromonte, Lewis Coser (“Louis Clair”), Paul Goodman, Josep Gutman (“Peter Meyer”), Victor Serge, Nicola Tucci e George Woodcock» (Macdonald 1957: 26). Tra questi, solo Goodman è americano. La loro posizione politica rende molto chiaro l’orientamento generale di Macdonald: due anarchici militanti (Goodman e Woodcock), un pacifista di tendenza anarchica (Tucci), due socialisti libertari antimarxisti (Caffi e Chiaromonte, quest’ultimo sempre più orientato verso soluzioni post-classiche), un socialista libertario militante in un partito marxista antibolscevico (Coser), un socialista libertario passato attraverso tutte le tempeste novecentesche (Serge), un marxista parecchio eterodosso (Gutman). Nella sua celebrazione di «politics» del 1968, Arendt afferma che «tutti i collaboratori erano ex marxisti»: il giudizio è palesemente errato (tra gli otto di Macdonald ben cinque, ovvero Goodman, Woodcock, Tucci, Caffi e Chiaromonte, non hanno avuto alcun genere di trascorsi marxisti), ma riflette forse il clima creatosi intorno alla rivista, in costante polemica con la potente fazione filocomunista dell’intellighenzia newyorchese, nonché la stessa storia personale di Macdonald, passato da quasi tutte le varie correnti trotskyste e licenziatosi da «Partisan Review», la rivista culturale più in della sinistra, per le troppo decise posizioni belliciste dei suoi direttori. In un clima arroventato dalle discussioni sullo stalinismo, sul collettivismo burocratico, sulla posizione di Trotsky, Macdonald riscopre così un altro «classico» della tradizione libertaria americana, l’anarco-pacifista Randolph Bourne.
Inizialmente «politics» si pone tra il radicalismo bourniano e l’interpretazione del totalitarismo fornito dal trotskysmo americano, secondo cui l’Unione sovietica è in preda a una forte involuzione burocratica. L’incontro con l’italiano Nicola Chiaromonte, decisivo per Macdonald e per il suo sviluppo culturale e intellettuale, lancia la rivista in una nuova orbita, che è in sostanza quella della fazione culturalista dell’organizzazione antifascista italiana Giustizia e Libertà. La cosa è meno paradossale di quanto possa sembrare: nel suo libro su «politics», Gregory Sumner ha ritrovato nei papers del direttore una nota manoscritta in cui si dichiara che la rivista è stata «una coproduzione italo-americana» (Sumner 1996: 27). Delmore Schwartz, uno dei poeti che gira intorno alla rivista, registra nei suoi diari che in una colazione del luglio 1944 con le famiglie Chiaromonte e Macdonald si ha un argument bet tra i due «sul socialismo e sullo stalinismo di Marx», a dimostrare quanto fosse intensa la
relazione teorico-politica tra i due (Pollet 1986: 229). Chiaromonte assume quindi un ruolo di guida intellettuale, che gli viene ampiamente riconosciuto: «Era da lui», scrive Mary McCarthy nel suo romanzo The Oasis riferendosi alla comunità dei libertari newyorchesi, «che essi avevano appreso quelle nozioni di
giustizia, libertà e socialità che ora si sforzavano di mettere in pratica» (Mccarthy 2002: 14-15). Chiaromonte convince l’amico Andrea Caffi, antico sodale in GL, a collaborare a «politics» dall’Europa. Gli scritti dei due italiani esercitano un’enorme influenza nel milieu newyorchese, dove di fatto trasbordano l’interpretazione della modernità già proposta a Parigi nei primi anni Trenta, con una lettura del totalitarismo che lo situa entro le linee di continuità date dalle tecniche di gestione del potere messe in atto dalla Stato-nazione centralizzato, all’interno di una disciplina militaresca e meccanizzata che rafforza l’identificazione ideologica tra politica e forza e disarticola le masse in individui anomici dominati dall’effimero. Da qui la condanna dell’esperimento totalitario sovietico ma anche un più generale impeachment dell’immaginario di sinistra fondato sul connubio Storia-progresso e sulla sacralizzazione della vocazione rivoluzionaria del proletariato. Di contro, la rivalutazione della tradizione libertaria proudhoniana e autogestionaria, interpretata come alternativa sociale alla gerarchia verticistica creata dallo Stato moderno e come strumento per la creazione di una «contro-società» in cui la politica riacquisti il suo carattere isonomico e orizzontale. È una lettura che insiste sul fatto che la stessa tradizione rivoluzionaria della sinistra, nelle sue matrici giacobine e romantiche, ha offerto un contributo importante a quell’«alienazione» delle masse che è il fondamento più vero del fenomeno totalitario (Adamo 2002: 55-93). Nel numero del novembre del 1946 di «politics» Caffi, richiamandosi al proudhoniano Georges Gurvitch e alla sua distinzione tra le diverse forme dello «stare insieme», afferma che la «massa» «implica una forma di socialità che è al contempo primitiva e inumana, nella misura in cui la coscienza critica, la scelta e la pluralità delle relazioni sociali spontanee vi mancano del tutto». A questa massa, che non può avere «alcuna cultura», si contrappone un «popolo» in cui è riassunta l’«esistenza di una comunità permanente» e una «società» composta da uomini che scelgono e agiscono in autonomia e responsabilità (European 1946: 354).
È questo il paradigma che i due italiani propongono a «politics» e in particolare al suo direttore: sono loro tre, insomma, a dare la linea. Assistiamo quindi, nell’incontro tra italiani e americani e nel contesto del rovente ambiente della sinistra newyorchese, alla combinazione tra una critica al progetto rivoluzionario della sinistra marxiana sulla base dell’avvento della cultura di massa e il genuino radicalismo della tradizione democratica americana. Le considerazioni più chiare vengono dalla penna di Paul Goodman. Il capitalismo di stato e il socialismo di stato si affidano entrambi alla “sociolatria”: questa consiste nel sentimento prevalente «nelle
masse alienate dalle loro nature profonde dal corretto funzionamento della macchina industriale dalla quale pensano di poter ottenere un tenore di vita più alto». Anomia e alienazione non solo rendono impossibile la politica progressista ottocentesca fondata sulle masse, ma sono altresì il perfetto strumento della demagogia totalitaria. Il lento processo di accettazione della sociolatria da parte delle masse dimostra che «il programma marxiano non è solo fallimentare ma anche reazionario». In definitiva, «le pre-
tese economiche marxiane (sui salari e le condizioni lavorative) cementano la sociolatria», mentre «le pretese politiche marxiane (l’espropriazione degli espropriatori per mezzo della presa del potere) conducono al socialismo di Stato» (Goodman 1945: 378). Gli scrittori di «politics» sono quindi tra i primi a insistere sulla relazione tra totalitarismo e cultura di massa. Ma è nell’affrontare l’altra componente fondamentale dell’ideologia totalitaria, lo Stato moderno, che il loro richiamo alla tradizione libertaria si fa stringente. Dopo Hiroshima, le conclusioni di Macdonald si fanno lapidarie: «Dobbiamo “beccare” lo Stato nazionale prima che lui becchi noi». E gli individui responsabili farebbero bene a cominciare a pensare in termini di «sabotaggio, resistenza, ribellione e la fraternità di tutti gli uomini ovunque» (Macdonald 1945: 225). L’atmosfera in «politics» è quella di un’acerrima contrapposizione allo Stato. Nel precedente gennaio, in una recensione del solito Gurvitch, Chiaromonte registra alcune «timidezze» del francese. Non solo sulla proprietà (in questo momento persino il gurvitchiano socialismo di mercato, con la sua distinzione fra tre differenti gradi di proprietà, individuale, pubblica e sociale, sembra troppo moderato all’italiano), ma soprattutto sullo Stato: Gurvitch insiste sull’idea che «il pluralismo giuridico non indebolirà lo Stato», e tuttavia per Proudhon il «punto base» è che «lo Stato (ov-
Se non «vogliamo esser divorati dallo Stato nazionale», occorre «dissociare la nazione dal governo del territorio e quest’ultimo dall’organizzazione della vita economica»
vero il potere politico) deve essere completamente e concretamente subordinato alla società. E questa, come mostrano sin troppo chiaramente gli sviluppi contemporanei, è precisamente la regola a cui lo Stato moderno rifiuta costantemente e violentemente di sottomettersi» (Chiaromonte 1945:
27). Secondo Caffi, si tratta «veramente della questione principale». Se non «vogliamo esser divorati dallo Stato nazionale», occorre «dissociare la nazione dal governo del territorio e quest’ultimo dall’organizzazione della vita economica». Caffi contrappone così allo Stato moderno «una pluralità di associazioni prive di qualsivoglia potere coercitivo, eccetto che per l’inevitabile pressione di maggioranze enormi e di un potere puramente economico», con la garanzia del diritto di exit per tutti gli individui: «Un qualsiasi legame tra l’individuo e il gruppo deve essere costituito liberamente e facilmente rescisso». Pur conscio che «nei termini della situazione attuale tutto ciò è ovviamente Utopia», Caffi insiste sulla necessità di ridurre «lo Stato, una volta privato del sacramento nazionale, a un macchinario e null’altro» (Caffi 1945: 374-376).
Per gli scrittori di «politics» l’esigenza centrale sta quindi nel ricreare le condizioni per un’azione politica sensata nella società di massa. Nel paragrafo intitolato Wanted: A New Concept of Political Action del suo The Root Is Man, Macdonald spiega che il presupposto dei «progressisti di ogni sfumatura, dai trotskysti ai sostenitori del New Deal», è che «la consapevolezza (e la coscienza) sono meno “reali” dell’ambiente materiale» e che «l’individuo è meno reale della società» (Macdonald 1946: 207). L’impossibilità di praticare la tradizionale politica delle masse in una società di massa spinge gli scrittori di «politics» in una paradossale zona di confine. Da un lato sembrano scivolare nell’impolitico, ritraendosi dal mondo della politica, dal quale sembra ineliminabile l’elemento della forza, applicata e pensata (e qui si rivela decisiva l’influenza di Simone Weil, tradotta e studiata nella rivista); dall’altro elaborano una concezione molto morbida di antipolitica, intesa come azione sensata che fondi un sistema di relazioni basato sul totalmente altro rispetto al mondo moderno, caratterizzato dal criterio della forza. Chiaromonte polemizza così vivacemente con chi intende la politica in senso «moderno»: «Dove la legge dell’azione è suprema», dichiara, «dove non c’è altro tipo di razionalità, l’impresa umana è resa una specie d’artifizio organizzato, e l’uomo d’azione non diventa altro che una orribile bestia da soma» (Chiaromonte 1947: 92).
Per gli autori di «politics» l’azzeramento degli individui e della caffiana società da parte della «massa» è difficilmente superabile. «Cosa ci resta allora da fare»?, chiede Macdonald. Gli fa eco Caffi, ponendo nel gennaio del 1947 la fatidica domanda «Che cosa rimane» dopo la dissoluzione di quei legami sociali che rendono possibile relazioni politiche reali, ovvero egualitarie e orizzontali. È il quesito capitale, che si aggira come un (marxiano) spettro tra le pagine della rivista di Macdonald (Macdonald 1946: 207). Non a caso anche una celebre intervista televisiva di Hannah Arendt del 1964 si intitola Che cosa resta? Resta la lingua; anche se tema e argomento sono diversi (ma non del tutto diversi), il modus in cui viene posta la domanda rientra nel paradigma di «politics» (Arendt 2001: 35-59). Qualche anno dopo Chiaromonte si porrà la stessa identica domanda, in un tono ancora più pessimistico ma ancora nel contesto fornito dall’interpretazione della tarda modernità come lenta dipartita della politica: «Non c’è proprio nulla da fare, dunque?» (Chiaromonte 1967: 6). La risposta fornita in «politics» rimanda esplicitamente alla tradizione libertaria, come riconoscono quasi tutti i commentatori. Del resto nella rubrica Ancestors, che assieme a quella sulle New Roads suscita le maggiori proteste da parte della sinistra marxista, oltre a un autore un po’ atipico (Kurt Tucholsky, tra i maggiori scrittori satirici della repubblica di Weimar), e a due «metodologi» dell’interpretazione della modernità (Tocqueville e Weber), compaiono Herzen e i dichiaratamente anarchici Tolstoj, Godwin e Proudhon. Il tono è talmente prevalente che nella sua celebrazione del 1968 Arendt annette alla lista persino Bakunin… Gli autori di «politics» forniscono in sostanza la stessa risposta: alla crisi della politica tradizionale si rimedia al di fuori della sfera pubblica determinata dalla presenza della massa e dal mito della Storiaprogresso, costruendone un’altra, alternativa alla prima, fondata su un approccio individualista che rifiuta il primato della forza e della valutazione etica puramente strumentale e che si oppone nella sfera pubblica con il boicottaggio, il rifiuto di cooperare, la resistenza passiva. «In piccoli gruppi», scrive Goodman nella sezione più criticata del suo articolo sulle New Roads,
dobbiamo tracciare la linea e cominciare subito ad agire in modo soddisfacente per le nostre più profonde nature. […] I gruppi devono essere piccoli, perché il mutuo appoggio è la nostra comune natura umana principalmente rispetto a coloro con cui abbiamo a che fare faccia a faccia. […] La nostra azione non deve mirare a […] soluzioni istituzionali future, ma […] a ordinamenti fraterni oggi, che incorporino progressivamente nella nostra società libera sempre più funzioni sociali (Goodman 1945: 379).
Macdonald esprime lo stesso concetto in The Root Is Man, conferendogli sfumature forse più aperte:
Dobbiamo ridurre l’azione politica a un livello personale, modesto e non pretenzioso, a un livello che sia reale nel senso che soddisfi, qui e ora, i bisogni psicologici e i valori etici delle persone che vi prendono parte. Dobbiamo cominciare di nuovo dal basso, con piccoli gruppi di individui in vari paesi, raggruppati intorno a certi principi e sentimenti che hanno in comune. Probabilmente non dovrebbe trattarsi di comunità isolate come nel secolo scorso, dal momento che così facendo ci si chiude all’esperienza comune dei propri confratelli uomini […]. Lo scopo di questi gruppi sarebbe duplice. All’interno, il gruppo esisterebbe per permettere ai suoi membri di giungere a conoscersi pienamente quanto possibile come esseri umani […]. Verso il mondo esterno lo scopo del gruppo sarebbe di intraprendere certe azioni insieme […] per sostenere gli individui […] che espongono ideali comuni, e per predicare tali ideali […] con la parola e l’azione (Macdonald 1946: 209).
Anche secondo Caffi tale soluzione, per quanto utopica si presenti, è l’unica praticabile. Alla domanda «Che cosa rimane?», la risposta è: «Pochi individui dispersi, e piccoli gruppi isolati, capaci, al tempo stesso, di un pessimismo risoluto quanto all’avvenire immediato e di non disperare dell’“eterna buona causa” dell’uomo». I piccoli gruppi dovrebbero esser fondati sull’amicizia, su un comune sentire, senza «regole o ortodossie collettive». Non conterebbero «sull’azione collettiva, ma piuttosto sull’iniziativa individuale e sulla solidarietà che può esistere tra amici che si conoscono bene e dei quali nessuno persegue fini di potenza»: «Il loro scopo» dovrebbe essere quello «di trasformare i modi di pensare e i costumi piuttosto che le cose»; proprio per questo potrebbero produrre un cambiamento reale (European 1947: 27). Chiaromonte resterà fedele al programma, riprendendolo vent’anni dopo, quando, divaricando la propria interpretazione del fenomeno ‘68 da quella degli amici Goodman, Macdonald e Arendt (Adamo 2002: 88-91), ritornerà a proporre l’antica tattica secessionista dei tempi di «politics»:
Il rimedio, in verità, se c’è è altrove. E a molto lunga scadenza. Consiste nella secessione risoluta da una società […]. Da questa società – da questo stato di cose – bisogna separarsi, compiere atto pieno di eresia. E separarsi tranquillamente, senza urla né tumulti, anzi in silenzio e in segreto; non da soli, ma in gruppi, in «società» autentiche le quali si creino una vita il più possibile indipendente e sensata, senza alcuna idea di falansterio o di colonia utopistica, nella quale ognuno apprenda anzitutto a governare se stesso e a condursi giustamente verso gli altri […]. Importa essere eretici, oggi, separati dalla massa, chiusi in cerchie ben definiti e tenute insieme da idee e interessi comuni. Il rapporto di queste cerchie o gruppi con la società «in genere» e lo Stato dev’essere di distanza, di partecipazione minima, di scepsi e critica ma non di rivolta. Perché lo scopo di tali «frátrie» è di ricostituire società giuste, anzi di ricostruire dalle fondamenta una società, sic et simpliciter. Tali «frátrie» hanno quindi, per cominciare, il compito di stimolare la società a passare dalla politica intesa come realizzazione di un assoluto Bene alla morale come misura e limite dell’azione politica, nonché come distanza da mantenere continuamente fra l’idea di comportarsi con giustizia verso gli altri e l’azione politica come mezzo per la realizzazione di una giustizia obiettiva impossibile (Chiaromonte 1968: 8; Chiaromonte 1995: 238).
Dalle pagine di «politics» emerge quindi una figura di «radicale» caratterizzato, secondo l’ultimo capitolo di The Root Is Man, da negativismo (la capacità si sospendere la propria cooperazione con lo Stato), irrealismo (la facoltà di vedere oltre le alternative «reali» e di sottrarsi alla scelta tra di esse), moderazione (la consapevolezza dei propri limiti e il rifiuto di progettare soluzioni «finali»), piccolezza (il coraggio di affidarsi alle individualità e ai piccoli gruppi) e self-ishness (la coscienza che la radice sta nell’uomo, nell’irriducibilità della sua singolarità) (Macdonald 1946: 210). La proposta si inserisce nella tradizione tipicamente americana di un antistatalismo comunitario e separatista che si propone di ottenere autonomia e autogoverno sul territorio tagliando quanto possibile i lacci che legano comunità e governo, si tratti di quello centrale dei singoli stati piuttosto che di quello federale costituito tra 1787 e 1791. La tesi centrale di «politics» si situa però in un panorama nuovo, quello delineato dall’avvento della società di massa, dall’esperienza del totalitarismo e dalla crescita a dismisura dei poteri
dello Stato moderno. Il progetto autonomista e separatista del libertarismo statunitense perde necessariamente contatto con le masse: la consapevolezza della pervasività del politico (e della sua imprescindibile relazione costitutiva con la forza) e della riduzione dell’individuo a numero conduce alla sfiducia nell’azione sul territorio volta a educare le persone all’autogoverno, contando sulla loro propensione razionale ma anche storico-culturale, a libertà e giustizia. Da qui l’insistenza
L’insistenza sul lungo periodo, sui «piccoli gruppi» e le «fratrie», microcosmi che sono contemporaneamente il luogo in cui vivere e praticare la libertà e la base possibile di una società libera futura
sul lungo periodo, sui «piccoli gruppi» e le «fratrie», microcosmi che sono contemporaneamente il luogo in cui vivere e praticare la libertà e la base possibile di una società libera futura. Alla fin fine, come si evince soprattutto dal tono della nota su taccuino di Chiaromonte sopra citata, è uno stile di sopravvivenza ma anche una modalità di porsi rispetto all’esistente («scepsi e critica», scrive l’italiano). Che non rinuncia al sogno del cambiamento totale, ma che ne immagina le linee di sviluppo entro il quotidiano, entro un quadro esistenziale, come strategia di resistenza e proposta impolitica, nel tentativo di imporre una nuova cornice di giudizio morale.
Michel de Certeau ha reso quasi famosa l’idea di una serie di strategie di resistenza attuate nel quotidiano da dissidenti di ogni tipo in età moderna e contemporanea (De Certau 2010), che si risolve nel progetto di conquistare uno spazio autonomo per la propria comunità, un progetto che ritroviamo in molti autori successivi: penso a scrittori post-controculturali e post-anarchici come Hakim Bey o Bruce Sterling, o a post-femministe come Rosi Braidotti o Judith Butler, disposti a sacrificare la stabilità nel tempo dello spazio conquistato in nome di un’identità nomadica e cangiante. I primi abbozzi di tali idee da parte di de Certeau compaiono in La prise de parole, sorta di diario critico di alto profilo filosofico sul ‘68 francese, dove si elogia il giovanissimo (all’epoca) Daniel Cohn-Bendit, in particolare per la «sua concezione anarchica e finalmente “apolitica” della rivoluzione» (De Certau 1968: 142). Il passo ripreso da Cohn-Bendit a colloquio con Sartre ci riporta alla logica separatista di «politics», testimoniando quanto la logica dell’anarchismo post-classico – che rinuncia alla rivoluzione-insurrezione come frattura nella storia e sceglie una tattica di gradualismo esistenziale radicato nel quotidiano – sia quasi egemone nei pensatori libertari più originali della seconda metà del XX secolo: «L’importante non è elaborare una riforma della società capitalistica, è piuttosto di lanciare un’esperienza in rottura completa con quella società, un’esperienza che non dura ma che lascia intravedere una possibilità» (Savaugeout, Geismar, Cohn-Bendit: 1968: 95).
Tornando a «politics», Hannah Arendt apprezzò la radical mentality della rivista, ma notò anche che i tentativi dei suoi autori «di arrivare a una nuova teoria politica» non erano invecchiati «bene». Del resto, già nella marea di critiche che quasi sommerge i collaboratori della rivista nel corso del 1946, emergono i punti critici della posizione di «politics». David Bazelon, critico nei confronti delle New Roads da un punto di vista marxista abbastanza ortodosso, accusa il direttore e i suoi amici di «idealismo» e «utopismo», ovvero di concentrarsi sugli «assoluti morali» e di staccarsi dal «mondo materiale», ritrovandosi, di fatto, senza alcun vero progetto politico. L’autore esprime una posizione teoretica classicamente storicistica: «Se la storia non fosse più grande degli individui che la fanno, allora sarebbe interamente la loro storia e noi», intendendo i rivoluzionari, «non avremmo problemi»; fortunatamente, conclude, sarà «il metodo scientifico, e non gli imperativi morali, a condurci a una piena comprensione del processo storico» (Bazelon 1946: 187). Forse più penetranti le considerazioni del socialista Irving Howe, poi direttore di «Dissent», che da giovane scrive per «politics», ma commenta le posizioni della rivista quasi quarant’anni dopo, nella sua autobiografia, dove illustra quasi spiritosamente le sue molte «deviazioni», ma anche, nel contempo, l’affetto e l’ammirazione che prova per essa. Riconosce l’approccio «individualistico e decentralizzante, essenzialmente anarchico» di Macdonald e dei suoi, ma è nella rilevazione del mood prevalente nella rivista che ci conduce al cuore del dilemma. Discutendo The Root Is Man, giudica che
il saggio era per molti versi una accurata espressione della difficile situazione di quei pochi intellettuali – Macdonald, Nicola Chiaromonte, Paul Goodman – che intendevano dissociarsi dalla nuova affermazione della Realpolitik, ma non riuscivano a trovare modi di trasformare sentimenti di rettitudine o visioni di utopia in politica funzionante (Howe 1982: 116-117).
Come si è visto sin qui, le critiche girano tutte intorno al tema dell’abbandono della politica. O meglio, intorno alla peculiare concezione del politico che emerge dalle pagine della rivista. Mi sembra che sia questo il punto chiave, il concetto che gli oppositori di Macdonald non riescono a digerire, e per alcuni versi neppure a capire. Il fatto è che gli scrittori centrali di «politics», i tre citati da Howe più Woodcock e Caffi, e per alcuni aspetti Coser, Calhoun, Tucci e qualche altro (nonché, ovviamente, gli intellettuali anarchici post-classici che li seguono nella seconda metà del Novecento), si muovono in un’orbita concettuale in cui il richiamo alle masse o persino alle classi lavoratrici diventa irrilevante, se non pericoloso: «masse» e «classi» hanno perso identità e forma, sono assoggettate e controllate dallo Stato, dai mezzi di comunicazione, dall’industria culturale, rendendo impossibile il lavoro politico così come la sinistra lo intende tradizionalmente. In un certo senso Macdonald e i suoi costituiscono la prima generazione di intellighenzia occidentale post-politica o impolitica: se nel politico non si possono più ravvisare le basi per un’azione collettiva che abbia senso entro una prospettiva di mutamento radicale, non resta appunto che «separarsi dalla massa» e fare eresia, puntando sul lungo periodo, sulla cultura, sul mutare degli atteggiamenti. Macdonald, Chiaromonte e Goodman sono oltre le possibilità del politico: dal loro punto di vista, i percorsi della sinistra hanno già battuto tutte le strade possibili e si sono infine ritrovati a convergere entro la società di massa, dove tutte le strade si chiudono, diciamo così, per definizione. Non sono avversi all’azione diretta, alla lotta, all’impegno: purché sia chiaro che tutto ciò che conduce a miglioramenti e riforme, obiettivi degni in sé, nulla ha a che fare con quel mutamento radicale del mondo così come lo conosciamo riassunto sotto l’etichetta di «rivoluzione». In un certo senso dall’esperienza di «politics» emerge una delle più radicali critiche del riformismo formulate in Occidente: si può, anzi si deve giocare il gioco delle riforme, partecipare alle battaglie per il miglioramento (dei salari, delle condizioni di vita, dell’ambiente, e così via, seguen-
do i mutamenti del linguaggio delle rivendicazioni), ma senza mai accordare a tutto ciò il potenziale della rivoluzione, cioè del cambiamento profondo del mondo. È vero che la teorizzazione dell’azione del «piccolo gruppo» tra i principali scrittori della rivista assume spesso le cadenze di un programma preparatorio, di un progetto pilota relativo alla creazione di una nuova etica e una nuova comunità, che dovrebbe man mano espandersi nella società «esterna», per così dire. Pur all’interno di una prospettiva che valorizza in primo luogo l’esperienza esistenziale stessa della vita nel piccolo gruppo, tale aspetto da alcuni è sottolineato con maggiore enfasi, per esempio da Goodman e Macdonald, non a caso entusiasti della New Left e della controcultura. Tuttavia, l’esperimento della «frátria» viene pensato, e in sostanza vi resta conchiuso, entro una bolla di pessimismo. Una bolla sociale e culturale, a partire dalla quale si tenta una difficile costruzione all’infuori del politico.
Che cosa rimane? What is left?, Was Beibt?, per tornare alla celebre intervista del ‘64 di Arendt. Cosa resta dunque delle intuizioni e della progettualità di «politics»? I Sixties, con le loro ribellioni, i loro rifiuti e la loro entusiastica logica separatistica fondata sul piccolo gruppo, sono sembrati per un breve momento confermare la tenuta delle idee e della concezione del politico di Macdonald e soci, come ha sottolineato Arendt nell’introduzione spesso citata alla ristampa della rivista. Goodman, Macdonald e McCarthy hanno riposto nel Movement, soprattutto nelle sue istanze separatiste libertarie, ardenti speranze, come ha fatto anche con meno calore Arendt. In una fase particolare, piuttosto vivace dal punto di vista culturale, nella New Left si è addirittura discusso della possibilità di trasformare le «strutture parallele» che i giovani e gli attivisti per i diritti civili andavano edificando in controistituzioni destinate a durare nel tempo e a sostituire funzionalmente gli enti della società capitalistica (Adamo 2016: 178-84).
Nel 2022 l’impressione è che i possibili spazi di espansione delle frátrie si siano ulteriormente rimpiccioliti e che pensare una politica radicale si faccia sempre più problematico. Tra egemonia dell’informazione (di contro alla formazione), crescita delle nuove corporazioni finanziarie post-industriali (se non contro-industriali), specializzazione repressiva dello Stato post-moderno sofferente per la svalutazione del politico, i timori per la massificazione della società e degli individui formulati inizialmente tra anni Trenta e anni Quaranta sembrano aver trovato conferme anche più positivo (e quindi terrificante) di quanto avessero pensato i loro primi formulatori. Le previsioni di Goodman, Caffi, Chiaromonte, Macdonald e via dicendo sulla impraticabilità di una politica radicale entro la mass society – se non quella del riformismo liberaldemocratico, non disprezzabile ma in fondo convergente con le ragioni dello status quo – sembrano oggi concretarsi in un progressivo impoverimento del discorso politico, che confina in territori sempre più marginali ogni ipotesi di mutamento del mondo, ogni progetto di discussione critica dell’esistente in quanto esistente, ogni lettura che si propone di scuotere le fondamenta sui cui si erge la civiltà attuale. Se la società di massa pare aver assunto, nella sua cadenza digital-televisiva del momento, una patina di impenetrabilità ancora più densa che in passato, non resta dunque che una frátria consapevolmente esistenzialista, capace di autocrearsi come comunità fraterna fondata sul rifiuto della supremazia della forza e del politico, come motore di critica e decostruzione dell’esistente, come modello di un’alterità sociale possibile: tutto ciò, tuttavia, entro una chiara coscienza dei limiti che tali azioni e iniziative incontreranno. Troppo poco, si dirà. Sempre meglio che niente, si potrebbe rispondere.
Bibliografia
AA.VV., Politics e il nuovo socialismo, a cura di A. Castelli, Marietti, Genova, 2012. P. ADAMO, L’anarchismo gradualista di Paul Goodman, in P. GOODMAN, Individuo e comunità. Scritti politici, tr. it. a cura di P. Adamo, elèuthera, Milano, 2014, pp. 7-48.
P. ADAMO, “La prima cosa è dire no!”. Nicola Chiaromonte tra ragione, storia e utopia, «Quaderni dell’altra tradizione», n. 1, maggio 2002, pp. 55-93.
P. ADAMO, L’anarchismo americano nel Novecento. Da Emma Goldman ai Black Bloc, Franco Angeli, Milano, 2016.
H. ARENDT, «Che cosa resta? Resta la lingua». Una conversazione con Günter Gaus, tr. it. Archivio Arendt. 1. 1930-1948, a cura di S. Forti, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 35-59. H. ARENDT, He’s All Dwight. Dwight Macdonald’s “politics”, «New York Review of Books», XI, n. 2, 1 agosto 1968.
- D. BAZELON, New Roads and Old Footpaths, «politics», July 1946.
- M. BRESCIANI, La rivoluzione perduta. Andrea Caffi nell’Europa del Novecento, il Mulino, Bologna, 2009.
- N. CHIAROMONTE, Social Law, after Proudhon, «politics», January, 1945.
- N. CHIAROMONTE, Remarks on Justice, «politics», May-June 1947.
- N. CHIARAMONTE, Noi e i Greci, «Tempo presente», maggio 1967.
- N. CHIAROMONTE, La rivolta degli studenti, «Tempo presente», marzo-aprile 1968.
- N. CHIAROMONTE, Che cosa rimane. Taccuini 1955-1971, a cura di M. Chiaromonte, il Mulino, Bologna, 1995.
- M. DE CERTAU, La prise de parole. Pour une nouvelle culture, Desclée De Brouwer, Bruges, 1968.
- M. DE CERTAU, L*‘invenzione del quotidiano*, Edizioni lavoro, Roma, 2010.
- EUROPEAN (A. CAFFI), Toward a Socialist Program, «politics», December 1945.
- EUROPEAN (A. CAFFI), Violence and Sociability, «politics», January 1947.
- EUROPEAN (A. CAFFI), Notes on Mass Culture, «politics», November 1946. Trad. it.: A. CAFFI, Popolo, massa e cultura, Id., Critica della violenza, Bompiani, Milano, 1966.
- P. GOODMAN, Revolution, Sociolatry, and War, «politics», December 1945.
- I. HOWE, A Margin of Hope. An Intellectual Autobiography, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego-New York-London, 1982.
- S. LYND, The First New Left … and the Third, Id., Living inside Our Hope. A Steadfast Radi-cal’s Thoughs on Revuilding the Movement, ILR Press, Ithaca-London, 1997.
- D. MACDONALD, The Root Is Man, «politics», April-July 1946.
- D. MACDONALD, articolo di fondo senza titolo, «politics», August 1945.
- D. MACDONALD, Introduction: Politics Past, Id., Memoirs of a Revolutionist, Farrar, Straus and Cudahy, New York, 1957.
- M. MCCARTHY, L’oasi, tr. it. a cura di M.R. De Bueriis, Liberal Libri, Firenze, 2002.
- C. PANIZZA, Nicola Chiaromonte. Una biografia, Donzelli, Roma, 2017.
- E. POLLET (cur.), Portrait of Delmore. Journal and Notes of Delmore Schwartz 1939-1959, Farrar-Strauss-Giroux, New York, 1986.
- Daniel Cohn-Bendit s’entretient avec Jean-Paul Sartre, in J. SAVAUGEOT, A GEISMAR, D. COHN-BENDIT, La révolte etudiante, Éditions du Seuil, Paris, 1968.
- G. SUMNER, Dwight Macdonald and the politics Circle. The Challenge of Cosmopolitan Democracy, Cornell University Press, Ithaca, 1996.
- M. WRESZIN, A Rebel in Defence of Tradition. The Life and Politics of Dwight Macdonald, BasicBooks, New York, 1994.


Conversazione con Loriano Macchiavelli
A cura di Marco Antonioli e A. Soto
Loriano Macchiavelli (Vergato, 12 marzo 1934) è uno scrittore, drammaturgo e sceneggiatore italiano, autore di pièces teatrali, racconti e romanzi polizieschi. Dal suo primo romanzo Le piste dell’attentato (1974) a oggi, ha pubblicato oltre quaranta titoli, tradotti anche all’estero. Molti suoi racconti hanno al centro le indagini di una fra le coppie investigative più originale del giallo italiano, ovvero quella composta da Sarti Antonio, un poliziotto credibile, onesto e tenace, ma non particolarmente dotato nell’arte delle indagini, e Rosas, extraparlamentare di sinistra, eterno studente universitario, una mente analitica degna dei polizieschi classici. Nel 1997 ha iniziato una collaborazione letteraria con Francesco Guccini, col quale ha scritto una decina di libri. I suoi romanzi più recenti sono Noi che gridammo al vento (Einaudi, 2016), Uno sterminio di stelle (Mondadori, 2017), Tempo da elfi (Giunti, 2017) con Francesco Guccini, Delitti senza castigo (Einaudi, 2019) e La stagione del pipistrello (Mondadori, 2022). Per saperne di più leggete questa intervista e consultate il suo sito www.loriano-macchiavelli.it.
Abbiamo pensato a una conversazione con te in quanto voce acuta e critica della storia dell’Italia repubblicana.
Va bene, non caricatemi di troppe responsabilità e di troppi oneri, non so quanti possa assumermene, uno o due forse…
Partiamo con le domande e partiamo dalla fine: La stagione del pipistrello*, ultimo romanzo della saga di Sarti Antonio, che hai pubblicato all’inizio del 2022.*
Iniziamo da questo: La stagione del pipistrello è un romanzo al quale tengo moltissimo perché rappresenta una sorta di discrimine fra il genere noir come lo vedo io, come è stato scritto fino ad oggi e come immagino dovrà cambiare. Facciamo un’altra precisazione indispensabile: il noir è un genere letterario abbastanza anomalo, nel senso che non ha delle definizioni precise. Il giallo ha un canone, un mistero irrisolto, indagini per scoprire e punizione del colpevole. Fine. Quattro, cinque schemi che si ripetono. Il noir è libero, è molto più aperto e vario, tanto che ogni scrittore, ogni autore, lo interpreta a modo suo, per fortuna! Tant’è vero che io ho smesso di leggere romanzi gialli quando avevo 18 anni, proprio perché mi sembrava di leggere sempre lo stesso romanzo. Il noir ha questa grande caratteristica, che per quanto mi riguarda è molto importante, ed è che si adegua alle esigenze dello scrittore. Le cose che vi dico riguardano la mia visione del romanzo noir, che è condivisa da alcuni e non è condivisa da altri. Tutto questo fa sì che il romanzo noir da una trentina d’anni, diciamo dagli anni Novanta, abbia questa grande fortuna. Possiamo dire che il tutto ha avuto inizio in quegli anni a Bologna in corrispondenza alla nascita del Gruppo 13, un gruppo di giovani scrittori (io ero il vecchio della compagnia) che avevano interesse per il noir. Ci siamo trovati e abbiamo discusso, avevamo le stesse intenzioni polemiche e siamo andati avanti per alcuni anni e credo, anzi ne sono certo, che la fortuna di cui gode ancora oggi in libreria il romanzo noir sia nata anche grazie al Gruppo 13, che ha fatto tante cose che adesso non vi sto a raccontare e che forse non interessano nessuno, ma che sono comunque state importanti per la conoscenza di questo genere nelle scuole, nei quartieri dove andavamo a parlare. I componenti del Gruppo 13 non me li ricordo tutti, eccetto i più importanti che poi hanno avuto un peso nella letteratura di genere. Sono, oltre al sottoscritto – e il mio piccolo peso me lo prendo – Carlo Lucarelli, Marcello Fois, Sandro Toni, Pino Cacucci, Danila Comastri Montanari, Gianni Materazzo e altri. Ecco, questo gruppo ha dato un notevole impulso alla diffusione del romanzo di genere, del romanzo popolare. Io ci tengo a questa definizione mentre altri si vergognano di questa etichetta, perché sono molto più nobili e hanno sangue blu nelle vene. Io ho il sangue che mi ha passato mio padre, che è abbastanza rosso. E quindi a questa definizione di popolare io tengo molto, perché la letteratura se non è popolare che cos’è? Cioè, lo è sempre stata. Pensate ai grandi poemi del passato, l’Iliade e l’Odissea. Cosa sono se non epopee popolari nelle quali si raccontano le gesta di questi mitici eroi? Per cui considero il noir come letteratura popolare e pertanto come tale desidero che venga apprezzata, se no è inutile scrivere.
Tutto questo preambolo per dire che quel romanzo dal quale siamo partiti, La stagione del pipistrello, è qualcosa di diverso rispetto al romanzo noir classico, che non ha più la sua forza disturbante. Perché cos’è che disturba il potere oggi? Niente, viene da rispondere; però quando questo genere è nato negli Stati Uniti, negli anni Trenta, dava fastidio. Citiamo alcuni autori perché se no di che cosa parliamo? Citiamo Chandler [Raymond Chandler], citiamo Hammett [Dashiel Hammett], due capostipiti del romanzo noir che non hanno avuto la fortuna che avrebbero dovuto avere due scrittori di quella statura. Hammett è morto disperato in un ospizio per poveri, è morto in miseria dopo essere stato in carcere per le sue idee, era iscritto al Partito comunista degli Stati Uniti, è stato sepolto in una cittadina sconosciuta. Poi qualcuno si è accorto che era invece un gigante della letteratura popolare. L’hanno tirato fuori dal cimitero e l’hanno sepolto ad Arlington, il cimitero degli eroi americani. Secondo me lui è lì che si gira, nella tomba. Perché questo? Perché le tesi che contrabbandavano attraverso una letteratura di genere popolare tendevano a far aprire gli occhi al lettore. In questa linea noi abbiamo continuato a produrre in Italia. Scerbanenco [Giorgio Scerbanenco] ci ha mostrato una Milano completamente nera. La Milano di Scerbanenco non era mai stata scritta prima. E sempre in Italia, Ezio D’Errico, un uomo straordinario, uno scrittore di moltissimi radiodrammi che ha avuto un processo al mese per quello che scriveva, anche come giornalista. Era anche lui contrario alla società del dopoguerra e intanto veniva ancora giudicato secondo il codice Rocco e per questo ha subito un sacco di vessazioni. E un altro grande personaggio della letteratura dimenticato, ovviamente – ma questo è il destino di chi è, di chi fa l’innovatore – è De Angelis [Augusto De Angelis], morto per le percosse subite da una squadraccia fascista. Siamo negli anni Trenta, sotto il fascismo De Angelis raccontava un’Italia che il fascismo non voleva fosse raccontata, ma era quella che lui vedeva per le strade. Su questa linea il romanzo noir ha sempre funzionato fino ai nostri giorni, quando è diventato una letteratura di consolazione. Ripeto, non si fa la rivoluzione con un romanzo, però si raccontano cose che possono dare fastidio. E quando ho cominciato io a scrivere, nel 1974, ho sopportato e subìto la contestazione di moltissimi cittadini e di autorità bolognesi perché ho gettato fango sull’isola felice. Bologna era l’isola felice, e tu cosa vieni a dirci, che invece è un incubo? Nel romanzo c’è dentro politica, c’è dentro collusione con i servizi deviati. Cosa ci racconti? Non è vero!
Bologna non era un’isola felice, l’abbiamo visto qualche anno dopo, negli anni Ottanta è scoppiato tutto, ma bastava aprire la pentola là, durante quel periodo, nei Settanta, per accorgersi che le cose non erano più queste. Ripeto, non ho fatto la rivoluzione. Però ho fatto conoscere una città, Bologna, in tutta Italia, che non era quella contrabbandata dalla politica. Ma è questo che il romanzo dovrebbe fare, far vedere al lettore qualcosa che nessun altro dimostra. Secondo il mio parere questo non avviene più.
Torniamo a La stagione del pipistrello. Questo libro è la riprova di quanto sia indisponente essere indisponenti. Infatti, nonostante abbia lo stesso protagonista di altri cento libri questo non sta avendo lo stesso riscontro di lettori come quelli del passato. Guardate che ho scritto prima di tutto sto casino tra Russia e Ucraina e le orde naziste nel mio romanzo venivano dall’Est. È questo che dobbiamo fare. Dobbiamo guardare dove non guardano gli altri.
In una sua analisi sul romanzo poliziesco Brecht dice che le cose non accadono mai per caso. Se guardiamo a quello che sta succedendo ci accorgiamo di quello che dice Brecht. Gli indizi vanno cercati prima che avvenga il delitto, perché così lo blocchi, accade sempre qualcosa prima che il delitto avvenga. Delitto di qualunque genere. Più delitto di una guerra? Quegli indizi c’erano là e ci sono anche da noi. Ad esempio l’indizio del centesimo anniversario della marcia su Roma a Predappio. Beh, tu in una repubblica democratica che si dice antifascista permetti tutto questo? Questi sono i sintomi che noi dovremmo analizzare. E se io ho scritto questo romanzo è proprio perché questi sintomi ci sono.
Ma tu sei andato oltre, ci dici quello che potrebbe arrivare…
E difatti il finale è proprio questo, dice questo Rosas. Allora? Come credo abbiate capito, non invento nulla, analizzo come dovrebbero fare le persone che fanno cultura, bassa o alta che sia, ammesso che anche ci sia una cultura bassa e una cultura alta. Ma qui andiamo troppo in là.
Un po’ ci hai anticipati e infatti volevamo chiederti perché i tuoi romanzi sono ambientati proprio a Bologna.
Ci tengo molto a questo. Per me Bologna non rappresenta Bologna. Bologna in tutti i miei romanzi ha sempre rappresentato il prototipo politico e sociale dell’Italia. Era un’isola felice quando ha fatto per prima le scuole, gli asili, gli ospedali, il tram, i trasporti e le case popolari. Questa era la Bologna che era e lo dico all’inizio del romanzo. C’è un pezzo dove dico che Bologna non è una città, ma tante città e le elenco. Bologna è il luogo mio, è dove io ho trovato rifugio, dove io sono stato protetto per anni. Ovviamente non poteva restare un’isola in mezzo a un casino come quello che c’era e pertanto è normale che sia degenerato. Non è normale che i politici non se ne siano accorti prima. Probabilmente hanno voluto che accadesse, che avvenisse questo, e vedete come le cose brutte si inseriscono negli spazi giusti. Ecco, Bologna è il simbolo di questo nostro Paese e lo rappresenta un po’, un luogo dove avvengono cose belle e cose brutte. Un tempo, per fortuna, erano quasi solo cose belle. Adesso non lo sono più, non lo sono più.
Un’ultima domanda su tutta l’epopea di Sarti Antonio: la figura di Rosas che figura è? A volte sembra un po’ il suo alter ego, la sua coscienza…
Anche qui non ho inventato niente. C’era bisogno di un personaggio, Sarti Antonio non è un personaggio che ha particolari qualità perché lo volevo uno come noi e credo di esserci riuscito, senza particolari doti, vessato da chi sta sopra, rivincite poche perché non se ne possono avere. Ma ci voleva qualcuno che avesse quelle doti che lui non aveva, se possiamo parlare di coppie classiche, il dottor Watson e Sherlock Holmes. Quindi anche qui non ho inventato niente, ho solo attualizzato due figure che all’epoca di Sherlock Holmes non esistevano, ma che esistevano invece nella mia stagione; per forza, sennò a chi le faccio dire le cose che mi stanno a cuore, a Sant’Antonio? Però qui in questo romanzo Sarti Antonio comincia ad acquistare una sorta di coscienza di classe. Ad un certo punto dice una frase che mi pare molto interessante per un personaggio che ha alle spalle una trentina di romanzi e soltanto oggi si accorge di quello che è.
In centinaia di incontri con il pubblico mi sono accorto che la gente legge andando avanti, una frase come quella che adesso vi leggo passa per i più come acqua fresca. Ogni frase invece ha un senso in un romanzo… Dice Sarti Antonio: «La mia non è stata una vita complessa, con storie e avventure o disavventure, nessun eroismo o codardia, virtù o perversione. Insomma, uno qualsiasi e fra, qualsiasi, anonimo caso». Questa è una presa di coscienza straordinaria! «Sono le tre di notte – continua – un momento storico. Alle tre di stanotte Rosas si trova davanti un personaggio diverso da quello che credeva, da sempre, di conoscere». Quindi c’è proprio il personaggio stesso che diventa diverso da come lo avevo descritto fino ad oggi. Lo trovo consapevole e già questa è un’indicazione per i personaggi dei romanzi noir. Devono avere un minimo di… Ecco, no, non facciamo polemiche. D’altra parte non è mio compito, il mio compito è quello di scrivere. Poi, se scrivo qualcosa di interessante, la gente mi legge. Se scrivo qualcosa di poco interessante, pazienza. Cosa posso dire? D’altra parte sono in libreria dal ‘74. Sono ormai quasi cinquant’anni, 48 anni, circa mezzo secolo.
Con successo..
No, con successo no. Perché se fosse con successo io forse avrei la villa a Montecarlo, come dice sempre Francesco Guccini quando andiamo in giro.
… e invece hai la casa a Monteombraro [sull’appennino tra le province di Bologna e Modena]
Sì ho questa casa che, vi giuro, è la cosa alla quale ho sempre aspirato, una casa in montagna mia, dove scrivere.
Per riprendere e chiudere il discorso su La stagione del pipistrello*, la descrizione che nel racconto fai della Bologna degli ultimi anni è sicuramente una delle più lucide che si possono trovare. Tra l’altro citi anche l’ex sindaco Merola. Una città che si è man mano sfaldata e nessuno se ne rende conto. Per chi la vede da fuori, Bologna continua a sembrare un’isola felice.*
Neanche oggi ci credono! Ma dove vivete? Siamo sul baratro, ragazzi! Viviamo in un mondo per cui fatalmente si arriva a questi risultati se non cerchiamo di darci una mossa, cosa impossibile ormai.
Una domanda-considerazione. Il romanzo Strage per noi è stato molto importante. Tu hai scritto anche su Portella della Ginestra (Noi che gridammo al vento) e su Ustica (Funerale dopo Ustica). Le cronache di questi mesi, nel trentennale di Capaci, hanno analizzato quella strage, evidenziando elementi significativi quali la presenza di Delle Chiaie sul luogo dell’attentato. Ciò ci ha fatto pensare a una cosa che si è detta più volte, cioè che la stagione delle stragi non è finita nell'84 con la strage del Rapido 904 e che probabilmente anche le stragi del ‘92 vi rientrano in questa stagione. Ti chiedo se è possibile fare un bilancio sulla stagione delle stragi, a questo punto.
Secondo me non si può fare un bilancio perché non abbiamo niente da bilanciare. Cosa abbiamo? Abbiamo solo quello che ci hanno detto, con cosa lo bilancio? Con quello che non so? I bilanci si fanno quando abbiamo almeno due oggetti da pesare. Qui non ci sono, ce n’è uno. Ho parlato con Bolognesi [Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980] qualche giorno fa perché mi serviva un’informazione e mi ha detto che questa storia della strage di Capaci fa riflettere. La magistratura ha aperto un altro canale di comunicazione, stanno venendo fuori delle cose per cui quell’ipotetico filo che collegava le stragi fino ad oggi è molto, molto, molto più lungo. E ha continuato dicendo che stanno saltando fuori delle informazioni che non avevamo, che saranno basilari per la conoscenza di quel periodo. Quindi non abbiamo ancora i dati per fare questo bilancio. Io posso però dirvi una cosa: ho fatto delle analisi per scrivere questi tre romanzi, perché io prima di scrivere mi sono documentato, anche se, ripeto, ho scritto un romanzo e ci tengo che sia chiaro. Un romanzo che, come tutti i romanzi storici e anche qui, non l’ho inventato io, si basa su dati di fatto, su una storia realmente accaduta. Quindi ci sono dati di fatto che poi sono stati utilizzati con lo scopo di costruire un romanzo. Ma perché costruire un romanzo? Perché il romanzo è una delle forme di trasmissione del ricordo e anche della storia che è più facile che il lettore trattenga. Io so di gente che ha imparato la storia dai romanzi e non è certo una novità. Ho letto delle poesie sulla strage di Bologna, dei romanzi al cui confronto non c’è saggio storico che tenga. Quand’ero a Piana degli Albanesi ho visto dei disegni e dei quadri di pittori anche dilettanti che hanno rappresentato la strage di Portella con una intensità che non dimenticherò mai. Come io me li ricordo, penso che anche altri ricordino un romanzo che leggono. Questa è la forma narrativa che ho scelto perché io scrivo e che quindi ho utilizzato quando ho fatto queste ricerche sulle stragi. Posso tirare le somme, ma non sono conclusioni, a partire da quello che ho scoperto fino a oggi. Ad esempio: sulla strage di Portella della Ginestra, 1º maggio del 1947, ho letto più di 700 pagine della sentenza di Viterbo, dove si è tenuto il processo alla banda Giuliano. Ho letto 700 pagine, tutte battute a macchina. Da lì ho appreso delle cose che mi hanno fatto venire i brividi. Un giudice che scrive cose che lette oggi fanno orrore. Bisognerebbe che tutti leggessero quella sentenza. Non entro nel dettaglio perché ho già avuto un primo processo per quello che ho scritto e mi è bastato. Però vi assicuro che quello che si può dire non è neanche un terzo di quello che andrebbe detto. Ci sono dei personaggi coinvolti nella strage di Portella della Ginestra dei quali ancora oggi non si può parlare perché altrimenti finisci in tribunale. Fra le varie cose ho scoperto che io devo stare molto attento perché ne ho già avuto abbastanza: secondo voi è logico che io mi autocensuri?
Non è un bel segno
Salto di palo in frasca, il romanzo Funerale dopo Ustica, pubblicato nell'89, cioè a nove anni dalla strage, allora non suscitò nessuna perplessità. Andò via liscio come l’olio. 80.000 copie vendute da un autore sconosciuto [Macchiavelli lo pubblico dietro pseudonimo]. Di recente per ristamparlo ho avuto delle difficoltà. Ora è stato ripubblicato e contiene tre capitoli nuovi con le novità uscite dall'89 a oggi. Allora torniamo a Portella. Mi sono accorto che tutti quegli avvenimenti extralegali che sono accaduti a Portella della Ginestra si sono verificati in maniera identica in tutte le stragi successive. Di cosa parlo? Parlo di collusione mafia-politica. Mafia, politica, depistaggi, servizi segreti deviati, ecc. Vi racconto questa. Alcuni anni fa, mentre lavoravo a Noi che gridammo al vento, viene fuori una teoria stranissima. A sparare ai manifestanti che festeggiavano il Primo maggio non è stato Salvatore Giuliano, che non avrebbe mai sparato ai suoi amici e ai suoi compagni, ma è stata la X Mas. Di colpo uno studioso scopre che è stata la X Mas. Da dove l’ha tirata fuori? Dal fatto che Salvatore Giuliano amava la sua gente, era andato lì solo per partecipare, mentre la X Mas sparava dall’altra vallata. Impossibile, perché i colpi sono stati sparati dal lato su cui si trovava Salvatore Giuliano. Che cos’è questo se non un ennesimo depistaggio? Quante volte è saltata fuori sulla strage di Bologna la pista palestinese? Un altro depistaggio. Ricordate i manifesti trovati su un treno che da Bologna andava verso il Brennero? Il terrorismo altoatesino: un altro depistaggio. I primi depistaggi sono venuti fuori proprio nell’epoca repubblicana. Secondo me Portella della Ginestra è la madre di tutte le stragi perché contiene in trasparenza tutto quello che è accaduto dopo e che abbiamo ritrovato nelle stragi successive. Una importante considerazione che dobbiamo fare è quella del coinvolgimento della politica con la mafia in tutte le stragi. Questa è una considerazione che dobbiamo fare, ma che non possiamo mettere nel bilancio, perché a questo punto non abbiamo le prove, come diceva Pasolini. Leggendo i dati degli atti del processo tu capisci chi c’è dietro e come diceva Pasolini noi non abbiamo detto no. Però è lì, è scritto lì. Che bilancio vogliamo trarre se io ho delle cose che pesano, ma che non posso mettere sulla bilancia?
Perché hai scelto di pubblicare questi tre romanzi con lo pseudonimo di Jules Quicher?
È una scelta di carattere letterario, non per paura di venire scoperto; una scelta della quale mi assumo tutta la responsabilità. Devo dire che ho il grande piacere di essere in un volume, non ricordo più il titolo, che contiene tutti i processi fatti a dei romanzi dal dopoguerra ad oggi. Questa cosa mi fa un piacere enorme. Ricordate De Vincenzi, De Angelis e D’Errico: sono quelli che ci hanno detto «queste cose si possono scrivere». Torniamo a Jules Quicher. Siamo negli anni Ottanta quando scrivere un romanzo, soprattutto un romanzo giallo come autore italiano, era una fatica improba, non avresti mai pubblicato. Bisognava utilizzare uno pseudonimo, ma questo pseudonimo io l’ho creato perché dietro c’era un progetto editoriale concordato con Rizzoli. Il progetto era: facciamo tre romanzi, una trilogia sui segreti italiani – perché questi non sono più misteri, sappiamo tutti chi c’è dietro e quindi non sono misteri. Poi vediamo se con lo pseudonimo hanno successo e infine facciamo una conferenza stampa in cui ci riveliamo ai critici (allora c’era molta critica letteraria, che sta giustamente sparendo, e che scriveva delle cazzate enormi). Avremmo rivelato che l’autore era Loriano Macchiavelli e avremmo detto: vedete che anche in Italia si può ambientare una spy story? Anche in Italia si può scrivere un thriller? Però poi con Strage sono dovuto andare a processo, è venuto fuori l’autore e il progetto non è andato in porto.
Come sei diventato scrittore? Come hai deciso? Hai fatto anche altro nella vita?
Io per vivere ho fatto sempre altro fino a che non sono riuscito ad alimentarmi con la letteratura. E non è facile. Ma io non mi ricordo quando ho cominciato a scrivere, so che ho sempre desiderato scrivere fin da bambino, poi negli anni ancora di più, tanto è vero che scrivevo racconti da vendere a 50 lire, con una macchina Olivetti trovata fra le macerie a Bologna e la carta carbone. Ogni tanto mi capita di ritrovare cose che ho scritto parecchi anni fa. Ho frugato di recente nel mio archivio, dove ho accatastato di tutto, una serie di racconti molto brevi intitolati Autostrada due, tutti ambientati su una ipotetica autostrada dove accadevano cose. Facevo la terza media, sono tutti scritti a mano con la biro. Io ho sempre amato molto la lettura, ma contemporaneamente ho anche amato la scrittura. Ho sempre scritto molto. Cose banali, ovviamente. Forse scrivo ancora cose banali, però sono quelle che danno un senso alla mia vita.
Come hai capito che a un certo punto la scrittura poteva diventare un lavoro?
Io prima di tutto ho fatto teatro. Ho letto, ho visto molto teatro. Mi ricorderò sempre una rappresentazione dell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht che ho visto alla Fenice di Venezia con mia moglie, ce l’ho ancora nelle vene. E le musiche di Kurt Weil… ragazzi che geni.
Ho scritto molto teatro e questo mi ha aiutato molto quando sono passato al romanzo. Perché? Perché in teatro puoi vedere quello che hai scritto prendere vita su un palcoscenico e ti fa capire se funziona o no. Poi contemporaneamente scrivevo racconti qua e là. Ho fatto 15 anni di teatro dal quale abbiamo guadagnato pochissimo a parte la fatica. Devo ringraziare Franca, mia moglie, una donna straordinaria che mi ha consentito di fare queste cose senza chiedermi niente. Sono stato molto fortunato. Per la verità sono fortunato per tutto quel che ho fatto e sono contento di me. Poi ho deciso di scrivere un romanzo giallo, ma per divertimento, per farlo leggere a Franca. Eravamo in vacanza, non avevamo con noi dei libri da leggere, e allora le ho scritto un romanzo. Poi quando siamo tornati a casa, Franca l’ha battuto a macchina e l’ha mandato al Festival Gran Giallo Città di Cattolica, festival di cinema, di teatro, di televisione e di letteratura edita ed inedita. Era il 1973-1974. Veniva premiato il miglior romanzo inedito e ha vinto quello che gli aveva mandato Franca. Quindi proprio una casualità incredibile e da lì ho scoperto che poteva funzionare. Allora lavoravo alla Cineteca di Bologna, con cui ho chiuso con grande rammarico e che ringrazio molto perché mi ha fatto conoscere gente straordinaria che sapeva molto più di me, come Dario Fo, col quale ho avuto un rapporto bellissimo, o come Giuseppe Petronio, un critico, uno storico della letteratura, credo il più grande che abbiamo avuto in Italia. Aveva già 90 anni, ma mi ha fatto capire molte cose con la sua cultura. Lo ammetto, bisogna essere fortunati. C’è gente che probabilmente scrive molto meglio di me, che non riesce a pubblicare un romanzo. Anche con Francesco [Francesco Guccini] è stata una casualità. Ci siamo trovati alla presentazione di un mio romanzo e lui mi ha raccontato una storia di Pavana, il suo paese, e avrebbe voluto ambientarla negli anni Venti. Invece l’abbiamo ambientata ancora più indietro, perché abbiamo scoperto la strage di Aigues-Mortes in Francia del 1893, dove hanno ammazzato una ventina di lavoratori italiani. Strage che noi abbiamo dimenticato. Questa storia è diventata Macaronì. Quando è uscito in Francia ha suscitato una reazione incredibile sui giornali e ne sono usciti saggi. Quindi a che serve il romanzo? Serve anche a questo, a scoprire.
Torniamo al tuo rapporto con Guccini di cui ci hai appena accennato. Come avviene il processo di scrittura a quattro mani? Uno butta giù una bozza e l’altro integra? Come vi coordinate?
Noi ci troviamo all’inizio quando decidiamo di scrivere e poi cominciamo ad abbozzare un’idea generale e ne parliamo con l’editore. Se gli va bene, partiamo. E la scrittura avviene in questo modo: ognuno prende un pezzettino di storia. Per esempio in Macaronì il primo capitolo è di Francesco, dove racconta la storia di Don Magnanelli, il secondo è mio. E poi avanti così. Dopo una settimana ci troviamo, lui legge il suo pezzo, io il mio, integriamo e modifichiamo se ci sono delle contraddizioni, poi andiamo avanti. Alla fine ci troviamo per tre, quattro giorni, ci leggiamo tutto il testo e cerchiamo di dargli un’unitarietà letteraria, in modo che non ci siano discrasie linguistiche. Vi dicevo del caso rispetto al nostro primo incontro. Lui mi racconta questa storia, lì con noi c’è l’editore e ci ha invitato a scriverla.
Non vi conoscevate, quindi?
No, io ero e sono un ascoltatore delle sue canzoni e lui un lettore dei miei romanzi. Mi aspettavo che l’incontro finisse lì, ma pochi giorni dopo Francesco mi chiama e abbiamo deciso di provare a scriverla. Abbiamo provato, era il 1997, e ormai sono più di vent’anni che scriviamo assieme.
E ne avete scritti parecchi
Sì, anche perché a scrivere con Francesco ci si diverte, ha una memoria storica dei luoghi, è veramente una miniera di avvenimenti che si raccontano in montagna. Molti dei nomi dei nostri romanzi non sono inventati da lui, ma sentiti dai racconti. È quasi un glottologo nella ricerca linguistica.
Poi, è noto in giro, finito di lavorare andiamo a cena, si beve e si scatenano le barzellette e i racconti.
Con questa rivista a cui abbiamo dato vita cerchiamo di individuare, interrogare, valorizzare quegli elementi, quelle dinamiche, quelle sperimentazioni e esperienze libertarie che si attivano nella società contemporanea e che si provano a dare senza rapporti di dominio e di sopraffazione. Secondo te nella società ci sono queste dinamiche, questi semi sotto la neve, come li chiamiamo?
Io spero bene che ci siano, sennò è meglio che chiudiamo. Se non ci sono, e se anche non c’è la speranza che esistano e che un giorno o l’altro vengano fuori vuol dire che abbiamo sbagliato tutto. Se non è così non vedo che senso abbia scrivere. Scrivo perché credo che ci sia ancora una possibilità. Ne La stagione del pipistrello c’è un finale che non cambia, che è anche molto triste, ma che dà speranza. Ve lo leggo perché rende l’idea:
«Otto capoversi, poche righe, per un finale che non è mio, ma che ci sta da dio.
Fuori, intanto, è autunno di un anno che verrà.
È autunno nelle selve e nelle gole, nei dirupi e nelle forre, nelle secche dei torrenti e sui sentieri dove corrono lupi e cinghiali. Così passò il tempo
che mi fu dato sulla terra.
È autunno nelle strade e nei sotterranei, nei teatri e sulle piazze, nei canali e nelle miserabili baracche di cartone e lamiera … ed è subito sera.
È autunno nell’ansia del prossimo, nelle menti e nei sentimenti, nella miserabile vita quotidiana, nel presente, nel futuro e si sta come d’autunno sugli alberi le foglie».
Vedete queste citazioni, questa era gente che voleva cambiare il mondo, Bertolt Brecht, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti. Allora è per questo che scriviamo perché ci crediamo che il mondo possa cambiare. Nel noir che immagino io una delle cose più importanti è questa: dobbiamo raccontare un mondo capace di cambiare. Perché se no non si va avanti. Noi dobbiamo raccontare un mondo che sia possibile cambiare. Io credo di avere tentato questa via.
Il guaio avviene quando scegliamo di raccontare l’esistente. Dobbiamo scrivere noir che abbiano senso, per dare senso bisogna essere in grado di andare oltre. Io all’inizio non venivo accettato proprio perché ero andato oltre, non perché io fossi un visionario o che vedessi il futuro. No, perché era normale che accadesse quello che è accaduto. Noi dobbiamo raccontare la possibilità di cambiare quel futuro a cui ci stiamo preparando. Noi non ci riusciremo? Pazienza.
Un futuro che è già quasi presente?
Sì, difatti non è detto in che anno si svolge questo romanzo [La stagione del pipistrello]. Ogni giorno che passa io vedo sempre più la dimostrazione di quel che sostengo e questo è gravissimo. E poi mi devo censurare. L’autocensura? Come si fa? Cosa di cui non mi dovevo preoccupare negli anni Ottanta, quando facevamo gli spettacoli in piazza Maggiore con il gruppo teatrale e finivamo tutte le sere in questura. Due questurini ci portavano in questura per farci la ramanzina, perché facevamo gli spettacoli senza permessi della SIAE e senza autorizzazioni. Non pagando i diritti d’autore facevamo già la nostra piccola rivoluzione. Ma adesso non la faccio più, perché non sono più in grado di farla, mi sono stancato. Però ogni tanto mi incazzo.
Hai in cantiere altri romanzi?
Adesso ho cominciato un romanzo con Francesco. Sarà un romanzo ambientato nel secondo dopoguerra, ma non vi posso dire molto di più.



Castigare, pacificare o decriminalizzare le «bande latine»? Esperienze in Spagna, Ecuador e El Salvador
Begoña Aramayona
L’approccio delle istituzioni, dei media e dell’opinione pubblica nei confronti delle «bande latine» ha un ruolo fondamentale per la comprensione, il percorso e la prospettiva di questi gruppi. Più si usa il pugno di ferro, più aumenta la clandestinità dei gruppi e più sono le possibilità che aumenti la conflittualità. Ma che alternative ci sono? In base ai casi di Spagna, El Salvador e Ecuador, questo articolo analizza le esperienze di approccio istituzionale al fenomeno delle bande basate sul binomio «criminalizzare versus regolare», e si propone di rispondere alla domanda: la decriminalizzazione è un paradigma che può essere utile per affrontare il fenomeno delle aggregazioni giovanili di strada, definite impropriamente bande?
Introduzione
La presenza di una narrazione volta a criminalizzare le «bande latine» è aumentata notevolmente nell’agenda mediatica e istituzionale degli ultimi mesi. Gli scontri sono sempre accompagnati da titoli allarmistici e morbosi che portano politici sia conservatori che socialdemocratici a condividere un discorso dai toni di crociata sulla necessità di «combattere le bande». Fanno da sfondo le notizie sulla delicata situazione che vive El Salvador nella sua lotta contro le gangs*:* il recente «stato d’eccezione» dichiarato dal Presidente Bukele prosegue la tradizione salvadoregna di indicare le gangs come il grande nemico pubblico e questa volta, e lo fa applicando un gravissimo «trattamento disumano», secondo le parole di Amnesty International (Amnistía Internacional 2022), sofferto da più di 30mila detenuti nelle carceri del paese centroamericano. Dopo 50 giorni di eccezione. Senz’acqua, senza cibo, dormendo sul pavimento.
Secondo Carles Feixa, l’interesse per le bande è intermittente: a volte riceve un’attenzione smisurata da parte del trattamento mediatico e istituzionale, soprattutto quando accadono gli episodi di violenza più gravi, poi per la maggior parte del tempo le gangs si trasformano in «fantasmi» dei quali non parla nessuno. I racconti scabrosi e dettagliati sui conflitti tra gruppi, contrastano con l’assoluto silenzio sull’argomento per il resto del tempo.
L’interesse per le bande è intermittente: a volte riceve un’attenzione smisurata da parte del trattamento mediatico e istituzionale, poi per la maggior parte del tempo le gangs si trasformano in «fantasmi» dei quali non parla nessuno
Una narrativa distorta, che fa caso solo alla violenza, e uniformata, che non entra nella diversità di gruppi e pratiche, contribuisce a favorire un clima di paura dell’altro, in questo caso in base allo stereotipo del giovane migrante, pericoloso e selvaggio. È evidente che il disinteresse per conoscere la realtà dei gruppi giovanili di strada, o famiglie di strada, va di pari passo con il disinteresse per trovare soluzioni reali, profonde e a lungo termine alla realtà che vivono questa gioventù e le loro comunità. Infatti, dopo un periodo di prolungato silenzio, oggi assistiamo al
ritorno delle «bande» come capo espiatorio dei mali della nostra società, e anche come oggetto di scambio nella lotta politica tra distinti partiti.
È innegabile che l’approccio delle istituzioni pubbliche, in stretta relazione con il ruolo dei media e dell’opinione pubblica, ha un effetto fondamentale non solo sulla comprensione del fenomeno delle bande, ma anche sul percorso e sulla prospettiva di questi stessi gruppi nella loro relazione con la società. Più si usa il pugno di ferro, più aumenta la clandestinità di questi gruppi e più sono le possibilità che aumenti la conflittualità. Ma che alternative ci sono?
Nei prossimi paragrafi mi propongo di analizzare le esperienze di approccio istituzionale al fenomeno delle bande, prendendo in esame i casi che esplora il progetto LEBAN (Legalizzare le Bande? La costituzione di associazioni a partire da gruppi giovanili di strada in Spagna, Ecuador e El Salvador). Analizzerò quindi l’impatto Più si usa il pugno di ferro, più aumenta la clandestinità di questi gruppi e più sono le possibilità che aumenti la conflittualità
delle esperienze di Madrid e El Salvador come esempi paradigmatici di pugno di ferro e di approccio punitivo contro le bande, e di Barcellona e dell’Ecuador come luoghi di sperimentazione istituzionale per generare canali di dialogo con questi gruppi. Nell’ultima parte, propongo di esplorare potenziali «terze vie» per quanto riguarda l’approccio a questo fenomeno. Aprendo un dialogo tra le esperienze e un quadro sulla decriminalizzazione, aspiro ad arrivare ad una riflessione sulle diverse alternative che esistono oltre a castigare e pacificare questi gruppi. In questo senso, le domande fondamentali che pone questo testo sono: quali effetti hanno avuto le diverse politiche di intervento sulle bande fino ad oggi? Possiamo considerare la decriminalizzazione un paradigma utile nell’affrontare il fenomeno delle aggregazioni giovanili di strada, definite impropriamente «bande»?
Il contenimento di sicurezza come dispositivo di governo della marginalità urbana: linea dura e linea morbida verso le bande in Spagna, Salvador ed Ecuador
Latin Kings & Queens, Ñetas, e Black Panthers sono solo alcuni esempi della diversità di forme di gruppi o «famiglie di strada» che vengono organizzati per dare risposta alle necessità materiali, identitarie e affettive delle popolazioni (spesso giovani, ma non solo) che abitano ai margini delle geografie transnazionali. Questi gruppi sono sostegno, rifugio, e in alcuni casi sono l’unico modo di esistere della subalternità urbana che abita i margini delle città post-industriali. Tuttavia, la denominazione di «banda», dall’inglese gang, è stata generata all’esterno di questi gruppi, con una finalità puramente criminale. In questo modo, ignorando le condizioni strutturali che obbligano ad abitare questi spazi, si rende invisibile l’immensa diversità di significati, identità, pratiche e obiettivi che sono parte dell’universo di senso di questi gruppi.
Nel contesto europeo questi gruppi hanno ricevuto l’appello di latini, insistendo sulla presenza maggioritaria – anche se non esclusiva – di giovani razzializzati1 o di origine migrante.
L’approccio, le definizioni e un clima generalmente bellicoso verso i gruppi giovanili di strada risponde a un’eredità della re-
lazione, storicamente problematica, degli stati moderni con la marginalità urbana. La marginalità urbana (i suoi spazi, le sue pratiche e la potenziale espansione della sua cultura) deve essere «contenuta» per il buon funzionamento delle società moderne. Le popolazioni ai margini sono potenzialmente pericolose dal punto di vista dello Stato e hanno quindi bisogno di essere vigilate, controllate e, in caso
di necessità, castigate (Foucault 2012). Tuttavia, le strategie di contenimento applicate dagli Stati contemporanei hanno raggiunto recentemente un livello di sofisticazione senza paragoni. Secondo Justus Uitermarck (2007), i nuovi dispositivi di governo della marginalità urbana in Europa seguono due grandi linee,
1 La razzializzazione è il processo attraverso cui un gruppo dominante attribuisce caratteristiche razziali, disumanizzanti e inferiori a un gruppo dominato, attraverso forme di violenza diretta e/o istituzionale che producono una condizione di sfruttamento e di esclusione materiale e simbolica. La parola razzializzata/o ci consente di vedere come la razza, che non esiste biologicamente, serva a mantenere rapporti di potere.
spesso intrecciate negli stessi territori: da una parte una strategia di «linea dura», caratterizzata dall’uso dei dispositivi di polizia e giuridici per castigare certe popolazioni fastidiose (la classica società del controllo). D’altra parte, l’uso di una «linea morbida», una versione più amabile e dolce che, in base a degli argomenti di carattere più «civico» (leggi per la convivenza, per un comportamento decente, ecc.) tenta di promuovere processi di integrazione delle popolazioni marginali per incanalarli verso un modo di esistere più «rispettabile» (nella nuova «società del rischio»). L’approccio delle istituzioni di fronte al fenomeno dei gruppi giovanili di strada normalmente ha seguito una logica simile. Fino ad ora, predomina sia a livello temporale che geografico l’approccio di linea dura, chiamato anche «bande fuori» (Feixa Et Alii 2022), che consiste nell’applicazione di una serie di politiche di esclusione, un approccio punitivo sia delle forze dell’ordine che a livello penale, affrontando il fenomeno con un’ottica bellicosa. Seguendo questo paradigma, i gruppi, considerati come «nemici pubblici» (Queirolo 2017), devono essere espulsi per mantenere un presunto ordine sociale e di convivenza. In questo modo si giustificano politiche pubbliche che tendono a perseguire, criminalizzare e castigare questi gruppi e, in certi casi, vengono creati nuovi strumenti giuridici per poterli rendere illegali. Meno utilizzato è invece un approccio inclusivo del tipo «bande dentro», caratterizzato da un’ottica più sociale, meno punitiva e che apre processi di dialogo e mediazione con questi gruppi, considerandoli un interlocutore rilevante e legittimo al momento di negoziare e trasformare la realtà sociale. Di seguito presenteremo alcune esperienze – e i potenziali impatti – di questo doppio modello di politiche di castigo o pacificazione.
Politiche di castigo: El Salvador e Madrid
Le scelte delle amministrazioni di Madrid, in Spagna, e del Salvador, in America Centrale, sono esempi paradigmatici dell’applicazione di una linea dura persistente e sostenuta nel tempo contro le bande o maras.
La politica di governo salvadoregna finora è consistita fondamentalmente nell’applicazione di un «punitivismo di Stato», da parte delle forze dell’ordine e altamente militarizzato, quasi una guerra tra lo Stato e le bande, con alcuni processi di tregua o pacificazione nati da mediazioni poco chiare tra lo Stato e questi gruppi (senza dibattito pubblico e nell’ottica di interessi elettorali). Il modello punitivo nel Salvador segue una logica classica, replicata poi dalle destre e dalle estreme destre europee: riforme penali con aumenti di pena e di casi, identificazioni e arresti arbitrari, assenza di programmi di reinserimento, corruzione e impunità nelle forze dell’ordine, criminalizzazione della stampa e dell’Accademia, ostacolare il lavoro di chi difende i diritti umani. Paradossalmente questa politica di linea durissima ha favorito la forza delle bande in quanto attore politico con un’altissima presenza e capacità di incidenza sul territorio (sia dentro che fuori dal carcere), fino a trasformarle in un vero e proprio Stato parallelo. Dopo trent’anni di guerra contro le bande il saldo è di un centinaio di morti e in questo momento più di 30.000 detenuti nelle carceri salvadoregne dormono senza materassi, senza acqua e senza cibo grazie allo «stato di eccezione» decretato dal Presidente Bukele.
Mettendo da parte le immense differenze, il caso di Madrid si avvicina a quest’ottica punitiva di linea dura persistente, anche qui con risultati deplorevoli in termini di difesa dei diritti umani e di riduzione del conflitto: dagli anni ‘90 l’onnipresenza di partiti conservatori nei governi municipali e regionali (sempre con il Partido Popular in testa, tranne un piccolo periodo di esperimento municipalista nel 2016-2019) ha generato un clima di normalizzazione della violenza istituzionale contro le bande e contro la gioventù razzializzata nei quartieri e nei comuni della regione.
La persecuzione, l’accanimento e la criminalizzazione ha raggiunto l’apice nel 2006, anni in cui è iniziato un processo contro i gruppi dei Latin Kings e Ñetas, accusati di «associazione illecita» e più tardi di «gruppo o organizzazione criminale». Recentemente, nell’aprile 2022, la morte di due giovani in un quartiere di Madrid per un presunto conflitto tra gruppi è stata utilizzata come giustificazione per l’organizzazione di un nuovo dispositivo «contro le bande» che ha significato il dispiegamento di agenti municipali, 500 poliziotti, 800 carabinieri nelle aree e nei comuni più poveri della regione, con l’identificazione di più di 18.000 giovani e l’arresto di 171 persone, secondo fonti della polizia. Come fa notare María Oliver, ricercatrice della UPF, «non ci sono così tanti ragazzi membri di questi gruppi», per cui non è fuori luogo che molti si interroghino sulla finalità di queste misure e accusino il governo municipale di implementare una strategia di accanimento verso la popolazione migrante e razzializzata (Ouled 2022). In conclusione, le politiche di «linea dura» (di eliminazione dei gruppi per la via repressiva e penale) non hanno posto fine all’ esistenza – semplicemente li hanno spostati verso spazi più clandestini – né alla conflittualità e alla violenza tra di essi.
Politiche volte a pacificare: Ecuador e Barcellona
L’Ecuador e Barcellona, invece, hanno iniziato processi di dialogo e mediazione che, tra le altre cose, hanno avuto un relativo successo nel momento di generare processi di pacificazione a medio e lungo termine con questi gruppi. L’esempio di Barcellona è particolarmente importante, in quanto, a differenza di Madrid, nel 2006-2007 i processi di mediazione (attivati grazie all’interlocuzione della parte accademica, delle Amministrazioni pubbliche e di altri membri della società civile, come il prete Joan Cabot e membri della Federazione Fedelatina) hanno portato alla formalizzazione di questi gruppi in associazioni: prima con la Organización di Reyes y Reinas Latinos de Cataluña nel caso dei Latin Kings & Queens, e in seguito con l’Associazione Socioculturale e Sportiva Ñeta. Questo è stato un progetto pionieristico nell’affrontare una forma innovativa di affrontare istituzionalmente la relazione con questi gruppi, generando relazioni di affetto e fiducia di indiscutibile valore tra attori inizialmente molto lontani tra loro (si veda ad esempio il libro «Diario di un Re» scritto a quattro mani da César Andrade, alias King Manaba ex leader di ALKQN Latin Kings, e il professore Carles Feixa). L’esperienza catalana ha significato la nascita di un progetto pilota di dialogo e mediazione tra questi gruppi e le istituzioni, così come tra gli stessi gruppi che prima si scontravano (si veda il progetto musicale Unidos por el Flow tra Latins e Ñetas). Tuttavia, questo processo di mediazione ha prodotto anche la rottura di questi gruppi tra settori che erano disposti a collaborare e quelli che non ne volevano sapere, aprendo poi la questione di cosa ne sarebbe stato di quelli che non hanno voluto aprire canali di comunicazione per vie istituzionali. Ispirandosi e appoggiandosi al modello di Barcellona, l’Ecuador ha aperto parallelamente un processo simile. Dal 2007 ha dato inizio a un processo di dialogo e mediazione tra il gruppo STAE (Nación Latin King dell’Ecuador) e il governo di Rafael Correa, che ha generato una svolta rispetto alla politica anteriore, che puntava a criminalizzare questi gruppi. Poco dopo, la legalizzazione della Corporación de Reyes y Reinas Latinos dell’Ecuador, ha significato un riconoscimento istituzionale che è arrivato al punto di incorporare un Latin King, Ronny Aleaga, come parte dell’assemblea e partecipe al progetto della Revolución Ciudadana. Grazie anche all’implementazione di altre misure di aumento della spesa sociale, l’Ecuador ha visto una drastica riduzione della violenza: secondo un rapporto della Banca Interamericana di Sviluppo, il tasso di omicidi del paese si è ridotto di un 75% in tre anni, portando l’Ecuador ad essere il secondo paese più sicuro dell’America Latina (Brotherton, Gude 2018).
Autonomia delle bande? Oltre a castigare o regolare, la de-criminalizzazione come paradigma di intervento
È evidente che i processi di criminalizzazione e punizione non solo non funzionano per ridurre la conflittualità, ma contribuiscono a intensificare la violenza e le condizioni di disagio delle comunità meno favorite. Gli esperimenti pionieristici di Barcellona e dell’Ecuador, che hanno visto l’apertura di processi di mediazione con questi gruppi, sono certamente un’esperienza da tenere in conto per i risultati ottenuti: la riduzione del tasso di conflittualità, così come la nascita di una rete funzionale di mediazione, hanno permesso di salvare vite. D’altra parte la frammentazione dei gruppi che è avvenuta parallelamente alla mediazione istituzionale porta a chiedersi in che modo il dialogo avrebbe potuto anticipare questo rischio e, in che misura si possono trovare vie alternative per generare processi di inclusione a medio e lungo termine senza che questi portino alla dissoluzione degli stessi gruppi.
In questo senso il paradigma della decriminalizzazione può esserci utile al momento di cercare alternative che vanno più in là del binomio castigare/reprimere versus regolare/legalizzare. Un breve esempio: la decriminalizzazione del lavoro sessuale in
Nuova Zelanda, paese che per primo al mondo ha proposto un approccio non proibizionista (linea dura, secondo lo stile statunitense) o regolatore (come fanno i paesi centroeuropei) della prostituzione, ha permesso di far diminuire la violenza subita dalle lavoratrici del sesso, favorendo la nascita di cooperative di lavoro e la protezione della polizia di fronte agli abusi (di clienti e protettori). Si tratta senza dubbio di uno dei mo-
Gli esperimenti pionieristici di Barcellona e dell’Ecuador, che hanno visto l’apertura di processi di mediazione con questi gruppi , sono certamente un’esperienza da tenere in conto per i risultati ottenuti
delli di maggior successo e più apprezzati dalle stesse lavoratrici del sesso. Un altro esempio: la depenalizzazione del consumo di marijuana in Portogallo ha portato a un ottimo risultato nella riduzione del consumo e nella riduzione delle pene per piccolo spaccio. Cosa hanno in comune questi due esempi? Da una parte una rinuncia da parte dello Stato a generare politiche pubbliche specifiche per regolamentare pratiche previamente considerate «ai margini» (una rinuncia al controllo o monitoraggio di queste attività). Dall’altra il superamento dell’ottica securitaria (le forze dell’ordine) e penale (giudiziaria); ovvero, smettere di considerarle come attori o pratiche fonte di rischio in se stesse.
È possibile pensare ad alternative simili per le aggregazioni giovanili di strada? È possibile promuovere processi di dialogo senza formalizzare questi gruppi in base agli schemi morali degli Stati moderni (europei, bianchi e di classe media)? Intuiamo quanto sia complicato rispettare il loro processo di autonomia senza la necessità di volerli «includere o integrare» nella società, rispettando il loro «stare al margine»; ma consideriamo che questa posizione offrirebbe grandi potenzialità di trasformazione.
Bibliografia
AMNISTÍA INTERNACIONAL, El Salvador: El estado de excepción ha creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos (2022) https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/04/el-salvador-state-of emergency-human-rights-violations/ .
D. BROTHERTON, R. GUDE, Inclusión social desde abajo. Las pandillas callejeras y sus posibles efectos en la reducción de la tasa de homicidios en el Ecuador, «Banco Internacional del Desarrollo», abril 2018 https://publications.iadb.org/es/inclusion-social-desde-abajo-las-pandillascallejeras-y-sus-posibles-efectos-en-la-reduccion-de-la .
Y.M. OULED, ¿Qué sabemos del operativo policial contra bandas juveniles en Madrid?, «El Salto» (2022) https://www.elsaltodiario.com/redadasracistas/quesabemos-operativo-policial-contra-bandas-juveniles-madrid. C. FEIXA, C. ANDRADE, El Rey. Diario de un Latin King, NED Ediciones, Barcelona, 2020.
C. FEIXA, B. ARAMAYONA, E. BALLESTÉ, S.P. DE LA TORRE, Bandas dentro, bandas fuera. (Des) securitización versus punitivismo de las organizaciones juveniles de calle en España, Ecuador y El Salvador, «Análisis Político» 34 (102) 2021, pp. 150-174.
M. FOUCAULT [1975], Vigilar y castigar, Siglo XXI, Madrid, 2012.
PROYECTO LEBAN, ¿Legalizar las Bandas? La constitución de asociaciones a partir de agrupaciones juveniles de calle en España, Ecuador y El Salvador https://www.upf.edu/web/leban.
L. QUEIROLO, Cómo se construye un enemigo público: las «bandas latinas», Traficantes de Sueños, Madrid, 2017.
Traduzione di Valeria Giacomoni, con qualche piccolo adattamento per un pubblico italiano. L’articolo è tratto dalla rivista «Libre Pensamiento», n. 111, estate 2022, Madrid, Papeles de Reflexion y debate Confederacion General de Trabajo (CGT).


Gustav Landauer (1870-1919) Con uno scritto inedito
Gianfranco Ragona
Le grandi storie complessive dell’anarchismo e del pensiero anarchico hanno a lungo trascurato l’impatto del movimento tedesco e l’apporto teorico dei suoi intellettuali. Le cose sono cambiate a partire dagli anni Ottanta, quando la storiografia internazionale, ma anche quella italiana (si pensi ai contributi di Mirella Larizza e Giampietro Berti), si sono accorti dell’importanza di figure quali Rudolf Rocker, Eric Mühsam e naturalmente Gustav Landauer.
L’attenzione per Landauer è andata crescendo nell’ultimo decennio, grazie alla pubblicazione delle Opere scelte (15 volumi usciti tra il 2008 e il 2019) e dell’enorme ricognizione biografica condotta da Tilman Leder (quasi mille pagine dettagliatissime). A esse, si è aggiunta una notevole produzione saggistica in diverse lingue, che ne ha ricostruito e discusso il pensiero e l’azione, nonché la traduzione dei suoi scritti in inglese, francese, italiano. Infine, negli ultimi anni sono stati convocati convegni internazionali (l’ultimo a Lione nel centenario della morte), quindi conferenze, presentazioni, iniziative diverse, molte promosse e divulgate dall’associazione Gustav Landauer Initiative di Berlino, che produce una ricca newsletter.
Chi era Landauer e quale importanza ha avuto per lo sviluppo del pensiero anarchico? Originario di Karlsruhe, Landauer divenne consapevolmente anarchico poco più che ventenne, quando a Berlino fu attratto da un’organizzazione politica, gli Indipendenti, che intendeva sfidare l’egemonia del Partito socialdemocratico sul mondo del lavoro e nelle lotte sociali. Fu un’esperienza fugace, ma che lasciò in vita un giornale anarco-socialista molto vivace, «Der Sozialist», di cui Landauer divenne anche direttore, fino alla sua chiusura nel 1899. Fu anche tra i più vigorosi protagonisti dello scontro internazionale tra il socialismo politico e il socialismo libertario ai Congressi di Zurigo (1893) e Londra (1896). Ammiratore di Kropotkin, ne tradusse gli scritti principali in tedesco, prima di dedicarsi al lavoro teorico autonomo (pubblicò La rivoluzione nel 1907 e l’Appello al socialismo nel 1911) e diventare il principale animatore di un’esperienza organizzata di qualche rilievo, l’Alleanza socialista (1908-1915), per la quale riportò in vita il «Sozialist», facendone l’organo di stampa ufficiale. Convinto pacifista durante la Prima guerra mondiale, partecipò attivamente alla Rivoluzione tedesca del 1918- 19, anche come Ministro della cultura nella seconda fase della Repubblica consiliare. Fu trucidato durante la repressione il 2 maggio 1919.
È impossibile in questa sede ripercorrere l’originale sviluppo del pensiero di Landauer e il coraggioso itinerario militante, due elementi – la riflessione teorica e l’impegno concreto – sempre intrecciatisi; è tuttavia opportuno ricordare alcuni aspetti della riflessione, che rimangono vitali ancora al giorno d’oggi e appaiono degni di approfondimento.
In primo luogo, è importante notare come Landauer offra una visione dello Stato inedita nella storia dell’anarchismo classico. Non guarda a esso come a un oggetto che si tratta di distruggere (o conquistare, secondo le correnti del socialismo politico), ma quale manifestazione di un dato assetto dei rapporti sociali. Ovvero, le istituzioni statali sono la forma storica concreta che assume la relazione tra i consociati: sono il rapporto sociale stesso, che si concreta in una specifica configurazione, con il compito di dare risposte ai bisogni della società. Queste risposte naturalmente non è detto che siano buone, corrette, ovvero sempre coerenti con le rispettive domande che promanano dal basso.
Così, con riferimento a Kropotkin, che aveva indicato nel mutuo appoggio una tendenza di fondo dell’evoluzione tanto nel mondo animale quanto in quello umano, trovando nelle libere città del medioevo un esempio paradigmatico di questo spirito, Landauer nella Rivoluzione rivela che lo Stato rappresenta un mero surrogato dell’autentico spirito comunitario tramontato agli albori dell’età moderna. Tuttavia, egli non interpreta il processo in maniera rigida e unilaterale: la crisi del mutuo appoggio, soppiantato da individualismo, autorità, centralismo, fu certo il prodotto di repressione e violenza di Stato, ma anche la manifestazione di una debolezza dei soggetti sociali, incapaci di tenere desti i principi e solide le istituzioni dell’aiuto reciproco. E allora egli si trova a riconoscere – e sono pochi a compiere un simile gesto nella tradizione anarchica – una certa legittimità alle istituzioni politiche vigenti, nella misura in cui danno risposte effettive ai bisogni della società, bisogni che i soggetti sociali non sono ancora in grado di (o non sanno più) soddisfare attraverso l’autogoverno e l’autogestione. Ripetiamo: la parola Stato indica il rapporto sociale dominante nell’epoca compresa tra il tramonto delle istituzioni di mutuo aiuto nel XVI secolo e la futura anarchia, che Landauer chiama popolo. Ovviamente, egli è consapevole e denuncia come in ogni momento lo Stato neghi, impedisca, conculchi ogni manifestazione risorgente del mutuo appoggio e della comunità, cioè osteggi con attenzione maniacale tutti i tentativi di rinascita del popolo sulla base di autonomia e cooperazione, ed è proprio qui che individua il compito specifico dei rivoluzionari: promuovere, diffondere e difendere tali tentativi.
La rappresentazione della realtà del suo tempo in termini di alternativa tra Stato e popolo non deve trarre in inganno: Landauer non crede che l’intera realtà si possa ridurre a tale coppia concettuale, trattandosi di rappresentazioni idealtipiche, cioè modelli che consentono di comprendere il reale, non di ingabbiarlo all’interno di rigide categorie. Così, ed è il secondo punto che bisogna sottolineare, negli spazi lasciati liberi dallo Stato, o sottratti allo Stato, non si trova necessariamente e immediatamente il popolo, perché esso va costruito per mezzo di comunità, di forme di vita cooperative e popolari, in cui il Nuovo impara a manifestarsi in maniera esemplare. E qui sta un’ulteriore declinazione del compito dei rivoluzionari: resistere al potere, contrastare «lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo», fornire esempi concreti, solidi e forti di vita giusta.
Su questo punto, l’ultimo qui presentato, è importante notare che il carattere esemplare delle forme che assume il popolo non è meramente contemplativo: non si tratta di creare isole felici in un mondo ostile, aspettando che tanti fiori sboccino perché irradiati dalla luce della verità. Bisogna piuttosto costruire pratiche sociali alternative, che poi sono anche processi politici che si svolgono gradualmente ma inesorabilmente dal basso in alto. Non ad atti improvvisi e dirompenti si appella Landauer (di cui non nega mai il valore, anzi riconosce le rivoluzioni in quanto «miracoli di eroismo»), ma alla sperimentazione qui e ora di tracce di socialismo: che ovviamente non potrà non essere anarchico.
Alcuni degli elementi qui sopra tratteggiati al fine di evidenziare l’attualità di Gustav Landauer sono sintetizzati in un articolo breve, ma molto incisivo, tradotto qui di seguito per la prima volta in lingua italiana.

Fiacchi statisti, debolissimo popolo!
Gustav Landauer
«Der Sozialist», III serie, 15 giugno 1910
Un uomo pallidissimo, alquanto nervoso, malaticcio e fragile, siede alla scrivania e disegna note su fogli di carta: compone una sinfonia. Lavora con la massima sollecitudine, mentre prorompe tutta l’arte che ha appreso nel tempo. La sinfonia viene quindi eseguita: centocinquanta persone compongono l’orchestra; nel terzo movimento compaiono insieme dieci timpani, quindici incudini e un organo; alla fine entra un coro di cinquecento persone, accompagnato da un’ulteriore orchestra di fiati e tamburi. Il pubblico è sopraffatto da questa straordinaria potenza, incantato dal vigore impetuoso che ne promana.
Ma in verità questi moderni compositori non posseggono un briciolo di forza, benché sia un gioco da ragazzi per loro impossessarsi delle masse con un simile sperpero di apparente energia: a essi assomigliano i nostri uomini di Stato e i politici. Anzi, giorno dopo giorno è l’intera classe dominante che ce li ricorda. Debole, goffa, improduttiva, abborracciata, la classe dominante ha dietro di sé un’orchestra colossale, docile e pronta a scattare al comando: il popolo in armi, l’esercito. Le proteste dei partiti, lo scontento di cittadini e lavoratori, coi pugni stretti in tasca, in generale l’intera opposizione e la critica non vengono presi troppo sul serio dal governo, che non si deve confrontare con una potenza reale: del resto, gli elementi che in ogni popolo sono per natura i più radicali, cioè i giovani tra i venti e i venticinque anni, sono irregimentati nell’esercito, a disposizione dell’inetto governo, e imparano a obbedire agli ordini senza fare domande. Le cose stanno effettivamente in questo modo e nessuno si accorge di quanto sia mortificante la nostra situazione politica, di quanto sia incapace l’esecutivo: non all’interno, non all’estero, e ovviamente neppure nel seno del governo stesso.
A Bethmann-Hollweg viene detto da tutte le parti che è una nullità: un cancelliere tanto impotente non si era forse mai visto. Anche Maximilian Harden, che si era reso disponibile ad appoggiarlo, ora gli volta le spalle. Altri intellettuali, che ci infliggono una cultura mediocre, melanconiche frasi fatte, una lingua sfuggente, incominciano a ridere di lui, irriverenti.
Noi socialisti sappiamo bene che il socialismo – ossia la relazione immediata degli interessi autentici – da più di un secolo combatte contro la politica, il dominio dei privilegiati per mezzo dell’inganno; noi socialisti appoggiamo la potente tendenza storica, che è destinata a condurre i nostri popoli verso la libertà e l’eguaglianza: lo facciamo, per quanto è possibile, risvegliando lo spirito e dando vita a molteplici realizzazioni sociali. Non intendiamo pertanto aver nulla a che fare con la politica di Stato. Tuttavia, se in futuro vedessimo risorgere forze contrarie allo spirito, l’autorità politica, grandi personalità, ossia politici forti di scopi ed energie, dovremmo comunque essere capaci di qualche rispetto per le figure che stanno in un altro campo, un campo nemico per noi, e domandarci onestamente, proprio in quel momento, se il potere del passato sia destinato ancora a una lunga esistenza. Sempre di più, tuttavia, vediamo – possiamo notarlo anche in altri paesi – che la forza dello Stato non risiede propriamente nello spirito e nell’autorità naturale dei suoi rappresentanti, bensì sempre più nel fatto che il popolo, anche la sua parte più scontenta, anche le masse proletarie, ignora del tutto che il suo compito è di prendere congedo dallo Stato e di edificare il Nuovo, che lo rimpiazzerà.
Da un lato, abbiamo il potere statale e l’impotenza delle masse frantumate in individui inermi; da un altro lato, vediamo organizzazioni socialiste, società di società, alleanze di alleanze, popolo. Ecco il contrasto che dovrebbe presentarsi in tutta la sua realtà agli uni e agli altri. Il potere dello Stato si indebolisce sempre più, così come il principio del governo e il carattere degli uomini che rappresentano il Vecchio. Tutto il sistema sarebbe irrimediabilmente morto, se il popolo incominciasse a costituirsi concretamente in quanto tale lontano dallo Stato. Ma i popoli non hanno ancora compreso che lo Stato conserva una funzione e rappresenta una ferrea necessità soltanto fino a quando non compare la realtà socialista, ciò che deve prenderne il posto. Un tavolo può essere rovesciato e il vetro di una finestra andare in frantumi; ma chi considera lo Stato una cosa o un feticcio che si possa distruggere mandandolo in frantumi è un inconsistente parolaio o un dogmatico adoratore di parole vuote. Al contrario, lo Stato è un rapporto, una relazione tra gli esseri umani, un modo in cui questi si collegano l’uno con l’altro. E lo si distrugge creando nuove relazioni, rapportandosi diversamente l’uno con l’altro. Il monarca assoluto poteva ben dire: io sono lo Stato. Noi, che nello Stato assoluto ci imprigioniamo da noi stessi, dobbiamo ammettere che in verità noi siamo lo Stato, e lo saremo fino a quando non saremo qualcos’altro, fino a che non avremo creato le istituzioni di un’autentica comunità, la vera società degli esseri umani.
(traduzione di g.r.)
Bibliografia
- G. LANDAUER, Ausgewählte Schriften, 15 voll., a cura di S. Wolf, Verlag Edition AV, Lich/Hessen, 2008-2019.
- G. LANDAUER, La rivoluzione, a cura di F. Andolfi, Diabasis, Reggio Emilia, 2009.
- G. LANDAUER, La comunità anarchica. Scritti politici, a cura di G. Ragona, elèuthera, Milano, 2012.
- G. LANDAUER, Per la storia dell’evoluzione dell’individuo (1895/96), a cura di F. Ferrari, Castelvecchi, Roma, 2017.
- G. LANDAUER, Appello al socialismo, a cura di G. Ragona, Castelvecchi, Roma 2019.
- G. LANDAUER, Esilio e anarchia. Scritti ebraici, a cura di L. Pisano, Castelvecchi, Roma, 2019.
- G. LANDAUER, Una strada per la liberazione dei lavoratori, a cura di G. Ragona, Edizioni Les Milieux Libres, Soazza (Svizzera), 2021.
- G. RAGONA, Gustav Landauer. Anarchico ebreo tedesco, Editori Riuniti UP, Roma, 2010.
- T. LEDER, Die Politik eines “Antipolitikers”. Eine politische Biographie Gustav Landauers, 2 voll., Verlag Edition AV, Lich/Hessen, 2014.

Clara Wichmann (1885-1922)
Edy Zarro
Agli interessati del movimento anarchico e libertario di lingua italiana, il nome della Wichmann probabilmente non dice nulla. Per quanto a mia conoscenza, un solo suo articolo è stato pubblicato in italiano e precisamente nel 1990 sulla rivista «Volontà», corredato da alcuni cenni biografici.
Pur essendo una teorica ed attivista di peso, impegnata in molti ambiti, il fatto di aver scritto i suoi testi in olandese non ha di certo facilitato la diffusione del suo pensiero al di fuori dei Paesi Bassi. Per fortuna, la madre ha tradotto parecchi suoi scritti in tedesco, che, pubblicati in varie riviste femministe e anarchiche, le hanno permesso di ampliare il raggio dei possibili lettori ed estimatori. Ora, a cent’anni dalla morte, è giunto il momento di farla conoscere, almeno sommariamente, anche al movimento di lingua italiana. Clara Wichmann studiò diritto a Utrecht, laureandosi nel 1912 con una tesi sulla trasformazione della nozione di pena. Durante i suoi studi universitari partecipò al movimento femminista. Dapprima nella Lega per il suffragio femminile, ma poi, più radicalmente, con articoli, dibattiti e conferenze a favore della liberazione delle donne. Riteneva che questa dovesse essere una liberazione sociale ed economica, per l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. Rifiutava l’idea di «donna vittima» e spingeva per una loro emancipazione interiore, affinché le donne rivendicassero la loro indipendenza e la loro dignità.
A laurea ottenuta, entrò nel mondo del lavoro. Dapprima per un breve periodo esercitò come avvocata, poi si trasferì all’Aia quando fu assunta presso l’Ufficio centrale di statistica, divenendo la responsabile delle statistiche di criminologia.
Questa attività le permise di avere una visione generale e approfondita del sistema giudiziario, dell’applicazione delle punizioni e del sistema carcerario. Sostenne che il diritto penale doveva essere abolito, poiché il crimine deriva nella stragrande maggioranza dei casi dall’ingiustizia sociale e la punizione va considerata un atto di rappresaglia della società nei confronti di chi «sbaglia». Il che non è di certo un sistema per rendere giustizia alla vittima e neppure al «criminale».
Nel 1919 Clara fondò il Comitato d’azione contro le nozioni di crimine e di punizione, redigendone lo scritto fondatore e per mezzo di questa organizzazione combattè l’istituzione penitenziaria in quanto tale. La Wichmann auspicò che, anziché reprimere brutalmente i criminali tramite la prigione con un sentimento di vendetta, si poteva intervenire con la comprensione e con soluzioni di lunga portata che dovevano coinvolgere l’educazione e la pedagogia.
Nel frattempo Clara era entrata in contatto con il movimento anarchico olandese e iniziò a collaborare con Bart de Ligt, dapprima nella Lega dei socialisti cristiani, successivamente nella più radicale Lega degli anarco-comunisti religiosi. Benché non avesse avuto un’educazione religiosa, la Wichmann mantenne sempre uno spirito aperto sia verso la corrente libertaria atea che la corrente libertaria religiosa.
Anche in questo ambito, contribuì con articoli e scritti teorici, in particolare una Teoria del sindacalismo, apparsa nel 1920, in cui sostenne che il sindacalismo rivoluzionario doveva essere più di un semplice principio di organizzazione, doveva divenire una concezione dell’intera società e metodologia di lotta, arricchendo lo scritto con considerazioni sul diritto da un punto di vista anarchico. Sotto quest’ultimo profilo, distinse tra diritto consuetudinario e diritto basato sul libero accordo (diritto contrattuale), accettabili da parte degli anarchici, e il diritto statuale, basato sull’autorità, al contrario giustamente criticato e combattuto dai libertari, perché fonte di sopruso, di dominio e di ingiustizia.
Ma la collaborazione con l’anarchico Bart de Ligt verteva anche sull’antimilitarismo radicale e l’appoggio agli obiettori di coscienza incarcerati durante la Prima guerra mondiale. In quest’ambito, conobbe anche il futuro marito, Jo Meijer, condannato a dieci mesi di prigione per la sua opposizione alla mobilitazione.
Nel 1921 a Bilthoven vicino a Utrecht i tre furono tra i fondatori della War Resisters’ International (l’Internazionale dei resistenti alla guerra), di cui Jo Meijer diventerà il primo segretario. L’organizzazione esiste tutt’oggi.
Anche nel contesto del movimento antimilitarista, Clara ebbe modo di distinguersi. Fu infatti teorica e fautrice di un’azione non-violenta attiva.
Pur riconoscendo, nel corso della storia umana e sociale, l’aspetto emancipatorio della violenza nella resistenza all’oppressione e al dominio, la Wichmann ritiene che si debba imperativamente agire in un modo diverso, non con l’astensione passiva alla violenza del potere e del sistema economico, ma sostituendo la reazione violenta con azioni non-violente, più ragionate, più mirate, più proficue nel lungo periodo. Insomma, Clara esortò a non scegliere come prima opzione la risposta violenta, ma a preferire di agire in modo più adeguato all’ideale libertario. Per questo, pose come condizione ineludibile la conformità tra i mezzi e il fine, sconfessando il detto ancora diffuso che «il fine giustifica i mezzi».
Con questa esortazione, auspicò dei comportamenti più umani, delle relazioni migliori come passi decisivi in direzione di una società più giusta e meno escludente. In questo reinterpretò il pensiero di Lev Tolstoj e dell’anarchico pacifista e anticlericale Eugen Heinrich Schmitt (1851-1916).
Clara Wichmann si interessò e scrisse anche di pedagogia, con una preferenza per il sistema Montessori. Rivestono un interesse particolare e curioso anche i suoi scritti sul diritto degli animali domestici. Oggi i diritti degli animali selvatici sono generalmente riconosciuti, semmai difettano nella loro applicazione: ne sono testimonianza le leggi a loro protezione e volte alla loro reintroduzione negli ambienti dai quali sono scomparsi a causa dello sterminio praticato dagli umani. Anche gli animali d’allevamento sono oggetto di leggi. Mentre gli animali domestici sono considerati solo marginalmente da queste legislazioni. Wichmann considerava che questi animali intrattengono una relazione con i loro proprietari umani molto più importante di quella con i loro simili e questa situazione li rende molto più dipendenti e sottomessi. Clara sostiene persino provocatoriamente (?) che questa sia una situazione simile a quella delle donne, dei bambini, degli schiavi e dei popoli sottomessi.
Clara Wichmann morì giovane, a soli 36 anni, poche ore dopo aver dato alla luce la sua unica figlia Hetty. Il marito, Jo Meijer, cercò di tenere viva la sua memoria e il suo pensiero, curando e dando alle stampe alcune antologie dei suoi scritti in olandese, ma va anche rilevato che negli ultimi anni sono stati pubblicati alcuni libri, biografie e antologie, in tedesco e in francese.
A conclusione di queste poche righe si può dire che gli argomenti affrontati, analizzati e sostenuti da Clara Wichmann (femminismo, diritto e giustizia, opposizione al sistema carcerario, antimilitarismo, non-violenza attiva) sono sempre presenti e ritenuti importanti, perché non ancora risolti, dal movimento anarchico e libertario contemporaneo. E che dunque i suoi scritti e il suo pensiero possono essere di aiuto per nuove soluzioni attuali.
Bibliografia
- T. HOLTERMAN, L’anarchisme au pays des provos. Constantes, organisations et force critique des libertaires hollandais, Atelier de Création Libertaire, Lyon, 2015 (in particolare pp. 44‐54).
- E. SMOLENAARS, Passie voor Vrijheid. Clara Wichmann (1885–1922), Verlag Aksant, Amsterdam, 2005.
- C. WICHMANN, Der Weg der Befreiung. Texte über aktive Gewaltlosigkeit 1917‐1921, Hrsg. von Gernot Jochheim, Verlag Weber‐Zucht & Co, Kassel/D, 1989.
- C. WICHMANN, Textes choisis, Les éditions libertaires, St‐Georges‐d’Oléron, 2016.
- C. WICHMANN, Vom revolutionären Elan: Beiträge zu Emanzipationsbewegungen 1917-1922, Hrsg. von Renate Brucker, Verlag Graswurzelrevolution, Heidelberg/D, 2018.
- C. WICHMANN, Scritti su non-violenza, giustizia e anarchia, Les Milieux Libres Edizioni, Soazza/CH (di prossima pubblicazione).

https://semisottolaneve.net/ semisottolaneve@riseup.net
Facebook: Semi-Sotto-la-Neve-Rivista-Libertaria Instagram: semisottolaneverivista
Collettivo di redazione Marco Antonioli, Francesco Berti, Anna Lisa Bertolo, Francesco Codello, Valeria Giacomoni, Maurizio Giannangeli, Luciano Giugno, Gloria Lanza, Francesco Mosca, Antonio Senta, Fiorenzo Urso
Progetto grafico: Marianna Rovere Logo e logotipo: Nicolas Lepel
Finito di stampare nel gennaio 2023
Il mondo del possibile si dilata

ISSN 2974-5632 7 euro