Numero Completo 02

Editoriale
Nel momento in cui chiudiamo il secondo numero della rivista, ancora lontana appare la fine della guerra in Ucraina, iniziata il 24 febbraio con l’invasione da parte dell’esercito russo del territorio ucraino. Molte, forse troppe parole sono già state spese su questo conflitto che, come tutte le guerre, segna naturalmente una sconfitta del genere umano e della civiltà, qualunque significato si voglia dare a queste espressioni.
Consci della difficoltà di sviluppare riflessioni penetranti, desideriamo proporre un’analisi di ampio respiro e alcuni spunti di approfondimento sul tema: troverete una interessante disamina dell’ideologia nazional-populista putiniana svolta da Sofia Tipaldou e un percorso di letture per adolescenti suggerito da Libri e formiche.
Al contempo, non vogliamo sottrarci al dovere di prendere una posizione il più possibile chiara, date le circostanze. È nelle corde della nostra rivista tentare di rafforzare lo spirito di libertà e solidarietà degli sfruttati e degli oppressi, in ogni luogo e sotto ogni regime. Sconcertati per le avvilenti contorsioni ideologiche del pensiero a cui stiamo assistendo da troppe settimane, ci teniamo a puntualizzare che, a nostro giudizio, nessuna equiparazione può essere accettata tra chi aggredisce e chi viene aggredito, tra chi proditoriamente attacca e chi cerca disperatamente di difendersi.
Il diritto alla difesa dall’ingiusta aggressione appartiene agli individui come ai popoli. Ogni pur doveroso e utile ragionamento sulle complesse cause del conflitto, sulla molteplicità degli interessi in gioco e le responsabilità di diversi attori locali, nazionali e internazionali, deve cedere il passo a quella solidarietà, umana, universale e libertaria, che non può che scattare nei confronti di chi difende la propria vita, la libertà e i propri beni, da un esercito invasore sospinto da un obiettivo chiaramente imperialista: conquistare o smembrare una nazione confinante, per accaparrarsi le sue risorse, costi quel che costi.
Diversi libertari e anarchici ucraini hanno scelto di contribuire alla difesa in armi dei propri cari e dei più elementari diritti. A loro va anzitutto il nostro fraterno abbraccio, che estendiamo con eguale intensità e affetto a quella coraggiosa parte della popolazione russa che, benché minoritaria, si oppone alle volontà conquistatrici della propria classe dirigente: un gruppo di potere che, godendo di un ampio consenso popolare, ha trascinato il paese e l’Europa in una spirale di violenza e di morte che deve al più presto cessare.
A chi ritiene di opporre a questo scenario purtroppo assai reale di devastazione morale e fisica e alla richiesta impellente di solidarietà concreta delle vittime, la visione, tanto dolce quanto astratta, di un mondo futuro che abolirà per sempre, insieme ai poteri economici e politici fomentatori di guerre e divisioni, frontiere e confini nazionali, ricordiamo l’imperituro monito di Aleksandr Herzen – una meta infinitamente lontana non è una meta, è un inganno – fatto proprio in tempi più recenti da Colin Ward, seminatore di libertà che fin dall’inizio di questa avventura editoriale abbiamo indicato come imprescindibile figura culturale e politica di riferimento. A Ward, esaltatore delle utopie concrete, e a Maria Luisa Berneri, studiosa delle utopie letterarie, accomunati da un libertarismo critico e fortemente antimilitarista, dedichiamo i profili delle nostre radici, curate rispettivamente da F.C. e A. Soto (al tema dell’utopia, in rapporto con la musica, è invece dedicato il frizzante contributo di Felice Liperi).
Ma se è necessario rifuggire dall’ideologismo irresponsabile ed avulso dalla realtà, occorre, al contempo, evitare di affossare valori e progetti di liberazione politica e sociale, individuale e collettiva, per allinearsi a una forma mentis volta a legittimare il triste status quo e ad accettare continue soluzioni di compromesso al ribasso. Ciò che deve essere opposto a una società ormai incapace di qualsivoglia desiderio di immaginazione politica e sempre più contrassegnata da una gretta materialità consumista, in cui ciascuno si pensa come bulimico titolare di diritti assoluti e insaziabili, non è un vuoto discorso retorico, privo di qualunque effettiva capacità di incidere nella realtà. La nostra società ha bisogno di un sapere davvero critico, prodotto da pensatori, scrittori e intellettuali che non si chiudono a riccio nei loro studi, ma sono capaci di costruire relazioni altre nel mondo culturale e hanno il coraggio creativo di attingere a pensieri e tradizioni differenti, purché libertari: come Goffredo Fofi, protagonista di una notevole conversazione con Francesco Codello.
Ciò che deve essere fatto valere contro un mondo che va esaurendo ogni spinta ideale e ogni senso di responsabilità sociale è la concreta esperienza di donne e uomini che hanno costruito realtà prefiguratrici di una organizzazione sociale diversa e migliore. Se la società, come scriveva Malatesta, è sempre il risultato di forze contrastanti che spingono in direzioni diverse, quando non opposte, ciò che può contribuire a spostare l’equilibro nella direzione da noi auspicata è, anzitutto, la forza dell’esempio concreto, che sola può essere davvero contagiosa.
Così, anche in questo numero, il lettore potrà, insieme a noi, interrogare una serie di esperienze che, a volte con difficoltà crescenti, costituiscono dei tentativi preziosi di dar vita a un microtessuto sociale e culturale informato a princìpi e pratiche affatto diversi da quelli vigenti. Franco Bunčuga, Thea Venturelli e Valeria Giacomoni ci portano in tre contesti molto diversi: i dintorni di Zagabria, Reggio Emilia e i sobborghi di Barcellona. Qui collettivi intraprendenti, nell’ambito della bio-edilizia, della finanza autogestita e dell’educazione libertaria, hanno dato vita a realtà la cui forza consiste, tra le altre cose, nella capacità di interagire con il mondo circostante senza perdere la propria identità e di mettersi costantemente in discussione.
La guerra non è naturalmente l’unico male che affligge il nostro mondo. La crisi ecologica, a cui sono dedicati due contributi diversi ma complementari di Simone Ogno e Marco Antonioli e A. Soto, impone un deciso cambio di rotta, politico ed economico, che non può che fondarsi su un diverso rapporto tra uomo e natura. Uno dei punti di partenza deve essere l’idea che la Terra è un bene comune che l’umanità condivide con le altre specie viventi, rispetto alle quali, come ci ha insegnato Bookchin, il genere umano deve porsi come autocoscienza morale. Ai beni comuni nel pensiero libertario è dedicato il puntuale approfondimento di Édouard Jourdain.
Dal pensiero all’azione: nostro preciso scopo è quello di diffondere la pratica della libertà, nella consapevolezza che le poche ma coriacee ginestre che sottoponiamo alla vostra attenzione non sono destinate a soccombere necessariamente sotto l’azione imperiosa di una natura matrigna e fatale. Possono crescere e moltiplicarsi, producendo cambiamenti tangibili.


Franco Bunčuga
A 25 km a sud di Zagabria perso nelle stradine sterrate nel bosco attorno al villaggio di Vukomeric a bordo di un taxi che si è perso più volte. Dopo aver chiesto indicazioni a diversi ignari contadini locali grazie a un trattorista arriviamo a un gruppo sparso di strane case dove scendo e proseguo a piedi in uno sterrato che porta ad un piccolo avvallamento nell’area collinosa. Su un cartello colorato attaccato a un vecchio furgoncino in disuso finalmente la scritta «eko-selo ZMAG», poi ecco appaiono degli edifici rurali ed il rumore degli attrezzi che Pero e i suoi amici stanno usando per lavorare il legno.
La «Zelena Mreža Aktivističkih Grupa», ZMAG1 (rete verde di gruppi di attivisti) è una organizzazione non governativa nata a nel 2002, che nel tempo ha realizzato un «eko-selo», un villaggio ecologico, adiacente al piccolo villaggio rurale di Vukomerić. Le attività dello ZMAG sono incentrate particolarmente sulla pratica e la promozione di soluzioni sostenibili, su programmi di istruzione e progettazione, sulla promozione e sviluppo di sistemi sociali ed economici giusti ed equi e sulle tecnologie appropriate. ZMAG è uno degli otto «Centri di studio per lo sviluppo sociale» in Croazia e si occupa, oltre che di tecnologie sostenibili per l’edilizia, anche dello sviluppo della permacultura ed ha recentemente iniziato a raccogliere una importante banca dei semi.
Pero Man e Ceki Cek, dopo aver terminato i lavori che stavano completando, mi accolgono convivialmente nel loro centro e mi
raccontano la loro storia e come sono diventati membri della cooperativa. Entrambi hanno iniziato a interessarsi alle attività di ZMAG una decina di anni fa. Pero è un tecnico informatico specializzato in gestione del network e non era soddisfatto del suo lavoro di ufficio in un’azienda a Zagabria. Aveva trascorso gran parte della sua vita in un villaggio, con altri ritmi ed immerso in un ambiente naturale e non sopportava più la vita cittadina e le sue nevrosi. Cercando alternative di lavoro su internet scoprì per caso lo ZMAG ed incuriosito si è iscrisse ad uno dei workshop che si tenevano a Vukomerić. Il centro era stato fondato da Matko Šišak nel 2002, quando aveva appena 19 anni e oggi è uno dei quattro soci della cooperativa. Era un periodo di grande fermento nel settore e nel 2012 quando Pero partecipò al workshop l’attività del villaggio era già molto sviluppata, si innamorò del progetto ed in breve ne divenne parte integrante e poi socio a tutti gli effetti.

Ceki Cek si è avvicinato a questa scelta di vita nello stesso periodo, ma con un percorso differente. Ceki aveva già partecipato a un gruppo di edilizia naturale ed aveva fatto riferimento ad un’altra realtà ecologica presente nella stessa zona, l’«eko-selo di Blatuša», anch’esso molto conosciuto in Croazia, nato con una caratteristica più neo-hippy, con influssi new age e spiritualisti. Anche alcuni militanti anarchici si sono saltuariamente avvicinati a Blatuša come Ceki che vi ha anche vissuto alcuni anni ed è in quel periodo che ha fatto le sue prime esperienze di costruzione in materiali naturali insieme a Goran Brumnic Mex, che adesso fa parte anche lui della cooperativa. I due si sono poi trasferiti allo ZMAG, un po’ perché il modo di vivere in quel villaggio e la loro ideologia non li convinceva, non si trovavano in sintonia con i membri della comunità di Blatuša eccessivamente influenzati dal loro «guru» e fondatore che insisteva in un approccio di tipo spiritualista, ma soprattutto perché lì non potevano mettere in pratica le loro capacità costruttive.
Nell’attuale gruppo ZMAG solamente Ceki proviene dalla militanza anarchica, così come Siniša Pocrnčić che faceva parte del gruppo originario di costruttori e che poi, dopo una lunga malattia invalidante, si è staccato dal gruppo ed ha intrapreso un’altra strada individuale. Entrambi sono ancora membri del MASA, una rete di iniziative anarchiche croata molto attiva nelle lotte sindacali come in quella recente dei portuali di Fiume, ma presenti anche a Zagabria dove anni fa hanno gestito le occupazioni studentesche dell’università, così come a Spalato ed in altri centri minori. Ceki ha partecipato da protagonista nelle lotte studentesche ed è stato molto attivo nel movimento sindacale in quegli anni a Karlovac e a Zagabria dove insieme al MASA ha organizzato alcuni sindacati di categoria indipendenti. Poi come ci racconta «mi sono stancato di impiegare tutte le mie energie ad organizzare la lotta per combattere contro il sistema e contemporaneamente non ne potevo più della vita urbana. Allora ho cercato altro». Ceki ha scelto di partecipare allo ZMAG quan-
do si è reso conto che i principi fondamentali praticati nell’associazione erano molto vicini a quelli anarchici in cui si riconosce: la gestione assembleare, le decisioni all’unanimità, il forte senso di collettività ed il rifiuto dello sfruttamento del lavoro che fanno in modo che tutto venga gestito in modo comunitario ed orizzontale. Pero ci riassume molto bene lo spirito del gruppo:
Noi tutti abbiamo obiettivi molto simili a quelli che sono i fondamenti anarchici
«Io non sono un anarchico, ma qui ho conosciuto molte persone davvero interessanti e mi sono reso conto che noi tutti abbiamo obiettivi molto simili a quelli che sono i fondamenti anarchici. E questo è ciò che conta, le differenze tra noi è proprio ciò che rende la nostra attività più interessante, relazionarsi solo con persone troppo simili a sé stessi diventa noioso».
Come Pero, anche Ceki non viene da una formazione specifica nell’edilizia, in realtà la sua prima esperienza di costruttore l’aveva fatta da giovanissimo quando aveva partecipato alla costruzione della propria casa insieme alla sua famiglia, tradizione ancora viva nella regione sino a poche decine di anni fa. In quell’epoca costruirsela da soli era l’unico modo per avere una casa. Sino a trenta o quaranta anni fa la tradizione di costruirsi la casa insieme alla famiglia e agli amici in quelle zone era la norma. E se si ha una grande famiglia tradizionale è una pratica ancora molto comune. Anche nei villaggi nel nord della Croazia da cui proviene Pero esiste tuttora un forte senso di comunità, «se vedo che i miei vicini stanno lavorando vado ad aiutarli, non c’è bisogno che loro me lo chiedano, è una cosa normale che viene spontanea», ci dice, e anche se oggi queste forme di autocostruzione sono state dichiarate illegali e si è cercato di sradicarle, tuttora permangono. Certo il sistema tradizionale di costruzione in legno ad incastri vivi senza leganti, facilmente assemblabile e smontabile per trasferirlo in altri siti non è più in uso, si sono perse le competenze.
Quello che cerca di fare l’associazione è recuperare le tecniche tradizionali alla luce delle nuove conoscenze tecnologiche, dei nuovi materiali e dei nuovi strumenti, usando per quanto possibile materiali naturali e sfruttando le competenze ancora presenti di autocostruzione e di mutuo appoggio delle comunità locali. In modo pragmatico le autorità locali non hanno mai posto problemi burocratici particolari o significativi vincoli legislativi. La cooperativa si è data la forma di un’organizzazione non governativa (O.N.G.), senza alcuno sponsor ufficiale ed in poco tempo è diventata un marchio molto conosciuto in Croazia, una sorta di istituzione e non solo nel campo dell’edilizia naturale. Se si cerca ad esempio su internet la voce «permacultura in Croazia» ZMAG è il primo nome che appare nella lista. Le autorità locali coinvolgono volentieri la O.N.G. in progetti dedicati alla didattica, e spesso la invita nelle scuole a tenere ai ragazzi corsi di economia sostenibile o di sistemi di organizzazione di attività cooperative. «La città di Velika Gorica ha finanziato un progetto di due anni per gestire corsi sull’utilizzo e l’implementazione delle risorse locali che è stato elaborato all’interno dello ZMAG. Così sono andati a tenere corsi in diverse scuole della città. È un progetto che guarda al futuro e tenta di coinvolgere le nuove generazioni in progetti sostenibili».
La gestione economica della cooperativa è complessa e diversificata. Oltre ai fondi che derivano progetti affidati allo ZMAG dagli enti locali l’associazione riesce ad essere autonoma dal punto di vista economico grazie a molteplici e differenziate attività. In primo luogo i workshop sull’edilizia naturale che sono stati una delle ragioni fondanti del gruppo e poi soprattutto con l’intervento di diversi investitori. La cooperativa si rende disponibile ad aiutare chiunque abbia la necessità di costruire e scelga le tecnologie naturali e fornisce le sue competenze e la propria mano d’opera, sia collaborando a forme di autocostruzione, sia gestendo in modo autonomo il cantiere per chi non avesse voglia o tempo di partecipare ai lavori in prima persona. In questo secondo caso la
cooperativa chiede compensi in linea col mercato. Il ricavato poi viene riversato in altri progetti non remunerativi della cooperativa, ad esempio facendo un mese di volontariato nella regione di Zagabria nei luoghi colpiti recentemente dal terremoto. In quella occasione ZMAG ha consolidato e riparato una cinquantina di case in quattro diversi villaggi della zona. Le tecniche che la cooperativa utilizza variano a seconda delle esigenze particolari e delle richieste della committenza, fondamentalmente strutture in paglia e legno, ma lo ZMAG continua a sperimentare nuove tecniche, come in un villaggio nei dintorni di Spalato, dove ha realizzato il suo primo edificio in canapa per conto di un architetto che sta progettando un sito dedicato alla permacultura.

Lo ZMAG nel tempo ha approfondito sempre di più il suo interesse per la permacultura sino a far diventare il settore uno dei più importanti tra le sue attività. E tutto questo in modo molto naturale, come ci spiega Pero: «In ciò che oggi si definisce permacultura ero inserito da sempre, senza averne l’idea, quando aiutavo mia madre nel nostro giardino o andavo nei campi con mio padre. Sono cresciuto in un piccolo villaggio in una zona profondamente rurale, il modo in cui da sempre la popolazione locale si rapportava all’agricoltura aveva gli stessi principi di quello che oggi viene definito permacultura. Tutti quelli della mia generazione che hanno avuto un legame con la vita di villaggio sanno cosa si intende quando si parla di permacultura. Quello che io e Ceki abbiamo sperimentato nella nostra infanzia e che veniva tramandato da generazioni era perfettamente in sintonia con i caratteri della permacultura». Sia Pero che Ceki nelle esperienze allo ZMAG, cosi come prima nell’eco-villaggio Blatuša, in realtà non hanno fatto altro che cercare di condividere e mantenere vive le loro conoscenze tradizionali che derivavano dalla pratica comunitaria ed innestarle in progetti innovativi.
Lo ZMAG ha anche allestito una banca dei semi molto attiva. Il gruppo di giardinaggio della cooperativa da più di cinque anni raccoglie specie antiche di semi, le immagazzina in situ, usa i propri orti per piantare i semi e riprodurli in modo da ruotarli e mantenerli sempre freschi. Vengono raccolti soprattutto semi rari e particolari che appartengono a specie vecchie anche di due o trecento anni. La cooperativa ha relazioni con altre banche in tutta la Croazia per fare scambio di semi rari o semplicemente venderli ed acquistarne altri.
Un’ulteriore attività che ZMAG organizza è una rete di «food for goods», in sostanza mette in relazione piccoli produttori locali ecologici in tutto il paese attraverso una pagina web su internet dove si possono ordinare differenti prodotti dalle varie aziende, in genere a conduzione familiare e una volta alla setti-
mana vengono distribuite cassette con la merce ordinata a Zagabria e in altre città. Gli addetti dello ZMAG controllano che tutte le produzioni siano naturali e biologiche per poter fornire cibo salutare.
La dimensione didattica è uno degli elementi costitutivi di ZMAG sin dalla sua fase iniziale. Insegnare alle giovani generazioni che esistono mezzi di costruzione naturali e che si possono creare forme associative comunitarie efficienti è molto importante. Ai workshop che sono il cuore pulsante dell’associazione partecipano persone di ogni tipo ed età. All’inizio prevalevano gli hippy e gli alternativi ma ora sono sempre più presenti persone comuni, uomini di affari e ultimamente un sempre maggior numero di architetti, di ingegneri edili, di esperti nelle costruzioni di ogni tipo. I workshop organizzati da ZMAG prevedono corsi dalla durata di quattro giorni da giovedì a domenica, a inizio di maggio, metà giugno e a fine luglio. Tutte le attività vengono gestite liberamente dai corsisti con la consulenza diretta dei membri della cooperativa. È un’esperienza di lavoro veramente intensa che lascia poco spazio alle lezioni teoriche, si usa soltanto materiale che prodotto per lo scopo nel sito e che poi viene riciclato. Non mancano i momenti conviviali, dei grandi banchetti con grigliate collettive, musica e grandi discussioni. Uno degli scopi dell’iniziativa è anche quello di creare una rete di costruttori naturali che restino poi in contatto tra di loro. Molti partecipanti di anni diversi poi hanno creato relazioni autonome tra di loro e creato nuovi progetti.
ZMAG è in crescita e sta cercando di coinvolgere altre persone
ZMAG è in crescita e sta cercando di coinvolgere altre persone, soprattutto giovani per sviluppare ulteriormente le attività. Attualmente oltre ai quattro soci nella cooperativa lavorano altre nove persone che ricevono un salario dallo ZMAG ma solo per funzioni particolari e in relazione a progetti specifici, non sono dipendenti. I soci, come Pero e Ceki prestano gratuitamente il proprio lavoro alla cooperativa e ricavano un reddito in modo individuale dalla partecipazione ai vari progetti a cui partecipa ZMAG, spesso finanziati da fondi statali o regionali, in particolare corsi, lezioni, conferenze e workshop. È un’attività separata da quella di costruzione. Ci sono anche persone pagate per seguire la parte amministrativa e burocratica delle attività così che il gruppo dei soci possa dedicarci completamente al settore edilizio. Una parte importante infatti delle entrate della cooperativa proviene dai singoli progetti di edilizia che i quattro soci realizzano soprattutto per committenti privati di vario genere, attività che si affianca alla realizzazione ed al miglioramento degli edifici sul sito.
Gran parte dei terreni del villaggio sono di proprietà privata di Marko e Goran, gli altri due soci della cooperativa che li hanno concessi in usufrutto gratuito alla ONG per trent’anni. I due proprietari hanno costruito le loro case sul terreno e lì risiedono mentre Ceki e Pero abitano nelle vicinanze. Ceki ha 53 anni e già ha in mente un progetto per la sua vecchiaia, per quando andrà in pensione, quello di costruire nel sito un grande edificio multifunzionale per ospitare tutte le principali attività di ZMAG: le aule e le residenze per i corsisti, la banca dei semi, la biblioteca, gli uffici ma soprattutto una grande cucina comunitaria di cui lui sarà il cuoco. La cucina è già da oggi la sua grande passione ed è lui che prepara i pranzi nei grandi incontri conviviali. Nei villaggi attorno ci sono un gran numero di piccoli produttori artigianali di cibi naturali che possono rifornire le cucine. Oltre ai corsisti e agli ospiti di ZMAG sicuramente la mensa sarà molto apprezzata dai nuovi abitanti che stanno arrivando nella zona, soprattutto ragazzi giovani che lavorano in città che hanno iniziato a restaurare o costruire, spesso con l’aiuto della cooperativa, delle proprie abitazioni per risiedere in mezzo alla natura e che non hanno molto tempo per prepararsi da mangiare o sem-
plicemente vogliono godersi in pace il week end. Non un vero e proprio ristorante, ma cibo per la collettività.
«Il lavoro di costruzione che facciamo è davvero molto duro e con l’avanzare dell’età diventa davvero difficile mantenere i ritmi che esige. Bisogna essere in buona forma fisica e giovani per lavorare serenamente. Il gruppo è molto affiatato ma il lavoro è davvero molto impegnativo e coinvolgente. A
Il gruppo è molto affiatato ma il lavoro è davvero molto impegnativo e coinvolgente
volte ci sembra di essere in guerra», dice Pero, «siamo sempre in forte tensione e pronti a scattare. La cosa positiva e che ne siamo ben coscienti, riusciamo a gestire la cosa, anche quando abbiamo forti discussioni dopo poco cambiamo umore e ridiamo insieme. Chi ci vede lavorare a volte pensa che ci odiamo a morte». Quando si lavora per un padrone si fa quello che viene indicato e non ci si preoccupa più di tanto, nel lavoro collettivo si è sempre responsabili di ogni proprio atto. Non è così facile lavorare assieme, per creare un team così affiatato ci è voluto tempo e pazienza. In questo tipo di costruzione ci sono sfide continue e bisogna spesso essere in grado di improvvisare e fare la scelta giusta. Non sempre il gruppo lavora per un committente che affida loro il cantiere in autonomia, spesso costruisce insieme ad amici o conoscenti che hanno bisogno di aiuto per trasformare vecchi edifici. E soprattutto in questi casi i quattro devono spesso affidarsi all’improvvisazione e inventarsi soluzioni appropriate. È sempre tutto una novità, non esistono casi standard.
Ma anche quando i committenti sono dei professionisti i problemi non sono da meno. Quando Ceki ha visto per la prima volta il progetto della grande villa che il team sta costruendo per conto di un architetto si è messo le mani nei capelli, non esiste nessuna competenza progettuale in relazione alle costruzioni in legno o alle tecnologie naturali tra i progettisti. Gli architetti spesso fanno un progetto sulla carta e senza avere nessuna idea del processo costruttivo necessario alla realizzazione, nessuno nelle università glielo insegna. Per un edificio in un villaggio vicino la cooperativa non si è occupata della realizzazione della parte strutturale in legno, è stata chiamata solo per eseguire le pareti in paglia e fango. Quando Pero e Ceki sono venuti ad ispezionare la struttura finita in legno a due piani si sono accorti che si muoveva ed era con evidenza una struttura non sicura. L’architetto insisteva che dal punto di vista statico non c’erano problemi, ma la struttura non era d’accordo e si muoveva e non si potevano costruire le pareti. Ceki aggiunge che: «L’operaio che stava costruendo il camino non riusciva a lavorare perché una delle travi del tetto si muoveva e sbatteva contro la struttura. È un modo di lavorare davvero stupido, abbiamo dovuto aggiungere dei rinforzi per stabilizzare la struttura. Gli architetti non hanno alcuna esperienza pratica». Pochi, anche i professionisti, si rendono conto che nell’edilizia in legno e paglia il metodo di organizzazione del cantiere è completamente diverso: nei sistemi tradizionali si inizia dalle fondamenta e si sale sino al tetto, nelle costruzioni in paglia prima si sistema la struttura per posare il tetto e poi si completa con le pareti. Se la struttura non è ben ferma è impossibile poi aggiungere le pareti.

Forse è anche a causa di questa mancanza di competenze fornite dall’istruzione tradizionale che ai corsi dello ZMAG si iscrivono in numero sempre maggiore molti architetti. Anche perché ormai molti committenti o investitori richiedono agli architetti che nel progetto si usino questo tipo di tecnologie. Ed è fondamentale progettare in accordo con gli architetti per poter scegliere insieme a loro le soluzioni più appropriate per il loro edificio. Ogni progetto presenta problemi e soluzioni specifiche ed è importante avere architetti che siano al corrente delle problematiche di questo particolare modo di costruire.
Siniša Pocrničić (Inder Zlatkes) Una voce diversa
Sera, un bar in centro a Zagabria, mi incontro con Siniša Pocrnčić (più conosciuto con lo pseudonimo Inder Zlatkes), io bevo una birra, lui una bibita e intanto mi racconta come sono nate le prime radici delle esperienze di costruzioni in paglia nel gruppo, la sua scelta operativa individuale e le sue attività attuali.
Siniša mi racconta che il gruppo originario di costruttori naturali era nato nel primo decennio del secolo ed aveva una forte impronta libertaria ed uno stile di vita comunitario. Inizialmente si riuniva nella sua casa ed operava con le tecniche di autocostruzione con l’obbiettivo di creare un piccolo insediamento abitativo autocostruito ed autogestito. Siniša con Ceki ed altri partecipanti era un militante di una delle più importanti organizzazioni anarchiche croate molto attiva nelle lotte ecologiche, sociali e sindacali del paese, il MASA.
Siniša da giovane aveva visto in rete il sistema di costruzione elaborato da Simon Dale2 per la costruzione del suo ecovillaggio a Lammas nel Galles Occidentale e se ne era subito innamorato. Abbandonato il suo lavoro precedente in tutt’altro campo, gestiva da tecnico una serie di sale giochi, si immerge completamente nell’esperienza della comunità di Lammas dove apprende le tecniche di costruzione in paglia e fango dallo stesso Dale con il quale realizza anche alcune costruzioni e si appassiona alla permacultura praticata nel villaggio. Ritornato in Croazia, il suo obbiettivo è trasformare il suo gruppo di amici e compagni in un gruppo di autocostruttori con competenze nelle pratiche di edilizia ecologica, recuperando le antiche tradizioni di costruzione in legno locali con l’aggiunta delle nuove tecniche apprese da Simon Dale.
In quegli anni in Croazia si erano presentate delle condizioni favorevoli per questo progetto: a causa della nuova legislazione che tassava fortemente la casa di proprietà e rendeva molto facile per chi avesse un basso reddito perdere i propri beni per morosità, la gente aveva letteralmente il terrore di rimanere senza abitazione, ciò spingeva molti a ritrovare quelle radici di spirito comunitario che ancora resistevano e cercare metodi alternativi di abitazione. Oggi purtroppo il panorama sociale è molto diverso e non si può più contare su questa spinta. Furono gli anni in cui il gruppo di amici che abitavano insieme nella casa di Siniša iniziò a costruire le prime case, in una zona rurale collinosa a pochi chilometri da Zagabria disseminata da piccoli insediamenti, la cui tradizione di autocostruzione in legno tipica locale non era ancora andata perduta. Nei loro primi edifici costruiti ancora in modo sperimentale, come nell’edificio realizzato a Trkulije e mai completamente terminato, sventolava sul tetto la bandiera rosso-nera dell’anarchia. Dopo una lunga malattia invalidante, al suo ritorno Siniša si accorse che il gruppo aveva deciso di andare in direzioni che lui non condivideva più e da allora ha continuato la sua esperienza in modo autonomo.
Siniša ha scelto di aprire una ditta individuale ed entrare nel mercato della realizzazione di case in paglia e in legno che in
2 http://www.beingsomewhere.net/
Croazia da alcuni anni si sta rapidamente espandendo, non necessariamente per motivi economici. Siniša mi spiega: «Quando mi chiedono se la tecnica che io utilizzo sia più economica di quella più diffusa in cemento rispondo: si, certo, ma solo a condizione che tu abbia almeno dieci amici che ti diano una mano», come una volta, sino a pochissimi anni fa, era la norma nei piccoli paesini qui attorno in cui era diffusa soprattutto la forma di costruzione in legno tipica locale, che permette di utilizzare elementi modulari prodotti in modo autonomo e facilmente assemblabili e riciclabili in seguito per altre costruzioni. Queste pratiche sono state quasi completamente abbandonate e le condizioni sociali e attuali non consentono più di evocare uno spirito comunitario nelle nuove generazioni che recuperi questo modello di autocostruzione. «In questo periodo tutta la nostra società è molto più corrotta di quando abbiamo iniziato a immaginare la creazione di villaggi ecologici autonomi e anche l’impegno politico in campo libertario è venuto scemando. Bisogna lavorare con altri strumenti per tempi nuovi, elaborare tecniche semplici di autocostruzione che possano essere usate in tempi migliori, quando le occasioni lo richiederanno o lo renderanno impellente o semplicemente da chi non ha ereditato od acquisito competenze costruttive specifiche. Il recupero di queste capacità comunitarie può un giorno diventare una via di fuga praticabile da ambienti via via più inabitabili o per tempi più difficili in cui ricostruire comunità diventerà una necessità per la sopravvivenza. O semplicemente per ricreare una accettabile qualità di vita qui ed ora». Così mi dice Siniša che sta lavorando ad un manuale di autocostruzione in cui mescola la tradizione locale di costruzione in legno con le possibilità di stereotomia lignea di precisione fornita dai computer. Dalla tradizione locale prende l’idea di edifici realizzati completamente in parti lignee ad incastro montabili e smontabili molto rapidamente da un piccolo gruppo di operatori, alla quale aggiunge la potenzialità data dai programmi 3D di progettare e realizzare in maniera millimetrica incastri perfetti e produrre elementi costruttivi facilmente
tipizzabili. Una specie di puzzle ad incastro con un manuale tipo IKEA per permettere a chiunque, anche con pochi amici, di realizzare strutture complesse ed efficienti, diversamente modulabili, integrabili e facilmente riassemblabili. Il nome di questo sistema non è ancora stato deciso, Siniša ha in mente qualcosa come click-clack, che abbia un suono semplice ed onomatopeico. Un sistema di autocostruzione che convinca la gente di essere in grado in modo semplice di costruirsi l’alloggio. Un modo di recuperare il modo collettivo di costruire comunità e di provvedere alle proprie necessità elementari che è sempre esistito ovunque, basato sul mutuo appoggio e la cooperazione, senza bisogno di piani regolatori né di legittimazione da parte delle autorità.
Pero e Ceki rimproverano a Inder Zlatkes di avere seguito una via «legale» e di aver fondato una ditta individuale, lui rimprovera loro una gestione poco trasparente e di lavorare indifferentemente per chiunque gli proponga un lavoro, dalle istituzioni ai singoli investitori privati, in più utilizzando dei salariati, cosa che loro negano dicendo che i collaboratori sono assunti solo a progetto e per necessità specifiche. Due vie divergenti che in realtà hanno molti punti in comune, dalle tecniche costruttive al tentativo di recupero in chiave contemporanea di tecniche tradizionali. Tutti loro hanno dovuto fare i conti con l’affievolirsi dello spirito comunitario, della perdita delle competenze tradizionali nei piccoli villaggi ed anche con il mutare della società e dell’impegno politico e sociale degli ultimi anni e ciascuno ha dato una risposta personale ed accettato compromessi diversi con le istituzioni, ma lo spirito rimane simile, il desiderio di mantenere vivi i caratteri libertari presenti nella loro esperienza di costruttori e tramandarli rinnovati e più efficaci alle nuove generazioni. I risultati, come si vede dalla qualità dei loro progetti, sono davvero incoraggianti.
A Ceki Cek e Pero Man

MAG6: il denaro e la finanza come se la gente contasse qualcosa Espe
Thea Venturelli
A Reggio Emilia esiste da oltre trent’anni l’esperienza della MAG6, nata sul finire degli anni ‘80 per volontà di una quindicina di persone legate al movimento pacifista e non violento. Ciò che caratterizza fin da subito questa esperienza è la volontà dei fondatori e delle fondatrici di dare concretezza alla propria idealità, sperimentandosi in prima persona nel cominciare ad attuare immediatamente quella possibilità di cambiamento tanto auspicata. E così ciascuno mette mano alle proprie tasche e con questo denaro, con quello che hanno a disposizione, cominciano a sostenere la prima cooperativa sociale finanziata da MAG6, una comunità di accoglienza per minori produttrice di Parmigiano Reggiano. La MAG6 si struttura come cooperativa, qualcuno rinuncia al suo posto di lavoro stabile e garantito per dedicarsi in toto alla realtà nascente e, parallelamente al finanziamento dei progetti, cresce l’impegno a diffondere una differente cultura del denaro in un processo evolutivo del suo utilizzo. Nella consapevolezza della sua forza anche simbolica, lo sguardo sul denaro viene ribaltato guardandolo come strumento, non come fine. Uno strumento attraverso il quale cambiare la realtà che ci circonda sostenendo quelle progettualità che non remano contro i propri obiettivi, gli ideali, i desideri, la visione del mondo ma vanno nella stessa direzione apportando cambiamenti positivi nel contesto sociale in cui operano. Così il denaro diviene strumento utile a unire, collegare, creare relazioni. In quegli anni esistevano in Italia già altre esperienze di MAG che hanno certo contribuito a creare quella struttura che poi ha portato la MAG6 a essere quella che è oggi, in particolare la relazione con MAG Milano. Lo statuto originario è stato frutto di un’elaborazione collettiva anche visionaria, al punto da immaginare quello che non esisteva ancora, elemento di sorpresa anche per chi, nella storica Lega delle Cooperative, si è trovato di fronte sogni, desideri e prospettive considerate molto alte. Una dimensione anche utopica, che permette di vedere quello che non c’è per poterlo costruire seguendo una visione che sia traiettoria, non un punto di arrivo, in perenne confronto e rielaborazione. La scelta di organizzarsi come cooperativa va oltre il vantaggio fiscale che rende appetibile questa forma giuridica, nasce proprio dalla volontà di organizzarsi in maniera orizzontale, valorizzando il contributo di ciascuno. Di qui la decisione di rimanere sempre fuori dai grandi consorzi e aggregazioni per salvaguardare la propria indipendenza. Stesso approccio viene mantenuto con le istituzioni con le quali MAG6 ha occasionalmente collaborato, attraverso figure ponte consapevoli del valore trasmesso dalle pratiche della cooperativa, senza rincorrere mai vantaggi, agevolazioni o finanziamento di attività che creassero meccanismi di dipendenza
a discapito della libertà di azione.
Una dimensione anche utopica, che permette di vedere quello che non c’è
Quando è nata la MAG6 le richieste legali per creare una realtà che si occupasse di finanza erano molto più semplici. La cooperativa ha potuto iniziare le sue attività con le modeste disponibilità di chi ha iniziato questo percorso, ora non sarebbe più possibile. Nel corso degli anni, infatti, la
regolamentazione del micro-credito e della finanza mutualistica solidale ha subito numerosi adattamenti ma la grossa stretta è stata tra il 2014 e il 2016 con la riforma del testo unico bancario («tub») che ha causato un grande contraccolpo alla sostenibilità della MAG. L’introduzione di nuovi criteri, altamente restrittivi e vincolanti, ha condizionato enormemente la finanziabilità dei progetti e, con le nuove regole, delle ottanta realtà finanziate nel momento dell’approvazione del «tub», solo quaranta avrebbero risultavano essere rifinanziabili. Questo è stato un duro colpo per la sostenibilità perché, fino a quel momento, le risorse eco-
nomiche necessarie a tenere in piedi le attività erano date dagli interessi applicati sui prestiti effettuati. Il tasso di interesse a è sempre stato svincolato dalle logiche finanziarie ma è legato alle esigenze di gestione, in primis il sostentamento economico per il lavoro dello staff. Questo gruppo di lavoro è attualmente composto da 6 soci lavoratori, ognuno dei quali in contratto part time di quattro giorni settimanali. Ciascuno ha un ambito di applicazione prediletto ma comunque flessibile, non si lavora a compartimenti stagni e una riunione settimanale mantiene in costante e aggiornata condivisione e comunicazione il gruppo di lavoro sugli sviluppi e le attività. Questo gruppo è anche sede decisionale collegiale. L’assemblea è inoltre occasione di ulteriori attività dello staff dedicate sia alle dinamiche e allo stato delle relazioni di e nel gruppo, sia agli sviluppi e le prospettive del progetto MAG6. Il tempo impiegato in questo lavoro è estrema-
mente impegnativo, richiede molte energie e disponibilità individuali e collettive ma è un impegno fondamentale che porta risultati tangibili per la fiducia, il supporto, l’assenza di giudizio, la capacità di confronto e rispetto reciproci che favoriscono un percorso costruttivo del gruppo operativo.
Una visione sempre di concreta sperimentazione
In questo momento l’attenzione è particolarmente concentrata sulle prospettive, su cosa sarà la MAG6 in futuro ma in una visione sempre di concreta sperimentazione quindi definendone l’operatività da condividere poi con il consiglio di amministrazione («cda»).
Il «cda» è un organo differente dallo staff lavoratori, allargato a soci e socie esterne al gruppo dei lavoratori che viene in questo modo sostenuto e potenziato su base volontaristica; la suddivisione degli impegni è stabilita anche qui in base a sensibilità e attitudini personali, restando centrati nel costante sviluppo di pratiche utili a favorire una relazione di condivisione e apertura.

Un tempo il gruppo «cda» era più allargato, ora sono venute a mancare energie e questa è sicuramente una fragilità da affrontare e gestire.
Anche il gruppo dei lavoratori, lo staff, ha subito un ridimensionamento legato a scelte personali di chi ha deciso di cambiare vita: questo venir meno delle energie a disposizione del progetto non è stata reintegrata da nuovi inserimenti, anche per cercare di far quadrare i conti di gestione in un momento storico in cui diverse realtà finanziate si sono trovate in difficoltà e le riforme imposte a livello europeo hanno causato un aumento del lavoro burocratico. Come accennato in precedenza infatti, la riforma del «tub» ha determinato un grande spostamento nelle attività MAG6. Se da una parte la finanza dei grandi numeri non riconosce rilevanza sistemica - parole loro - alla finanza mutualistica e solidale, dall’altra ha dovuto comunque riconoscerne l’esistenza, creando riserve giuridiche ad essa dedicate dopo averle addirittura interpellate e coinvolte. Questo coinvolgimento non
ha portato risultati costruttivi, ma si è trasformato nel più ostacolante tra i numerosi sgambetti subiti nel corso degli anni. Ora la finanza autogestita è stata pesantemente normata, è stata comunque posta sotto il controllo della Banca d’Italia e ha un tetto minimo di capitale sociale richiesto per poter essere riconosciuta, che ammonta a 250 mila euro. Se questo fosse stato in vigore quando la MAG6 ha iniziato, non avrebbe potuto iniziare le sue attività o, almeno, non avrebbe potuto farlo nella modalità in cui ha operato. La credibilità del gruppo originale è stata data anche dal mettere immediatamente in gioco se stesso, nel cominciare ad applicare quello che veniva proposto come pratica cioè utilizzare il denaro come strumento per creare rete e relazioni. La fiducia che ha portato alla costruzione della rete è stata data dall’evidenza della sua applicabilità, della sua fattibilità e degli effetti positivi raggiunti per quella cooperativa che operava sul territorio e questo ha dimostrato l’affidabilità delle persone coinvolte e la realizzabilità di una tensione ideale. Ha dimostrato che le fideiussioni patrimoniali non sono l’unico (e nemmeno il più efficace) strumento per assicurare la responsabilità di chi decide di farsi garante di una progettualità e che le soluzioni ai problemi arrivano mettendo invece in gioco la propria consapevole disponibilità a creare alternative. Così le persone hanno acquistato fiducia e interesse, in una rete sempre più estesa, e hanno messo a disposizione le loro risorse monetarie. Il lavoro da fare oggi sarebbe esattamente l’opposto: prima chiedere fiducia su una base teorica e ideale, raccogliere il denaro e poi operare. Uno stravolgimento non indifferente per chi mette in primo piano l’esigenza di concretezza, la volontà di creare sperimentando.
Non stupisce certo che l’istituzione finisca per fare sgambetti normando: per funzionare, per perpetuarsi ha bisogno di controllo e standardizzazione. Ma la standardizzazione è esattamente l’opposto di quanto necessario per lavorare sulle relazioni: ogni progetto presentato, ogni realtà finanziata ha le sue proprie caratteristiche e necessità e il lavoro di accompagnamento della MAG6 nel finanziare i progetti, nel crearne la sostenibilità è un lavoro di sartoria, cucito su misura. Se al centro abbiamo le relazioni, se al centro mettiamo le persone, inevitabilmente si è in contrapposizione con la standardizzazione. Tenere al centro la relazione, il rapporto con le persone delle realtà finanziate, il gruppo che le porta avanti, è un lavoro che richiede tantissime energie e responsabilità da entrambe le parti, richiede reciprocità. La MAG6 non è prestazione di servizio, non è erogazione di credito, ma è un’impresa di comunità, crea benessere e vantaggi non solo per chi partecipa nei progetti finanziati o per chi ci lavora, ma anche per la comunità nella sua interezza. Oggi la priorità è quindi rafforzare un gruppo di lavoro affaticato, perché l’alternativa non si costruisce nel tempo libero, la convinzione è che ad essa vadano dedicate le migliori energie a disposizione, anche lavorative, non solo volontaristiche o movimentiste.
La MAG6 ha osato rilanciare, rimettendo in circolo energie preziose
Coerentemente con i presupposti fondanti si vuole campare delle proprie idee, le forme di lotta si traducono in pratica quotidiana, in proposta realizzata. Se la MAG6 è riuscita a superare i momenti che avrebbero potuto stravolgerne il senso è stato perché ha goduto della rete costruita negli anni ma soprattutto perché in un momento drammatico ha osato rilanciare, rimet-
tendo in circolo energie preziose, aprendosi a possibilità e riattivandosi nel proprio centro. Valorizzando ulteriormente quella tensione pratica comunitaria fondante del progetto.
Così, per non far ricadere un ulteriore carico economico della gestione della MAG6 sui progetti finanziati è nato il progetto della sostenibilità condivisa: ogni socio e socia è invitato a sostenere le spese di gestione delle attività della MAG6 attraverso una liberalità che andrà a creare una sorta di fondo cassa utile ad abbassare il tasso di interesse sui prestiti. Questo passaggio ottiene almeno due risultati: il primo di rinforzare quell’economia di comunità cui tanto lavoro è stato dedicato, il secondo di co-
minciare a smuovere un nodo dolente che è stato sempre vissuto come criticità e che per i progetti finanziati ha comunque costituito un impegno non indifferente da sostenere. I progetti che si avvicinano per essere finanziati non hanno infatti l’obiettivo di arricchirsi, non sono attività d’impresa, ma piuttosto vogliono produrre ricchezza e benessere sociale senza sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano, e dello stesso sul pianeta: i ricavi ottenuti sono di conseguenza utili per vivere dignitosamente e il peso del tasso di interesse da rimborsare è spesso gravoso. Ma anche chi non avvia progetti, anche chi non richiede finanziamenti trae benefici per la propria vita quando il territorio si arricchisce in esperienze di autogestione libertaria. Così, per sostenere lo strumento della sostenibilità condivisa, non solo si invitano i soci alle liberalità, ma diverse realtà operative hanno deciso di destinare una parte dei loro ricavi, ottenuti dal rapporto con i soci, al progetto sostenibilità. Rafforzare la mutualità, ampliare il raggio di azione entro il quale agisce la comunità. Abbiamo così altre reti nella rete: le attività di consulenza e formazione, il gruppo d’acquisto solidale che mette ulteriormente in relazione le realtà MAG, la REPA (rete a prezzo agevolato, i cui aderenti applicano un reciproco abbassamento dei prezzi), la rete degli apicoltori e quella degli agricoltori, il grande confronto che è nato con la rete di «Campi Aperti» e con il circuito WOOF, il rapporto con diversi spazi sociali del territorio e non solo, la creazione e utilizzo di una moneta complementare (il BUS) attraverso la quale potenziare le possibilità individuali e collettive di accesso alla ricchezza creata nella rete di reti MAG6. Si stanno ulteriormente affinando pratiche di relazione con i soggetti finanziati valorizzando quanto non ha funzionato in passato e sperimentando possibilità altre, coinvolgendo in modo più consapevole e responsabile i garanti in modo da riequilibrare la diminuzione di forze disponibili nello staff. Al momento ci sono poche richieste di finanziamento nonostante numerosi avvicinamenti e la credibilità di cui gode la MAG, l’incertezza dei tempi genera cautela. Ciononostante i tassi di interesse su alcuni
progetti sono stati rivisti e ridimensionati per sostenere realtà in forte difficoltà: queste decisioni vengono prese in accordo tra le parti valorizzando sempre, per quanto possibile, il senso di responsabilità reciproca fondamentale per la crescita e mantenimento di un progetto comunitario. Viviamo un tempo in cui la consapevolezza del valore della comunità è diventata chiara e visibile, l’invito al sentirsi comunità arriva anche da fonti che lavorano nella direzione di distruggere il tessuto sociale più che di rafforzarlo. In ambito storico e antropologico, nelle scienze naturali è un continuo fiorire di ricerche volte a riconoscere che l’essere umano, e non solo, ha potuto superare i momenti più difficili e pericolosi della sua storia grazie alla solidarietà reciproca, a quel mutuo appoggio di cui noi libertari possiamo farci vanto grazie alle straordinarie intuizioni verificate scientificamente dal grande Kropotkin. Eppure manca l’esperienza della pratica della reciprocità, siamo ancora in una dimensione teorica che ha bisogno di sperimentarsi attuandola: veniamo da secoli in cui questo

è stato contrastato, represso, condannato ma rimane comunque insita nell’essere umano la consapevolezza del bisogno di comunità per sopravvivere. Allora, cosa facciamo, come decliniamo nel quotidiano questa consapevolezza inibita da un’educazione che ci ha portati in direzione opposta, da un’organizzazione sociale, politica, economica che continua a premiare l’individualismo e trae straordinario profitto dal divide et impera, dal farci sentire soli con noi stessi, con i nostri limiti e problemi troppo spesso troppo grandi per trovare soluzioni vitali e non di mera sopravvivenza? Quello che propone MAG6, quello che pratica, è la possibilità che ci sia ben altro oltre l’economia di mercato, che si possono creare imprese di comunità pubbliche, collettive, aperte a tutti coloro che di questa comunità scelgono di fare parte, in cui l’accesso ai bisogni primari e alla soddisfazione dei desideri sia svincolato dalle possibilità economiche individuali ma sia un bene condiviso e accessibile. Dimensione della cura, la cura della comunità in cui si vive e opera, la costruzione e rafforzamento di strumenti economici e sociali, di ampliamento della consapevolezza sono la base su cui costruire una differente organizzazione sociale più ricca e soddisfacente per tutte.
Un grande ringraziamento a Enrico e Mariangela di MAG6 per la disponibilità, la cura e la determinazione che hanno condiviso permettendomi di raccontare anche con le loro parole.
Per chi desidera approfondire la vita e la struttura della MAG6: www.mag6.it

La «Pinya», collettivo di autogestione educativa Espe
Valeria Giacomoni
È possibile un progetto di scuola che non coinvolga solo i bambini ma anche gli adulti nel processo educativo? In cui anche i genitori possano sostituire gli insegnanti perché hanno costruito insieme le dinamiche educative?
A Barcellona funziona da quasi vent’anni un progetto con queste caratteristiche, che si definisce «collettivo di autogestione educativa» e parte proprio dall’idea di prendere decisioni collettive: condividere la responsabilità pedagogica per non delegare la questione educativa a degli specialisti. Si parte dal concetto che educare implica anche educarsi: non si tratta quindi di una semplice escuelita che si prende cura dei bambini, ma alla «Pinya» (questo il nome del progetto) ci si prende cura di tutto il gruppo, adulti e bambini. La creazione di uno spazio educativo orizzontale, in cui si rispetta il processo di crescita di ognuno, è una scelta che punta alla trasformazione sociale. Il progetto ha sede in uno spazio occupato, mantiene relazioni con i maggiori centri sociali a Barcellona, e partecipa a mobilitazioni e scioperi riconoscendo la trasversalità della lotta per l’emancipazione sociale. Si inserisce in un quadro di lotta attiva contro le istituzioni statali, e contesta l’educazione ufficiale che aspira a perpetuare gli equilibri di una società neoliberale.
Uno dei punti su cui lavora di più il collettivo è proprio il disfarsi dei condizionamenti della società nella quale siamo immersi, sia nell’educazione dei più piccoli sia nelle relazioni interpersonali. Non riprodurre gli schemi di una società capitalista e patriarcale è uno degli obiettivi più chiari del progetto e anche dei più impegnativi, tenendo in conto quanto tutti li abbiano assimilati.
Decostruzione e costruzione
Il lavoro di decostruzione di abitudini, comportamenti e mentalità è un processo continuo sia a livello di gruppo sia a livello personale, che interroga perennemente la quotidianità e le dinamiche relazionali. Questo è l’impegno che viene richiesto ad ogni persona che fa parte del collettivo: la disponibilità a mettersi in discussione e ad approfondire temi considerati fondamentali (come per esempio le questioni di genere) attraverso il dibattito in assemblea; ma anche attraverso corsi di formazione con persone esterne al gruppo, giornate di riflessione sul tema con altri collettivi, invito di osservatori alla «Pinya» per ricevere un feedback sulle dinamiche interne. Questo è l’approccio che caratterizza il progetto: non c’è una linea da seguire a priori e si vuole evitare che venga accettata acriticamente l’opinione di

chi magari si intende di più di un determinato tema. Per questo motivo si spinge ognuno a esprimere il proprio parere sull’argomento per poi confrontarsi e costruire insieme un pensiero condiviso. Spesso chi non ha grande conoscenza di un tema evita di entrare nella discussione e lascia prendere le decisioni agli altri; qui si
Alla «Pinya» l’apprendimento è un’attitudine collettiva, multidirezionale e reciproca
cerca di ovviare a questo meccanismo, caratteristico di una società in cui la delega agli specialisti è la normalità, coinvolgendo l’intero gruppo in un processo che porta a una coscienza collettiva. Alla «Pinya» l’apprendimento è un’attitudine collettiva, multidirezionale e reciproca: i bambini imparano dagli adulti, gli adulti dai bambini, ma soprattutto i bambini imparano tra di loro.
Con questo metodo tutti gli adulti contribuiscono a costruire l’approccio educativo e non ci si affida semplicemente alla sensibilità o alle competenze degli «insegnanti»: sviscerando temi e proposte insieme, tutti gli adulti sono considerati alla pari degli educatori e a essi possono sostituirsi, come effettivamente fanno in molte occasioni, sia in situazioni di emergenza (coprire assenze, malattie) sia per l’organizzazione di gite, colonie estive, campeggi.
La costruzione del progetto è avvenuta a partire dalle conoscenze ed esperienze delle persone coinvolte, aggiungendo elementi di altre iniziative pedagogiche ritenuti convincenti. Questa base, sommata alla costante attenzione ai processi che vivono i bimbi, costituiscono gli strumenti con cui far fronte alle situazioni e alle necessità che sorgono nella quotidianità. Per questo l’assemblea è fondamentale in quanto luogo e momento in cui si definiscono le pratiche che formano la «Pinya». L’importanza ed il rispetto dell’assemblea, spazio di riflessione, dibattito e impegno collettivo è ciò che ha permesso al progetto di plasmarsi in quanto tale e di progredire.
Sviluppo del progetto
Il progetto è nato nel 2003 in un centro sociale emblematico in città a Barcellona, ma con lo sgombero del locale ha cambiato varie sedi cercando un luogo adatto con uno spazio esterno. Nel 2007 approdano a «Can Garrofa», masseria occupata dopo anni di abbandono e utilizzata dalle persone del quartiere come sede di diverse associazioni. «Can Garrofa» si trova a Esplugues, nella cintura periferica metropolitana: non è strano nell’immensa periferia urbana di Barcellona trovare ancora questi vecchi edifici, testimoni di un passato agricolo non troppo lontano, spesso soffocati dalla costruzione di strade o moderni palazzi. Se ne possono vedere vari esempi anche arrivando dall’aeroporto del Prat, a mezz’ora dal centro della città. Il contatto con la natura è quindi assicurato da questo ambiente privilegiato in cui la comunità educativa dispone di un giardino dove correre, osservare, costruire, dove ci sono alberi da scalare e un orto in cui sperimentare.
L’approccio educativo, come accennato, si nutre di diverse provenienze e soprattutto si costruisce nel lavoro quotidiano, pronti a mettere tutto in discussione. Il rispetto per il lavoro di anni di dibattiti, riflessioni e decisioni non dimentica che la vitalità è fondamentale per l’esistenza del progetto, che appunto è un collettivo vivo, in cui entrano ed escono persone continuamente. Questa flessibilità inizialmente non prevedeva una presentazione scritta del progetto per le nuove incorporazioni, perché aperti a un processo di costruzione permanente. Gradualmente però si è sentita la necessità di mettere nero su bianco il lavoro svolto fino al momento. Non perché ci siano aspetti che non si possono discutere, ma per capire come si è arrivati a ogni decisione e il lavoro che c’è dietro. Alcune metafore molto riuscite per trasmettere l’essenza del progetto parlano di passarsi la «fiamma pinyera» oppure di fare un delicato lavoro di «idraulica politica e pedagogica» in cui la «Pinya» è l’acqua e i tubi sono la capacità di trasmettere contenuti degli adulti. È importante «saper riconoscere le proprie radici per poter continuare a crescere, adattandosi alle necessità del momento».
Ed è proprio questo passaggio, di mettere nero su bianco, che permette al progetto di progredire, di non tornare sempre sugli stessi temi, di affrontare la sfida di pensare anche una scuola primaria vista l’età dei bimbi in crescita. Alle persone che si avvicinano per la prima volta alla «Pinya» si consegna un re-
È importante «saper riconoscere le proprie radici per poter continuare a crescere, adattandosi alle necessità del momento»
port della sua traiettoria fino al momento e si chiede un periodo iniziale di osservazione anche nelle assemblee, con l’appoggio di una famiglia di riferimento per capire meglio le dinamiche. Ad esempio anche solo il linguaggio utilizzato nella quotidianità può avere bisogno di un’introduzione.
Un lessico per l’emancipazione
L’obiettivo di smantellare i condizionamenti della società in cui siamo cresciuti passa anche attraverso il lessico che utilizziamo e alla «Pinya» si è riflettuto sull’utilizzo di parole che aiutino a uscire da dinamiche patriarcali. Ad esempio si è scelto di utilizzare tutti i plurali al femminile generico invece che al maschile (come nella maggioranza delle iniziative libertarie) e i genitori (in catalano pares, letteralmente «padri») vengono chiamati pamares (letteralmente «pamadri») per coinvolgere entrambe le figure in un termine inclusivo. L’attenzione alle questione di genere nello sviluppo di ogni bambina/o e le sue relazioni all’interno del gruppo offre l’occasione di prendere una chiara posizione sul tema dell’approccio più o meno «interventista» degli adulti. In una società in cui le disuguaglianze di genere influiscono sui giochi, sui comportamenti e sugli atteggiamenti dei bambini, alla «Pinya» si considera necessario intervenire per sviluppare atti-
tudini altrimenti represse dal patriarcato. Per «interventi» non si considera la lezione frontale o un’azione guidata dagli adulti, ma semplicemente provocazioni con materiali nelle sale, cambiamenti nella distribuzione degli spazi, proposte di attività o di un argomento all’assemblea, ecc. Un altro strumento utilizzato è il problematizzare gli stereotipi che si presentano, ad esempio se si sente dire che «questo è un gioco da femmine», chiedere cosa vuol dire che «è un gioco da femmine» o chiedere a diverse bambine e bambini: «ma a te piace giocare a questo gioco?». Si valorizza e sottolinea che ci sono molti modi di essere uomo e molti di essere donna, cercando di svincolare delle attività precise dal sesso di ognuno. Si definiscono le bambine e i bambini «socializzati come maschio o come femmina», coscienti del fatto che molti interessi nascono non tanto dalle attitudini personali ma dal percorso, dai giochi e dagli stereotipi che la nostra società impone ai maschi o alle femmine.

Un esempio è l’occupazione dello spazio esterno che spesso le bambine devono lasciare libero perché i maschi giocano a calcio. Il lavoro e le riflessioni portate avanti sul gioco del calcio sono state veramente tante finché si è cercato di cambiare dinamiche con degli interventi «provocatori»: un giorno ad esempio si è chiesto che per mezz’ora la palla la tenessero le bambine con grande delusione dei maschi ma con il risultato che qualche bimba ha poi affermato di aver imparato a giocare a calcio in quell’occasione. Inoltre dopo ogni partita si cerca di fare un momento di condivisione e, quando possibile, che un adulto/a faccia da arbitro.
Riferimenti storici
Non è associata alle questioni di genere invece la scelta della definizione di acompanyantes («accompagnatori») per gli educatori o insegnanti, ma a un cambiamento di prospettiva, di un passo indietro dell’adulto di fronte al rispetto delle tappe evolutive delle bambine/i che si rifà alle teorie di Montessori, Freinet, Piaget e alla «Nuova Educazione» in generale mettendo la bimba/o al centro del processo educativo. Nella pratica la «Pinya» non adotta un’unica linea pedagogica e utilizza strumenti e metodi di diverse teorie educative, costruendo la sua peculiare visione, tanto che una bella definizione colloquiale del suo metodo è Pinyassori.
Possiamo quindi considerare queste teorie tra i riferimenti storici della «Pinya», che però rivendica anche la sua base politica nell’esperienza catalana della Scuola Moderna di Ferrer (1901- 1906) e nelle scuole razionaliste sostenute dagli anarchici della CNT fino alla rivoluzione del 1936. Il processo storico che ha vissuto la Spagna nell’ultimo secolo è molto diverso da quello della maggior parte di Stati europei: la guerra civile spagnola (1936-39), prologo della Seconda Guerra Mondiale, ha portato a quarant’anni di dittatura di Franco e la transizione alla democrazia nel 1975 è avvenuta senza una condanna del regime
nazional-cattolico e senza un riconoscimento dell’interessantissimo tessuto sociale e culturale creato dagli anarcosindacalisti a inizio secolo. Rimangono molte questioni mai affrontate, e queste esperienze educative pioneristiche restano etichettate come politiche e non valorizzate, anche se sono state molto avanzate per l’epoca e fortemente legate al territorio.
La spinta all’orizzontalità e al rifiuto della delega della popolazione catalana è ancora presente nell’organizzazione delle feste di quartiere e nelle numerosissime associazioni presenti sul territorio. Dopo la transizione la creazione di centri civici con proposte calate dall’alto ha ostacolato la ricostruzione di un tessuto sociale di attivismo, ma negli anni ‘90 la capacità di reinventarsi del movimento libertario spagnolo, soprattutto a Barcellona, ha trovato nell’occupazione di case abbandonate una strategia per recuperare spazi comuni e abitativi. I metodi assembleari e l’apertura degli spazi al quartiere hanno permesso una sinergia tra diverse generazioni.
È proprio dal «movimento okupa» nei primi anni 2000 che nasce la necessità di creare uno spazio di socialità per i più piccoli che fosse coerente con il modo di vivere orizzontale e assembleare dei genitori. La «Pinya» infatti nasce come uno spazio di militanza e non solo come una critica ai metodi della scuola statale, ma come attività correlata alla vita che questi genitori stavano già mettendo in pratica. La dimensione politica dell’educazione è un concetto chiave del progetto della «Pinya» che rifiuta l’idea di una neutralità pedagogica. Questa convinzione porterà presto il progetto ad allontanarsi da altre sperimentazioni pedagogiche nate in quegli anni.
Definirsi anche attraverso le differenze
Infatti a Barcellona negli anni Duemila sono nati vari progetti che puntavano a un’educazione alternativa, sia per offrire un tipo di accompagnamento diverso, sia per mancanza di posti nella scuola statale (per bimbi dai 2 ai 6 anni inizialmente). È del 2007 la creazione della «Rete di Educazione Libera» (XELL, Xarxa d’educaciò lliure in catalano), di cui in partenza fa parte anche «La Pinya»; ma le differenze con le altre escuelitas non tarderanno a manifestarsi. La XELL gradualmente amplierà la sua rete di scuole fino ad arrivare a influenzare con i suoi metodi le scuole statali negli ultimi anni, ma non considera la scelta di aprire delle scuole alternative come scelta politica, tende piuttosto a parlare di un cambiamento basato sul benessere dell’individuo, di cura dell’anima (cuidado del alma), di filosofie orientali vicine allo yoga. È un po’ il discorso di curare sé stessi per stare bene al mondo, ma senza entrare nel merito di come questo mondo sia organizzato.
La «Pinya» gradualmente prenderà le distanze da questa «Rete di educazione libera» ponendo in discussione proprio questa definizione di educazione «libera». Sull’ambiguità del termine «libero» troviamo un bell’aneddoto nella scelta del nome del progetto. Quale occasione migliore per mettere in pratica questa libertà e fare in modo che fossero le stesse bambine/i a scegliere il nome della scuola? All’inizio si parla di bimbe/i di 3-4 anni, in maggioranza femmine, alle quali viene chiesto di decidere sul nome da darsi. Quindi si riuniscono, come avevano imparato a fare in un progetto orizzontale. Essendo indecise tra due parole, alla fine arrivano all’accordo di usarle entrambe: «Collana Principessa» sarebbe stato il nome della loro scuola. Si può immaginare la reazione degli adulti! «Abbiamo capito che più che la libertà che offre la società capitalista, dovevamo offrire loro strumenti per remare controcorrente».
Per quanto riguarda il nome della scuola, alla fine gli adulti hanno insistito per un nome che rappresentasse il progetto e la «Pinya» (pigna in italiano) non rimanda solo all’ambiente privilegiato della masseria di «Can Garrofa» dove ha sede la scuola, circondata da giardino e boschi, ma anche a un’espressione idiomatica catalana e spagnola dove con fer pinya/hacer piña si intende fare squadra, supportarsi l’uno con l’altro.
Impegno dei genitori
E questa squadra inizia con l’organizzarsi collettivamente per il trasporto delle bambine/i dai diversi quartieri della città o dai paesi vicini a Can Garrofa a Esplugues (30-40 minuti dal centro città col trasporto pubblico). I genitori si occupano a turno anche della preparazione del pranzo e delle pulizie, oltre che dell’adeguamento dello spazio alle necessità dei bimbi. L’impegno per un genitore che sceglie di mandare sua/o figlia/o alla «Pinya» è quindi su diversi fronti: da una parte l’apporto economico, dall’altra una necessaria disponibilità di tempo da investire nel progetto. Le due questioni sono in qualche modo legate visto che
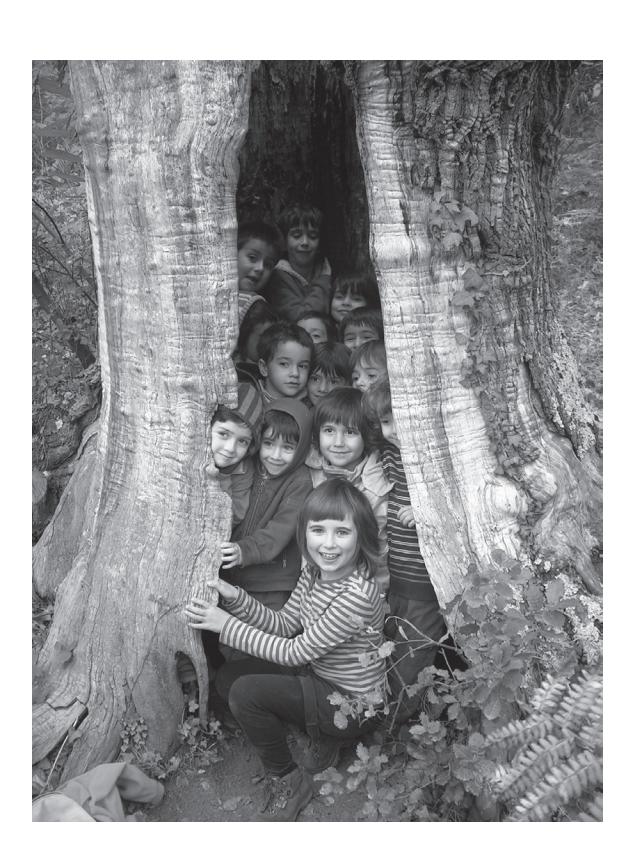
fanno entrambe riferimento al modo di sussistenza che scelgono i genitori o il genitore (si parla anche di famiglie monoparentali), tenendo conto che di solito chi ha più disponibilità economica ha meno tempo a disposizione durante la giornata o meno flessibilità.
L’assemblea ha decretato che il tempo e le energie spese insieme per costruire qualcosa sono il collante per questo tipo di progetto
Per quanto riguarda la quota da versare per la sostenibilità del progetto all’inizio ci si affida al principio «ognuno secondo le sue possibilità», senza grandi specificazioni né vincoli, ma dopo un breve periodo ci si rende conto che il consolidarsi dell’attività passa anche dalla stabilità economica. Inoltre il buon funzionamento della quotidianità con i bambini permette ben presto l’allargamento del nucleo di famiglie iniziale, legato da un solido rapporto di fiducia/ amicizia/ affinità e da qui anche il bisogno di proporre una regolamentazione più chiara.
Si insiste quindi sulla necessità di prendersi l’impegno di pagare tutto l’anno scolastico (anche in caso di viaggi o assenza della bambina/o), di venire incontro alle esigenze di tutte/i ma di stabilire una quota fissa per ogni nucleo familiare da pagare ogni mese. Inoltre per abbassare la spesa di ogni famiglia si richiede la collaborazione per organizzare attività di autofinanziamento come cene, concerti, incontri di presentazione del progetto. Questa attività viene considerata fondamentale e come parte integrante del collettivo: nel corso degli anni è capitato che qualche famiglia chiedesse di pagare una quota più alta perché non aveva tempo/voglia di partecipare alle attività di autofinanziamento, ma l’assemblea ha decretato che il tempo e le energie spese insieme per costruire qualcosa sono il collante per questo tipo di progetto e valgono di più dei soldi guadagnati individualmente. Sia il nucleo di famiglie iniziale che le persone che poco a poco si sono avvicinate al progetto, possiamo dire (generalizzando) che scelgono di avere un lavoro flessibile, part-time o stagionale, per
avere tempo ed energie da dedicare al processo di educazione dei loro figli, non solo individualmente ma appunto collettivamente, un processo che inevitabilmente porterà a crescere anche loro. Si arriva a dire che «La Pinya esiste anche fuori dalla Pinya» nei rapporti che si creano condividendo feste di compleanno dei bimbi, balli, fatiche, risate e tristezze, e inevitabilmente «La Pinya te la porti anche a casa, nelle tue relazioni personali» per sottolineare come si associ una visione della vita al progetto e non semplicemente una escuelita.
Modalità libertarie
Il collettivo de «La Pinya» si è anche interrogato in varie occasioni se diventare una «comune» e allargare il focus dall’educazione a una convivenza di gruppo, ma la flessibilità, i cambiamenti e le nuove sfide che si presentano ogni anno hanno portato in altre direzioni. È vero che il progetto permea la vita di chi vi partecipa, ma uno delle sue peculiarità è proprio la non staticità, l’essere sempre work in progress, costituire un momento intenso e cruciale del percorso di ognuno. Ed è difficile coniugare queste caratteristiche con un progetto sedentario e a lungo termine di convivenza. La «Pinya» beve invece da questi flussi di energie in movimento, viaggi, amicizie, amori che vanno e vengono. Il progetto è aperto alle contaminazioni ed è pronto a mettersi continuamente in discussione per raggiungere gli obiettivi comuni. Infatti, per quanto riguarda gli acompanyantes è chiaro che non si offre loro semplicemente un lavoro, ma si propone di entrare in un nuovo modo di vivere e condividere. Il ruolo di acompanyante è così cruciale e intenso che spesso queste figure vengono assorbite completamente dal progetto, senza poter però ricevere un adeguato compenso economico per tutta la quantità di tempo ed energia investita. Succede quindi che ciclicamente abbandonino il progetto, entusiasti del percorso costruito insieme, ma sfiniti e con la necessità di prendere aria. Questo da una parte arricchisce, perché al progetto si sommano tante visioni diverse, dall’altra crea lo stress di cambiare o aggiornare spesso l’equipe.
Questa scelta di fare un passo indietro quando non si hanno più le energie significa saper riconoscere i propri limiti e non aver paura del cambiamento. Questa flessibilità, insieme all’importanza attribuita a una coscienza collettiva è la grande peculiarità della «Pinya»: crescere costruendo la propria libertà, coscienti di formare parte attiva di un gruppo, di una società, implica una chiara responsabilità politica.
Per raccontare la loro esperienza l’anno scorso la «Pinya» ha pubblicato un libro, che rappresenta perfettamente la struttura, l’idea e la pratica del progetto: un lavoro collettivo, in cui la scrittura non è delegata a qualcuno di specializzato, bensì un coro di voci, di adulti e bambini che raccontano la loro esperienza e aiutano a comprendere le diverse fasi del progetto. Il testo è inoltre arricchito da un’analisi del contesto storico-sociale in cui si è sviluppata «La Pinya» e da approfondimenti pratici che raccontano situazioni vissute e come sono state risolte, o quali obiettivi si propongono e come si mettono in pratica. Questo mettere nero su bianco e condividere metodi ed esperienze, difficoltà e soluzioni adottate è il modo migliore per far germogliare altri progetti e per permettere che tutto questo lavoro arrivi più lontano possibile.
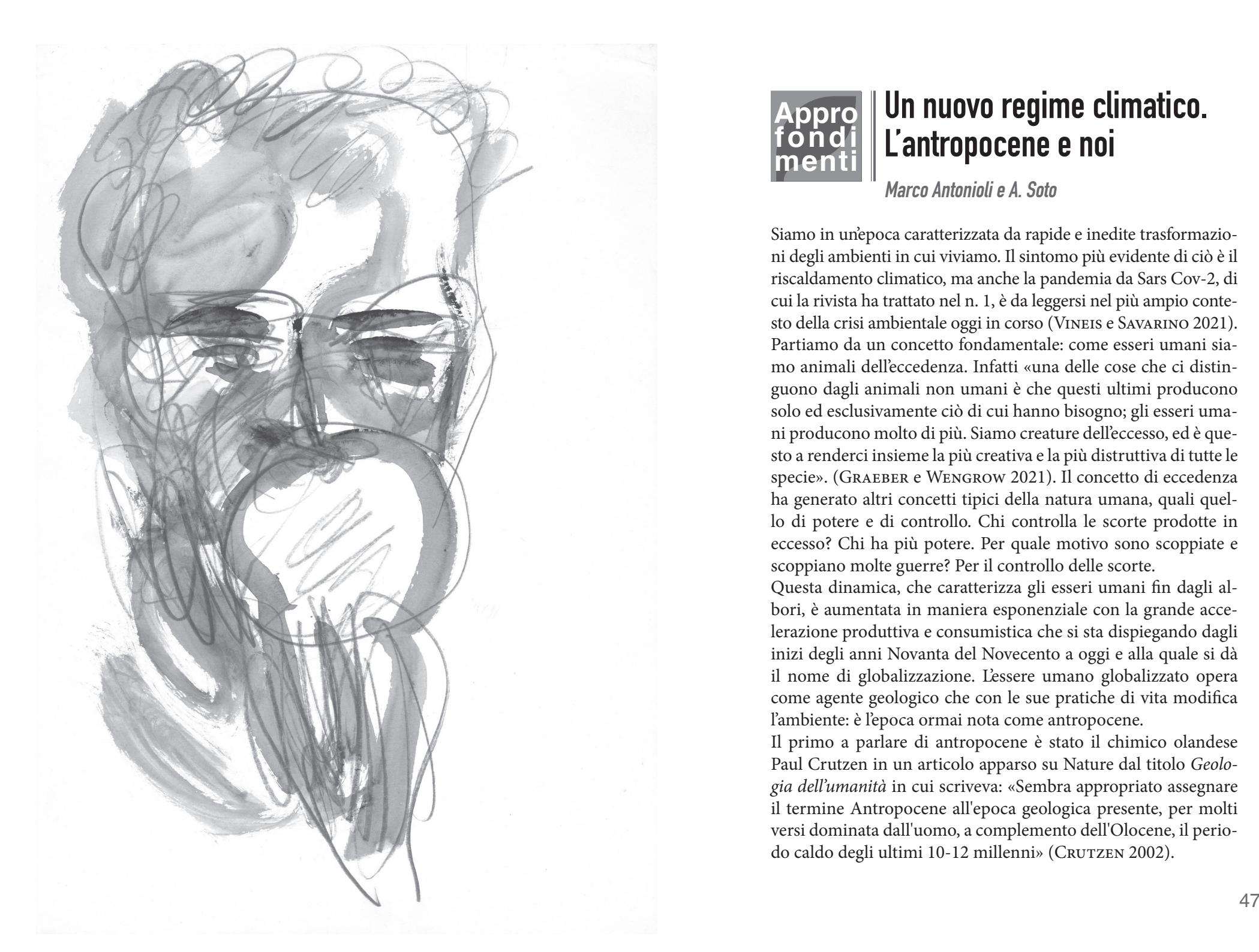

Un nuovo regime climatico. L’antropocene e noi
Marco Antonioli e A. Soto
Siamo in un’epoca caratterizzata da rapide e inedite trasformazio ni degli ambienti in cui viviamo. Il sintomo più evidente di ciò è il riscaldamento climatico, ma anche la pandemia da Sars Cov-2, di cui la rivista ha trattato nel n. 1, è da leggersi nel più ampio conte sto della crisi ambientale oggi in corso (Vineis e Savarino 2021). Partiamo da un concetto fondamentale: come esseri umani sia mo animali dell’eccedenza. Infatti «una delle cose che ci distin guono dagli animali non umani è che questi ultimi producono solo ed esclusivamente ciò di cui hanno bisogno; gli esseri uma ni producono molto di più. Siamo creature dell’eccesso, ed è que sto a renderci insieme la più creativa e la più distruttiva di tutte le specie». (Graeber e Wengrow 2021). Il concetto di eccedenza ha generato altri concetti tipici della natura umana, quali quel lo di potere e di controllo. Chi controlla le scorte prodotte in eccesso? Chi ha più potere. Per quale motivo sono scoppiate e scoppiano molte guerre? Per il controllo delle scorte.
Questa dinamica, che caratterizza gli esseri umani fin dagli al bori, è aumentata in maniera esponenziale con la grande acce lerazione produttiva e consumistica che si sta dispiegando dagli inizi degli anni Novanta del Novecento a oggi e alla quale si dà il nome di globalizzazione. L’essere umano globalizzato opera come agente geologico che con le sue pratiche di vita modifica l’ambiente: è l’epoca ormai nota come antropocene.
Il primo a parlare di antropocene è stato il chimico olandese Paul Crutzen in un articolo apparso su Nature dal titolo Geolo gia dell’umanità in cui scriveva: «Sembra appropriato assegnare il termine Antropocene all’epoca geologica presente, per molti versi dominata dall’uomo, a complemento dell’Olocene, il perio do caldo degli ultimi 10-12 millenni» (Crutzen 2002).
Inoltre, Crutzen citava cinque caratteristiche tipiche dell’antropocene. Ai fini di questo articolo è bene ricordarne due: l’attività umana ha trasformato da un terzo a metà della superficie del pianeta e l’uomo usa più della metà delle risorse accessibili di acqua sorgente al mondo.
Altre due caratteristiche tipiche di quest’epoca sono che il mondo muta con modalità che obbligano le specie a spostarsi e che muta con modalità che generano nuove barriere – strade, aree deforestate, città, fiumi deviati – che impediscono agli animali di migrare.
Rispetto all’età preindustriale la temperatura globale è oggi maggiore di 1,59°C sulla terraferma e di 0,88°C negli oceani. Questo aumento della temperatura è stato più rapido negli ultimi 50 anni di quanto avvenuto negli ultimi 2000 anni, mentre la temperatura degli oceani è aumentata più rapidamente nell’ultimo secolo che nei precedenti 11.000 (Interngovernmental Panel on Climate Change 2021). A ciò si devono aggiungere molteplici altre sofferenze che colpiscono il pianeta tra cui la deforestazione e il consumo di suolo, l’inquinamento da plastiche, l’acidificazione degli oceani, lo sfruttamento intensivo delle risorse minerarie, la produzione di scarti che sta trasformando la terra in una grande discarica globale (Armiero 2021) e quella che viene definita la sesta estinzione di massa.
Dipesh Chakrabarty, storico indiano, già una delle figure di rilievo del pensiero postcoloniale e da diversi anni impegnato nell’analisi del cambiamento climatico, lega questa distruzione direttamente all’esercizio della libertà da parte dell’essere umano. Scrive: «in nessuna delle riflessioni sulla libertà c’è mai stata la consapevolezza della potenza geologica che gli esseri umani stavano contemporaneamente acquisendo per effetto e per mezzo di processi strettamente collegati alla loro conquista della libertà» (Chakrabarty 2021). Così egli lega l’esercizio della libertà al progresso e alla devastazione ambientale che è intrinseca ad esso.
Problema di una portata tale da fare venire le vertigini e che a nostro avviso è ben riassunto dal termine antropocene. L’assunLa manipolazione violenta della natura da parte degli esseri umani
zione di tale termine potrebbe infatti indicare la gravità della situazione e la conseguente necessità di muoversi verso un cambiamento di prospettiva e di abitudini materiali, più di
quanto possa fare la categoria di capitalocene utilizzata da alcuni in ambito accademico e militante. Siamo convinti infatti che la manipolazione violenta della natura da parte degli esseri umani sia tipica non solo dei sistemi capitalistici, ma sia un atteggiamento tipico anche dei regimi di tradizione comunista quali Russia e Repubblica Popolare Cinese.
La questione è così vasta da non risedere solo in un sistema economico specifico quale è il capitalismo, quanto nell’attitudine produttivista e consumista dell’essere umano moderno e occidentale, nonché nel suo considerarsi dominatore dell’ambiente circostante e degli esseri che lo popolano.
Murray Bookchin legando la dimensione ecologica a quella sociale, ha indicato una strada, difficile e tortuosa, ma che forse vale la pensa percorrere: bisogna battersi per trasformare in senso libertario e tendenzialmente egualitario i rapporti sociali e personali di dominio (Bookchin 1982).
Ma non è più «solo» l’oppressione dell’essere umano sull’essere umano a doverci riguardare. Oggi la sfida è superare l’oppressione dell’essere umano anche nei confronti degli esseri non umani e dell’ambiente e fermare così l’usura del mondo.
Noi ci rifacciamo all’idea di anarchia: assenza di comando e autorità, libertà intesa in maniera responsabile, solidale e col-
lettiva, tensione verso l’assenza di dominio e per la diffusione più estesa possibile di potere, inteso non in senso negativo ma come possibilità (Bertolo 1983).
Tale concetto oggi non consiste più solo nel propagandare e vi-
Non è più «solo» l’oppressione dell’essere umano sull’essere umano a doverci riguardare
vere l’eliminazione dello sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano, ma anche nel riconsiderare criticamente lo stile di vita in cui siamo immersi, all’insegna del consumo forsennato, del dominio sull’ambiente e sugli esseri, e dei veleni che ne scaturiscono.
Scriviamo «siamo immersi» sottintendendo un «noi» generico. Sappiamo che ci sono differenze di status, di classe, di genere e geografiche, tra «noi». No, non siamo tutti uguali. Ma tutti, o quasi tutti, a gradi diversi, siamo accomunati dall’avere portato il mondo alla rovina aderendo alla «allucinazione della crescita continua» (Danowski e Viveiros de Castro 2017). Abbiamo tutti delle responsabilità, seppure in maniera differenziata.
Dunque, con sano realismo crediamo sia doveroso tentare di alleviare l’essere umano da questa triste situazione in cui si è cacciato, riducendo autonomamente le nostre pretese di consumo e di espansione, agendo in prima persona perché si possa imprimere un cambiamento nelle politiche economiche ed energetiche dei nostri odiati governi.
«L’ecologia, o è sociale o non è» scriveva Bookchin. Anche il nostro intento è tanto ecologico quanto sociale, poiché gli effetti del «nuovo regime climatico» si stanno facendo sentire maggiormente su chi già viveva in condizioni di vulnerabilità economica e sociale e così sarà in maniera crescente e accelerata (Latour 2020). È un dato di fatto che siano i più poveri del pianeta a subire duramente le conseguenze dei cambiamenti climatici, pur non essendone responsabili.
Il cambiamento climatico ha un impatto su metà della popolazione globale, dal momento che un abitante su due soffre gli effetti della siccità o vive in un’area «altamente vulnerabile ai cam-
La nostra casa è in fiamme biamenti climatici» (Interngovernmental Panel on Climate Change 2022). La nostra casa è in fiamme avvisano le attiviste e gli attivisti in difesa della Terra e i colpevoli sono i maggiori inquinatori del mondo siano essi grandi corporation o enti pubblici che, mentre si puliscono la coscienza con termini come «transizione ecologica», «transizione energetica» e «rinnovabili», continuano a finanziare l’economia fossile e a reiterare le dinamiche tipiche del sistema produttivo che ci ha condotto in questa situazione. Nel presentare il sesto rapporto del comitato intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) il segretario generale delle Nazioni Unite ha indicato la necessità di «urgenti e radicali investimenti per opere di adattamento». Noi pensiamo che oltre agli investimenti si potrebbero mettere in pratica una serie di soluzioni varie, non preconfezionate, stabilite a livello locale e regionale, che facciano leva sulla crescente consapevolezza di un approccio finalmente egualitario tra essere umano e ambiente. Capire quali possano essere e cominciare qui e ora a praticarle è compito di ognuno di noi. In altri termini «è tempo di mettere in discussione il tipo di civiltà in cui gli essere umani vogliono vivere» (Chackrabarty 2021b), ricordando che «portando all’estinzione le altre specie, il genere umano sta recidendo il ramo su cui esso stesso si posa» (Kolbert 2014). E ne siamo tutti, in varia misura, responsabili. Siamo a un bivio: o continuiamo a recidere il ramo su cui viviamo o scegliamo di svoltare partendo anche dai comportamenti individuali.
Bibliografia
M. AIME, A. FAVOLE, F. REMOTTI, Il mondo che avrete, UTET, Torino 2020 M. ARMIERO, L’era degli scarti, Einaudi, Torino 2021
A. BERTOLO, Potere, autorità, dominio: una proposta di definizione, “Volontà”, n. 2, 1983 (ora in Anarchici e orgogliosi di esserlo, elèuthera, Milano 2017)
M. BOOKCHIN, L’ecologia della libertà, eléuthera, Milano 2017
D. CHAKRABARTY, Clima, Storia e Capitale, Nottetempo, Milano 2021
D. CHAKRABARTY, La sfida del cambiamento climatico, ombrecorte, Verona 2021
P. CRUTZEN, Geology of mankind, «Nature» 415, 23 (2002). https://doi. org/10.1038/415023a
D. DANOWSKI, E. VIVEIROS DE CASTRO, Esiste un mondo a venire?, nottetempo, Milano 2017
D. GRAEBER, D. WENGROW, L’alba di tutto, Rizzoli, Milano 2022
E. KOLBERT, La sesta estinzione, BEAT Edizioni, Milano 2014
IPCC, Quinto e sesto rapporto, 2021-2022 (Ipcc.ch)
B. LATOUR, La sfida di gaia, Meltemi, Firenze 2020
A. MALM, Clima, corona, capitalismo, Ponte alle Grazie, Milano 2021
P. VINEIS E L. SAVARINO, La salute del mondo. Ambiente, società, pandemie, Feltrinelli, Milano 2021

Dal basso e per il basso. Le sfide di una giusta transizione ecologica
Simone Ogno (ReCommon)
Pandemia, guerra e crisi climatica
Il 2020 sarà ricordato come l’anno che ha sconvolto la vita di miliardi di persone a causa della pandemia di Covid-19. Con l’abitudine di considerare ciò che accade intorno a noi come «emergenza», si è posta molta enfasi su quella pandemica, senza considerarla in relazione a fenomeni più ampi.
La crisi climatica che viviamo sembra essere passata in secondo piano, nonostante le acclarate relazioni che intercorrono tra essa e la diffusione di eventi pandemici1 , a partire dalla devastazione dell’ambiente per sfruttarne le risorse naturali, che facilita il passaggio di virus tra specie animali, compresa quella umana. Per di più, numerosi studi scientifici dimostrano come la prolungata esposizione all’inquinamento atmosferico, causato prevalentemente dai mezzi di trasporto e dalla combustione di carbone, petrolio e gas, aumenti le possibilità di contrarre forme più gravi di patologie cardiorespiratorie2 .
Se ciò non bastasse, insieme alla pandemia è tornato l’incubo della guerra su scala globale, che rischia di essere l’ultimo chiodo sulla bara di una giusta transizione ecologica.
Quando, a causa dell’invasione dell’Ucraina, l’Unione europea ha deciso di adottare le prime sanzioni economiche nei confronti della Federazione russa, si è compreso realmente quanto il Vecchio continente dipenda dagli idrocarburi prodotti in altri paesi. Una novità solo agli occhi di chi non ha mai voluto ve-
1 https://www.thelancet.com/article/S0140-6736(20)32290-X/fulltext
2 https://www.hsph.harvard.edu/c-change/subtopics/coronavirus-and-pollution/
dere. Nel dibattito pubblico sono emerse finalmente numerose questioni, alcune delle quali troppo spesso sottaciute da governi, multinazionali energetiche e gruppi finanziari. Questioni che i movimenti per la giustizia ambientale e climatica denunciano da tempo: l’industria dei combustibili fossili alimenta situazioni di violazione sistemica dei diritti umani e instabilità sociopolitica ed è causa diretta o indiretta di numerosi conflitti armati.
La nuova corsa estrattivista globale
Tuttavia, le prime risposte dei governi non hanno fatto che reiterare la volontà di non vedere, con il rischio di spingere numerosi paesi europei da una dipendenza a un’altra. L’Italia non fa eccezione. In altri invece si rischia di aggravare quella che viene chiamata «maledizione delle risorse naturali», con le rispettive zone e persone di sacrificio, come affermato recentemente da Nnimmo Bassey (Health of Mother Earth Foundation) e Anabela Lemos (Justiça Ambiental/Friends of the Earth Mozambique)3 . Zone e persone di sacrificio sono quei territori, comprendenti le persone che li abitano, storicamente sfruttati dal capitalismo estrattivista a ogni latutidine, da cui quindi estrarre valore con modalità sempre nuove. In questo caso il capitalismo estrattivista agisce attraverso le operazioni delle multinazionali energetiche, che sfruttano i territori per poi lasciare macerie o cattedrali nel deserto.
Molti di questi paesi «maledetti» si trovano nel continente africano, in prima fila per la produzione di petrolio e gas: Nigeria, Mozambico, Egitto, Angola, Algeria, Repubblica del Congo, Ghana, Tunisia, Uganda. A questi paesi possiamo aggiungerne altri afferenti a un presunto «Occidente» ma periferici rispetto ad esso, come Australia e Argentina. E non dimentichiamoci degli Stati Uniti. In ogni caso, la nuova corsa estrattivista non rinuncia al suo marchio di fabbrica neocoloniale, impattando
3 https://www.foreignaffairs.com/articles/africa/2022-02-17/africas-fossil-fuel-trap
ulteriormente le frontline communities, cioè quelle comunità già marginalizzate o razzializzate in maniera sistemica. In altri casi, l’industria fossile implementa la sua agenda in ecosistemi fragili ed esposti più di altri alla crisi climatica, come gli abissi oceanici e la regione artica, attraverso operazioni di esplorazione, produzione, trasporto e stoccaggio di idrocarburi.
La finanza globale, guidata dai fondi di investimento statunitensi come BlackRock e Vanguard, nonché dalle banche cinesi come la Bank of China e l’Industrial and Commercial Bank of China, può iniziare così ad aprire il portafoglio e orientarlo verso altri mercati. La menzione di soggetti finanziari privati e pubblici, per quanto afferenti a contesti politici differenti, non è casuale. La finanza privata, intesa come l’insieme di fondi di investimento, banche commerciali e compagnie assicurative, è uno dei perni del capitalismo estrattivista, poiché determina la distribuzione della ricchezza. È stata questa a gettare le basi per l’emergere dell’economia del petrolio, e ora ci spinge verso l’economia del gas.
Tuttavia, i contraccolpi all’economia reale dovuti prima alla pandemia e poi alla guerra hanno riportato in auge anche la finanza pubblica, il più delle volte proprio a servizio delle grandi concentrazioni di potere private.
Chi ostacola la giusta transizione ecologica in Italia
Qualsiasi sia l’origine della prossima dipendenza fossile italiana, avrà sicuramente bisogno di nuovi gasdotti e terminal di GNL (gas naturale liquefatto). Un settore in cui ENI e SNAM la fanno da padrone4 . L’Algeria e l’Egitto sembrano in prima fila per soddisfare entrambe, attraverso nuovi progetti esplorativi e un aumento della produzione di idrocarburi5 .
4 https://www.recommon.org/di-chi-sono-i-gasdotti-e-quale-ruolo-giocanoeni-e-snam/
5 https://www.recommon.org/le-scelte-eni-sul-gas-ci-consegnano-alla-russia/
Una proliferazione di progetti complessi o in contesti «a rischio» quindi. Il contesto ideale per le agenzie di credito all’esportazione, cioè gli assicuratori pubblici che coprono dai rischi politici e commerciali le multinazionali nel loro export e investimenti esteri. Un ambito in cui l’italiana SACE, controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ricopre un ruolo di primo piano, avendo già assicurato numerosi progetti fossili in Nigeria, Mozambico, Egitto e Russia6 . E se qualcosa dovesse andare male? Nessun problema: SACE rimborsa le aziende oppure le banche che hanno prestato soldi alle aziende per i loro progetti esteri, trasformandoli in debito pubblico per i paesi in cui si re-
alizzano gli investimenti. Profitti privati, perdite pubbliche.
Profitti privati, perdite pubbliche In seguito all’emergere della pandemia, il decreto-legge Liquidità di aprile 2020 (governo Conte II) ha innescato un processo di radicale trasformazione di SACE, divenuta così
un attore di primo piano per tutto il Sistema-Italia a trazione estrattivista, non solo sul lato dell’export. Successivamente, con il decreto-legge Semplificazioni di luglio 2020, è stato affidato a SACE il ruolo di rilasciare garanzie a sostegno dei progetti del Green Deal italiano, concretizzatosi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Il gruppo bancario in prima fila a supportare la supposta transizione ecologica italiana è Intesa Sanpaolo, che, nell’ambito del PNRR, ha messo a disposizione un importo complessivo di oltre 400 miliardi di euro in termini di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine. È stato inoltre il primo istituto di credito italiano a stipulare un protocollo di collaborazione con SACE in seguito all’entrata in vigore del DL Liquidità7 . Intesa Sanpaolo che, per la sua esposizione all’industria fossile sul lato creditizio e degli investimenti, si è guadagnata l’epiteto di «banca fossile n.1 in Italia»8 .
Quando ancora si chiamava Recovery plan, il PNRR è stato oggetto delle mire dell’industria fossile. Questa è infatti riuscita a ottenere almeno centodue incontri con i ministeri incaricati di redigere il piano: una media di oltre due incontri a settimana9 .
ENI, principale multinazionale fossile italiana, ha dominato
l’azione lobbistica con almeno venti incontri ufficiali, promuovendo le sue false soluzioni per il clima e l’ambiente tra i decisori politici, tra cui l’idrogeno - che attualmente è prodotto per il 99% da gas - e la cattura dell’anidride carbonica (CCS). Stesso numero di incontri per SNAM, società che controlla la rete di gasdotti strategici europei e mediterranei.
Il PNRR è stato oggetto delle mire dell’industria fossile
La Commissione europea ha però bocciato la versione originaria del PNRR, costringendo l’esecutivo italiano a modificarlo in maniera sostanziale nel capitolo riguardante la transizione energetica. Tuttavia, sulla scia della guerra in Ucraina non sono da escludersi deroghe volte a modificare tutti i piani nazionali già approvati. E questo potrebbe significare un prepotente ritorno di false soluzioni o, addirittura, proprio di progetti fossili, con la giustificazione del contesto emergenziale servita su un piatto d’argento.
6 https://www.recommon.org/stato-di-garanzia-il-rapporto-sulla-sace/
7 https://group.intesasanpaolo.com/it/sala-stampa/comunicati-stampa/2020/04/ intesa-sanpaolo–prima-banca-a-sottoscrivere–protocollo-sace-pe
9 https://www.recommon.org/le-mani-del-settore-dei-combustibili-fossili-sul-recovery-plan/
Transizione ecologica dal basso, per il basso
Secondo la narrazione dominante, in caso di eventi catastrofici come pandemie e guerre i governi agiscono a tutela degli interessi collettivi. Siamo però sicuri che, quando la crisi climatica si riverserà con tutta la sua violenza sulla maggioranza della popolazione mondiale, i governi agiranno? Pandemia e guerra sono diverse dalla crisi climatica.
Data la molteplicità e complessità delle crisi in corso, assisteremo a un maggiore autoritarismo diffuso e alla crescita di un consenso intorno a questo? E la narrazione dominante, orientata dai governi e dai poteri corporativi industriali e finanziari attraverso i rispettivi canali istituzionali e i media mainstream, spingerà ancora di più all’odio verso e tra le fasce subalterne, deviandolo così da chi governa le crisi?
Che tipo di cambiamento vogliamo? La domanda poggia sull’assunto che non si tratta solo del modello energetico, ma dell’intero sistema produttivo globale. Anche i settori dell’acciaio, del cemento e dell’agribusiness non molleranno la presa sul sistema come lo conosciamo: la questione è quindi molto più ampia di petrolio vs rinnovabili. I gruppi industriali e finanziari, a partire da quelli
L’unica transizione possibile deve passare per un cambio del modello energetico
a partecipazione a statale, che ci hanno condotto in una nuova era di pandemie e guerre, possono essere riformati per guidare una transizione ecologica che sia giusta?
La proliferazione delle comunità energetiche è una pratica sana, tuttavia sotto il regime normativo attuale ci sono margini per erodere il potere delle multinazionali energetiche? Anche in questo caso, ritorna la questione di quanto sia opportunistico cogliere gli spazi grigi del sistema per cercare di superarlo, oppure muoversi direttamente fuori e contro di esso. Il punto fermo è che, oltre i consumi individuali, sono da considerare anche produzione industriale, trasporti e logistica.
Un esempio di transizione ecologica «dal basso e per il basso» è quello di Som Energia, cooperativa catalana di produzione e consumo di energia esclusivamente rinnovabile. Fondata nel 2010, Som Energia conta più di 70mila soci e 127mila contratti in Catalunya e in tutta la Spagna. Organizzati in gruppi territoriali, alcuni tra i soci di Som Energia hanno poi animato processi di trasformazione in altri contesti, che vanno oltre l’energia: è il caso di Som Mobilitat, cooperativa di mobilità che si pone l’obiettivo di favorire l’utilizzo di mezzi pubblici e delle bici, e acquistando poi collettivamente anche alcuni veicoli elettrici.
La questione della concentrazione vs diffusione del potere non è quindi più teorica, ma sempre più reale. Assistiamo a un maggiore protagonismo dello Stato, che fa da stampella al privato, soprattutto alla finanza.
L’unica transizione possibile deve necessariamente passare per un cambio del modello energetico e produttivo, in cui le comunità e i territori abbiano voce in capitolo. E per avere voce in capitolo, il potere nelle mani dei pochi deve essere smantellato, diluito e diffuso, affinché siano proprio comunità e territori a riappropriarsene. Solo questi possono infatti individuare i bisogni reali, non basati sulle proiezioni plasmate dalle stesse multinazionali e gruppi finanziari che oggi controllano il mercato energetico, e non solo quello.

Populismo e nazionalismo nella retorica patriottica di Vladimir Putin
Sofia Tipaldou
La Russia di Vladimir Putin «non è una democrazia, ma un governo in nome del popolo e per il popolo. La base elettorale principale di Putin è il popolo. Tutto il suo potere proviene dall’appoggio del popolo», spiega Migranyan (in Ioffe 2018). La legittimità popolare in Russia non deriva, però, dalle elezioni. Dall’inizio della sua presidenza, Putin ha configurato una politica interna che non solo ha enfatizzato elementi di patriottismo, xenofobia e antioccidentalismo, ma ha anche costantemente spinto a una depoliticizzazione della società, facendo contemporaneamente ricorso a un linguaggio esplicitamente populista (Casula 2013). Poiché il concetto di populismo1 può essere volto in diverse direzioni, occorre chiedersi chi forma, nella pratica, il popolo che tanto importa al sistema russo in momenti topici della vita politica del paese.
Nell’era Putin, il discorso ufficiale ha separato rigorosamente l’etnicità dall’identità nazionale e ha introdotto nelle sua definizione di «russo» (rossijskij) una combinazione di simboli presovietici e sovietici. Il modo di esercitare la politica di Putin ha portato alcuni accademici a paragonarlo a politici populisti consolidati, come Hugo Chávez o Umberto Bossi e Geert Wilders (Fella e Ruzza 2009, Fish 2017). Putin fu anche accusato dal suo oppositore politico, il defunto Boris Nemtsov, di seguire una politica di populismo belligerante, con l’obiettivo di aumentare i suoi indici di approvazione.
Le situazioni di tipo bellico implicano una dicotomizzazione populista dello spazio politico. Per Putin, è la politica a essere la continuazione della guerra, ricorrendo alla celebre inversione di Foucault (1980) dell’affermazione di Carl von Clausewitz. All’inizio del suo mandato, la chiave per conquistare importanti settori della popolazione russa fu la dichiarazione di guerra contro il crimine, una dittatura della legge, che divise lo spazio politico tra ordine e caos. Quindi Putin proseguì, vincolando il suo nome alla guerra in Cecenia, e questa divise lo spazio politico tra terroristi e i suoi avversari, scatenando un sanguinoso conflitto (Hale 2000).
Da quando arrivò al potere nel 2000 nominato da Eltsin, lo sconosciuto Vladimir Putin (all’epoca tuttavia a capo del KGB) sembrava voler identificare la sua immagine di giovane, aitante
Le situazioni di tipo bellico implicano una dicotomizzazione populista dello spazio politico. Per Putin, è la politica a essere la continuazione della guerra
e macho con quella del Paese, per riscattare la Russia dell’anziano, debole e alcolizzato Eltsin. In quei primi anni, la società russa si poteva definire una democrazia non ancora consolidata, con elezioni, libertà di stampa etc. e l’Occidente si aspettava un’apertura in questo senso. Ma le cose andarono in maniera molto diversa e la guerra in Cecenia fu una dimostrazione di forza per farsi conoscere. D’altra
parte, nel 2004 un primo campanello d’allarme arrivò proprio con la Rivoluzione arancione in Ucraina, quando gli ucraini per la prima volta scesero in piazza perché non volevano che i russi mettessero loro uomini nei posti chiave. Queste rivendicazioni si inserirono nell’ondata di proteste della Primavera araba, e costituirono uno shock per Putin, che cominciò a temere che potesse succedere la stessa cosa anche in Russia. Aumentò quindi la repressione interna e nel 2008, quando in Georgia ebbe luogo la Rivoluzione delle rose per allontanare il paese dalla Russia, la risposta fu una guerra lampo di otto giorni, che portò a trasformare due territori contesi in repubbliche indipendenti, che finirono sotto il controllo russo. Fu poi appoggiando la Siria di Assad che l’esercito russo perfezionò la sua tattica di bombardamenti, e
cambiò gli equilibri di quel conflitto.
Intorno al 2010 in Russia l’ambiente iniziò ad essere più teso. Furono varate leggi contro organizzazioni internazionali accusate di spionaggio e Putin iniziò a piazzare oligarchi di fiducia in posti chiave. Iniziò un graduale smantellamento dell’opposizione e della dissidenza, con castighi esemplari ai pochi che tentavano di avere iniziativa (come Khodorkovsky, a cui furono inflitti dieci anni di carcere e poi l’esilio), e assorbimento degli altri nel suo circolo. Così fu, per esempio, con i nazionalisti, pubblico al quale era interessato Putin anche per la costruzione del suo discorso.
È del 2013 l’Euromaidan, ovvero un’altra grande ondata di proteste di piazza in Ucraina, quando il presidente filorusso non accettò di firmare trattati economici con la UE, schierandosi apertamente con Putin e venne rimosso. Nel 2014 alle elezioni ucraine vinse un presidente filoccidentale e in breve si scatenò la guerra di Crimea e del Donbass, regioni strategiche per i russi. Ma, a differenza della guerra in Cecenia – nella quale si fece ricorso anche a una narrativa religiosa che creava una divisione tra russi ortodossi e ceceni musulmani –, il popolo a cui fece appello lo Stato russo durante la crisi in Crimea e la posteriore guerra nel Donbass, è risultato essere una costruzione molto più instabile, scivolosa e problematica, dato che gli ucraini sono considerati una nazione slava sorella. Questi fratelli – che includono anche i musulmani tatari della Crimea – dovevano però ancora essere convinti, cosa che il governo non avrebbe potuto fare, facendo appello alla sola retorica nazionalista russa. Ecco perché il discorso ufficiale ha dovuto attivare gli elementi più populisti e inclusivi, per porli all’interno di una visione nazionalista russa ufficiale addomesticata (Kolstø E Blakkisrud 2018).
Il vincolo speciale tra Ucraina e Russia, coltivato durante secoli – soprattutto dalla Russia – è ciò che conferisce ai conflitti della Crimea e del Donbass un carattere di eccezionalità: come si possono giustificare l’intervento in Crimea e la guerra nel Donbass, se l’immagine dell’altro antagonista non è nitida? Quali sono le caratteristiche del popolo al quale si dirige il discorso ufficiale russo?
L’analisi dei discorsi di Putin del 2014 permette di ottenere un’immagine più chiara del popolo al quale si dirige, dei suoi alleati e amici, dei nemici e dei simboli per mantenere questo popolo unito, e ci permette di comprendere il nesso tra populismo e nazionalismo nella Russia attuale.
Nonostante i tre elementi costitutivi del populismo – il popolo, i nemici e i simboli – si definiscano sul piano teorico in maniera distinta rispetto al nazionalismo, per certi aspetti il nazionalismo russo e il populismo si sovrappongono. Nel contesto del conflitto con l’Ucraina, la separazione dicotomica di identità tra “noi” e “loro” non è sufficiente. Esistono elementi di una definizione molto ampia della nazione russa, una nuova divisione dello spazio politico, e anche l’insistere su nuovi e vecchi simboli di unità che concorrono a creare un’identità chiaramente panrussa. Si ricorre al populismo quando il nazionalismo non basta e perché quest’ultimo offre alla Russia un nazionalismo non etnico, che cerca di unificare le nazioni euroasiatiche, ricordando in ciò l’era sovietica.
L’analisi delle strategie discorsive di Putin in relazione con l’Ucraina e il modo in cui ha costruito il concetto di popolo, ci aiutano a capire da un lato la relazione tra il nazionalismo e il populismo come strategie per mantenere il potere delle élites politiche, dall’altro il legame della Russia di Putin con i movimenti populisti europei. Taggart (2004) e Weynert (2014) affermano che la flessibilità del populismo lo rende particolarmente adatto a sostenere ogni tipo di politica, dato che può essere sia un movimento di opposizione, democratico e di emancipazione – come afferma Laclau (2005) –, sia uno strumento di tensione con la democrazia. Qui si insiste sulla sua capacità di costruire un concetto di “popolo” (o di “gruppo interno”) che si oppone a un nemico esterno (Woods 2014).
Lo studio del populismo in Russia è ancora poco approfondito, dato che finora i paradigmi dominanti attraverso i quali
studiare il regime sono stati il nazionalismo o i diversi livelli di autoritarismo, nonostante il ruolo centrale riconosciuto su scala planetaria al populismo nei regimi neo-autoritari (come in Venezuela o in Cina). Inoltre, lo studio della narrativa populista utilizzata dal governo russo per definire il “popolo” può avere ripercussioni in ambito di politica estera (Faizullaev y Cornut 2016), dato che il populismo può essere anche transnazionale, con appelli a destinatari stranieri da parte dei mezzi russi internazionali.
Populismo e nazionalismo: considerazioni concettuali
Il modo in cui i leaders populisti definiscono la politica spesso può portare ad una polarizzazione (Taggart 2017). La guerra e i conflitti armati hanno bisogno di questa polarizzazione del “noi” contro di “loro”. Definire il popolo è dunque fondamentale, dato che le narrative si usano a modo di strumenti di argomentazione politica e di persuasione, come hanno mostrato Faizullaev e Cornut (2016).
Nel conflitto con l’Ucraina è entrata in gioco la dimensione populista nell’attuale politica russa. Per questo bisogna definire chi rappresenta il “noi” e il “loro”, specialmente a causa dei legami storici intricati tra Russia e Ucraina. Il discorso ufficiale russo ha creato un popolo che è diventato politico e, addirittura, il destinatario ad hoc del conflitto con l’Ucraina. Accademici come Teper (2016) hanno mostrato il modo in cui la televisione russa aveva spostato poco a poco il focus del discorso identitario ufficiale dallo Stato alla nazione; altri, come Hutchings e Szostek (2015), hanno presentato le narrative che hanno prevalso nel discorso politico e mediatico russo durante la crisi ucraina, legate alla «missione di costruire la grande nazione» russa, un’idea che si è intensificata sotto il mandato di Putin.
Contrariamente a questa tesi nazionalista, qui si considera il populismo come uno strumento di grande importanza per Putin al fine di perpetuare il suo potere e la gloria nazionale come caratteri distintivi, la cui perdita sarebbe una minaccia… per il suo regime (Aron 2017; Fish 2017).
Consideriamo, quindi, che populismo e nazionalismo non sono la stessa cosa. Secondo Yannis Stavrakakis (2005): «nonostante sia populismo che nazionalismo Il discorso ufficiale russo ha creato un popolo che è diventato politico e, addirittura, il destinatario ad hoc del conflitto con l’Ucraina
condividano una logica equivalente, si articolano innanzitutto intorno a points de capiton distinti (la nazione e il popolo rispettivamente) e in secondo luogo, costruiscono un nemico molto distinto come altro antagonista: nel caso del nazionalismo di solito il nemico da affrontare è un’altra nazione; mentre nel populismo il nemico è di tipo interno – i poteri forti, i settori “privilegiati”, ecc."» .
Nel caso del populismo, è possibile identificare i nemici dentro la propria nazione e gli amici al di fuori. Inoltre, mentre il nazionalismo può contare su un gruppo rappresentato chiaramente delimitato, il populismo no, dato che la sua base è puramente “politica” e ha bisogno di funzionare politicamente per mantenersi unita. Dalla definizione di populismo di Laclau (2005) si possono estrapolare tre concetti fondamentali:
- il non considerare il popolo come un’unità data, preesistente. Su questo punto il populismo si distingue chiaramente dal nazionalismo, il quale assume un’entità preesistente mitica, etnicamente pura, la cui esistenza è anteriore alle lotte politiche e alla modernizzazione dell’economia. La maggior parte dei nazionalisti credono che il loro popolo sia sempre esistito, mentre i populisti no. Per loro e per i teorici del populismo come Laclau, il popolo è una categoria politica, una soggettività politica che deve ancora nascere. Questo aspetto è particolarmente importante nel contesto sovietico e post sovietico, dato che entrambi hanno sempre operato con
nozioni di popolo diverse, come russkij narod, rossiiskij narod o sovietskij narod, dove le ultime due sono il risultato della fusione di diversi paesi.
-
stabilire una frontiera dicotomica che divide lo spazio politico e separa il popolo da un nemico comune. In questo senso, la guerra è la tipica situazione che non lascia spazio a terze opzioni e nella quale lo spazio politico rimane ridotto a un “noi contro di loro”. Questo meccanismo sarebbe simile al modo in cui opera il nazionalismo, ma nel populismo la dicotomizzazione non si basa su nazionalità, etnia o razza.
-
Elementi che possono unire il popolo e i diversi settori o richieste, come i simboli. Questi sono il collante che unisce diversi interessi ed elementi discorsivi in un unico discorso populista: un collante che risulta necessario, perché il popolo è vario e quindi pieno di diverse richieste che possono essere incoerenti. Ecco perché i simboli agiscono come punti nodali di unione. A differenza del nazionalismo, il populismo non dispone di riferimenti a un mito fondativo o, antenati comuni o legami di sangue. Ha però bisogno di simboli simili, anche se nel populismo questi sono molto più spontanei e circostanziali. Allo stesso tempo, deve comparire un leader populista, che possa ricondurre ad ogni elemento del discorso.
Poniamo ora in relazione le tre componenti concettuali del populismo sovraesposte con tre insiemi di problemi che presenta il discorso ufficiale russo nel contesto della crisi ucraina, per capire in che misura si tratti di una formulazione populista.
a) In primo luogo, si identifica il soggetto politico collettivo che si è creato, ovvero, occorre sapere di che popolo stiamo parlando. Il caso ucraino è interessante, perché in Russia esiste una lunga tradizione che sostiene che l’Ucraina, e in particolare Kiev, sono la culla dello Stato russo. Inoltre, per rendere più legittima l’annessione della Crimea, si presentò una nuova definizione di entità russa che andava oltre la mera dimensione nazionale etnica e che potesse includere la Crimea nello spazio nazionale russo. Si affermò addirittura che la Crimea era la culla della Russia. Nel contesto del successivo referendum si unirono in un unico fronte ogni tipo di pregiudizio, richiesta e lamentela della popolazione della Crimea contro Kiev, per contribuire a conformare un nuovo soggetto politico. Per questo sia il populismo che il nazionalismo furono alternati in base ai destinatari: si utilizzò un discorso populista con gli abitanti della Crimea e uno nazionalista con il pubblico domestico (Teper 2016).
b) Si determinò una situazione binaria in cui fu collocato questo soggetto politico, per il quale i referendum sono risultati particolarmente adatti. La divisione dello spazio politico è stata pensata in varie forme, tra le quali una divisione tra il popolo della Crimea e le élites di Kiev, presentate come indifferenti alle esigenze della Crimea e più tardi anche del Donbass; divisione che è stata formulata anche in termini nazionali, linguistici e politici. c) Nuovi simboli collettivi, quali slogan, leaders ecc., sono stati usati per creare questo nuovo soggetto politico, come lo slogan Krimnash («La Crimea è nostra»); i nastri di San Giorgio, o lentohchki, simbolo della vittoria nel 1945 che attualmente sono un simbolo più ampio di patriottismo russo; e di figure come il Procuratore Generale della Crimea, Natalia Polonskaiatrasformata in una stella di Youtube-, o dello stesso Vladimir Putin. Sono tornati in auge addirittura simboli comunisti come lo stesso nome di «repubbliche popolari» di Donetsk e Luhansk, così come il ritratto di Putin come saggio dirigente nel documentario Il cammino verso la Crimea (finanziato dallo Stato russo) che si avvicina al modo in cui si rappresentava Stalin prima della politica di destalinizzazione di Jruschov.
L’uso del populismo nelle politiche russe nell’est dell’Ucraina: il popolo
Nel discorso ufficiale russo, costruito attraverso le parole di Vladimir Putin, «il popolo russo» si definisce combinando una visione generica e allo stesso tempo multipla di entità russa. Per
Putin, i russi sono un popolo multinazionale, concezione che si basa sia sulla definizione russa presovietica incentrata sulla fusione spirituale dei popoli (dujovnoe slijanie), sia sull’apparizione di un popolo sovietico (Tolz 2011). Egli sottolinea il fatto che i distinti gruppo etnici, nazioni e nazionalità che vivono in Russia, sono uniti da un «potente codice genetico» e culturale comune, che raccoglie la totalità del mondo russo (Russkij mir). Ad esempio, il popolo che appartiene al mondo russo è caratterizzato da una particolare moralità, grazie alla quale i suoi membri si sentono connessi da una visione collettiva che va oltre l’individualità. Altri valori, come il sacrificarsi per un amico o per la patria, costituirebbero la spina dorsale del patriottismo russo. Con parole dello stesso Putin: «siamo meno pragmatici e meno calcolatori che i rappresentanti di altri popoli, ma abbiamo più cuore. Forse è un riflesso della grandezza del nostro paese e della sua vasta immensità. La nostra gente ha uno spirito particolarmente generoso» (2014c).
Quindi non sono la nazionalità, l’etnia o la lingua a determinare il carattere russo, bensì un insieme di qualità e valori, soprattutto morali. Questa retorica, che sposta l’attenzione dai tratti razziali a quelli civici, è molto estesa nei gruppi nazionalisti in Europa occidentale – per esempio tra britannici e greci – ed evidenzia la possibilità di sovrapporre affermazioni populiste e nazionaliste. La storia sovietica è stata evocata con il proposito di costruire un’immagine dei russi come popolo vittimizzato, vittima della repressione del regime sovietico, del fascismo e della Seconda
Guerra Mondiale, e anche della dissoluzione dell’URSS. I russi sono stati presentati come un popolo privato dei suoi diritti, svantaggiato e addirittura oppresso – tutti i popoli soffrirono la disintegrazione dell’URSS, afferma Putin, ma soprattutto i russi. Secondo Putin (2014b), «milioni di
Questa retorica, che sposta l’attenzione dai tratti razziali a quelli civici, è molto estesa nei gruppi nazionalisti in Europa occidentale
persone andarono a dormire in un paese e si svegliarono in un paese diverso».
Putin (2014a) si è riferito all’Ucraina in termini cordiali: non solo è una nazione vicina, ma anche «una repubblica sorella», un «paese amico»; gli ucraini sono tutti uguali per noi, sono «nostri fratelli». Egli ha affermato che la Russia non avrebbe lottato contro il popolo ucraino, dato che è il popolo con cui i russi hanno legami storici, culturali ed economici più stretti.
Il discorso di Putin inizialmente era costruito intorno alla speranza che gli ucraini comprendessero che in Crimea la Russia non aveva altre opzioni e che rispettassero la volontà degli abitanti della Crimea. Putin si è presentato addirittura come il paladino dei veri diritti degli ucraini, sottolineando che in Ucraina sono stati i politici corrotti ad aver «spremuto il paese e lottato contro di loro per il potere» (2014b). Contro la corruzione, l’inefficiente gestione pubblica e la povertà, Putin ha tentato di accreditarsi come il leader della lotta di questo popolo contro un élite politica corrotta, come aveva fatto per i crimei. Nel suo discorso, è stato il governo dell’Ucraina ad avere fallito, non il popolo ucraino, e per questo ha affermato di empatizzare con l’Ucraina, una terra che «ha sofferto molto» e che dal 2014, nei suoi territori occidentali, avrebbe vissuto una nuova recrudescenza del nazionalismo e del neonazismo (2014c).
A questo punto, Putin ha iniziato a dividere la popolazione ucraina, affermando che la situazione nel centro, est, e sudest è una questione distinta rispetto al resto del paese. Questi territori che, secondo lui, cosituiscono Novorossiya o la Nuova Russia, furono ceduti all’Ucraina nella decade del 1920 da parte del governo sovietico, e quindi le sue radici sono strettamente legate alla Russia. Gli abitanti di Novorossiya «hanno una mentalità in certo modo distinta» che rende difficile che possano relazionarsi con l’Occidente; cita anche la composizione etnica della Crimea come elemento di differenza del sud est dell’Ucraina. «La Crimea è stata e continua ad essere terra di russi, ucraini e tatari» che poi riduce a due grandi gruppi
l’annessione della Crimea è stata presentata come l’espressione di una volontà popolare
linguistici ovvero russofoni e tatari, minimizzando le ingiustizie sofferte dai tatari (2014b).
La separazione della Crimea dalla Russia è stata decretata sotto il mandato di Jrushov. Secondo Putin, essa è stata il risultato di una decisione sbagliata presa da politici sbagliati: egli è solito
presentare decisioni del passato ritenute erronee come contrarie al senso comune e alla volontà popolare. Quindi l’annessione della Crimea è stata presentata come l’espressione di una volontà popolare, una ribellione contro le decisioni sbagliate prese in passato. Il popolo si sarebbe aspettato una nuova entità politica capace di sostituire l’URSS e avrebbe sperato che la Comunità di Stati Indipendenti svolgesse questa funzione.
Inoltre i russi «sono persone native in Ucraina», espressione con la quale viene aggiunto un altro intreccio tra russi e ucraini nello spazio post sovietico. Putin si sente responsabile di «tutti i russi in qualunque luogo», inclusi quello che stanno in Ucraina, in particolare in Crimea, dove effettivamente una gran parte della popolazione è russofona.
I nemici
«I paesi occidentali ci hanno mentito molte volte e prendono decisioni alle nostre spalle interpretando le leggi internazionali a loro piacere». Secondo Putin non è stata la Russia a cominciare le ostilità. La Russia avrebbe anzi avvisato per tempo gli statunitensi e gli europei di non continuare a prendere decisioni affrettate e di nascosto per annettere l’Ucraina all’UE, cosa che costituirebbe una grave minaccia per l’economia dell’Ucraina e per gli interessi della Russia quale suo principale socio commerciale. Oltre all’Occidente in generale, Putin ha individuato come maggior nemico gli Stati Uniti, accusati di autoproclamarsi vincitori della Guerra Fredda e di proporsi come unico centro di potere mondiale, portando alla costruzione di un mondo unipolare incapace di rispondere alle “vere minacce”, come i conflitti regionali, il terrorismo, il traffico di droga, il fanatismo religioso e il neonazismo (2014d).
L’ultimo nemico ad essere identificato da Putin è stato la NATO, che non avrebbe mantenuto la sua promessa di non estendersi più a est. Per tale ragione, la Russia si troverebbe di fronte alla minaccia di essere «realmente espulsa da questa regione, che è estremamente importante per noi». Putin inoltre ha insistito sul
fatto che in Occidente si usano due pesi e due misure: gli Stati Uniti possono intervenire in paesi come Yugoslavia, Iraq, Afganistan e Libia, e invece non si considera appropriato che la Russia «difenda i suoi interessi», tra i quali il Kosovo sarebbe l’esempio più lampante (2014c).
L’ultimo nemico ad essere identificato da Putin è stato la NATO che non avrebbe mantenuto la sua promessa di non estendersi più a est
I simboli
Diamo ora brevemente conto di alcuni simboli individuati dalla retorica populista e nazionalista utilizzata da Putin e dal regime russo.
Nel contesto della crisi della Crimea e la guerra del Donbass un primo simbolo può essere costituto dalla comparsa di militari in vari punti della Crimea attrezzati come truppe d’assalto, ma senza emblemi nazionali. Ciò ha fatto pensare a una forza militare pura, senza Stato, nella quale tutti potevano identificarsi. Quando si venne a sapere che quei soldati erano forze speciali
russe, contribuirono a offrire l’immagine di una forza militare moderna, che aveva superato le sconfitte del passato, e si proponeva come simbolo di un uomo nuovo, un nuovo potere russo in cui identificarsi e di cui essere orgogliosi. Quest’immagine della Russia forte e mascolina si contrappone in particolare a un altro simbolo apparso nella prima fase della crisi ucraina: l’immagine di Natalia Poklonskaija, Procuratore generale della Crimea, che rappresentava lo stereotipo femminile debole e vittimizzato, di una Russia in pericolo.
Un’immagine della Russia forte e mascolina
Un altro simbolo chiave è stato il ponte costruito per unire la Federazione Russa con la Crimea, che Putin inaugurò nel maggio 2018, prima del previsto e con una gran trovata pubblicitaria: guidando un tipico camion russo Kamaz dal continente fino alla penisola. Un progetto costosissimo e
simbolico, per mostrare l’unione dei due territori.
Infine, la Crimea stessa è diventata un simbolo nel discorso populista: «La Crimea è la nostra eredità storica comune e un fattore di enorme importanza per la stabilità regionale; questo territorio strategico deve formar parte di una sovranità solida e stabile, che al giorno d’oggi solo può essere russa» (Putin 2014b).
Conclusioni
Quest’analisi ha inteso mostrare gli sforzi di Putin volti a tracciare una visione degli ucraini e dei russi come un unico popolo con un passato comune, con simboli condivisi e nemici comuni e a sottolineare la necessità di creare un popolo che vada oltre la dimensione meramente etnica e nazionale. Questo popolo si identifica con l’opposizione a determinate élites e a determinati nemici del passato e del presente. Questa prospettiva populista è il punto forte di Putin, ma è anche la sua debolezza: i suoi discorsi attivano narrative storiche non per rappresentare una nazione, bensì, come esige la retorica populista, per creare un popolo.
Identificare dei chiari nemici aiuta in questo compito. Quindi, oltre a proporsi come un paladino della giustizia che si prefigge di riparare gli errori del passato Putin, si presenta come colui che, invocando l’Occidente come nemico, intende ricreare un sovietskij narod (popolo sovietico), anche se questo popolo non esiste più.
Il nazionalismo tuttavia non scompare nella comunicazione propagandistica del regime. Esso svolge anzi un ruolo importante nel discorso ufficiale russo, in cui si intrecciano, come abbiamo visto, elementi populisti, imperialisti e nazionalisti. Ma l’appello al populismo comporta che il nazionalismo russo di stampo etnico venga trasceso e che il discorso nazionalista sia utilizzato per creare l’immagine di un popolo multinazionale cosciente di essere oppresso e vittimizzato, capace così di compattarsi contro le supposte élites corrotte (in particolare in Ucraina), il fascismo e l’Occidente.
Bibliografia
L. ARON, «The Kremlin Emboldened: Putinism After Crimea». Journal of Democracy, vol. 28, n.4 (2017)
P. CASULA, «Sovereign Democracy, Populism, and Depoliticization in Russia: Power and Discourse During Putin’s First Presidency». Problems of PostCommunism, vol. 60, n.º 3 (2013)
A. FAIZULLAEV y J. CORNUT,«Narrative practice in international politics and diplomacy: The case of the Crimean crisis». Journal of International Relations and Development, vol. 20, n.º 3 (2016)
S. FELLA e C. RUZZA, «Populism and the Fall of the Centre-Right in Italy: The End of the Berlusconi Model or a New Beginning?». Journal of Contemporary European Studies, vol. 21, n.º 1 (2013)
S. M. FISH, «What Is Putinism?». Journal of Democracy, vol. 28, n.º 4 (2017) M. FOUCAULT, Power/Knowledge. Selected Interviews and Other Writings 1972- 1977, Pantheon, NewYork, 1980
P. KOLSTØ y H. BLAKKISRUD, «Introduction: Exploring Russian nationalisms», in Russia Before and After Crimea: Nationalism and Identity, 2010-17. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2018
H. E. HALE, Is Russian Nationalism on the Rise? Davis Center for Russian Studies, Harvard, 2000
J. IOFFE, «What Putin Really Wants». The Atlantic (febbraio 2018) https:// www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/01/putinsgame/546548
S. HUTCHINGS y J. SZOSTEK, (2015) «Dominant narratives in Russian political and media discourse during the Ukraine crisis». E-International Relations (28 aprile 2015) http://www.e-ir.info/2015/04/28/dominantnarratives-in-russian-politicaland-media-discourse-during-the-crisis/
E. LACLAU, On Populism. Verso, Londres, 2005
V. PUTIN, «Vladimir Putin journalists’ questions on the situation in Ukraine». President of Russia website (4 marzo 2014a) http://en.kremlin. ru/events/president/news/20366
V. PUTIN, «Address by President of the Russian Federation». President of Russia website (18 marzo 2014b) http://en.kremlin.ru/events/president/ news/20603
V. PUTIN, «Direct Line with Vladimir Putin». President of Russia website (17 aprile 2014c)
http://kremlin.ru/events/president/news/20796
V. PUTIN «Meeting of the Valdai International Discussion Club». President of Russia website (24 ottobre 2014d) http://en.kremlin.ru/ events/president/news/46860
Y. STAVRAKAKIS, «Religion and Populism in Contemporary Greece». In: Panizza, Francisco (ed.). Populism and the Mirror of Democracy. Verso, Londres, 2005
P. TAGGART, Populism. Open University Press, Buckingham, 2000
P. TAGGART, «Populism and representative politics in contemporary Europe». Journal of Political Ideologies, vol. 9, n.º 3 (2004)
P. TAGGART, «Populism and “unpolitics”: Populism and Unpolitics: Narratives of Conspiracy, Religion and War». Mobilising «the people»: The rise of populist nationalism in Europe conference, 16.1.2017, Loughborough University
Y. TEPER, «Official Russian identity discourse in light of the annexation of Crimea: national or imperial?». Post-Soviet Affairs, vol. 32, n.º 4 (2016) V. TOLZ, Russia’s Own Orient. Oxford University Press, Oxford, 2011
D. WOODS y B. WEJNERT, (eds.). Many Faces of Populism: Current Perspectives. Emerald Group Publishing, Bingley, 2014
Traduzione di Valeria Giacomoni


Conversazione con Goffredo Fofi
a cura della redazione
Goffredo Fofi, nato a Gubbio nel 1937, è sicuramente uno dei principali punti di riferimento di una cultura libertaria oggi in Italia. Critico letterario e cinematografico, scrittore, animatore di riviste e di gruppi di azione, maestro elementare e operatore sociale, da oltre sessant’anni cammina in direzione «ostinata e contraria» rispetto alle varie forme che assume sistematicamente il dominio. Questa breve conversazione ci offre innumerevoli stimoli per migliorare lo sguardo libertario che questa rivista intende praticare e, soprattutto, ci incoraggia nella scelta che abbiamo intrapreso, per tenere sempre uniti pensiero e azione e per mettere a punto un pensiero antiautoritario e solidale, propositivo e positivo.
«Semi sotto la neve»: questa felice espressione di Ignazio Silone è stata ripresa da Colin Ward per esemplificare la sua teoria dell’organizzazione anarchica. L’anarchia è qualcosa che già esiste, nonostante tutte le forme di dominio esistenti, in tutte quegli esempi di autorganizzazione che uomini e donne hanno via via messo in atto per risolvere in modo libertario i vari problemi sociali e personali che si sono trovati di fronte. Condividi questa visione? Se sì qual è la sua più vera espressione?
Sono ovviamente d’accordo con Colin, anche se non ho la profondità di pensiero e di conoscenze che lui aveva (in parole povere, sono in fondo un autodidatta, ho studiato da maestro elementare e da assistente sociale e non ho fatto – e quando mi ci sono accostato ne sono rimasto sconcertato - l’università, un mondo che mi pare sempre più da riformare, partendo proprio dalle basi). Anche perché nella mia esperienza, da sud a nord,
qui a Conversazione con Goffredo Fofi Conversazione con Goffredo Fofi
ho incontrato tante situazioni come quelle descritte da Colin, e altre ho contribuito a metterne in piedi. Per esempio la Mensa dei bambini napoletana degli anni settanta, e tutto il lavoro delle riviste, che ho voluto fosse sempre un vero lavoro di gruppo; e la cosa che oggi mi manca di più è proprio il lavoro di gruppo, che la «cultura del narcisismo» ha messo fortemente in crisi; ed è proprio per questo che guardo con molta attenzione ai piccoli raggruppamenti che nonostante tutto continuano a nascere (e alle riviste! «semi sotto la neve» anche loro, quando non sono strumenti di affermazione e di carriera, o sfoghi narcisistici di frustrati idolatri della cultura e nemici del rapporto indispensabile tra pensiero e azione). Il piccolo gruppo ha valore non solo come difesa dalla opprimente bruttezza della storia e della società, che lascia oggi poco spazio alla solidarietà, ma come luogo di esperienze che rafforzino la nostra capacità di capire e di agire.
Sempre molto interessante il tuo sguardo nei confronti dell’azione sociale. In particolare trovo stimolante la tua riflessione sulla funzione delle minoranze attive nel processo di cambiamento sociale. In tuo libro del 2006 («Da pochi a pochi», Elèuthera) riflettevi sulla necessità di non separare mai pensiero e azione. E ti chiedevi cosa possano fare le minoranze «lucidamente perdenti», quali di queste sono oggi «frequentabili», come trasmettere ad altri i valori e l’esempio di quelle più degne, di ieri e di oggi, come gridare nelle circostanze attuali il nostro «non accetto». Tu hai partecipato a diverse minoranze attive, hai creato molte esperienze minoritarie ma importanti, hai insomma vissuto da minoranza con il pessimismo della ragione e l’ottimismo della volontà. Tra le tante, vorrei qui chiederti di soffermarti su di una in particolare.
Agli esordi della tua lunga e intensa attività di animatore di esperienze e di riviste, di critico e polemista, di studioso e di ricercatore, hai sposato la straordinaria esperienza siciliana di Danilo Dolci. Puoi tratteggiarcene una breve presentazione? Quali sono le peculiarità, le caratteristiche più interessanti, il metodo più coerente, che Dolci ha sperimentato tra il 1952 e i primi anni settanta?
È uscito di recente un ottimo saggio storico di un giovane, Marco Grifo, che si intitola «Le reti di Danilo Dolci» (Franco Angeli editore, che lo fa pagare davvero troppo) e che non parla soltanto di quelle, ma in generale delle reti del dopoguerra, degli anni della ricostruzione e della democrazia, dei rapporti intrattenuti da operatori, intellettuali e militanti in una confluenza di esperienze e di conoscenze, di scambi e di proposte… da nord a sud, da punti di partenza diversi per competenze e aspirazioni. Un’Italia di cui ci siamo dimenticati. Danilo fu un personaggio esemplare e centrale di quegli anni, ma anche lui come tanti altri «lottatori» (da Pasolini a Bianciardi a Mastronardi, per fare i nomi di tre narratori e polemisti di punta degli anni cinquanta) fu sconcertato dal boom economico e dalla grande mutazione, proprio antropologica, di quegli anni, che cambiò il carattere stesso del nostro popolo; e reagì – quando vide che le dighe ormai le costruiva lo stato e ne approfittavano le mafie – dedicandosi a imprese più pedagogiche che sociali (o «politiche»). Ma il contributo che ha dato alla conoscenza delle disparità economiche e sociali di quelli anni, alla vita vera dei contadini, disoccupati, banditi, è stato enorme. E non va dimenticato che Dolci, come per esempio Pasolini, che aveva ben conosciuto, era anche un poeta, e non dei meno forti. Sono sempre stato affascinato dal legame, in loro, tra una vocazione poetico-letteraria (da un forte fondo filosofico e in qualche modo religioso, se non altro nella lotta per un mondo di giustizia; e non è casuale che entrambi avessero avuto dei rapporti con un prete-poeta come Turoldo) e una vocazione decisamente sociale, eminentemente attiva.
(Noi che siamo cresciuti dentro il boom, e dentro le nouvelles vagues, eravamo più disposti ad affrontarlo cercando nuovi modi di reagire, quelli che poi hanno portato al ‘68).
Conversazione con Goffredo Fofi
In particolare ci piacerebbe che tu ti soffermassi sull’idea dolciana di sciopero alla rovescia. Qual è il valore innovativo di questa idea e come è spendibile oggi seppur in contesti così diversi?
Va chiarito che non è stato Danilo a inventare lo sciopero a rovescia, sulla base della constatazione che i disoccupati non possono ovviamente occupare il luogo del loro lavoro, ma che si trattava di esperienze nate spontaneamente nelle lotte dei disoccupati del dopoguerra. Assistite e a volte anche stimolate ai livelli locali dal sindacato, nella speranza che gli enti locali provvedessero (ma qualche volta accadde?) a compensare il lavoro socialmente utile fatto dai disoccupati. Quello degli inizi del 1956 di Partinico, a cui ho avuto la fortuna di prendere parte, fu preparato da un digiuno collettivo sulla spiaggia di Trappeto, con i disoccupati che pochi giorni dopo occuparono la «trazzera vecchia» di Partinico – una trafficata strada di campagna che partiva dal paese – con zappe e badili, per rimetterla in sesto. Grazie al rapporto epistolare instaurato con Aldo Capitini, teorico-pratico della nonviolenza, Danilo aveva scoperto Gandhi e i suoi metodi di lotta; e se aveva fatto precedere da un digiuno lo sciopero era anche perché poco tempo prima a Venosa (Basilicata) un ragazzo, che mi pare si chiamasse Rocco Girasole, era stato ucciso dalla polizia durante uno sciopero di disoccupati.
Di quel periodo ricordo tante cose, quelle fondamentali per la mia formazione, e tra loro anche che a Partinico feci un po’ di scuola serale a ex banditi della banda Giuliano man mano che uscivano dal carcere (Montelepre dista 8 chilometri da Partinico, molti di loro erano partinicesi) e conobbi degli straordinari militanti di base socialisti e comunisti e alcuni giovani sindacalisti non molto alfabetizzati. Grazie a Danilo conobbi anche, a Sciara, la madre di Salvatore Carnevale, e a Corleone il padre di Placido Rizzotto, ammazzati dalla mafia.
Il lavoro di Danilo va insomma inquadrato in un contesto di iniziative e di lotte più vasto, meridionale e nazionale, e in riferimento ad altri grandi militanti e intellettuali del tempo, in Sicilia e altrove i «meridionalisti» (Giuseppe Di Vittorio, Carlo Levi, Rocco Scotellaro e Rocco Mazzarone), Manlio Rossi-Doria, gli olivettiani di Matera, Tommaso Fiore a Bari, i giornalisti di «L’ora» di Palermo, Ernesto de Martino, Vittorio de Seta, e tra Sud e Nord Raniero Panzieri e i «Quaderni rossi», e a Roma la scuola del «Cepas» e il gruppo attorno ad Angela Zucconi del «progetto pilota» di sviluppo di comunità dell’alto Abruzzo, l’Associazione di Silone, e Guido e Maria Calogero, e riviste come «Nuovi Argomenti» e «Tempo presente», e un settimanale come «Il mondo» di Pannunzio, e quel che restava del «giro» di Ernesto Buonaiuti soprattutto intorno a Arturo Carlo Jemolo, e i comunisti Dina Jovine e Lucio Lombardo Radice con la rivista «Riforma della scuola», e a Firenze Piero Calamandrei e «Il ponte», Romano Bilenchi e «Il nuovo corriere», un sindaco come Giorgio La Pira, e don Lorenzo Milani e don Facibene, e ancora in Toscana Luciano Bianciardi e Carlo Cassola, e a Torino il giro di amici di Ada Gobetti e Bianca Guidetti-Serra, di Antonicelli e Norberto Bobbio, e ancora al nord Danilo Montaldi e i cremonesi, e molti dell’Umanitaria a Milano, e in giro per la penisola i maestri del Movimento di cooperazione educativa e dell’Unione lotta contro l’analfabetismo, eccetera, eccetera. Una «rete» che lambiva in qualche modo anche la politica ufficiale, grazie ai Ferruccio Parri, ai Lelio Basso, a tanti comunisti soprattutto i meno condizionati da Mosca.
Chi sono (e perché) i tuoi maestri?
Ne dichiaro a ragion veduta quelli dai quali credo di avere imparato di più, e dopo Danilo Dolci e Aldo Capitini e, su un fronte più «marxista» e «operaio» Raniero Panzieri, si tratta soprattutto di donne, Ada Gobetti e Angela Zucconi, Gigliola Venturi e le maestre del Movimento di cooperazione educativa (MCE), più tardi due immense scrittrici e pensatrici come Elsa
qui a Conversazione con Goffredo Fofi Conversazione con Goffredo Fofi
Morante e Anna Maria Ortese; ma con loro vorrei ricordare gli ultimi e più veri «pedagogisti» (nel senso dell’educazione civica) che l’Italia abbia avuto, don Lorenzo Milani, Pier Paolo Pasolini e Leonardo Sciascia – dai quali confesso di avere molto più da imparare che dai «marxisti», anche di quelli che si consideravano i più puri. Dell’area dei «Quaderni piacentini», con Grazia Cherchi e Piergiorgio Bellocchio, forse qualcosa sono riuscito a imparare da poeti e scrittori come Paolo Volponi e Vincenzo Consolo, Vittorio Sereni e Giovanni Giudici, Andrea Zanzotto e Fernando Bandini, e da un grande psicanalista libertario come Elvio Fachinelli – insomma i poco o niente «marxisti». (Fu Elvio a correggere uno di noi che parlava in una riunione di un nostro «marxismo critico» dicendo giustamente che «se è marxismo, non è critico»). Ma non vorrei dimenticare i francesi – gli amici del «reseau Jeanson» e i redattori di «Positif» eccetera – e i registi cinematografici che più ho amato e che ho avuto modo di conoscere, Luis Buñuel e Fritz Lang (e ci aggiungerei Robert Bresson; e in Italia Federico Fellini e, ovviamente, Carmelo Bene amico e maestro). Quanta fortuna ho avuto, nella vita!
So di avere imparato molto o moltissimo da dei coetanei o quasi, Grazia Fresco, Grazia Cherchi, Piergiorgio Bellocchio, Vittorio Rieser, Dario e Liliana Lanzardo, Marcello Benfante, Franco Maresco, Lorenzo Barbera, Alberto L’Abate, Francesco Ciafaloni, Carlo Donolo, Mariuccia Salvati, Paul-Louis Thirard, Paolo Gobetti, Luca Baranelli, Alfonso Berardinelli, Giancarlo Gaeta, Amedeo Bertolo, Maria Concetta Sala, Lucia e Cinquia Mastrodomenico, Peppe Carini, Giampiero Brega, Beppe Gozzini, Paola Costa, Gianluigi Castelli, eccetera, eccetera, eccetera. E dai bambini, da quelli di Palermo e di Napoli, poverissimi e maestri nell’arte della sopravvivenza e della solidarietà. (Un libro che ho conservato negli anni, di Caroline Pratt, una maestra statunitense degli anni trenta-quaranta, si intitolava «Imparo dai bambini», ed è tra quelli che mi sono rimasti più cari).
Questa lista apparentemente lunga di nomi di persone che hai incontrato, con le quali hai condiviso momenti e tempi significativi, persone che rappresentano sensibilità diverse ma autenticamente libertarie, può apparire uno sterile elenco. In realtà credo sia giusto cogliere come già nell’Italia del secondo dopoguerra esistesse un milieu culturale che, seppur minoritario, testimoniava e agiva con spirito laico e libertario. Minoranze all’interno di una società, quella italiana, fortemente condizionata da due chiese (cattolica e marxista) che si cercheranno e si uniranno in quell’aggregazione catto-comunista che ha egemonizzato la cultura italiana e ha impedito a questo paese di trovare una propria autonomia laica e veramente progressista nella forma di un socialismo libertario e non autoritario.
Dagli anni settanta ti sei impegnato (anche oggi) a editare importanti riviste culturali e politiche («Quaderni Piacentini», «Linea d’ombra», «La terra vista dalla luna», «Ombre rosse», «Lo straniero», «Gli asini», ecc.). Evidentemente hai sempre ritenuto il mezzo della rivista stampata uno strumento fondamentale per promuovere una cultura del dissenso. Che ne pensi oggi in un’epoca invasa da altri mezzi di comunicazione o meglio di disinformazione?
Ho purtroppo abbandonato il lavoro che mi piaceva di più e da cui ho ricavato le migliori esperienze e soddisfazioni, quello con i bambini, e anche, dopo la Torino dei «Quaderni rossi» e degli immigrati, delle grandi lotte operaie, sono diventato «un intellettuale» e me ne vergogno. Potessi tornare indietro, non lo rifarei… Ma l’aspetto migliore di questa nuova e secondaria vita è stato il tentativo di legare tra loro esperienze e persone anche disparate attraverso il lavoro delle riviste – che non sono mai state specialistiche ma aperte a esperienze e competenze diverse, a regioni diverse, a età diverse, secondo un’idea di apertura che ho appreso soprattutto da Aldo Capitini. Oggi, mentre diffido sempre più degli specialismi e dei conseguen-
ti narcisismi (e dei professori universitari!), guardo però con attenzione a piccoli gruppi locali che cercano di studiare, pensare, fare, per esempio a riviste locali come «Malamente» nelle Marche o «Scorci» in Sicilia. O «Semi sotto la neve»! Il piccolo gruppo purché attivo e non chiacchierone o, peggio, strumento di affermazioni personali, è una delle poche cose che oggi vanno davvero sostenute e propagandate. I nemici principali, sia chiaro, sono oggi le banche e internet.
Goffredo Fofi, lo si coglie anche in questa conversazione, ci rende consapevoli del significato concreto dell’essere minoranza, ma ci incoraggia a riflettere da un lato ma ad agire dall’altro. Ci mette in guardia dal pericolo del narcisismo (uno dei suoi autori preferiti è quel Christopher Lasch che sul narcisismo ha scritto pagine illuminanti) e dalle derive che esso produce in una società come la nostra. Ci dimostra come sia oggi più che mai necessario ricostruire una cultura laica, socialista, libertaria che sappia nutrirsi delle intuizioni di un attualizzato pensiero anarchico. Fofi, quando denuncia la cultura dello spettacolo, quell’ostentata e superficiale produzione e manifestazione culturale che oggi rappresenta spesso solo una logica performante ed economica, quando smaschera gli intellettuali di professione e da talk show, quando ci indica come indispensabile e imprescindibile il lavoro di tessitura e di raccordo tra esperienze prefigurative e pensiero critico, rappresenta sicuramente una figura che con piacere annoveriamo tra i nostri maestri.



Èdouard Jourdan
È in reazione al neoliberismo che all’inizio degli anni Ottanta prende piede il movimento dei beni comuni. Il suo principio? L’autorganizzazione decentralizzata delle comunità di vita e di lavoro. I suoi obiettivi? Da un lato riappropriarsi e preservare le risorse di fronte alle molteplici forme di privatizzazione e di rapina, dall’altro esercitare l’autogoverno attraverso l’elaborazione di regole comuni. Se è vero che quello dei beni comuni è un movimento eterogeneo, è altrettanto vero che i suoi princìpi ispiratori richiamano quelli che costituiscono l’ossatura principale dell’anarchismo. Malgrado le numerose teorie che a esso si richiamano, l’anarchismo poggia su alcuni princìpi che possono costituire un denominatore comune. Possiamo concepirli ogni volta in una duplice accezione: negativa e positiva. Il rifiuto dell’autorità coercitiva, incarnata dallo Stato o dal governo, rimanda alla libera associazione o alla federazione di individui e gruppi; il rifiuto del capitalismo e dello sfruttamento rimanda all’abolizione delle classi sociali attraverso la riorganizzazione della produzione; il rifiuto dell’alienazione conduce allo sviluppo dello spirito critico e antidogmatico, primo passo per spezzare la servitù volontaria.
Inoltre, nell’anarchismo la libertà non può essere separata dall’uguaglianza: esse si sostengono a vicenda. La libertà senza uguaglianza, nell’accezione liberale, giustifica lo sfruttamento di un
Nell’anarchismo la libertà non può essere separata dall’uguaglianza
individuo da parte di un altro; l’uguaglianza senza libertà è autoritaria e giustifica il dominio di un gruppo su un altro. In virtù di questa conformazione, l’anarchismo si propone come superamento tanto del liberalismo, quanto del marxismo. Il movimento dei beni comuni si inscrive potenzialmente in un’analoga prospettiva, dal momento che non è riducibile a priori né a determinati beni (come ad esempio i beni naturali), né a un certo economicismo che vuole farsi passare per apolitico.
Che cosa sono i beni comuni?
Il movimento delle enclosures a poco a poco segnò la fine dei «beni comuni», precipitando nella miseria gran parte della popolazione rurale
La storia dei beni comuni risale alle origini dell’umanità e identifica una gestione collettiva delle risorse comuni. Un punto di svolta importante si ha nell’Inghilterra del XVI secolo, quando i beni sono progressivamente scomparsi, in favore di una gestione esclusiva della proprietà. Nel Medioevo alcune terre, che venivano definite «comunali», potevano essere coltivate o sfruttate da tutti: ognuno aveva la possibilità di raccogliere la legna per il fuoco o i funghi, e i contadini
potevano far pascolare liberamente le proprie pecore. Il movimento delle enclosures – la chiusura dell’accesso a questi terreni da parte dei proprietari fondiari – a poco a poco segnò la fine dei «beni comuni», precipitando nella miseria gran parte della popolazione rurale (Polanyi 2009). La creazione dei beni comuni dunque va sempre di pari passo con i tentativi di creare nuove enclosures, essendo le risorse condivise oggetto di predazione da parte di alcuni che ambiscono alla proprietà esclusiva. È quanto accade anche oggi in ambito digitale (la questione delle licenze) o per le risorse naturali (la brevettabilità del materiale vivente). Il movimento per i beni comuni cerca di contrastare, attraverso regole e modalità di gestione collettive, quello delle enclosures. La nozione di bene comune riemerge nel 1968 con la pubblicazione dell’articolo intitolato La tragédie des communs [La tragedia dei beni comuni] del sociobiologo Garret Hardin. Prendendo in considerazione il caso di alcuni pascoli comuni nei quali dei pastori cercano di sfamare ognuno per proprio conto il numero maggiore possibile di animali e che così facendo riducono considerevolmente la quantità di erba disponibile, Hardin arrivava alla conclusione che l’utilizzo libero dei beni comuni avrebbe condotto tutti alla rovina. Ne consegue, ai suoi occhi, che solo due soluzioni sono in grado di porre rimedio a questa tragedia: un obbligo di legge imposto dallo Stato a protezione delle risorse, o la proprietà privata delimitata attraverso dei recinti. A questa lettura si contrappone quella della ricercatrice statunitense Elinor Ostrom, il cui merito è stato quello di aver dimostrato che una tale concezione dei beni comuni riposa su una visione astratta, distaccata dalla realtà, spesso risalente a parecchi secoli fa. I beni comuni in realtà sono connessi a una comunità di abitanti o fruitori, e dunque a valori e regole collettive grazie alle quali le persone comunicano e negoziano. E tutto questo perseguendo obiettivi non riconducibili ai loro interessi immediati.
«Tanto i partigiani della centralizzazione quanto quelli della privatizzazione accettano il principio cardine secondo cui i cambiamenti istituzionali devono provenire dall’esterno ed essere imposti alle persone coinvolte» (Ostrom 2010: 27). Ora, la nozione
di bene comune è politica nella misura in cui presuppone la capacità naturale degli individui di deliberare e decidere collettivamente ciò che è giusto per loro, ed è la partecipazione all’attività comune a costituire la base dell’obbligo di rispettare le decisioni collettive. I beni diventano comuni attraverso questo processo: nulla è bene comune di per sé. Un bene comune è una istituzione votata a durare nel
I beni comuni in realtà sono connessi a una comunità di abitanti o fruitori, e dunque a valori e regole collettive grazie alle quali le persone comunicano e negoziano
qui a I beni comuni I beni comuni
tempo attraverso l’elaborazione di regole e pratiche, facendosi carico della risoluzione dei conflitti e dei processi decisionali, in virtù del principio di autogoverno. Prevale sia nella sfera pubblica che in quella sociale e in questo modo sottopone ogni tentativo di abuso di potere (economico o politico) a dei limiti. Infine, il bene comune determina ciò di cui non ci si può impadronire e il cui uso è garantito affinché resti a disposizione di tutti.
A partire dagli studi di Elinor Ostrom, i beni comuni possono essere definiti mediante la combinazione di tre fattori: 1) una risorsa con accesso condiviso; 2) un sistema di diritti e di doveri in capo a chi ha accesso alla risorsa; 3) regole per il controllo e la gestione dei conflitti. Per Ostrom, essendo oggetto di una governance non imposta né dal mercato né dallo Stato, la preoccupazione per i beni comuni conduce sempre a conciliare il diritto di usufrutto con la preservazione delle risorse. Sono le stesse parti in causa che elaborano il loro contratto e si considerano mutualmente responsabili della sua corretta esecuzione. Que-
La gestione mediante i beni comuni è molto più efficace di quella statale
sto contratto ha luogo con cognizione di causa, essendo le parti in possesso di informazioni essenziali legate alla loro attività e al loro ambiente. Qui l’autogoverno presenta quel vantaggio praticamente assente nell’ambito dell’esercizio dell’autorità centrale che consiste, per le persone, nell’aver sufficienti informazioni per valutare quale
sia la politica più pertinente da perseguire in funzione della situazione. Inoltre, la sorveglianza reciproca delle parti e la scelta autonoma delle sanzioni in caso di non rispetto del contratto, si rivelano più efficaci e meno costose che il rimando a un’autorità esterna.
In questo, la gestione mediante i beni comuni è molto più efficace di quella statale (esterna rispetto alle risorse interessate e incapace di valutarne il potenziale) o del mercato (dove la concorrenza dei proprietari e la ricerca del profitto conducono a un esaurimento delle risorse). La produzione di beni comuni è un costrutto sociale e politico, poiché dipende dall’arbitrato della collettività fra ciò che essa può e vuole supportare a beneficio di tutti, e la produzione di beni ad accesso libero.
Il movimento dei beni comuni inizialmente si è sviluppato a partire dalle problematiche legate alla gestione delle risorse naturali, per poi allargarsi al mondo della conoscenza e alla questione dei dati personali nel mondo digitale. Internet era infatti uno spazio originariamente aperto, ma ormai è oggetto di numerose “enclosures”. Questi due primi ambiti non sono nuovi, in quanto a teorie e pratiche libertarie – rintracciabili già nel XIX secolo – mentre altri, pur essendo a loro volta già stati oggetto di un’attenzione particolare da parte del movimento anarchico, sono solo ai loro balbettanti esordi in riferimento a un approccio basato sui beni comuni: stiamo parlando della gestione dei mezzi di produzione e dell’organizzazione politica attraverso i beni comuni territoriali.
I beni comuni nelle risorse naturali
Questa vasta categoria raggruppa oggetti diversi, uniti però dall’effetto significativo che il loro sfruttamento può avere sulla popolazione mondiale: l’ambiente naturale, i fondali marini, il genoma, il corpo umano, il patrimonio culturale, l’acqua, l’atmosfera…
Una riflessione rispetto a cosa rientri nella categoria dei beni comuni globali è volta a definire le forme di protezione delle risorse che devono essere escluse dalla sfera commerciale, o il cui sfruttamento commerciale debba essere fortemente regolamentato da nuovi diritti fondamentali. Secondo l’Associazione internazionale di studi sui beni comuni, i beni comuni di sussistenza che si costituiscono in presenza di risorse naturali e che esistono dunque al di fuori del mercato e senza diritti di proprietà privata, sono di vitale importanza per circa due miliardi di individui a livello mondiale. Nel New Mexico, ad esempio, a partire dal XVII secolo
le comunità autoctone gestiscono collettivamente alcuni sistemi di corsi d’acqua conosciuti sotto il nome di acequias, sistemi che soddisfano il bisogno idrico delle comunità nel rispetto dei limiti ecologici della risorsa. Se è vero che l’istituzione delle acequias si avvale della sanzione legale dello Stato del New Mexico, è altrettanto vero che sono le comunità stesse che governano questa istituzione. Ogni membro contribuisce al suo buon funzionamento, sia consentendo il soddisfacimento dei bisogni di approvvigionamento idrico, sia preservando le risorse naturali.
Alcuni beni comuni vengono creati al fine di preservare la biodiversità e la cultura dei popoli indigeni
Alcuni beni comuni vengono creati al fine di preservare la biodiversità e la cultura dei popoli indigeni. È questo il caso ad esempio del Parco delle patate in Perù, che ha lo scopo di preservare 900 varietà di patata selezionate nel corso di millenni dai differenti popoli andini. Sottraendo questa biodiversità ai tentativi di apporre brevetti da parte delle multinazionali, circa settemila
abitanti di sei comunità indigene gestiscono collettivamente il parco. Questo approccio ecologico si ritrova in alcune intuizioni formulate negli scritti dei primi pensatori libertari, da Proudhon a Kropotkin, ma anche e soprattutto nell’opera di Elisée Reclus, celebre per i 19 volumi della sua Nouvelle géographie universelle. Secondo Reclus, l’essere umano è un elemento della natura che costituisce un tutto equilibrato: «L’uomo è la natura che prende coscienza di sé stessa» (Reclus 1905) e deve vegliare affinché non si rompa questo equilibrio, quello stesso equilibrio che gli conferisce la sua libertà. La constatazione di quanto sia precario l’equilibrio fra uomo e natura permette a Reclus di dedurre che il capitalismo e il produttivismo sono dannosi tanto per il primo quanto per la seconda: in una grande metropoli come Londra, notava, la cattiva gestione delle acque comportava un tasso di mortalità tre volte più elevato nei quartieri poveri che in quelli ricchi.
I beni comuni digitali
Se la rinascita dei beni comuni ha avuto luogo soprattutto in ragione dell’urgenza ecologica, è stata altresì accompagnata dall’emergere di una nuova tecnologia, uno spazio aperto in molti aspetti simile a ciò che furono i beni comuni nel Medioevo: mi riferisco a Internet. In questo spazio, ritroviamo risorse di sapere digitale che hanno come caratteristica peculiare quella di moltiplicarsi quando vengono condivise (mentre normalmente la condivisione di un bene comporta la sua suddivisione in parti più piccole).
I pionieri di Internet avevano una concezione molto libertaria del Web: esso doveva costituire uno spazio affrancato dalle regolamentazioni statali e dalla predazione capitalista, in particolare in materia di proprietà intellettuale e dati personali. Ad esempio, John Perry Barlow – cofondatore nel 1990 dell’Electronic Frontier Foundation, una ONG che si prefigge l’obbiettivo di proteggere le libertà su Internet – ha redatto nel 1996 una Dichiarazione di indipendenza del cyberspazio. Rivolgendosi a Stati e imprese scrive: «Vengo dal cyberpazio, la
nuova dimora della Mente […] Non siete i benvenuti tra di noi. Non avete alcuna sovranità là dove ci riuniamo» (Barlow). Così licenze di tipo Creative Commons si sono sviluppate molto velocemente con l’obiettivo di proteggere le opere dell’ingegno da qualsiasi tipo di attività predatoria, pubblica o privata, e assicurarne allo stesso tempo la circolazione. Sono emerse collaborazioni creative con regole condivise: la nascita di Wikipedia ne è un esempio.
licenze di tipo Creative Commons si sono sviluppate molto velocemente con l’obiettivo di proteggere le opere dell’ingegno da qualsiasi tipo di attività predatoria, pubblica o privata, e assicurarne allo stesso tempo la circolazione
La crittografia diventa poi uno strumento per la protezione dei beni comuni dell’ingegno da nuove «enclosures» che parallelamente si sviluppano (Boyle 2003). Come già notava Timothy C. May nel 1989 nel suo The Crypto Anarchist Manifesto (Il manifesto cripto-anarchico): se «un’invenzione apparentemente minore come il filo spinato ha reso possibile la recinzione di vasti terreni e fattorie cambiando per sempre i concetti di terra e di diritto di proprietà in Occidente, la scoperta apparentemente minore di una branca misteriosa della matematica diventerà il tronchese per tranciare il filo spinato che limita la proprietà intellettuale» (May 1989). D’altra parte, nuove forme di organizzazione del lavoro si sviluppano nell’economia delle piattaforme digitali, privilegiando l’associazione dei lavoratori, la condivisione del capitale, o valorizzando obiettivi legati all’ambiente, alla filiera corta e alla solidarietà, sulla scia delle prime cooperative, e non alla ricerca di profitti, come invece fanno le piattaforme di impronta capitalistica come Uber o Airbnb.
Trebor Scholz, professore alla New School di New York, ha elaborato il concetto di «cooperativismo di piattaforma» per definire queste nuove organizzazioni. Nell’articolo Platform cooperativism: Challenging the Corporate Sharing Economy le qualifica attraverso dieci principi: «Una proprietà condivisa dalla piattaforma con i suoi utilizzatori; dei ricavi decenti accordati agli utilizzatori della piattaforma (in caso vengano offerti servizi commerciali), trasparenza nella raccolta e nell’utilizzo dei dati personali e il loro libero scambio fra le piattaforme; un dialogo/ mediazione fra la piattaforma e i suoi utilizzatori; una co-determinazione del lavoro fra utilizzatori e gestori della piattaforma; la promozione di una quadro giuridico di tutela, in particolare in materia di concorrenza fra piattaforma e lavoratori e in materia di diritto del lavoro; diritti e tutele per gli utilizzatori validi sulle differenti piattaforme; una tutela dalle decisioni arbitrarie delle piattaforme; una limitazione della sorveglianza sull’attività degli utilizzatori e il diritto alla disconnessione» (Compain, Eynaud, Morel, Vercher-Chaptal 2019: 12-13). Il cooperativismo di piattaforma mira così a restituire agli utilizzatori la gestione di quest’ultima e lo fa attraverso una linea improntata all’autogestione cara alla tradizione libertaria. Una delle sfide di queste piattaforme è quella di mantenere tale tipo di modello in un ambiente economico ostile, come testimonia l’esperienza di Linux – sistema operativo nato dall’incontro del modo di operare hacker e i principi del software libero – ormai diventato per il 90% di proprietà di imprese capitaliste.
Beni comuni e fattori di produzione
La categoria dei beni comuni può anche essere applicata ai mezzi di produzione. In questo caso, l’approccio dei beni comuni suppone che tutti coloro che sono influenzati dalle decisioni di un’azienda (o di una unità di produzione) abbiano interesse a partecipare a questo tipo di gestione: in primo luogo i dipendenti, ma anche i residenti in caso di imprese inquinanti, o infine i consumatori… Queste idee si rifanno ai princìpi autogestionari che si sono sviluppati nella seconda metà del XIX secolo sotto l’impulso di Proudhon (in particolare si veda De la capacité des classes ouvrières), e poi del sindacalismo rivoluzionario o dell’anarcosindacalismo, sia nella teoria che nella pratica.
Elinor Ostrom lo mostra esponendo il caso dei pescatori di Alanya in Turchia. Negli anni Settanta, questi lavoratori si trovarono di fronte a un doppio vincolo: da un lato la concorrenza per le risorse rendeva precaria la condizione dei pescatori aumentando la possibilità di conflitto; dall’altro scatenava un sovrasfruttamento delle risorse stesse – nel loro caso i pesci – che in questo modo si riducevano. In risposta, i pescatori del litorale di Alanya decisero di riunirsi e di sperimentare alcune soluzioni arrivando in meno di dieci anni a stabilire le seguenti norme: innanzitutto i pescatori e le zone di pesca devo essere elencati; le zone di pesca vengono poi divise attraverso un sorteggio fra tutti i pescatori; l’attività di pesca viene poi limitata al periodo com-
qui a I beni comuni I beni comuni
preso fra settembre e maggio in modo che nei mesi restanti i pesci possano riprodursi; infine i pescatori devono alternarsi, passando da una zona all’altra, da ovest a est, in modo che a ognuno sia permesso di pescare su tutta l’estensione del litorale per tutto il periodo consentito. Un tale approccio ai beni comuni di lavoro e produzione, garantendo sia l’uguaglianza dei produttori in termini di accesso e diritto allo sfruttamento sia la salvaguardia delle risorse naturali, si dimostra più efficace della concorrenza di tipo capitalistico o dell’amministrazione statale, troppo lontana dagli eventi per comprenderne e regolarne i problemi.
Questa pratica di produzione autogestita, senza Stato né capitalismo, si ritrova a più riprese nel corso degli ultimi due secoli. L’esperienza più articolata e più radicale rimane senza dubbio quella della Spagna anarchica del 1936, da cui rimangono ancora da trarre numerosi insegnamenti. Fin dal principio della rivoluzione tutta una parte della Spagna si sollevò, forte delle centinaia di migliaia di militanti anarchici appartenenti alla FAI (Federación Anarquista Ibérica) e alla CNT (Confederación Nacional del Trabajo), con l’obiettivo di socializzare i mezzi di produzione. Come racconta George Orwell nel suo Omaggio alla Catalogna, Barcellona fu il centro di questo entusiasmo libertario. È così che nel luglio del 1936 la fabbrica Hispano-Suiza di Barcellona, che contava 1400 lavoratori e operava nel settore metalmeccanico, venne requisita dai sindacati. Anche l’industria del legno, molto importante per l’economia della città, venne collettivizzata. La produzione era organizzata fra collettività in modo tale che i differenti tipi di prodotti fabbricati fossero complementari e potessero essere scambiati, questo per evitare la concorrenza e un aumento non necessario della produzione. Molte altre tipologie di industria furono poi collettivizzate: se le situazioni specifiche potevano variare, tutte rispondevano allo stesso principio anarchico di autogestione, che consiste nel declinare sempre assieme autonomia e uguaglianza.
Nel luglio del 1936, bisognava provvedere ai raccolti e rimettere in produzione le terre abbandonate. Centinaia di migliaia di contadini procedettero alla collettivizzazione della terra, autorizzando quei pochi singoli proprietari desiderosi di mantenere la propria proprietà a farlo, a patto che non sfruttassero nessuno. Spesso questi proprietari finirono comunque per riunirsi alle collettività per goderne i vantaggi. Possiamo contare circa 350 collettività in Catalogna, 500 nel Levante, 450 in Aragona e ancora 240 in Nuova Castiglia (Leval 1971). L’autogestione era organizzata in tre settori principali: le statistiche per l’organizzazione dell’economia, riunite in federazioni; le nuove tecniche, che avrebbero dovuto portare al miglioramento e alla ristrutturazione dell’economia concentrando l’industria e sviluppando le innovazioni; la cultura, che si apriva su una nuova visione del mondo, principalmente attraverso le scuole.
I beni comuni territoriali
Con beni comuni territoriali si intende la possibilità per i cittadini di autogovernarsi in comune su un territorio dato (quartiere, comune, regione, ecc.). I beni comuni territoriali presuppongono deliberazioni e capacità decisionale reale da parte dei cittadini per tutto ciò che riguarda la gestione del loro territorio (incluse tutte le attività economiche che abbiano una ricaduta su di esso). […] Come scrivono il filosofo Pierre Dar-
I beni comuni territoriali presuppongono deliberazioni e capacità decisionale reale da parte dei cittadini per tutto ciò che riguarda la gestione del loro territorio
dot e il sociologo Christian Laval nel loro libro Commun: «Per rispondere realmente a dei bisogni collettivi, è opportuno che [i servizi pubblici] siano espressi, dibattuti ed elaborati attraverso votazioni democratiche. Senza questo impegno civico, il fruitore è o soggetto o cliente, e a volte le due cose assieme. In entrambi
i casi c’è un’usurpazione o una diluizione dell’interesse generale e una perdita della dimensione civica. Ma in che modo dunque si può passare da un modello basato sul servizio pubblico a uno basato sul servizio comune? Quest’ultimo implica una modifica considerevole della concezione che abbiamo dello Stato. Se da un lato possiamo ben ricordare le lontane origini della nozione di servizio pubblico, radicata nelle categorie classiche e medioevali dell’utilità pubblica e dell’interesse generale, non possiamo dimenticare che lo Stato è principalmente costruito come imperium e non come obsequium» (Dardot e Laval 2014: 516-17). Ma è proprio come obsequium che Proudhon concepisce lo Stato, ossia come entità che ha il dovere di mantenere il carattere pubblico della carica assegnatagli dalla collettività. Bisogna metterlo allo stesso livello della società privandolo così del suo carattere assoluto. Allo stesso modo bisogna fare con la proprietà. Lo Stato – se a questo punto possiamo ancora chiamarlo «Stato» (nella misura in cui, per dirlo correttamente, non è più segnato dal sigillo della sovranità) – diventa allora «il supervisore della società, la sentinella del popolo» (Proudhon 1997: 197). Con la governance dei beni comuni ritroviamo il superamento della forma tradizionale di Stato fondata su di una sovranità monolitica. Come ben riassume il militante statunitense David Bollier in La renaissance des communs: «Questo tipo di governance non assumerà la forma di una struttura formale o gerarchica imposta e amministrata dallo Stato-nazione, ma piuttosto quella di una coalescenza di grandi reti di sistemi di produzione tra pari motivati dal loro mutuo interesse. Non è una visione utopica. Possiamo già sin da ora osservare una tale federazione cooperativa all’opera in seno ai beni comuni di Internet» (Bollier 2014: 150-51).
I beni comuni suppongono dunque il superamento dello Stato in un approccio orientato in direzione del luogo originario della politica, la città. Qui, il municipalismo libertario, teorizzato principalmente da Bookchin, si trova naturalmente chia-
I beni comuni suppongono il superamento dello Stato
mato in causa. Esso afferma l’idea secondo la quale le istituzioni libertarie possono nascere parallelamente allo Stato e ai margini del capitalismo, soppiantandoli entrambi poco a poco. Questa strategia è possibile a partire dalla Comune, che costituisce il luogo d’elezione della libertà politica, e questo almeno a partire dalla città nella Grecia antica. Così «l’unico mezzo per ricostruire la politica è cominciare dalle sue forme più elementari: i villaggi, le città, i quartieri e le municipalità, luoghi dove le persone vivono il livello più intimo di interdipendenza politica oltre la vita privata. È a questo livello che possono cominciare a familiarizzare con il processo politico, un processo che va ben al di là del voto e dell’informarsi» (Bookchin 2021). Le grandi metropoli come New York, Londra o Parigi non hanno più evidentemente molto a che fare con le città dell’Antichità come Atene, città che permettevano l’esercizio della democrazia diretta (anche se tuttavia le donne e gli schiavi ne erano esclusi).
Nonostante questo, qualunque sia la dimensione delle città, ognuna è divisibile in un certo numero di quartieri che consentono di concepire dei territori di dimensioni umane che permettano l’esercizio di questo tipo di pratiche. La grandezza di una città non è in alcun modo determinante per stabilire quale sia il regime che la deve reggere, a meno che non si conceda che se la democrazia diretta può aver luogo solo in città di 20 mila abitanti allora in città con 2 milioni di abitanti, l’unica possibilità sia l’imperare di una burocrazia dittatoriale. Bookchin porta l’esempio della città di Parigi nel 1793, a quel tempo popolata da numero compreso tra 500 e 600 mila abitanti, i quali grazie alla federazione in sezioni, aveva tranquillamente potuto organizzare l’approvvigionamento, la sicurezza, far rispettare i prezzi massimi o perfino assicurare lo svolgimento degli incarichi amministrativi più complessi. Bookchin mette del resto in evidenza anche un pericolo: che i lavoratori siano i soli a dover decidere in merito alle politiche di produzione. Molto presto si ritornerebbe a logiche corporative o, in altri termini, i lavoratori stessi sarebbero condotti a reiterare le malefatte della concorrenza capitalistica. Dovrebbe essere dunque l’insieme
della popolazione di un comune o di un territorio dato a decidere in merito alle politiche di produzione. La dimensione locale del municipalismo non potrebbe tuttavia fare a meno del federalismo per prefigurare delle problematiche globali, come per esempio quelle che riguardano l’ambiente.
Conclusioni
Se l’accesso a certi beni comuni può essere oggetto di forti disuguaglianze (per esempio fra uomini e donne) a causa di regole prodotte dalla tradizione e non messe in discussione, o a causa di regole che non hanno integrato il principio di un’uguaglianza inclusiva, la radicalità libertaria – quella radicalità che consiste nell’affrontare le questioni alla radice e preservare lo spirito di autonomia – costituisce un antidoto al ritorno alla tradizione, alle ingiustizie e alle esclusioni. Nella misura in cui esiste una congruenza fra teorie e pratiche, gli apporti mutui e le critiche reciproche fra anarchismo e beni comuni non possono che essere fecondi.
Traduzione di Abi. Questo testo è stato inizialmente pubblicato con il titolo «La part anarchiste des communs» sul sito Bellast nel gennaio del 2020 e, con il titolo «Des communs dans le pensée libertaire» nel sito Acontretemps nel giugno 2021. Si ringraziano l’Autore e la redazione di Acontretemps per la disponibilità.
Bibliografia
- J.P. BARLOW, «A Declaration of the Independence of Cyberspace», Electronic Frontier Fondation < https://www.eff.org/it/cyberspace-independence&g.
- D. BOLLIER, La Renaissance des communs, Charles Leopold Meyer, Paris 2014 [trad. it. La rinascita dei commons, Stampa alternativa, Viterbo, 2015]. M. BOOKCHIN, From Urbanization to Cities, AK Press, New York 2021. J. BOYLE, The Public Domain: Enclosing The Commons Of The Mind, Yale University Press, New Haven & London 2003.
- G. COMPAIN, P. EYNAUD, L. MOREL, C. VERCHER-CHAPTAL, «Les plateformes collaboratives: éléments de caractérisation et stratégies de développement», https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02140103/ document>.
- P. DARDOT, C. LAVAL, Commun, La Découverte, Paris 2014, pp. 516-517 [trad. it. Del Comune, o della rivoluzione nel XXI secolo, DeriveApprodi, Roma, 2015].
- É. JOURDAIN, Quelles normes comptables pour une société du commun?, Éd. Charles Léopold Mayer (ECLM), Paris 2019.
- G. LEVAL, Espagne libertaire 1936-1939 : l’œuvre constructive de la révolution espagnole, Éditions du Cercle et de La Tête de feuilles, 1971 ; rééd. Édition Tops/Trinquier, Paris 2013.
- T.C. MAY, The Crypto Anarchist Manifesto, 1989 < https://www.activism.net/cypherpunk/crypto-anarchy.html>.
- E. OSTROM, Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche des biens naturels, De Boeck, Louvain-la-Neuve 2010, p. 27 [trad. it. Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia, 2006].
- K. POLANYI, La Grande Transformation, Gallimard, Paris 2009 [trad. it. La grande trasformazione, Einaudi, Torino, 2010].
- P.-J. PROUDHON, Confessions d’un révolutionnaire, Tops/Trinquier, Paris 1997. E. RECLUS, L’Homme et la Terre [1905], La Découverte, Paris 1998.


Maria Luisa Berneri (1918-1949)
A. Soto
Maria Luisa Berneri nasce ad Arezzo nel 1918 da Camillo e Giovanna Caleffi. Il padre si può considerare il più innovativo degli anarchici italiani della prima metà del Novecento, la madre è stata, tra le altre cose, redattrice della rivista «Volontà» nel secondo dopoguerra. Maria Luisa, così come la sorella Giliana, è un’attiva militante. Costretta dal fascismo a emigrare, nel 1926 si stabilisce insieme alla famiglia in Francia. Dopo l’uccisione di Camillo per mano stalinista, si trasferisce a Londra, dove condivide l’amore e la militanza con Vernon Richards ed è tra le animatrici più influenti del movimento anarchico inglese. Durante la seconda guerra mondiale è redattrice di «War Commentary», contribuisce alla fondazione delle edizioni Freedom Press e dal 1945 diventa redattrice della rivista «Freedom», attorno a cui si raccolgono George Orwell, George Woodcock, Herbert Read, Alex Comfort e un giovane Colin Ward. Muore nel 1949 a soli trentuno anni a causa di un’infezione.
Maria Luisa è stata un’acuta intellettuale. Si è interessata di psicologia infantile, di letteratura, di pittura e di fotografia ed è entrata nel vivo di alcune tematiche chiave del suo tempo. Ha sottolineato la chiusura in senso nazionalistico e burocratico della classe operaia europea del secondo dopoguerra, ha denunciato lo sviluppo dei programmi atomici, la politica imperialista statunitense, la repressione della dissidenza in Unione sovietica e nei paesi della cortina di ferro e l’asservimento dei lavoratori in questi regimi. Due sono le ulteriori tematiche di cui si è interessata in maniera originale e che possono essere di stimolo per la riflessione e l’attività odierna: la guerra e l’utopia.
La guerra
Maria Luisa Berneri nega la validità di un’interpretazione della seconda guerra mondiale come una lotta decisiva tra sistemi politici contrapposti, con la libertà, la democrazia, la collaborazione internazionale da una parte e la barbarie del fascismo e del nazismo dall’altra. Facendo ciò si distingue non solo da gran parte del pensiero dell’epoca, ma anche da una parte del movimento - mi viene in mentre tra i vari il nome di Rudolf Rocker - che invece individua la necessità di scegliere il male minore, ovvero schierarsi al fianco degli Alleati. Per lei, inflessibile contro i totalitarismi, la democrazia di guerra americana (così come quella inglese) è una maschera dietro cui si cela una politica sfacciatamente imperialista.
La quasi totalità dell’opinione pubblica occidentale, scrive Maria Luisa, ha attribuito ai nazisti il monopolio della violenza, chiudendo gli occhi sui crimini degli Alleati considerati come «necessari». Ha fatto eccezione Vera Brittain, che nel suo Massacre by bombing ha denunciato sì l’uccisione di circa cinquantamila civili inglesi a opera delle bombe naziste, ma anche quella di un milione e duecentomila civili tedeschi (dei quali ventimila nella sola Amburgo) come conseguenza dei bombardamenti degli Alleati dal 1939 all’ottobre 1943. E altrettanto violento, denuncia la Berneri, è costringere alla fame la popolazione tedesca, come hanno fatto gli Alleati durante la guerra: una decisione consapevole che rientra nelle tattiche della guerra (Berneri, Brittain 2004).
La «guerra contro il fascismo» ha ridotto in macerie Amburgo, Lipsia, Milano, Genova, Torino, Napoli, Messina, in maniera non diversa da quanto l’aviazione tedesca ha fatto con Clydeside e Coventry, Plymouth e l’East End londinese. Ma ciò non ha provocato le ire dell’opinione pubblica, che anzi ha avallato tali operazioni spesso assumendo una posizione di ostilità nei confronti della popolazione tedesca nel suo insieme. La seconda guerra mondiale, conclude, ha rafforzato il principio di leadership e la

qui a Maria Luisa Berneri Maria Luisa Berneri
tendenza degli sfruttati a obbedire all’autorità, e su questo ha influito il fatto che gli Alleati abbiano combattuto il nazifascismo con i suoi stessi mezzi, tra cui appunto il terrore indiscriminato per mezzo dei bombardamenti a tappeto (Berneri 1952).
Una posizione, la sua, integralmente antimilitarista che rimane un riferimento ideale e un pungolo alla riflessione odierna, quando le sirene antiaeree, i carri armati, i missili supersonici, le trincee e le peggiori atrocità di una invasione pianificata dal governo russo squassano di nuove il cuore d’Europa e ci lasciano atterriti.
L’utopia
Un suo contributo prezioso è il libro pubblicato postumo a Londra e a New York, Journey through Utopia, che è a oggi, secondo il giudizio di Nico Berti, «la più importante disamina anarchica del pensiero utopico» (De Maria 2013). Questo testo è stato edito in italiano nel 1981 e, esaurito da tempo, è stato ora ristampato, dalle edizioni Malamente.
Il volume analizza decine di progetti utopici attraverso sei epoche - Antichità, Rinascimento, Rivoluzione inglese, Illuminismo, Ottocento e Novecento - mettendo in evidenza quei pochi progetti non autoritari che presentano caratteri di apertura e di sperimentazione, che rifuggono da schemi fissi e che non mirano all’uniformità dell’individuo, permettendone anzi la piena libertà.
Tali utopie si caratterizzano anche per l’accento posto non sul «dopo» e sull’«altrove», ma sul «qui» e «ora», ovvero sul cominciare a vivere utopicamente date le condizioni presenti invece che aspettare una liberazione a venire.
È ciò che lei vede nell’utopia disegnata da William Morris in News from Nowhere: in una Londra del XXI secolo non vi è proprietà privata, né stabilimenti industriali (sostituiti da laboratori dove il lavoro è volontario e la produzione si limita al necessario), né palazzi del governo, né prigioni. Ognuno è padrone di sé [ed] è uguale al suo simile perché non ha autorità su di lui (Berneri 2022). La Londra di Morris è una città aperta e sperimentale che lascia ai singoli le decisioni su ciò che li riguarda e che si è lasciata alle spalle il mito del progresso e della produzione esasperata. Maria Luisa Berneri ci aiuta così a delineare le caratteristiche feconde dell’utopia libertaria. Essa non è la perfezione né l’identità tra verità e perfezione, non segna la fine della storia né l’eliminazione del conflitto, non è escatologica, ma è un processo prefigurativo che non conosce soste, muovendo continuamente da un obiettivo al successivo: è slancio ideale e, allo stesso tempo, concretezza del mutamento.
Il movimento anarchico, nei decenni successivi, analizza ulteriormente il tema, arrivando a una parziale conclusione, in particolare grazie al lavoro di chiarificazione condotto da Amedeo Bertolo. L’utopia anarchica, sottolinea Bertolo, ha una doppia funzione: quella di far crescere la volontà di trasformare la società con una rottura della cultura dominante, e quella di lasciare sempre aperto il piano della sperimentazione mentale e materiale di ulteriori modelli utopici. Inoltre la tensione utopica serve per per far vivere già qui e ora il futuro e il nonluogo. Sono ora temi tipici della cultura sovversiva contemporanea, come sottolinea Tomás Ibáñez nell’articolo pubblicato sul n. 1 di «Semi sotto la neve».
A mio parere, una delle forme feconde che assume oggi l’utopia è anche quella dell’autogestione, intesa come applicazione immediata di pratiche organizzative libera dalla competizione e dall’interesse personale tesa a trasformare in senso libertario i rapporti sociali. Essa si fonda su un’etica cooperativa, altruista, solidale, in cui ciascuno trova il suo interesse nell’interesse di tutti e che si basa sulle pratiche di solidarietà e di mutuo appoggio.
Secondo un’indicazione già presente in Viaggio attraverso utopia, l’utopia anarchica consiste quindi non in una promessa di soluzione ai mali del mondo, ma in una trasformazione concreta degli ambiti sociali che si fa destrutturazione concreta dei rapporti di dominio.
Alcuni scritti di Maria Luisa Berneri:
Workers in Stalin’s Russia, Freedom, London, 1944
Neither East nor West, London, Marie Louise Berneri Memorial Commitee, 1952
Con V. BRITTAIN, Scritti sui bombardamenti di massa (1939-1945), a cura di C. Baldoli, Spartaco, Santa Maria Capua a Vetere, 2004.
Viaggio attraverso utopia, a cura di A. Senta, edizioni Malamente, Fano, 2022, (prima ed. 1952)
Alcune scritti su Maria Luisa Berneri:
MARIE LOUISE BERNERI MEMORIAL COMMITEE, Marie Louise Berneri 1918-1949. A tribute, London 1949.
- F. CHESSA, G. SACCHETTI, Maria Luisa Berneri, in M. Antonioli, G. Berti, S. Fedele, P. Iuso, Dizionario biografico degli anarchici italiani, vol. 1, Biblioteca Franco Serantini, Pisa 2003, pp. 151-152 <https://www. bfscollezionidigitali.org>.
- C. DE MARIA (a cura di), Maria Luisa Berneri e l’anarchismo inglese, Biblioteca Panizzi-Archivio famiglia Berneri-Aurelio Chessa, Reggio Emilia 2013.
- L. PEZZICA, Maria Luisa Berneri, in Id., Anarchiche. Donne ribelli nel Novecento, Shake edizioni, Milano 2013, pp. 173-181.
- G. SACCHETTI, Eretiche. Il Novecento di Maria Luisa Berneri e Giovanna Caleffi, Biblion, Milano 2017.
- A. SENTA (2022), <https://intellettualinfuga.fupress.com/it//scheda/ maria-luisaberneri-vernon/2748>.

Colin Ward (1924-2010)
F. C.
«Come si reagirebbe alla scoperta che la società in cui si vorrebbe realmente vivere c’è già […] se non si tiene conto, ovviamente, di qualche piccolo guaio come sfruttamento, guerra, dittatura e gente che muore di fame? […] Una società anarchica, una società che si organizza senza autorità, esiste da sempre, come un seme sotto la neve, sepolta sotto il peso dello Stato e della burocrazia, del capitalismo e dei suoi sprechi, del privilegio e delle ingiustizie, del nazionalismo e delle sue lealtà suicide, delle religioni e delle loro superstizioni e separazioni».
In questa citazione (Anarchia come organizzazione) è compendiato in maniera esemplare l’approccio di Colin Ward all’anarchismo. L’intento è quello di dimostrare che l’anarchia non è una visione, basata su congetture, di una società futura, quanto piuttosto un modo del tutto umano di organizzarsi, ben radicato da sempre nella concreta esperienza della vita quotidiana, che funziona a fianco delle tendenze spiccatamente autoritarie della nostra società e nonostante quelle.
Le principali influenze culturali (non le uniche ovviamente) verso le quali si sente debitore, ce le ricorda egli stesso, e sono quelle di William Godwin e Mary Wollstonecraft per l’educazione, Alexander Herzen per la politica, Peter Kropotkin per l’economia, Martin Buber per la sociologia, William Richard Lethaby e Walter Segal per l’architettura, Patrick Geddes e Paul Goodman per la pianificazione urbanistica. Ward dimostra nei suoi scritti quanto importante sia utilizzare in senso antiautoritario studi, idee, ricerche, visioni che non provengono dal pensiero anarchico ma che possono trovare in ambito libertario una loro specifica utilità. I suoi molteplici interlocutori
testimoniano la varietà dei suoi interessi che hanno impegnato le fasi della sua vita professionale e relazionale.
Fin dal 1961 (Anarchism and Respectability, Freedom) pone a se stesso ma anche agli anarchici una domanda: in quanto libertari, siamo sufficientemente «rispettabili», la qualità delle nostre idee e proposte sono meritevoli di rispetto, suggeriscono cioè soluzioni concrete antiautoritarie ai problemi del vivere sociale, e sono da preferirsi a quelle autoritarie?
Questa domanda è tutt’ora cogente e per me inevitabile. Capovolta la concezione classica e ottocentesca dell’anarchismo come movimento rivoluzionario che pensa alla rivoluzione come un evento storico in grado di creare una società diversa, per sostituirvi un’idea di anarchia come organizzazione sociale che già esiste, seppur in modo incompleto, qui e ora, come rendere «rispettabili» le nostre idee nella concretezza del nostro agire?
Innanzitutto Ward riprende da Alexander Herzen l’idea che una meta infinitamente lontana, non è una meta ma un’esca, un inganno; una meta deve essere più vicina, e concreta. E assume come propria la convinzione di Paul Goodman secondo cui il prevalere di una soluzione libertaria o autoritaria non è, il risultato di uno scontro definitivo di proporzioni cosmiche, ma è piuttosto determinato da una serie di round consecutivi, senza vincitori né vinti nella maggior parte dei casi, che si sono susseguiti, e continuano a verificarsi, nel corso della storia umana. Ogni società, se si escludono le più autoritarie e le distopie, è una società pluralistica, con vaste aree che non sono in conformità con i valori ufficialmente imposti o sbandierati. E la soluzione che egli prefigura è ben espressa nella convinzione che «l’alternativa anarchica è quella che propone la frammentazione e la scissione al posto della fusione, la diversità al posto dell’unità, propone insomma una massa di società e non una società di massa». Inoltre assume la riflessione di Landauer secondo la quale «lo Stato non è qualcosa che può essere distrutto attraverso una
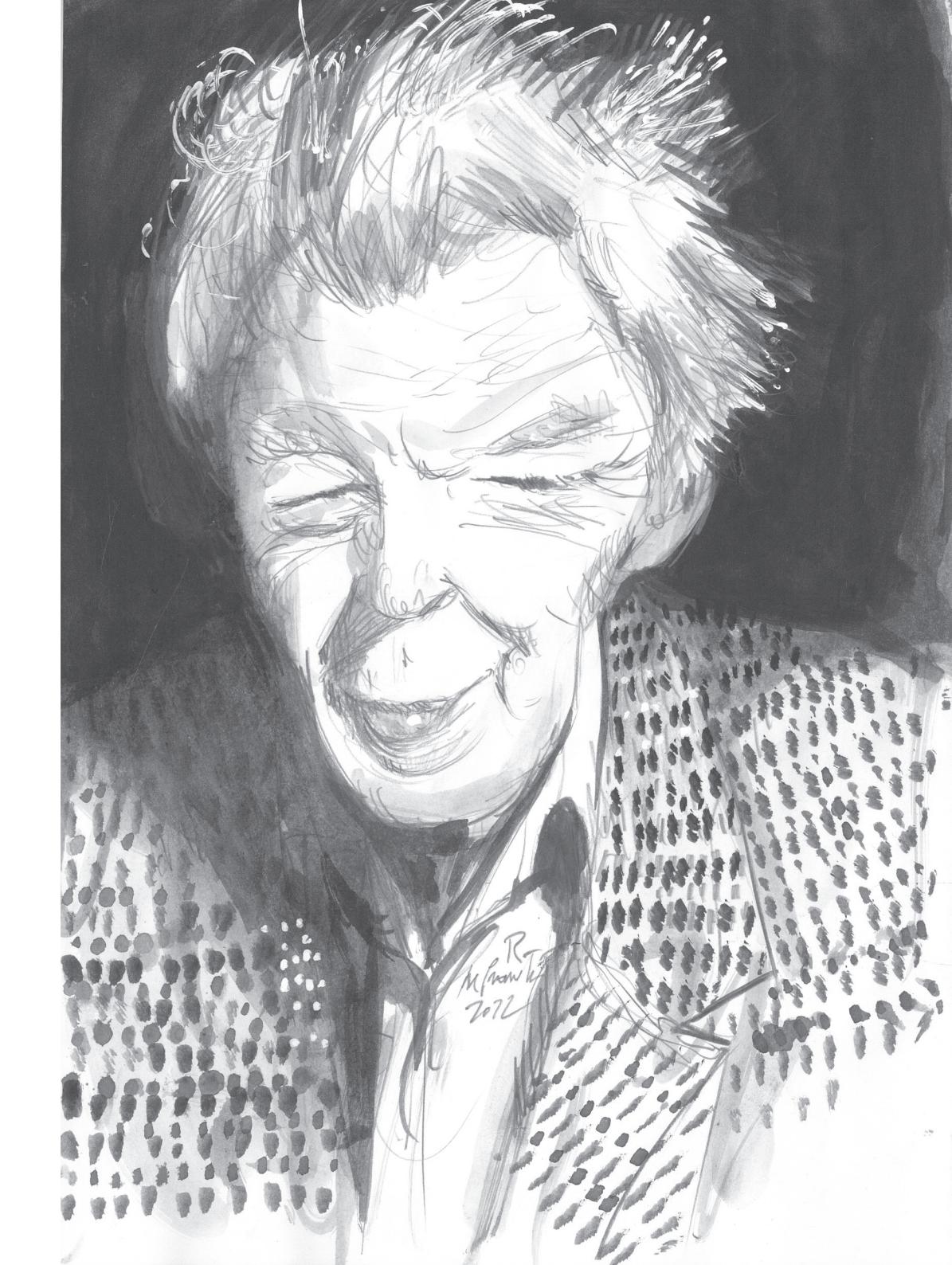
rivoluzione, ma è una condizione, un certo tipo di rapporto tra gli esseri umani, un tipo di comportamento; lo possiamo distruggere creando altri rapporti, comportandoci in modo diverso». Ward sottolinea che lo Stato è come una sorta di abdicazione della società nei confronti della Politica, è potere non utilizzato. Questo surplus politico costituisce la principale fonte di depauperamento della società. Arriva a questa conclusione grazie alle idee espresse a tale proposito da Martin Buber (Society and the State, 1950).
Il milieu anarchico e libertario nel quale egli matura le sue idee e sviluppa la sua azione è costituito da un gruppo di intellettuali con i quali interagisce e di cui utilizza la collaborazione soprattutto nella rivista da lui fondata e diretta «Anarchy». Si instaurano una serie di rapporti anche personali che producono una sinergia intellettuale, che rappresenta quanto di meglio si potesse pensare per rielaborare le teorie anarchiche e applicarle alla società contemporanea, secondo questa metodologia da lui sperimentata ampiamente. Figure come George Woodcock, Herbert Read, Alex Confort, Nicolas Walter, Geoffrey Ostergaard, George Orwell, Dwight Macdonald (per ricordare solo i più stretti), divengono interlocutori privilegiati di Ward assieme all’immancabile Paul Goodman, a Michael Young, agli statunitensi Noam Chomsky e Murray Bookchin (già meno stretti). Infine occorre ricordare che egli si è spesso misurato con il pensiero di uno dei più grandi pensatori liberali del Novecento, vale a dire con Isaiah Berlin. Tra i classici dell’anarchismo il suo riferimento costante è quello di Pëtr Kropotkin che ispira tutte le sue opere in diversi ambiti soprattutto nelle parti che, a suo giudizio, sono ancora valide e attuali. Colin Ward ha messo alla prova queste sue idee in ambito educativo, sociologico, urbanistico e architettonico, ma anche in territori fino ad allora inediti per un anarchismo tradizionale. Questo anarchismo pragmatico, sperimentalista, induttivo, è il fondamento della lezione wardiana di cui oggi più che mai abbiamo bisogno. Non si tratta né di pragmatismo fine a se stesso né, tantomeno, di un nuovo ideologismo. Appare essere piuttosto una terza via che nella sperimentazione continua acquisisce una sempre maggiore consapevolezza che è, prima di tutto, rielaborazione personale e collettiva. Lo sforzo metodologico di Ward è quello di cercare nella realtà gli esempi e le testimonianze che le soluzioni libertarie sono migliori e più efficaci di quelle autoritarie. Dopo aver dimostrato che l’anarchismo è una teoria dell’organizzazione, egli si sforza, riprendendo l’insegnamento malatestiano, di farci capire che tutto questo non può prescindere da un atto di libera volontà, vale a dire che l’anarchismo non può esistere se non accompagna le sue risultanze organizzative con un’etica libertaria fondata sulla autodeterminazione individuale e sociale. Colin Ward impiega il suo talento particolare per capire e spiegare il modo in cui operano i principi anarchici di aiuto reciproco e cooperazione nell’agire quotidiano e nelle varie situazioni, dai campi da gioco alle scuole, dagli ospedali ai luoghi di lavoro, dalle forme spontanee e autogestite di produzione e di consumo all’organizzazione dei trasporti, ecc. Era determinato a esorcizzare l’immagine dell’anarchico ingenuo utopista o fosco lanciatore di bombe, affermando il profondo radicamento concreto nella vita di tutti i giorni delle istanze antiautoritarie.
Questa visione dell’anarchismo lascia davanti a noi uno spazio enorme di possibilità ma anche evidenti sfide. Come coniugare una visione utopica (necessaria per contrastare l’immaginario sociale dominante) e un serio e credibile programma di azioni e soluzioni concrete (rispettabili)? In che modo l’abbandono della visione rivoluzionaria classica a favore della dimensione della rivolta come condizione continua individuale e sociale può essere davvero fondamentale per chi comunque si pone in una prospettiva di cambiamento radicale della società? A mio parere leggere e discutere oggi i testi di Colin Ward può essere indispensabile per approfondire un’agenda concreta che eviti almeno un po’ il pericolo di lasciare l’anarchismo contemporaneo in una triste condizione di marginalità. Questa postura
ci aiuta a capire come Ward sia anarchico nonostante il proprio scetticismo circa la possibilità di costruire una «società anarchica». Egli è un anarchico «in senso normativo, ovvero sostiene che il criterio etico chiave per giudicare i meriti delle varie società sta nella misura in cui sono anarchiche. Il che non comporta la convinzione che una società possa verosimilmente essere del tutto anarchica, o che sia possibile che lo diventi» (White 2007). Tutto questo perché «l’anarchismo, in tutte le sue forme, è una affermazione della dignità e della responsabilità degli esseri umani. Non è un programma di mutamenti politici, ma un atto di autodeterminazione sociale» (Anarchia come organizzazione).
Bibliografia essenziale in italiano di Colin Ward:
Anarchia come organizzazione, elèuthera, Milano, varie edizioni;
L’anarchia, elèuthera, Milano, varie edizioni;
Architettura del dissenso ( a cura di Giacomo Borella), elèuthera, Milano, 2016;
L’educazione incidentale (a cura di Francesco Codello), elèuthera, Milano, 2018;
Dopo l’automobile, elèuthera, Milano, 2012;
Acqua e comunità, elèuthera, Milano, 2011;
Lo sguardo anarchico (a cura di David Goodway), elèuthera, Milano, 2021; La città dei ricchi e la città dei poveri, Roma, e/o, 1998.
Su Colin Ward:
S. WHITE, Un anarchismo rispettabile?, Bollettino Archivio Pinelli, n. 30, Milano, 2007;
F. CODELLO, Il seme sotto la neve, in: Libertaria, Milano, anno 12 numero 1-2, gennaio/giugno 2010;
Sotto la neve. L’anarchismo di Colin Ward, (a cura di F. Codello), in: A Rivista anarchica, Milano, a. 50 n. 6, Estate 2020.
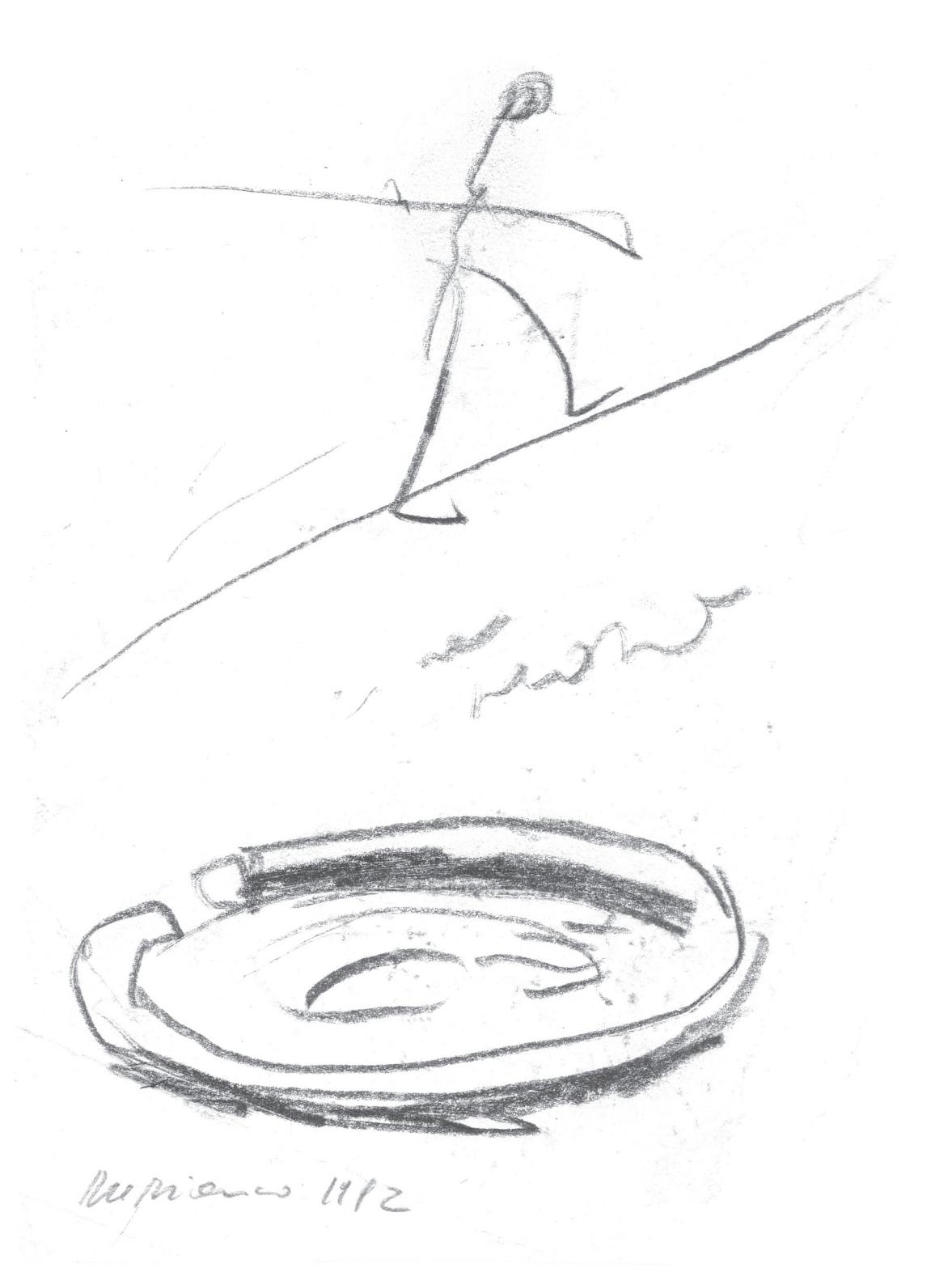

Rock, utopia e liberazione all’alba degli anni ‘70
Felice Liperi
Giocare col mondo
facendolo a pezzi
bambini che il sole
ha ridotto già vecchi.
Non è colpa mia
se la tua realtà
mi costringe a fare guerra all’omertà.
Forse così sapremo
quello che vuol dire
affogare nel sangue
Tutta l’umanità
Versi di Frankenstein (Gianni Sassi) da «Luglio, agosto, settembre (nero)» degli Area.
Queste parole tratte dal brano di apertura di «Arbeit Macht Frei», il primo album degli Area, al di là della sua straordinaria qualità musicale, ne evidenziano oggi, a 50 anni dalla realizzazione, anche la dimensione profetica con la frase: «Forse così saqui a Rock, utopia e liberazione Rock, utopia e liberazione
premo quello che vuol dire affogare nel sangue tutta l’umanità». Un messaggio che rappresenta in modo drammatico e potente la sensibilità di una generazione di artisti verso una narrativa dai contorni inediti e segnata da una nuova consapevolezza. Basta guardare anche altri titoli presenti nel disco come, appunto, «Consapevolezza» e «Le labbra del tempo» per cogliere come mettessero in campo temi imprevisti molto al di là delle battaglie ideologiche che avevano animato il passaggio fra ‘60 e ‘70 e affermavano come uno strumento, quale stava diventando la musica, si potesse utilizzare anche per raccontare storie e lanciare nuovi sguardi sul futuro. Un passaggio lucidamente raccontato dallo studioso di movimenti politici Diego Giachetti, con riflessioni utili a comprenderne il percorso.
«Per anni, più o meno esplicitamente, le manifestazioni di protesta legate alla moda, ai comportamenti anticonformistici, alle canzonette e ai complessi beat, furono trattate come parentesi felice, ma infantile, dei giovani prima della vera presa di coscienza, quella politica che venne col movimento studentesco, e con la costituzione dei gruppi extraparlamentari. Col prevalere della politica, intesa come impegno e militanza attiva, sembrò legittimo porre l’accento sulla rottura, sulla separazione fra la dimensione politica e quella impolitica, tipica del beat e dei capelloni. Ciò che non era impossibile fare per gli Stati Uniti, dove dividere il movimento hippy dalla rivolta studentesca era impossibile, andava invece fatto per l’Italia».
Questo passo verso possibili orizzonti si sarebbe compiuto nel nuovo decennio accendendo la passione creativa su possibili profili culturali e terreni artistici: musica ma anche arte, filosofia, comunicazione. Se, infatti, il ‘68 era stato l’anno della svolta per una canzone che trovava in Fabrizio De André, Sergio Endrigo, Lucio Battisti i suoi nuovi profeti, è nei primi anni ‘70 che matura nel rock una rivoluzione negli stili e nei profili culturali di riferimento. Non a caso anche la lezione di Beatles e Beach Boys su versanti geografici opposti è ormai rivolta alla costruzione di un messaggio più ambizioso della canzone beat ristretta in pochi minuti e gli obiettivi sembrano molto ampi e innovativi perché la stagione di Woodstock aveva aperto le menti delle nuove generazioni verso una visione del mondo dove si aprivano forme inedite di sogni libertari, lotte ecologiste e diritti delle differenze solo in seguito centrali nella trasformazione dell’esistenza moderna. Un patrimonio di idee e valori che troverà spazio nel 1970 nell’avventura culturale di «Re Nudo», rivista dedicata ai temi della controcultura e alle esperienze libertarie con particolare attenzione alla questione delle droghe, della sessualità, delle pratiche sociali alternative utilizzando forme diverse di comunicazione come la musica, la grafica e i fumetti. Pur con importanti sussulti successivi nel 1996 e nel 2008 la vita della rivista scorrerà per tutto il decennio ‘70 fino al 1980 fra meeting alternativi dedicati alle pratiche dedicate alla liberazione del corpo, alla parità di genere, all’ecologia. Questioni che torneranno anche al centro dei «Festival del Proletariato Giovanile» organizzati da «Re Nudo» nel corso degli anni ‘70 e in iniziative come quella di lanciare nel 1972 il movimento delle «Pantere Bianche» per cercare di unire temi controculturali come l’aborto, il divorzio, le condizioni nelle carceri, il disagio delle periferie urbane all’impegno politico tradizionale.
Questo nuovo universo culturale in forte evoluzione tocca anche la letteratura internazionale che sembra fare un importante passo avanti con l’entrata in scena negli Stati Uniti di autori come Toni Morrison che esordisce nel 1970 con il romanzo «L’occhio più azzurro» descritto dalla critica come il primo tentativo di mettere in scena la sensibilità delle donne afroamericane. Mentre in Italia dopo il furore creativo di Mario Schifano è soprattutto il nuovo teatro a offrire prospettive innovative con il lavoro della postavanguardia che si anima di multimedialità, acrobazie del corpo e performance fuori dagli schemi di compagnie come la «Gaia Scienza» (dal 1975), «Falso Movimento» (dal 1977) e
qui a Rock, utopia e liberazione Rock, utopia e liberazione
«Magazzini Criminali» (dal 1980) che non a caso cercano legami molto stretti con il mondo della musica più innovativa come mostra il festival «Electra 1 – Festival per i fantasmi del futuro» che si tiene a Bologna nel luglio del 1981 a cui partecipano esponenti di punta dell’elettro-rock e jazz come Bauhaus, DNA, Brian Eno, Chrome, Lounge Lizards, Gaznevada e Rats. E la parola futuro nel titolo del festival rende ancora più evidente la volontà di questi artisti di immaginare un’idea musicale di profilo ben più ampio e ricco di visioni nuove. Sulla scia di queste esperienze prendono il via progetti ancor più utopistici e ambiziosi come la «Socìetas Raffaello Sanzio» attiva dal 1981 e il «Teatro Valdoca» nei primi anni Ottanta per iniziativa della poetessa e drammaturga Mariangela Gualtieri e del regista Cesare Ronconi. Se gli spettacoli della «Socìetas» sono caratterizzati da una rappresentazione svincolata dal testo letterario di riferimento attraverso performance e videoinstallazioni il teatro «Valdoca» si muove con una costruzione della azioni sceniche senza mansioni predeterminate come accade agli esperimenti musicali provati alla fine degli anni ‘70 dal progetto «Carnascialia» con «esplorazioni» di territori africani e brasiliani e collaborazioni con artisti di diversa estrazione come pittori, scultori, compositori e musicisti. Un’eredità che verrà raccolta da un’altra rivista: «Frigidaire», che dal 1980 riunisce intelligenze che esprimono prima di tutto con una nuova grafica e fumetti innovativi una visione della cultura, della creatività, persino della politica, diversa da quella che aveva dominato soprattutto gli anni ‘60. Basta ricordare la celebre performance di Andrea Pazienza e Vincenzo Sparagna con cui venne presentato il primo numero della rivista a «Lucca Comics» nel 1980. Il direttore paragonò il gesto provocatorio di mimare l’uso di una siringa di Pazienza ai colpi «sparati» da Sid Vicious dei Sex Pistols sui fan in ascolto, una scena che anticipava lo sguardo nuovo su comportamenti e pratiche esistenziali che stavano per affermarsi nel nuovo decennio ‘80. Come pure la presenza di Mario Schifano fra i collaboratori e il protagonismo di figure immaginarie come Ranxerox e Zanardi mostravano la capacità di rappresentare un mondo mutato attraverso forme grafiche e narrative totalmente nuove. Un messaggio che si riproporrà all’alba degli anni ‘20 del terzo millennio con le strisce con cui Zerocalcare racconterà la quotidianità del quartiere romano di Rebibbia e la guerra in terra curda.
Tornando alla sperimentazione nei campi dell’arte creativa che esplode nei primi anni ‘70 va sottolineato come si muova con un’attenzione crescente alla sperimentazione proprio mentre incita alla ribellione e alla ricerca di nuove utopie esistenziali e creative. Un’idea che si afferma anche nella scena britannica con il lavoro della cosiddetta scuola di Canterbury che vede fra i suoi protagonisti la psichedelia pastorale di Robert Wyatt, Henry Cow, Gong, Caravan, schieramento importante perché fa convivere, come in Italia nel lavoro di Area, Stormy Six e in parte al Canzoniere del Lazio, impegno politico e innovazione musicale ed esistenziale. Sta di fatto che temi nuovi come le culture alternative e l’internazionalismo inteso come condivisione di valori e strumento per la liberazione dei popoli stanno entrando anche nel flusso emotivo di musicisti che emergono in quegli anni anche in Italia, fra questi Eugenio Finardi («Extraterrestre»), Claudio Rocchi («Volo magico»), Battiato («Fetus»), che accantonano la canzone «politica» in senso stretto per cercare prospettive nella sperimentazione supportata da pensieri e valori morali nuovi. Non a caso la voce recitante che apre l’album «Arbeit Macht frei» nel citato pezzo «Luglio, agosto, settembre (nero)» è una voce araba che evoca territori diversi e ben più ampi delle piazze italiane per indirizzare gli ascoltatori verso nuovi spazi sonori che dilatano la sensibilità della mente e del pensiero e proseguono con l’evoluzione del sound del gruppo in cui si mescolano melodie arabeggianti, veloci cambi di tempo, progressioni armoniche. Un mix che trova il marchio di riferimento già in una copertina «mirabilmente situazionista-dadaista all’esterno, come scrive Roberto Gatti nella presentazione del disco, con quel pupazzo inchiavardato con un grande lucchetto Yale, trova
qui a Rock, utopia e liberazione Rock, utopia e liberazione
al suo interno una soluzione fotografica profondamente visionaria» e internazionalista che si esplicita nella presentazione della band come «Area International POPular Group» proprio a sottolineare la forte attenzione verso uno spirito comune ad altri popoli accomunati dall’area geografico-culturale mediterranea. Ma anche a evidenziare, scrive ancora Gatti: «come in quegli anni, qualunque empito di carattere nazionalistico, qualsiasi arroccamento di tipo regionalistico sui modi e i ‘mood’ del fare musica sarebbe stato sconfitto senza pietà. Non dalla volontà dei singoli, ma dal giudizio superiore della Storia». Infatti i valori proposti dalla band, sono condivisi non solo da radicali, comunisti, utopisti del nuovo rock ma da altre formazioni musicali che avviano l’attività sempre in quel fatidico 1972. Come il Banco del Mutuo Soccorso che pubblica l’album «Darwin!» seguito da un altro con un titolo che sembra la sua logica evoluzione: «Io sono nato libero» e idealmente affiancare il citato «Fetus» di Franco Battiato. Una serie di messaggi che prendono le distanze dal furore ideologico del passaggio ‘60/‘70 ma non dall’idea che si debba aprire la mente verso un’idea più ampia di quella proposta dai confini culturali tradizionali. I musicisti sembrano porsi il problema di come affrontare un mondo che non si comprende perché anche gli strumenti a disposizione fino a quel momento appaiono limitati o forse semplicemente superati, vedi il caso di «Aspettando Godot» pubblicato dal cantautore bolognese Claudio Lolli nel 1972, o «Preludio, tema, variazioni, canzona» degli Osanna che unisce racconti dei musicisti napoletani ai sinfonismi psichedelici di Luis Enriquez Bacalov. E anche Francesco Guccini, il più sensibile ai temi politici fra i narratori canori degli anni ‘60 con titoli come «Auschwitz» e, soprattutto a proposito di squarci visionari sul futuro, «Noi non ci saremo», lancia sempre nel 1972 «Radici» il suo album più celebre animato da una sfrenata voglia di libertà e da un sentimento di lotta contro le diseguaglianze come mostrano canzoni come «La locomotiva», «Canzone dei dodici mesi», «Il vecchio e il bambino» e «La canzone della bambina portoghese». Così pure Claudio Rocchi è un altro testimone importante di questa stagione come attivista del movimento pacifista e attento osservatore di nuovi valori che condivide con altri musicisti di quel periodo come gli stessi Area. Ne sono prova anche la sua raccolta di poesie «Le sorprese non amano annunciarsi: sono un gruppo rock di fanciulle, suonano nude e sono bellissime» e la partecipazione al film di Franco Battiato «Musikanten». Esperienze che spiegano bene come prospettive culturali e idee stessero cambiando perché venivano costruite su percorsi nuovi in cui gli impegni personali potevano diventare decisivi. Come racconta Demetrio Stratos, memorabile voce degli Area, che ha descritto l’infanzia ad Alessandria d’Egitto simile a quella di «un facchino in un albergo internazionale» capace di vivere l’esperienza dei viaggiatori e di assistere al traffico di culture in quel Mediterraneo ricco di diverse etnie e pratiche musicali.
Questi nuovi protagonisti della musica sembrano consapevoli che la musica, la letteratura e le nuove arti possano offrire un racconto più profondo, come mostra anche la corrente del folk revival rappresentata in modo particolare dall’esperienza ambivalente del Canzoniere del Lazio. Che nel primo album «Quando nascesti tune» del 1973 si muove con obiettivi politici originati dalla ricerca sulla musica popolare mentre nei lavori successivi «Lassa sta’ la me creatura», «Spirito bono», «Miradas» e «Morra» scelgono di privilegiare il linguaggio dell’innovazione e della sperimentazione. Un percorso che, non a caso, si sviluppa parallelamente a quello degli Area, nel corso degli anni ‘70 e si discosta nettamente dal lavoro di un gruppo come gli Stormy Six che invece rimane fedele all’uso politico della musica mentre nel caso di Area, Canzoniere e Rocchi è la musica ad essere politica. L’approdo di questo lungo percorso non potrà che essere un’opera collettiva come la citata «Carnascialia», ambizioso progetto lanciato nel 1978 da Pasquale Minieri e Giorgio Vivaldi del Canzoniere del Lazio con il coinvolgimento della crema dei musicisti più attivi nel rock, jazz e folk più sperimentale di
qui a Rock, utopia e liberazione Rock, utopia e liberazione
fine anni Settanta, fra cui Demetrio Stratos, Piero Brega, Mauro Pagani, Carlo Siliotto, Maurizio Giammarco, Clara Murtas, Walter Calloni, Danilo Rea. «Carnascialia» apre ancor più ad influenze diversificate costruendo una musica di fusione mediterranea dove trovano spazio sperimentazione e linguaggi della tradizione popolare e una anticipazione della multimedialità che caratterizzerà l’approccio di molta parte della scena musicale del terzo millennio. Prima con le utopie sonore dei CCCP di «Epica Etica Etnica Pathos», poi dei CSI di «Ko de mondo» quindi degli Ustmamò, Disciplinatha e del laboratorio Great Complotto di Pordenone per confluire infine nel lavoro di narratori della scena indipendente 2.0 come Vinicio Capossela, Simone Cristicchi, Vasco Brondi, Colapesce. D’altra parte tornando al 1973 titoli come «Caravanserai» e «L’abbattimento dello Zeppelin», presenti sempre in «Arbeit Macht Frei», profetizzavano attraverso metafora un racconto del tempo che mutava secondo una descrizione vicina al lavoro di un compagno di strada degli Area, anche se non stretto collaboratore, come Franco Battiato. L’artista siciliano non per caso è stato il primo a lavorare con strumenti multimediali: pittura, elettronica, folk per presentare le sue traiettorie utopistiche e libertarie. Dal 1973 con testi ricchi di metafore e simbolismi vicini alle avventure di Area e Rocchi in album come «Sulle corde di Aries», «Clic!», «L’Egitto prima delle sabbie» e poi dagli anni ‘90 con le narrazioni viscerali e teatrali del filosofo Manlio Sgalambro in lavori come «L’ombrello e la macchina da cucire», «Gommalacca», «Ferro battuto» e «Dieci stratagemmi». A dispetto della descrizione di Battiato come grande autore di melodie, cosa che in effetti è sempre stato, va ricordato quanto abbia anticipato il rilancio del testo al servizio di una luce nuova attraverso l’evocazione delle filosofie orientali oppure, all’opposto, la grande musica di Beethoven a cui ha dedicato il film «Musikanten». È interessante vedere come le traiettorie che collegano Demetrio Stratos e gli utopisti libertari degli anni ‘70 ai nuovi semi culturali del tempo presente trovino un riferimento simbolico in Vasco Brondi, già Luci della Centrale Elettrica, che presenta i suoi spettacoli/reading come «Una cosa spirituale. Canzoni, poesie, letture, riflessioni» in questo modo:
«Un cortocircuito tra musiche sacre: candomblé e raga, madrigali e mantra, Bach e canti gregoriani. Attraverso voci e parole di scrittori, poeti e filosofi che hanno sovrapposto la ricerca artistica a quella mistica da Thoureau a Chandra Candiani, da Franco Battiato a Carrére, da Rumi a Santa Teresa, da Mariangela Gualtieri ai CCCP e altri. E in mezzo le mie canzoni con personaggi in ricerca continua che si agitano cercando la pace».
Le parole di Vasco Brondi già così rilevanti sul piano emotivo e ideale in un momento in cui tutti abbiamo una estrema necessità di riflettere sul tema della pace acquistano ancora maggior forza. D’altro canto utilizzare la sua narrazione musicale per questioni che riguardano le relazioni umane e il lancio di nuovi valori è sempre stato l’obiettivo fin dai suoi esordi con il marchio di Luci della Centrale Elettrica perché per comprendere la profondità dei sentimenti che ci circondano spesso non basta ascoltare le melodie. Infatti Brondi è solo uno dei molti artisti che ha utilizzato i mezzi più diversi – scrittura, fumetto, fotografia - per realizzare la sua produzione poetico musicale. Anche quando porta in scena «Una cosa spirituale». «Un’idea che da tempo avevo voglia di sviluppare – ha dichiarato - e che negli ultimi mesi sono riuscito finalmente a mettere a fuoco in uno spettacolo terreno e ultraterreno, un’indagine nel doppio fondo di un mondo materialista». Una traiettoria che Brondi aveva avviato già cinque anni fa con «Dieci anni di musica fra la via Emilia e la via Lattea»: «un libro di avventure. Un monologo di questi anni di musica visti da dentro. Coloratissimo con foto sgranate fatte con i primi cellulari e ad alta definizione. Locandine fotocopiate, copertine e disegni di avvicinamento alla copertina con le liste dei libri che leggevo mentre scrivevo un disco o dei viaggi che facevo». Ma con questo lavoro l’artista non intendeva consacrare la superiorità della parola sulla melodia ma confermare
quanto affermava De André quando definiva la musica un tram che portava le parole. Intento mostrato con grande evidenza dai lavori realizzati dal cantautore genovese nei primi anni ‘70 – «La Buona novella» e «Non al denaro non all’amore né al cielo» – in cui si affidava più alle parole e alla poesia per immaginare nuovi possibili percorsi e utopie. Così anche nel terzo millennio, come in quei primi anni ‘70, torna l’urgenza da parte dei nuovi artisti, fra cui sicuramente Vasco Brondi, di rappresentare le proprie visioni ideali con composizioni fortemente metaforiche come «Spiaggia deturpata», «Costellazioni», «Paesaggio dopo la battaglia». Tutti brani che richiamano con potente carica emotiva il messaggio proposto in «L’abbattimento dello Zeppelin» degli Area, «Up patriots to arms» di Battiato, «Spara Jurij» dei CCCP dove venivano lanciati gli stessi inquietanti presagi.

Percorso di lettura: tra guerra e pace
Libri e formiche
La guerra come morbo subdolo che si insinua nelle vite. La guerra come macchina implacabile, che tutto distrugge e calpesta. Che piove dal cielo con scrosci di bombe. Che non sa leggere, sa solo incendiare. Sono queste alcune delle immagini che evoca lo scrittore e poeta José Jorge Letria nell’albo La guerra (Salani, 2020) e da cui partiamo per un breve percorso di letture sul tema.
Uno degli aspetti che colpisce maggiormente in questo libro, e che si nota anche attraverso le illustrazioni di André Letria, è la rappresentazione della non-umanità della guerra. Vediamo raffigurati mezzi bellici, inquietanti ragni e serpenti ciechi e poi divise, stivali, elmi. Ma l’elemento più caratteristico per raffigurare l’essere umano - il corpo nella sua unicità - scompare. Quando appaiono volti, sono maschere prodotte in serie in una fabbrica; quando vediamo i soldati, essi sono tutti uguali, nell’abbigliamento e nella posa, indistinguibili. Quando ci sono dei corpi, scomposti e abbandonati, non riusciamo a distinguerne la faccia. Colpisce e fa riflettere questo modo asciutto e incisivo, estremamente efficace, che hanno i due autori di descrivere come la guerra può stravolgere tutto ciò che tocca, cambiandone addirittura l’intrinseca natura.
La capacità di toccare questioni essenziali quando si parla di temi universali è anche una caratteristica di David Almond, autore inglese di numerosi romanzi per ragazzi. Recentemente pubblicato in Italia, La guerra è finita (Salani, 2021), racconta una storia nel contesto della prima guerra mondiale ma il mondo in crisi che viene descritto e la sua assuefazione alla violenza sono pienamente attuali. Il cuore del racconto è racchiuso nella domanda urgente di John, il bambino inglese protagonista: “come
può un bambino essere in guerra?” Il mondo adulto, anestetizzato dalla propaganda, non vuole ascoltare, né sembra capace di cercare parole da contrapporre al rombo sordo delle fabbriche di granate. È, allora, lo stesso John, dopo l’incontro fortuito con un uomo che ha scelto di ribellarsi alla guerra, a gettare un seme di speranza. La risposta alla sua domanda si trova in parole di pace, semplici ma dirompenti, che il bambino scrive per lettera a un coetaneo sul fronte nemico. “Sono un ragazzino come te. Non sono in guerra contro di te. Non sei in guerra contro di me”. John lo conosce solo attraverso un disegno e un nome - Jan - molto simile al suo. Ma tanto basta: la barriera si spezza, l’altro non è più un mostro senza nome.
La rappresentazione distorta di chi è dalla parte opposta è il tema dell’albo illustrato Il nemico di Davide Calì e Serge Bloch (Terre di mezzo, 2014, purtroppo attualmente esaurito ma reperibile in biblioteca). In questo libro si racconta la storia di un uomo che combatte in trincea contro il suo nemico. Il soldato non ha mai visto in faccia il suo avversario ma gli hanno ripetuto che è spietato e malvagio. Per questo ogni mattina, obbedendo agli ordini dei suoi comandanti, spara verso l’altra trincea, e subito corre al riparo perché il nemico puntualmente risponde allo stesso modo. Ma cosa succede se una notte il soldato decide di strisciare verso la linea avversaria per cogliere di sorpresa il nemico? Quello che troverà sarà sconvolgente perché lo metterà di fronte al fatto che il nemico non è poi così diverso da lui.
Per concludere il nostro percorso è doveroso citare almeno un testo del maestro Gianni Rodari che nelle sue filastrocche e nelle sue novelle ha parlato spesso di guerra e di pace. All’interno della raccolta Favole al telefono (Einaudi, la prima edizione è del 1962) si trova il racconto La guerra delle campane in cui vediamo due eserciti fronteggiarsi. Ad un certo punto, per mancanza di bronzo entrambi gli schieramenti decidono, l’uno all’insaputa dell’altro, di fondere le campane dei loro paesi per fabbricare cannoni così potenti da annientare definitivamente i nemici. Ma qui compare, ancora una volta, il guizzo geniale del grande autore che trasforma uno strumento di violenza e di morte di qualcosa di opposto. Perché, con enorme sorpresa dei due tronfi condottieri, quando vengono azionati, i cannoni non sparano palle infuocate ma producono uno scampanio allegro che risuona per le valli. Ai generali non resterà che fuggire mentre tutti gli altri festeggeranno lo scoppio della pace.
Testi citati:
J. J. LETRIA e A. LETRIA, La guerra, trad. it. di Vivian Lamarque, Salani, Firenze 2020
D. ALMOND e D. LITCHFIELD, La guerra è finita, trad. di G. Iacobaci Salani, Firenze 2021
D. CALÌ e S. BLOCH, Il nemico, Terre di mezzo, Milano 2014
G. RODARI, La guerra delle campane in Favole al telefono, Einaudi, Torino 2010
